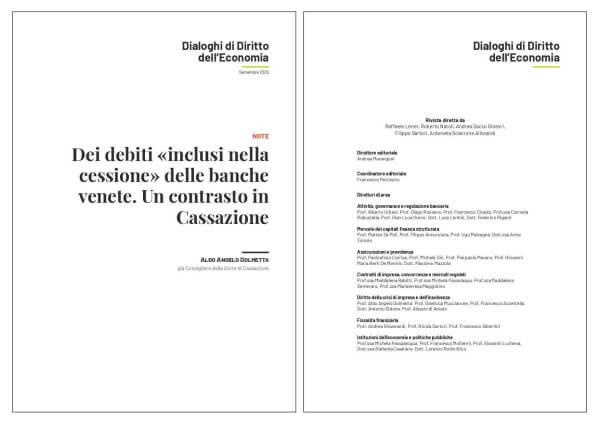SOMMARIO: Il presente contributo prende spunto dall’udienza dello scorso 30 maggio della prima sezione della Corte di Cassazione con cui è stata affrontata una delle questioni più controversie relative alla vicenda delle banche venete: quella della responsabilità della banca cessionaria per le pretese restitutorie o risarcitorie azionate in giudizio dai clienti delle banche cedenti precedentemente al contratto di cessione di azienda.
Più specificamente, l’autore approfondisce tale profilo ponendo a confronto i differenti approcci interpretativi sostenuti dalla prima sezione e dalla terza sezione, sia con riferimento alla lettura della normativa del d.l. 99/2017 che alla sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 2022, pronuncia essenziale per comprendere struttura e contenuti del contratto di cessione.
ABSTRACT: This contribution takes its cue from the hearing held on 30 May by the First Civil Section of the Italian Supreme Court, which addressed one of the most controversial issues surrounding the case of the Venetian banks: the liability of the transferee bank for restitution or compensation claims brought by customers of the transferor banks prior to the business transfer agreement.
More specifically, the author explores this issue by comparing the differing interpretative approaches taken by the First and Third Civil Sections, both with regard to the interpretation of Decree-Law No. 99 of 2017 and in light of Constitutional Court ruling No. 225 of 2022—an essential decision for understanding the structure and content of the transfer agreement.
1. Le pronunce della Prima Sezione civile
1.1. Nell’udienza dello scorso 30 maggio, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affrontato una delle questioni più calde e importanti della assai complessa vicenda delle «banche venete»: quella dell’eventuale responsabilità della banca cessionaria per le pretese restitutorie o risarcitorie azionate in giudizio dai clienti delle banche cedenti in epoca antecedente alla stipula del contratto di cessione di azienda. Fermi il presidente e gli altri membri del collegio, nel concreto delle otto fattispecie[1] fatte oggetto di esame le pretese azionate dai clienti hanno tratto titolo da fatti di usura, di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto, di giorni valuta e da scorretti comportamenti di una delle banche cedenti nello svolgimento del rapporto di mutuo[2]; in uno dei casi esaminati, da assunta nullità del contratto quadro e da inadempimenti nel contesto dello svolgimento di servizi di investimento (con particolare riferimento a derivati in valuta estera)[3].
Con motivazioni tra loro sovrapponibili – salva naturalmente la parte iniziale, relativa alla descrizione dei motivi di ricorso in concreto proposti, talvolta dalla banca cessionaria, talaltra dai clienti delle banche cedenti -, le otto ordinanze decisorie hanno escluso la (legittimazione passiva e) la responsabilità della detta banca, ritenendo che le pretese così azionate rimanevano esterne ed estranee al perimetro fatto oggetto della cessione di azienda con il contratto del 26 giugno 2017, in ragione del fatto che derivavano da «rapporti esauriti» (ovvero «estinti», secondo altra terminologia utilizzata da queste pronunce) al tempo della cessione medesima. Più nel dettaglio, la motivazione sviluppata dalle dette pronunce si snoda essenzialmente – e al di là di qualche ansa espositiva – a mezzo degli step che seguono (per semplicità, i richiami e riferimenti vengono tratti, salvo diverso avviso, dalla pronuncia n. 15083/25, la prima in ordine di pubblicazione delle otto ordinanze gemelle).
1.2. Il primo nodo dà vita a una lunga premessa (n. 2.3. ss.), contenente la trascrizione di più passaggi della pronuncia della Corte Costituzionale, 7 novembre 2022, n. 225 (emessa in relazione a stimati, ma esclusi, vizi del d. l. n. 99/2017, quale normativa «a monte» del contratto di cessione[4]), specie con riferimento, tra le altre cose, ai richiami dalla Consulta fatti (i) alla manifestazione d’interesse espressa dalla banca futura cessionaria; (ii) alla natura di «norma-provvedimento» del detto decreto legge; (iii) alla rilevanza del «programma obbligatorio regolato dalle parti nel contratto di cessione».
Da questi passi la motivazione ritiene di trarre più riflessi: che per la ricostruzione dell’oggetto della cessione vale solo il contratto reso tra le parti (senza che il decreto possa mai interferire) e che il contratto di cessione – come pure, quindi, la relativa ricostruzione – ha «diretta efficacia» pure nei confronti dei terzi; che per la ricostruzione del medesimo valgono le «comuni regole dell’ermeneutica contrattuale» e che, tuttavia, il contratto in questione risulta un «contratto sui generis»: «è evidentemente da escludere» – così si assume – «che la previsione secondo cui sono escluse dalla cessione, ai sensi dell’art. 3, “le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” possa essere intesa nel senso che, a contrario, sono viceversa incluse nella cessione le medesime controversie qualora sorte anteriormente a essa»; «questo è un ragionamento che in modo piano avrebbe potuto svolgersi, ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, se si fosse trattato di interpretare l’art. 3 sulla base delle regole di interpretazione normativa», ma qui «all’opposto» il decreto «rimette invece ai contraenti l’individuazione» dell’oggetto della cessione (p. 11).
1.3. Lo snodo successivo si concentra – dopo avere riportato ampi stralci del testo contrattuale – sull’interpretazione della clausola dell’art. 3.2. lett. b)[5]. Per l’inclusione nella cessione non basta – si segnala – che la controversia sia anteriore alla cessione; occorre altresì che «si tratti di debiti che “derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”».
L’«espressione» – avverte la pronuncia – è «di contenuto non del tutto univoco», prestandosi a più e contrapposte letture. Più indici mostrano, tuttavia, come con tale «locuzione le parti abbiano inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre a essere inclusi nei rapporti aziendali, rilevino finalisticamente per lo svolgimento della specifica attività di impresa della cessionaria: che cioè le passività oggetto di trasferimento debbano inscriversi in rapporti che, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria» della cessionaria.
Tali indici consistono – specifica la Corte – in ciò: che la clausola parla non già di attività (bancaria), bensì di «impresa» (bancaria) e che tale parola «si identifica, sul piano oggettivo, con l’azienda»; che ogni altra lettura della clausola renderebbe inutile la posizione della clausola, dato che l’«azienda è per definizione (art. 2555 c.c.) comprensiva di tutti i rapporti che sono inerenti a funzionali all’esercizio dell’impresa stessa»; che l’interpretazione accolta è «coerente con l’interesse manifestato [dalla banca cessionaria] nei confronti dell’operazione», le stesse premesse del contratto chiarendo che «l’obiettivo della cessionaria» consisteva «nell’estrarre valore dall’acquisizione … anche recuperando la fiducia nella clientela [e] contribuendo alla salvaguardia dei livello occupazionali» .
1.4. L’ultimo, breve, snodo è dedicato alle «conferme» della soluzione che è stata così raggiunta (fine n. 2.6 e n. 2.7). Di queste, una viene vista nel fatto che il contratto esclude dalla cessione i crediti deteriorati: «sarebbe poco coerente» – si chiosa – che la cessionaria, non subentrata nei rapporti in atto in cui il debitore non era un buon pagatore … lo sia invece nelle obbligazioni restitutorie dell’indebito e/o risarcitorie concernenti rapporti già estinti»[6] .
Un’altra conferma viene individuata in ciò che «nel Secondo Accordo Ricognitivo stipulato in data 17 gennaio 2018, l’esclusione dalla cessione «è stata ribadita dai commissari liquidatori» e dalla cessionaria[7]. Ulteriore conferma è ravvisata, poi, nel fatto che «nell’allegato D al contratto di cessione [si], rispettivamente, i “crediti verso clientela” e i “debiti verso clientela”, tale (cioè clientela) potendo essere solo quella intestataria dei contratti in corso».
2. Le pronunce della Terza Sezione civile
2.1. Alla questione, che è stata così decisa dalla Pima Sezione (nel senso appunto che le azioni restitutorie o risarcitorie proposte dai clienti delle cedenti prima stipula del contratto di cessione e in relazione a «rapporti estinti» al tempo della cessione, non fanno parte della cessione operata nel giugno 2017), ha tuttavia dato risposta diversa – opposta, si può anche dire – la giurisprudenza della Terza Sezione della Corte. Che ha affermato (la legittimazione passiva e) la responsabilità della banca cessionaria nei confronti delle pretese di taglio restitutorio o risarcitorio azionate da terzi in tre diverse occasioni, sgranate nel tempo e frutto di collegi di diverse composizioni (pur se presiedute dal medesimo magistrato).
2.2. La prima decisione, che viene in considerazione al riguardo, è la sentenza di Cass., 21 giugno 2023, n. 17834, che ha, come sua sponda di base, il (mancato) «pagamento delle somme derivanti dalla liquidazione delle obbligazioni ordinata dalla curatela» (n. 12 della motivazione) fallimentare creditrice rispetto a un «rapporto sostanziale già esaurito e chiuso» (n. 7) e inerente a un «deposito titoli funzionalmente connesso al contratto di conto corrente» (n. 29)[8]. Secondo questo arresto, dunque, «il combinato disposto del menzionato decreto [ d. l. n. 99/2017] e del contratto di cessione – le cui disposizioni “hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia (nel proprio sito internet) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa” comporta il subentro [della banca cessionaria] anche nei rapporti processuali pendenti e, dunque, anche nei debiti eventualmente derivanti dalle relativa decisioni giudiziali, senza che assuma rilievo la cessione della posizione giuridica sostanziale».
A fondamento di questa diversa soluzione, la sentenza pone come centrale la considerazione (che riprende dalla sentenza della Corte di Appello), che il contratto di cessione «non ha trasferito solo il diritto controverso ma ha espressamente incluso nella cessione il “contenzioso pregresso” così definito dall’art. 3.1.2.b.vii»; che tale clausola «chiarisce quali sono le “passività incluse”», e che l’Allegato D «riporta un elenco esemplificativo di tali passività incluse e, al punto (vii) si riferisce ai “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di esecuzione diversi da controversie con azionisti della Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati …». Tale articolato – si spiega – «appare coerente con quello dell’art. 3 d. l. n. 99/2017: «è sulla base del contenuto della norma citata e dell’atto negoziale» che dalla cessione restano «escluse solo le controversie non ancora pendenti alla stata della cessione d’azienda, dovendo evidentemente essere incluse, invece, le controversie pendenti a tale data» (n. 6).
La soluzione così accolta – aggiunge altresì la sentenza – «trova ulteriore conferma nelle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 7 novembre 2022». A conforto di quest’ultima osservazione, la sentenza non manca – nei successivi nn. 9, 10 e 11 della motivazione – di trascrivere ampi passi della sentenza della Consulta: passi che, per la verità, vengono sostanzialmente a coincidere con quelli riportati dalle pronunce della prima Sezione per avvalorare l’opposta tesi (cfr. sopra, n. 1.2.).
2.3. Un’ulteriore decisione della Terza Sezione, che viene qui in interesse, è rappresentata dalla sentenza di Cass., 4 febbraio 2025, n. 2785, che ha, come suo back sostanziale, un’azione revocatoria (non altro appare ricavabile sul punto dal testo del provvedimento).
Richiamati i contenuti espressi dalla precedente decisione della Sezione (cfr. appena sopra, n. 2.2.), «nel solco tracciato» dalla suddetta sentenza, l’arresto precisa che – «in linea con l’art. 3 comma 1, del d. l. n. 99/2017» – «a contrario, le ragioni di credito oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione, con efficacia nei confronti del terzi a far data dalla pubblicazione sul sito della Banca d’Italia della notizia della cessione stessa» (p. 11 s.)[9]. Per poi formalizzare il seguente principio di diritto: «in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete, dal disposto di cui all’art. 3 comma 2 d. l. n. 99/2017 … (che delimita il perimetro della cessione dell’azienda, dei suoi rami, ivi compresi passività e rapporti giuridici, con la sola esclusione delle controversie indicate alla lett. c., “relativa ad atto o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente a essa, e relative passività”) discende, a contrario, che le ragioni di credito (e di debito) oggetto del contenzioso e, quindi, delle controversie sorte anteriormente sono comprese nella cessione».
2.4. L’ultima decisione (allo stato, almeno) della Terza Sezione, che va qui riferita, appartiene all’ordinanza decisoria rilasciata da Cass., 7 giugno 2025, n. 15238, che ha – quale fattispecie concreta di riferimento – una truffa attuata a mezzo di «assegni non trasferibili» versati su un conto corrente (diverso da quello dell’attore) e con il concorso di un dipendente della Banca; questa veniva chiamata in giudizio ex art. 2049 c.c. La Corte di Appello, ritenuto il carattere «bancario della lite» e assunta pure la risoluzione del rapporto di conto prima del contratto di cessione, aveva escluso ogni responsabilità della Banca cessionaria.
Nell’accogliere il ricorso proposto dall’ex cliente, la Corte ha rilevato, anzitutto, che nella specie non veniva in questione un «rapporto bancario», bensì il tema delle «obbligazioni scaturenti dalla legge» (quali, appunto derivanti dall’art. 2049 c.c.). Nel prosieguo, essa, pure richiamando il precedente di Cass., n. 17834/2023, ha rilevato che l’art. 3, comma 1, d. l. n. 99/2017 escludeva non altro che le controversie connotate dalla somma di due caratteristiche: l’essere sorte da fatti anteriori alla cessione; l’essere la relativa lite avviata dopo la cessione[10].
Ciò posto, la decisione segnala inoltre che sulla stessa linea sostanziale si pone pure il contratto di cessione. Questo suddivide «i debiti derivanti da liti pendenti al momento della cessione in due categorie: il «contenzioso pregresso» e il «contenzioso escluso». La prima categoria include «i debiti scaturenti da liti pendenti al momento della cessione»; «la seconda categoria include “qualsiasi contenzioso diverso dal contenzioso pregresso». «Sicché, una volta accertata la sussumibilità del credito [del ricorrente] nella prima categoria, il principio inclusio unius, exclusio alterius [impedisce] di ritenere quel credito estraneo alla cessione».
3. Una pronuncia della Prima non convergente colle precedenti della Sezione
In data 29 luglio 2025 – e quindi proprio nei giorni dell’oggi – è stata pubblicata un’altra decisione della Prima Sezione che attiene alla materia in discorso. Si tratta dell’ordinanza decisoria n. 21808/2025. La peculiarità di questa pronuncia sta in ciò che, a ben vedere, essa risulta non propriamente in linea con l’orientamento espresso dai precedenti rilasciati da questa Sezione (sopra, n. 2), ma per certi versi divergente rispetto ai contenuti dello stesso. Nel senso che segue.
La pronuncia, dunque, riporta ampiamente i precedenti della propria Sezione – del tutto ignorando, invece, quelli della Terza – e sottolinea, anzi, come tali precedenti escludano dall’ambito della cessione «i rapporti bancari già estinti alla data predetta» (come indicata nel «26 giugno 2017»; cfr. il n. 4.1. dell’assetto motivazionale). Ma ritiene che la fattispecie nel concreto sottopostale sia diversa: «nel caso ora in esame … si deve riscontrare una peculiarità che non solo varrebbe a distinguerlo dai casi oggetto delle precedenti decisioni di questa Corte, ma anche viene a evidenziare la stessa inammissibilità del motivo di ricorso» (presentato dalla banca cessionaria). Peculiarità che così viene individuata: «i rapporti di conto corrente intercorrenti originariamente tra «la banca veneta] e gli odierni controricorrenti risultavano, al momento della istaurazione del giudizio, non estinti».
Ora, è chiaro che il criterio discretivo così utilizzato si manifesta diverso da quello adottato da quelle dei primi interventi della Prima Sezione (sopra, n. 1): un conto è che il rapporto non sia chiuso al tempo della cessione[11]; un altro conto, invece, è che non risulti chiuso al tempo di avvio della lite (purché questa sia comunque anteriore alla cessione): anche sotto il profilo meramente materiale, tra i due criteri possono passare anni. Né, per vero, il criterio della permanenza del rapporto al tempo di avvio della lite appare particolarmente coerente con i contenuti funzionali della tesi sviluppata dai primi otto arresti di tale Sezione.
Tutto questo potrebbe fors’anche far pensare, allora, che la pronuncia in discorso venga, in una qualche misura, a dare corso a una tendenza per così dire un po’ «riduzionistica» della tesi – della «inclusione pressoché inesistente» (su questo punto v. pure infra, nel n. 6.2) – che è stata inizialmente enucleata dalla Prima Sezione; comunque, a una prospettiva diversa. E in questa direzione – va aggiunto – spinge pure la constatazione che a presiedere il collegio, che ha governato la fattispecie concretamente esaminata dalla decisione n. 21808/2025, è lo stesso magistrato che ha presieduto il collegio che ha esaminato le prime otto fattispecie (: le ordinanze gemelle).
4. L’effettiva attualità del contrasto
4.1. Non mancano, per la verità, precedenti di casi in cui gli orientamenti delle due Sezioni della Corte – della Prima e della Terza – hanno preso prospettive divergenti e, nel merito, anche molto lontane tra loro. Per il recente, basta qui richiamare la questione dell’eventuale rilevanza sui contratti di mutuo e di leasing dell’«Euribor manipolato» tra il 2005 e il 2008[12]: positivamente instradata dalle decisioni della Terza e dalla Prima senza alcun indugio rinviata – con ordinanza interlocutoria apertamente orientata nel senso invece della non rilevanza – al giudizio delle Sezioni Unite. In quell’occasione, appena riscontrata la sussistenza del contrasto con la Terza, la Prima Sezione ebbe, tra l’altro, pure a sottolineare di essere, essa, «tabellarmente competente per le controversie sia in materia di concorrenza e impresa in generale, sia in materia di contratti bancari»[13].
Nella presente occasione, la Prima Sezione pare abbia deciso di intraprendere una strada diversa e, se si vuole, anche di profilo minore. Presa notizia dei contrari precedenti della Terza (rectius, dei primi due arresti, l’intervento della pronuncia n. 15238/2025 essendo sostanzialmente contestuale al suo; cfr. sopra, n. 2.4.) la Prima – che anche su questa problematica ancora non si era espressa – decide di tirare dritto: solo in coda alla motivazione, e per dire anche in margine, apponendo poi una breve nota di puntualizzazione, che in via espressa principia specificando di venire svolta solo per «esigenze di completezza» (questo passaggio è tratto da Cass., n. 15083/2025, n. 2.9.).
Nel concreto delle cose, la Prima Sezione viene ad assumere che «non può darsi seguito» all’indirizzo della Terza Sezione, «sia per la peculiarità delle concrete fattispecie che ne costituivano l’oggetto» , «sia, soprattutto, per l’essere mancato, in quelle sedi, l’esame della disciplina del contratto di cessione intercorso … sotto il particolare profilo della inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria dei rapporti» indagati (così, in particolare, si esprime la decisione n. 15671/2025, n. 14)[14].
A ben vedere, però, i rilievi così svolti dalla Prima si manifestano un po’ troppo sbrigativi nei confronti dell’orientamento che risulta sviluppato dalla Terza; o così, almeno, a me pare. In ogni caso, tali rilievi non appaiono bastanti a sopire – a non fare emergere, se si preferisce – il contrasto tra i due orientamenti, e quindi il conflitto, che nell’attuale attraversa la materia al livello della giurisprudenza della Corte di Cassazione. E tanto, naturalmente, del tutto al di là della correttezza degli argomenti hinc et inde spesi al riguardo (per questo aspetto v., peraltro, i cenni che verranno fermati nel contesto dei prossimi nn. 5 e 6).
4.2. In proposito, è da osservare, prima di tutto, come non risulti condivisibile l’affermazione della Prima Sezione sulla «peculiarità delle fattispecie concrete» giudicate dalla Terza Sezione. Questo, se non altro, perché una delle fattispecie concrete scrutinate dalla Terza non ha sostanza differente da quella esaminata da uno dei casi proposti alle ordinanze gemelle: sia la n. 17834/2023 (Terza Sezione), sia la n. 15686/2025 (Prima Sezione) gravitano, infatti, nell’ambito dell’attività imprenditoriale di «gestione titoli»; la stessa banca cessionaria segnala, del resto, che la fattispecie concreta lì analizzata dalla Terza rientra nell’ambito dell’art. 1838 c.c. e, per conseguenza, riflette un contratto dal codice civile definito come bancario (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 2.2.).
D’altra parte, le decisioni della Terza ritengono che la responsabilità della banca cessionaria nei confronti dei terzi (tali rispetto al contratto di cessione) possa venire a operare anche al di fuori dai «rapporti bancari»: esplicita in questa direzione è (al di là di ogni altro risconto) la decisione n. 15238/2025 (v. n. 2.4.). Il che, per vero, toglie molto spessore, al di là di ogni altro rilievo[15], alla critica della mancata lettura della formula della «inerenza e funzionalità all’esercizio dell’impresa bancaria» che la Prima Sezione rivolge alla Terza: se non altro, la priva, per così dire, di ogni ipotetica perentorietà.
In ogni caso – è bene pure aggiungere per la maggiore completezza di esposizione -, non sarebbe corretto assumere che le decisioni delia Terza riguardino fattispecie per certi lati diverse da quelle oggetto degli arresti della Prima e, cioè, che non si occupino di rapporti contrattuali esauriti ovvero estinti. Per smentire l’attendibilità di una simile (ipotetica) idea, sembra sufficiente in questa sede osservare che nelle fattispecie decise dalla Terza[16] la banca cessionaria ha per l’appunto sostenuto, nel contesto delle proprie difese, che si trattava, nella specie concreta, di rapporti contrattuali esauriti e che – a una valutazione che adotti il metro praticato dalla Prima Sezione in punto di definizione di «rapporto esaurito» (cfr. n. 6) – presumibilmente i casi della Terza sarebbero da etichettare nei termini di rapporti contrattuali esauriti.
Non pare dubbio, comunque, che i principi di diritto rispettivamente emessi dalla Terza Sezione e dalla Prima Sezione siano tra loro non compatibili[17].
4.3. Detto questo, occorre altresì (e, forse, soprattutto) osservare che, al fondo delle cose, le due Sezioni leggono la questione in discorso e la normativa (di legge e di contratto), che alla stessa fa da riferimento, secondo prospettive alquanto differenti.
La Terza l’affronta nella prospettiva della «controversia» e, quindi, della responsabilità della banca cessionaria nei confronti dei terzi: secondo quanto è consentaneo alla norma dell’art. 2560, comma 2, c.c.[18] e secondo quanto è propriamente richiesto dalla tipologia problematica che forma oggetto delle controversie concretamente portate all’esame. Sul punto, la sentenza n. 17834/2023 è davvero esplicita: il tema attiene al «subentro [della banca cessionaria] anche nei rapporti processuali pendenti e, dunque, anche nei debiti eventualmente derivanti dalle relativa decisioni giudiziali, senza che assuma rilievo la cessione della posizione giuridica sostanziale» (l’enfasi è aggiunta). Come si vede, pensiero e prospettiva sono esposti in modo nitido[19].
Questi, tuttavia, rimangono del tutto ignorati dalle ordinanze gemelle della Prima: sia in termini di critica dell’opposto orientamento, sia pure – e ancora prima – in termini di positiva ricostruzione dei termini della questione. Nei fatti, la prospettiva della Prima si ferma su un altro problema: quale appunto consistente nell’individuazione del soggetto a cui – nel contesto dei contraenti della cessione – appartenga la sopportazione finale del debito di cui si discute. Per trasporre senz’altro – e, parrebbe, pure in modo sostanzialmente inavvertito – la soluzione così raggiunta al piano della responsabilità nei confronti dei terzi.
Si tratta, tuttavia, di tematiche non solo diverse ma, per vero, pure del tutto indipendente l’una dall’altra: non è di certo un caso che – secondo i principi del diritto civile, comuni e basici – la responsabilità esterna (: versi i terzi) segua alla legge, mentre la responsabilità interna (: della ripartizione finale del peso di cui al compendio della cessione) discenda dal contratto.
4.4. Ciò posto, ancora è da riscontrare – sul punto dell’effettivo contrasto in essere tra gli orientamenti esposti dalle due Sezioni – come ben diverse e distanti siano le letture che queste danno della normativa dettata dal d. l. n. 99/2017. Per questo proposito basta qui un esempio. Entrambi gli orientamenti rilevano che, secondo la disciplina, il contratto di cessione prende efficacia diretta nei confronti dei terzi. Sennonché, il significato che viene rispettivamente dato a questa «presa di efficacia» si manifesta radicalmente diverso.
Nel contesto dell’orientamento della Terza si tratta, semplicemente, della presunzione di conoscenza dell’avvenuta cessione, in coerenza del resto con il testo dell’art. 3, comma 2 del decreto («le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d’Italia … della notizi della cessione»). L’orientamento della Prima dà, per contro, un significato assai forte – e alquanto inusuale – a tale presa di efficacia: quella di vincolare senz’altro i terzi, di bloccarli all’interpretazione che, anche dopo la conclusione del contratto e anche dopo l’avvenuta pubblicazione della relativa notizia, i contraenti stabiliscano di dare al testo negoziale.
E poi c’è il punto della sentenza della Corte Costituzionale. Che entrambe le Sezioni ritengono deponga a favore del proprio orientamento. Tant’è che si trovano riportati – di qui, come di là – gli stessi passi motivi della Consulta (cfr. sopra, nel 1.2. e nel n. 2.2., ultimo capoverso). Senza, peraltro, che nessuno spieghi come e perché questi passi avallino l’una ovvero l’altra tesi. Ed è, per vero, ben singolare che le ordinanze gemelle della Prima – che cadono temporalmente quasi due anni dopo il primo (e conosciuto) intervento della Terza – non dicano nulla (: proprio nulla) sulle ragioni per cui ritengono non corretto l’esame costituzionale che appena prima è stato fatto dall’altra Sezione.
A parte tutto il resto, sembra chiaro, insomma, che tra queste due Sezioni non vi sia proprio dialogo.
5. Qualche riflessione a margine, in critica dell’orientamento adottato dalla Prima Sezione
5.1. Registrata l’effettiva sussistenza, nell’attuale, di un contrasto, e quindi di un conflitto, tra gli orientamenti rispettivamente assunti dalla Prima e dalla Terza Sezione della Corte sulla questione in oggetto, rimane ancora un poco di spazio per svolgere qualche piccola (e sparsa) riflessione ulteriore, a margine dell’operazione. A muovere, in particolare, dal contesto che a quest’ultima fa da specifico riferimento.
5.2. Il primo ordine di osservazioni assume – (e tuttavia solo) in thesi – che sia corretto il ragionamento della Prima Sezione per cui, per procedere alla lettura del contratto di cessione, si può – e anzi si deve – prescindere completamente dal decreto n. 99/2017 e dai suoi contenuti: anche se, per la verità, non risulta per nulla chiaro quale sia l’argomento che regge una simile impostazione e pur al di là di ogni regola di gerarchia delle fonti (dell’affermato compiuto svincolo dell’autonomia del contratto di cessione rispetto all’eteronomia del decreto, che pure del concreto negozio traslativo costituisce la base necessaria).
Per riempire questa (ipotetica) carta bianca, la Prima Sezione – nel dare attuazione al criterio interpretativo dell’art. 1362 c.c. – dà molto peso all’interesse manifestato dalla banca cessionaria (cfr., tra le altre, la decisione di Cass., n. 15083 p. 16, in fine; «di assicurare una maggiore sua presenza sul territorio», per il fine di «estrarre valore dall’acquisizione» e «contribuendo alla salvaguardia dei livelli occupazionali»). O meglio: dà peso unicamente all’interesse della banca cessionaria. Perché dell’interesse dei commissari liquidatori, che pure sono costituiscono una parte del contratto, non ne viene proprio a parlare.
Il che, per vero, non sembra corretto: la norma dell’art. 1362 c.c. essendo esplicita nel fare appunto riferimento alla «comune intenzione delle parti». Sì che non pare inopportuno aggiungere, in via di corollario, che l’interesse dei commissari rispetto al contratto di cessione è – non può che essere – istituzionale, quale appunto rappresentato nel contesto del decreto da cui la vicenda (anche) contrattuale prende tratto. Né il decreto si manifesta ambiguo (o assente) in proposito, nel capoverso n. 15 delle premesse sottolineando invece, tra le altre cose, che «in assenza di misure pubbliche di sostegno, la sottoposizione [delle banche venete] a liquidazione coatta amministrativa comporterebbe la distruzione di valore delle aziende bancaria coinvolte, con conseguenti gravi perdite per i creditori non professionali chirografi, che non sono protetti né preferiti» (enfasi aggiunta). Che è poi, nella sostanza, quanto pure è stato ripreso e ribadito dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, n. 225/2022 (con passo che, per verità, non è richiamato a conforto né dalla Prima, né dalla Terza Sezione)[20].
Ne discende, allora, che non corretto e non condivisibile appare pure l’atteggiamento della Prima Sezione là dove essa senz’altro «si quieta» della nuda constatazione che l’interesse dichiarato dalla banca cessionaria non fa riferimento che alla mera (e generica) «salvaguardia dei livelli occupazionali» delle aziende cedute[21].
Anche perché, a ben vedere, la posizione dei clienti creditori da indebito e/o da risarcimento, oltre a essere radicalmente diversa da quella dei soggetti portatori di azioni e obbligazioni subordinate[22], diversa è, per vero, pure da quella dei creditori semplicemente «non professionali e non protetti». In effetti, nella specie presente si sta parlando di una categoria di creditori propriamente involontari: come tali, ovviamente da proteggere anche prima (e, nel caso, in modo più intenso) dei creditori volontari.
D’altra parte, e ancora, tra i criteri ermeneutici di immediato utilizzo da parte dell’interprete compare anche quello che ricorre in modo diretto al canone della buona fede oggettivo (art. 1366 c.c.). Il silenzio tombale, che la Prima Sezione ritiene di mantenere in proposito, non manca, per vero, di fare parecchio rumore.
5.3. Il secondo ordine di osservazioni continua a tenere fermo (in thesi) l’assunto – base non dimostrata di tutto il ragionamento svolto dalla Prima Sezione – per cui le disposizioni del contratto di cessione prescindono compiutamente dai contenuti portati dal decreto n. 99/2017. Anche assunta una simile prospettiva, rimane comunque da chiedersi, nei fatti, se una tale affermata indipendenza totale valga pure (ovvero: persino) nei confronti delle comuni regole del codice civile (se non, addirittura, pure rispetto a quelle di rango più elevato ancora).
Una simile eventualità – che non mi pare sia stata affrontata (quanto piuttosto trascurata o, comunque, data senz’altro per presupposta) dalle pronunce della Prima Sezione, che anzi si richiamano alle comuni regole dell’interpretazione contrattuale – apre, per vero, una prospettiva alquanto diversa e «maggiore»: che va oltre, cioè, quella del contratto sui generis (come dichiarato dalla Corte), per incamminarsi verso il format dell’unicum.
Nel concreto, se non ad altre disposizioni il riferimento, comunque, va di sicuro alla norma dell’art. 2560, comma 2, c.c., che già sopra si è richiamata (nel n. 4.3.), laddove questa dispone la responsabilità (c.d. esterna) del cessionario per i debiti del cedente anteriori alla cessione, che siano inerenti all’azienda e che risultino dai libri contabili obbligatori: fermo comunque restando – è bene per chiarezza ribadire – l’autonomia dei contraenti sul diverso tema della ripartizione interna del debito. Non pare che una simile regola (della responsabilità esterna) sia liberamente derogabile dai contraenti, dato che la stessa viene a incidere direttamente sulla posizione dei terzi, secondo il regime consegnato a loro favore dalla disciplina di legge[23]. In questa prospettiva da sottolineare è, piuttosto, che la tutela apprestata dalla legge comune nell’art. 2560, comma 2, c.c. per i creditori dell’alienante l’azienda costituisce – secondo quanto riscontrato dalla stessa Corte di Cassazione – una sorta di tutela avanzata dei chirografi, per così dire evolutiva della azione pauliana[24].
D’altra parte, non mi pare di avere riscontrato, nel contesto del decreto n. 99/2017, nessuna norma autorizzativa al riguardo, quale passaggio di apertura verso la derogabilità del precetto della legge comune da parte del contratto di cessione[25]. Sarebbe davvero difficile, del resto, accreditare l’idea di un’autorizzazione implicita al riguardo, come pure disponibile per un qualunque ordine di taglio.
Ciò fermato, si può anche aggiungere in limine: quello appena esposto si pone, a me pare, come ordine di ragioni sufficiente per ritenere senz’altro preferibile l’orientamento adottato dalla Terza Sezione (n. 2), che afferma la responsabilità esterna della banca cessionaria, senza occuparsi (visto il tema proprio della controversia) del punto della responsabilità interna.
5.4. Ancora da chiedersi è, in ogni caso, se l’irrilevanza del decreto n. 99/2017 nei confronti del contratto di cessione, che la Prima Sezione predica, sia – ove effettivamente esistente – davvero assoluta o invece, e comunque almeno per certi versi, di segno relativo. E questo, nel caso, anche solo nel senso minimale che, nel caso risultino disponibili più interpretazioni alternative del testo contrattuale della cessione, si debba scegliere quella conforme al dato rappresentato dal decreto (o comunque quella meno lontana dalla scelta fatta della eteronomia).
Quest’ulteriore rilievo prende campo dalla constatazione che – una volta preso atto del solo interesse della banca cessionaria -, per giungere alla conclusione della compiuta estraneità della banca cessionaria nei confronti della categoria di creditori in questione, l’esame della Prima Sezione, se riporta ampi stralci del testo contrattuale della cessione, nella realtà delle cose risulta limitato (alla) ed esaurito dalla considerazione di un pezzetto (di un semplice frammento), della clausola di cui all’art. 3.2.b., che il contratto dedica alle «passività incluse» (cfr. sopra, il passaggio tra il n. 1.2. e il n. 1.3.; per l’esame del frammento v. il prossimo numero).
Si potrebbe ipotizzare, di conseguenza, che un simile modo di procedere non risulti propriamente in linea col criterio interpretativo prescritto dall’art. 1363 c.c. Ciò che, a sua volta, potrebbe (tra l’altro) portare a interrogarsi sulla conformazione tipologica e causale dell’operazione[26], posto in particolare che il canone sistematico, nel predicare la necessità della lettura delle clausole «le une per mezzo delle altre», ricomprende pure (se non prima di ogni altra cosa) il profilo della qualificazione del contratto.
Ora, se ben ho visto, il testo del decreto n. 99/2017 appare far riferimento, per questo peculiare proposito, allo schema sostanziale della c.d. «vendita a prezzo negativo»[27], secondo un modello che, del resto, si trova spesso utilizzato nell’operatività delle cessioni di aziende che presentino livelli di debito assai consistenti: il contratto rimane di scambio, sub specie del tipo della vendita, per il pagamento del relativo prezzo solo prevedendosi peraltro – e in luogo della comune regolamentazione per pezzi monetari – l’assunzione da parte de cessionario di una serie di debiti del cedente, a mezzo accollo (eventualmente, anche esterno); ovvero pure utilizzando al riguardo (in via parziale o anche totale) la figura della responsabilità verso i terzi, che è prescritta nell’art. 2560 comma 2, c.c., e così dando una profilazione anche contrattuale all’obbligazione che è prevista dalla legge. Spesso – si può anche precisare – a una simile conformazione dell’obbligazione del prezzo si congiunge la previsione di un obbligo di prestazioni somme da parte del cedente ovvero pure la predisposizione (a latere) di apposite garanzie reali e/o personali, per la cautela del regresso che il cessionario, che ha pagato i debiti del cedente, venga a esercitare nei confronti di quest’ultimo. In ogni caso, in questa fattispecie tipo la responsabilità – esterna e/o interna – del cessionario dei debiti verso terzi prende (pure) il ruolo di corrispettivo del trasferimento dell’azienda.
A sua volta, il contratto di cessione contempla due previsioni che, per la verità, sembrerebbero disporsi naturalmente nei termini della reciproca corrispettività[28]. Da un lato, sta il trasferimento degli sportelli e filiali delle banche cedenti alla banca cessionaria, con connesso incremento di quest’ultima delle quote del locale mercato bancario, secondo un valore che, a quanto pare, viene stimato assai consistente, posto che le stesse decisioni della Prima Sezione parlano della cessione in termini di «rafforzamento» della cessionaria «come realtà operativa sul mercato creditizio», secondo la specifica funzione di «estrarre valore dall’acquisizione»[29]. D’altro lato, sta la «inclusione» nell’«oggetto» della cessione di una serie di passività, quali appunto quelle rappresentate dai debiti di cui alla clausola dell’art. 3.1.2. lett. b), come dal testo contrattuale predicata in termini positivi, a fianco di una serie di passività, per contro dichiarate «escluse»[30].
Questo, tuttavia, a patto che si tratti in concreto di una corrispettività vera e non già solo fittizia ovvero di mera facciata. Il punto si manifesta, a me pare, di peculiare importanza. Cerco di spiegarmi meglio: la risposta all’interrogativo, che è implicito nell’osservazione appena sopra rappresentata, dipende dall’interpretazione che si ritenga di dare della clausola appena richiamata (sulle passività incluse) ovvero dei contenuti di cui la stessa risulti oggettivamente riempita.
Dare un’interpretazione particolarmente restrittiva della clausola sulle passività incluse – così come potrebbe essere (e come sicuramente è, nel pensiero delle ordinanze gemelle della prima Sezione; sul punto v. melius nel contesto del n. 6.2.) – o comunque mortificante la portata della clausola medesima, in effetti, comporta di per sé stesso l’esplosione di un rischio molto forte: quello di far diventare, di trasformare, un’operazione nata (e consentita) come vendita a prezzo negativo in una operazione di vendita che in realtà risulta essere fatta «a prezzo vile» ovvero pure costituire una liberalità (ché, com’è ben noto, molto labili sono i confini tra l’uno e l’altro ordine di qualificazione).
Sì che allora, in una simile prospettiva effettuale, l’interrogativo sui limiti del possibile distacco dell’operazione costruita nel contratto di cessione rispetto allo schema disegnato nel decreto n. 99/2017 molto difficilmente, a me pare, potrebbe essere non sollevato e, dunque, pure puntualmente approfondito: sia in termini di validità del contratto di cessione[31], sia pure, e comunque, in termini di corretta interpretazione delle sue clausole (nel senso, appunto, della preferibilità della soluzione conforme allo schema del decreto n. 99/2017).
6. (Segue): con riguardo all’interpretazione della clausola dell’art. 3.1.2. lett. b) del contratto di cessione (: «per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria»)
6.1. Rimane ancora da riscontrare la clausola di cui all’art. 3. 3.1.2. lett. b) del contratto di cessione: o meglio il frammento di questa su cui si impegna l’attenzione della Prima Sezione (: «per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti … che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria»; il testo intero della clausola è riportato sopra, nota 5). A me pare, per la verità, che – anche a voler prescindere (sempre in thesi, naturalmente) da tutti i rilievi sin qui svolti[32] – la lettura, che del detto frammento fornisce la detta Sezione, non possa non suscitare più perplessità e assai forti.
6.2. La prima osservazione, che mi pare sia da svolgere al riguardo, possiede per più versi carattere preliminare. Secondo la lettura della prima Sezione, dunque, dovrebbero rimanere esclusi dalla cessione i rapporti bancari già «esauriti» al tempo della cessione[33]. Data una simile formula, ne segue, all’evidenza, che occorre individuare con nettezza i precisi contorni di questa nozione di «rapporto esaurito».
Ora, le ordinanze gemelle non si curano (se ho ben visto, almeno) di esplicitare indicazioni e ragioni per questo particolare proposito. Dal contesto delle fattispecie concrete decise sembra desumibile, peraltro, che esse assumano una nozione molto ampia di «rapporto esaurito»; e quindi, per converso, molto ridotta di «passività inclusa».
Così, per fare un esempio, sembrerebbe di dovere pensare che – secondo il metro per l’appunto adottato nel concreto dalla Prima Sezione – la stessa semplice dichiarazione di chiusura del conto corrente comporti che, da allora in poi, il rapporto contrattuale vada considerato come «rapporto esaurito». Pure è chiaro, poi, che una simile lettura finisce per svuotare praticamente di contenuto la clausola relativa alle passività incluse in effetti: se è sicuramente possibile che un cliente attivi una controversia nella pendenza dello svolgimento fisiologico di un rapporto contrattuale (e cfr. sopra, la fattispecie richiamata nel corso del n. 3), certo è pure, però, che nei fatti si tratta di evenienza per nulla frequente. E ancora meno frequenti, inoltre, che una simile situazione (di controversia in essere e, insieme, di prosecuzione fisiologica del rapporto) perduri nel tempo: nella specie sino alla sopraggiunta cessione di azienda. In definitiva, una clausola di «inclusione» sostanzialmente inesistente.
Non è solo per queste ragioni, tuttavia, che, a mio avviso, le decisioni della Prima Sezione avrebbero dovuto dar conto e ragioni specifiche della nozione di «rapporto esaurito» che di fatto praticano. In effetti, non credo si possa dire che quella di «rapporto esaurito» sia una nozione scontata. Parrebbe, anzi, che si tratti di problema piuttosto delicato. Così, solo per fare qui qualche esempio, è da chiedersi (muovendo dalla impostazione adottata dalla Prima Sezione) se sia «esaurito» il rapporto in cui al tempo della chiusura del conto corrente residui ancora un credito della banca nei confronti del cliente[34]. Come pure è da chiedersi se possa mai essere «esaurito» un mutuo radicalmente nullo o rimasto incompleto. Ma ancora più delicato parrebbe – prendendo tratto dagli spunti svolti dalla pronuncia della Terza Sezione, n. 15238/2025 (sulla quale v. sopra, il n. 2.4.) – il caso in quanto tale della pretesa restitutoria: l’azione di ripetizione d’indebito deriva dalla legge, e non già da un rapporto contrattuale; sembrerebbe difficile ipotizzarsi, allora, che il relativo rapporto (obbligatorio) possa esaurirsi prima che giunga a compimento il termine di prescrizione dell’azione.
Non si può non segnalare, del resto, che in proposito esiste anche un risalente orientamento nella giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale per «rapporti esauriti» si debbono intendere quelli definiti con sentenza passata in giudicato o nei quali siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione» (Cass., 12 agosto 1994, n. 7395)[35].
6.3.1. Secondo l’orientamento della Prima Sezione, dunque, la formula «rapporti funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria», pur «non del tutto univoca», per significato e portata è da considerare equivalente a quella di «rapporti non ancora esauriti»: per tale strada – così si assume – la clausola contrattuale di inclusione ha escluso dalla cessione le passività derivanti dai «rapporti esauriti».
Non si può proprio dire, per la verità, che la trascritta «equivalenza» si manifesti di immediata evidenza[36]. Né tale la fanno diventare, a me pare, il distinguo tra la parola «attività» e la parola «impresa», il richiamo alla nozione di azienda, lo stesso rinvio all’interesse egoistico della Banca cessionaria (al di là del generico riferimento all’interesse di quest’ultima per «pagare il meno possibile»), che le decisioni della Sezione mettono a immediato supporto della scelta che hanno fatto (cfr. sopra, nel n. 1.3.). A chiarire i termini dello snodo interpretativo, che viene operato, sta, piuttosto, la formula che – in sede di descrizione della problematica delle fattispecie – le decisioni riprendono da un «giudice di merito»: all’opposto di quelle ancora in essere – così si segnala -, le passività da rapporti esauriti sono «con evidenza, situazioni giuridiche sganciate dall’attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale» (cfr. p. 7 della decisione n. 15083/2025).
Ne segue – al di là del riferimento alla «logica della cessione aziendale» (che, francamente, non c’entra nulla: si sta parlando del prezzo di una vendita; attiene, quindi, al fenotipo del compratore l’idea di «pagare il meno possibile») – che l’argomentazione in discorso si nutre (quanto meno) dei due seguenti passaggi: introdurre il fattore «tempo» all’interno del concetto di funzionalità, che di suo a tale fattore rimane, per contro, del tutto estraneo; far assumere all’aggettivo «funzionale» il significato di «profittevole» ovvero di «fruttifero», che, in sé, risulta molto lontano (se non più) dall’uso normale, corrente della parola (sul punto del «profittevole» si torna nel n. 6.4.).
Come si vede, comunque si tratta – a tacer qui d’altro – di un percorso interpretativo tortuoso assai; e complesso, se non proprio complicato. Che più di dipanare, alimenta i dubbi. Sì che non sembra sia possibile sfuggire alla domanda che a me sembra fondamentale e che – pur nella sua banalità – le pronunce della Prima Sezione hanno per contro tralasciato del tutto. È da chiedersi, insomma, se i «formatori» del testo contrattuale, di cui si sta discutendo, non avrebbero potuto stendere, in proposito, una formula piana e di immediata comprensione: scrivere senz’altro, cioè, che le passività derivanti da rapporti ormai esauriti al tempo della cessione rimangono fuori dall’ambito della stessa; e magari – già che erano lì – anche manifestare cosa di preciso volessero intendere con tale espressione.
La domanda – può essere opportuno esplicitare – non ha nulla di provocatorio; e, per vero, neppure è oziosa. È tecnica: il criterio della «qualità dei contraenti» rientra, infatti, nell’ambito dei canoni interpretativi della volontà contrattuale (volendo, ex art. 1362 c.c.). Ora, nel caso di specie, di cui si sta trattando, non potrebbe davvero essere revocato in dubbio l’elevatissima professionalità – e capacità tecnica – delle parti contraenti. E tantomeno potrebbe essere messo in forse il livello dei professionisti chiamati dalle parti (e, come tali, alle stesse pertinenti) a formare e redigere il testo contrattuale: nei fatti, si tratta di professionisti di primissima fascia, haut de gamme, si potrebbe anche dire.
Ne consegue allora, a me pare, che – rapportata alla fattispecie concretamente in discorso, alla qualità delle parti contraenti e al livello delle professionalità che sono state scelte per la formazione e stesura del testo contrattuale – l’interpretazione seguita dalle decisioni in discorso appare, per vero, alquanto inverosimile[37].
6.3.2. Se si fa perno sul criterio della «qualità delle parti contraenti», come pure sarebbe da fare, l’interpretazione della formula in questione non dovrebbe – è da notare ancora – consistere nel frutto di particolari, e grandi, speculazioni. Dovrebbe invece declinare verso il «semplice». Così come, in effetti, potrebbe anche essere (e agevolmente).
La norma dell’art. 2560, comma 1, c.c. fa riferimento al «debiti inerenti all’esercizio dell’aziende»; la formula viene parzialmente ripresa dalla clausola in questione, nel senso che ai debiti «inerenti» aggiunge quelli «funzionali all’esercizio dell’impresa». Si tratta, a me pare, di debiti «altri» rispetto a quelli «inerenti»[38]: quelli, cioè, serventi all’esercizio in concreto dell’impresa, così come in concreto conformata dalle imprese sviluppate dalle banche venete all’epoca della cessione (a muovere, dunque, dai contratti di affitto o locazione delle filiali interessate in poi).
6.4. Un’ultima osservazione (che intende prescindere anche dalle altre svolte nel presente paragrafo). Il «giudice di merito», nell’evocazione effettuata dalla pronuncia n. 15083/23, con decisione dichiara che «né sul piano della logica, né su quella della razionalità, né su quello dell’economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data delle cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato» (: quello, cioè, della «attività bancaria considerata in prospettiva futura»).
Nonostante l’enfasi che vi viene immessa, credo sia davvero lecito dubitare dell’effettiva puntualità di una simile affermazione. Più precisamente, a me sembra che – se, da un lato, non sempre i «rapporti non esauriti» possono dirsi «funzionali» al futuro svolgimento di un’impresa (in specie) bancaria –, d’altro, pure i «rapporti esauriti» ben possono rivelarsi, peraltro, «funzionali» nei confronti di un simile sviluppo: in via peculiare, ove le rispettive situazioni vengano poste a confronto – come è necessario nel caso in interesse – con la necessaria sussistenza in atti di una «controversia» corrente tra le parti del rapporto, posto che la presenza una «controversia in atto»[39] al tempo della cessione è, per l’appunto, requisito necessario dell’inclusione[40]. E tanto più, questo, ove si acceda a una nozione larga di «rapporto esaurito», secondo il parametro ricavabile dagli interventi delle ordinanze gemelle della Prima Sezione (cfr. sopra, nel n. 6.2.).
Si pensi, per il primo dei profili appena evocati, al caso del rapporto di conto corrente via via nel corso del tempo diventato attivo per il cliente – e quindi gravato, nell’attuale, dalle sole spese di conto – a fronte di una richiesta di indebito anatocistico da quegli proposta per una somma elevatissima. Quanto invece ai «rapporti esauriti», si può pensare, se si intende (formalisticamente) rimanere nello stretto, alla eventualità dell’innesto sul corpo di tale rapporto di un pactum de non petendo ad tempus, con rinegoziazione fermata nel limite dell’accessorio (art. 1231 c.c.).
Ma se si apre un poco più lo sguardo all’orizzonte – e si considera, secondo quanto sembra richiesto anche dall’affermazione sopra trascritta, il tema nella prospettiva dell’impresa, quale attività attuale che va a riflettersi nel suo futuro (: l’impresa nel suo continuo farsi, insomma) – il «rapporto esaurito», che nel contempo risulti oggetto di un contenzioso (restitutorio o risarcitorio) promosso dal cliente, si mostra come ben disponibile a essere, e venire, reso funzionale allo svolgimento futuro dell’attività. In effetti, non possono non venire subito in mente, al riguardo, le figure della rinegoziazione e della transazione, quali strutture idonee a ridurre le perdite (eventualmente) derivanti dal contenzioso di cui al «rapporto esaurito» e, quindi, anche idonee a liberare risorse per lo svolgimento di nuovi e ulteriori rapporti. Nel caso, anche a «riprendere» i rapporti con lo stesso cliente di cui alla lite.
[1] Per quanto noto, almeno. La prima pronuncia reca la data di pubblicazione 6 giugno 2025 e il numero 15083; le altre sono state tutte pubblicate il successivo 12 giugno e portano i seguenti numeri: 15671; 15573; 15680; 15682; 15684; 15686; 15689.
[2] Così è, ad esempio, per il caso deciso da Cass., n. 15083/2025.
[3] Cfr. Cass., n. 15686/2025.
[4] L’ordinanza di rimessione, emessa dal Tribunale di Firenze (20 luglio 2021), prospettando una serie molto ampia (e con approccio, per vero, più generico, che mirato) di vizi di costituzionalità, secondo quanto resocontato dalla pronuncia della Consulta.
[5] Cass., n. 15083(2025: l’esame della clausola principia a metà di p. 15; essa viene riportata a p. 13, secondo questo testo: «per “Passività Incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni, di BPVI e VB […] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D […], tra cui, in particolare: […] vii) i contenziosi civile (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi».
[6] Con confronto che di necessità suppone – si può già qui anticipare un rilievo che sarà ripreso e sviluppato più in là (cfr. nel n. 5) – – una lettura della fattispecie impostata su un’unica linea di fondo: quella dell’interesse della banca cessionaria a trarre il maggior profitto dall’operazione di cessione (ovvero a «spendere il meno possibile»).
[7] Le pronunce non riportano (se non ho visto male) il tenore di questo «accordo ricognitivo». Sì che l’assunto, che viene riferito qui sopra, si manifesta oggettivamente non verificabile.
[8] Secondo la prospettazione che (stando al testo della pronuncia) viene fornita dalla stessa banca cessionaria, qui nella veste di ricorrente.
[9] Da sottolineare, qui, la diversità in proposito dell’impostazione della Terza rispetto a quella assunta dalla Prima (cfr. la prima parte dell’ultimo capoverso del n. 1.2.): il tema sarà ripreso nel contesto del prossimo n. 4.4.
[10]Come si vede, la prospettiva della Terza fa perno sulla «controversia» in atto; quella delPrima, per contro, sul fatto sostanziale del «rapporto (non) in essere».
[11] Sul punto le ordinanze sono davvero inequivoche: cfr., per tutte, Cass. n. 15083/2025, ad esempio a p. 16.
[12] Attualmente giacente presso la Corte di Giustizia UE (e avendo l’ordinanza interlocutoria di Cass. Sezioni Unite, 15 marzo 2025, n. 6943 mandato a nuovo ruolo l’esame del ricorso sottopostole dall’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione; v. la nota successiva).
[13] Cfr. l’ordinanza interlocutoria di Cass., 19 luglio 2014, n. 19900: «sulla questione relativa alla validità dei contratti di finanziamento che nella determinazione del tasso di interesse dovuto dal soggetto finanziato fanno riferimento all’indice rappresentato dall’Euribor si formato un orientamento in seno alla Terza Sezione» /n. 10); «ritene questa Sezione [: Prima] – tabellarmente competente per le controversie sia in materia di concorrenza e impresa in generale, sia in materia di contratti bancari – che l’orientamento della Terza Sezione desti alcune perplessità e meriti di essere ripensato» (n. 15).
[14] I medesimi rimproveri di fondo si ritrovano – solo espressi in termini molto più espansi – anche nella decisione n. 15083/2029 (nn. 2.9. e 2.10): l’opzione di trascrivere il passo della decisione n. 15671 dipende solo da una scelta di «organizzazione dello spazio».
[15] Il fatto è, in realtà, che le pronunce della Terza Sezione non ritengono – per risolvere in modo corretto la questione – necessario scendere sino al livello del frammento di clausola che le decisioni della Prima, per contro, stimano essere decisivo (con lettura, tuttavia, nel merito non condivisibile: cfr. il n. 6).
Per meglio chiarire questo nodo, peraltro, sembra opportuno anche ricordare che – secondo quanto segnalato in più passaggi del presente lavoro – la pronunce della Terza affrontano il tema nella prospettiva della «controversia con terzi» e quindi in modo diverso da quanto fatto dalla Prima, che guarda invece alla natura sostanziale del rapporto (su cui si innesta la lite), secondo una linea per sé attinente, in realtà, alla dinamica delle relazioni contrattuali tra banche cedenti e banca cessionaria.
[16] Con maggiore esattezza: il riferimento è sicuro per la decisione di Cass., n. 17834/2023 e per quella di Cass., 15238/2025; per quella di Cass., n. 2785/2025, invece, il riscontro rimane sospeso, le notizie riportate in tale pronuncia non consentendo alcuna ricostruzione in proposito.
[17] Quello espresso dalla Terza Sezione è stato riportato già sopra, nel n. 2.3. Questo è quello formulato dalla Prima Sezione (come tratto da Cass., n. 15083/2025): «in tema di controversie intraprese da o contro Veneto banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendente alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d. l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al c.d. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».
[18] Che appunto si occupa, secondo il suo testo e secondo quanto comunemente si ritiene, solo della c.d. responsabilità esterna.
[19] Non diversamente, nella sostanza, le altre due pronunce della Terza Sezione (la sentenza di Cass., n. 2785/2025 a mezzo di rinvio alla precedente pronuncia di Cass., n. 17834/2025)
[20] Cfr. nel n. 5 della parte in diritto della sentenza della Corte Costituzionale.
[21] Salvaguardia che – almeno in via di principio – dovrebbe seguire (in misura più o meno intensa) all’acquisizione della rete territoriale delle aziende cedute.
[22] Che peraltro hanno ricevuto un parziale indennizzo a mezzo del «Fondo Indennizzo Risparmiatori» (FIR).
Non mi pare dubbio che l’orientamento assunto dalla Prima Sezione ponga i creditori involontari di cui si discute nel testo in una posizione sostanzialmente deteriore anche rispetto agli azionisti e obbligazionisti subordinati. Ciò che non può – se non altro sotto il profilo della complessiva gestione della crisi delle banche venete – non destare perplessità: in effetti, una simile «gestione» sembrerebbe (più che altro) governato dal caos (: nella prospettiva dell’interesse pubblico, s’intende).
[23] Cfr. A.A. Dolmetta e U. Malvagna, «Banche venete» e problemi civilistici di lettura costituzionale del decreto legge n. 99/2017, in Riv. dir. banc., 2017. P. 303 ss.
Per il rilievo che la norma dell’art. 2560 c.c. non è tra quelle «derogate» dalla disciplina del decreto v. anche U. MInneci, Sull’art. 3, comma 1 lett. c) del d.l. n. 99/2017: una soluzione pro banca costituzionalmente fragile, ivi, 2017, p. 253 s.
[24] Cfr., in particolare, le pronunce di Cass., 10 dicembre 2019, n. 32134. e di Cass., 6 luglio 2020, n. 13903.
[25] Secondo quanto invece avviene, per dire, nell’art. 2, commi 1 e 2 (con richiamo espresso, tra gli altri, all’art. 2559 comma 1 c.c.) del decreto n. 99/2017.
[26] Stante la forte polisemia della parola, può essere non inopportuno esplicitare che con «causa» si intende qui richiamare la prospettiva dei diversi titoli (: «cause») atte a reggere, nel nostro sistema, le attribuzioni patrimoniali effettuate da un soggetto a favore di un altro.
[27] Su questa figura in generale cfr., ad esempio. V. Roppo, Il contratto, nel Tratt. dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 366.
[28] Se ho ben inteso, nel contratto di cessione è presente una clausola per cui il trasferimento avviene nummo uno (al «prezzo simbolico» di 50 centesimi per azienda ceduta).
A me pare, per la verità, che una simile clausola non cambi la reale sostanza dell’operazione, posto che in questa prospettiva a contare è la dimensione effettiva (come prevedibile ex ante) delle passività incluse nel perimetro della cessione. Si tratta, in definitiva, di una clausola di stile.
Comunque, ove per contro si opinasse che la ridetta clausola venga a orientare la lettura del testo complessivo del contratto, sarebbe allora da rilevare che è proprio una simile clausola a portare l’operazione dalla sfera dello scambio (di cui al decreto legge) a quella della liberalità, quand’anche «mascherata» dalla giustapposizione di un prezzo vile.
[29] Cfr. Cass., n.15083/20255 (il passo, di cui peraltro già sopra è stata riportato una parte, si trova alla fine di p. 16).
[30] Attesa la tipologia di controversie che sono in discussione nella presente sede (di controversie con soggetti terzi, estranei al negozio di cessione di azienda) non interessa, evidentemente, stabilire se si tratta di una responsabilità solo esterna o, invece, anche interna.
[31] In effetti, la ricostruzione operata dalla Prima Sezione della Corte sembra mettere a nudo – in via segnata là dove segnala che l’operazione di cessione è disposta per portare significativi vantaggi alla banca cessionaria – un certo senso di «unilateralità» (una certa propensione all’«unilateralità») nel comportamento tenuto, nell’ambito dell’operazione di acquisizione aziendale, da parte della banca cessionaria. Sullo sfondo, insomma, sembrerebbe affacciarsi l’idea di qualche attitudine predatoria nel comportamento della detta banca.
[32] Compreso anche quello per cui, nel caso di più possibili letture di una clausola, o di una sua frazione, ve preferita l’interpretazione conforme allo schema di operazione disegnato del decreto n. 99/2027 (le stesse ordinanze gemelle ammettono che, preso di per sé stesso, il frammento di clausola di cui si discute mostra un «contenuto non del tutto univoco»: Cass., n. 15083/2025, p. 15).
[33] L’uso del modo condizionale riprende le osservazioni svolte sopra nel n. 3, a proposito della pronuncia di Cass., n. 21808/2025.
[34] Può essere utile segnalare, in proposito, che – secondo quanto riferisce la sentenza di Cass., n. 17834/2025 (cfr. n. 25) – nel relativo giudizio del merito la Corte di Appello di Venezia aveva «escluso che il rapporto di deposito titoli potesse considerarsi estinto, perché la compensazione era stata negata dalla sentenza azionata e il contratto non poteva dirsi esaurito in ragione di obbligazioni rimaste inadempiute».
[35] Traggo l’indicazione da F. Briolini. Fideiussioni omnibus non «esaurite” e legge sulla trasparenza, in BBTC, 1996, I, p. 685 ss.; ove pure ulteriori riferimenti bibliografici. Più di recente v. pure il mio Operazioni bancarie e sopravvenienze legislative, in Contratti bancari a cura di E. Capobianco, ed. II, Milano, 2020.
[36] Sull’interpretazione della clausola che oggi viene abbracciata dalla prima Sezione, si era già espressa in termini negativi I. Mecatti, La responsabilità della banca cessionaria nell’ambito della L.C.A. delle banche venete, per le pretese risarcitorie e restitutorie dei creditori della banca cedente, in BBTC, 2019, II, p. 784 ss.
[37] Per fare solo un esempio (peraltro, non marginale): non è pensabile che il livello di professionalità, connotante i tecnici incaricati della formazione e stesura del testo contrattuale, abbia omesso di fornire la definizione convenzionalmente adottata di «rapporto esaurito», considerata se non altro la «vaghezza» di questa formula (e v. sopra, la nota 36 e testo corrispondente).
[38] In effetti, l’interpretazione della Prima Sezione non chiarisce, tra l’altro, perché si dovrebbe ritenere che i qualificativi «intrinseco» e «funzionale» siano requisiti cumulativi dei «debiti inclusi»; e non già, secondo quanto si prospetta nel testo, requisiti alternativi: debiti se non già intrinseci, quanto meno funzionali. Atteso il rischio di violazione della norma dell’art. 2560, comma 2, c.c. (sopra, n. 5.2.), del resto, questa ultima interpretazione si fa preferire anche ai sensi del criterio di cui all’art. 1367 c.c. (letto in termini sostanziali).
[39] Sul tema del significato da assegnare all’espressione «controversie» nel contesto del contratto di cessione v. le divergenti letture proposte da M. Vaccari, Lca delle banche venete e principio di tutela giurisdizionale effettiva, in dirittobancario.it, e da A.A. Dolmetta e U. Malvagna, op. cit.
[40] E come, per contro, «giudice di merito» richiamato dalle ordinanze gemelle, e non meno queste ultime, trascurano di considerare.