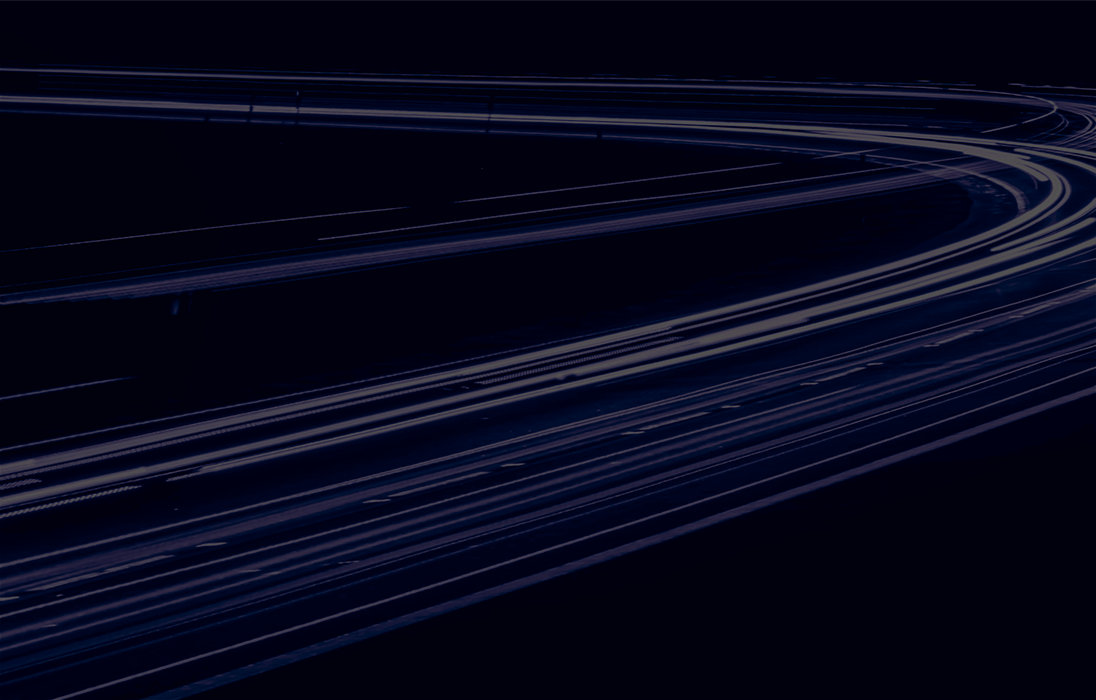Con l’ordinanza n. 19574/2025 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della deducibilità forfettaria dei costi, in forma di presunzione contraria, nei casi di accertamento analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 e della giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale, condotta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società in accomandita semplice, mediante la quale era stato accertato un maggior reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA, in ragione dalla mancata fatturazione di alcuni ricavi e dalla disconosciuta deducibilità di alcuni costi.
Il Giudice di legittimità, richiamando quanto statuito nelle proprie sentenze n. 18563/2023 e 5586/2023, ha osservato come dalla regola generale ritraibile dall’art. 109 del T.U.I.R., che onera il contribuente di provare in modo certo e preciso l’esistenza dei costi non contabilizzati ai fini della loro deducibilità, derivino esiti irragionevoli “perché si finirebbe per prevedere un trattamento più severo, quanto al regime della possibile prova contraria rispetto alla presunzione legale in esame, in danno del contribuente che ha tenuto una contabilità complessivamente attendibile […] rispetto al regime probatorio di cui si avvede chi, destinatario di un accertamento «induttivo puro», ha omesso qualsiasi contabilità, ovvero ne ha tenuta una complessivamente inattendibile o ha posto in essere gravi condotte, quale l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi”.
La Corte ha, dunque, espresso il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti”.