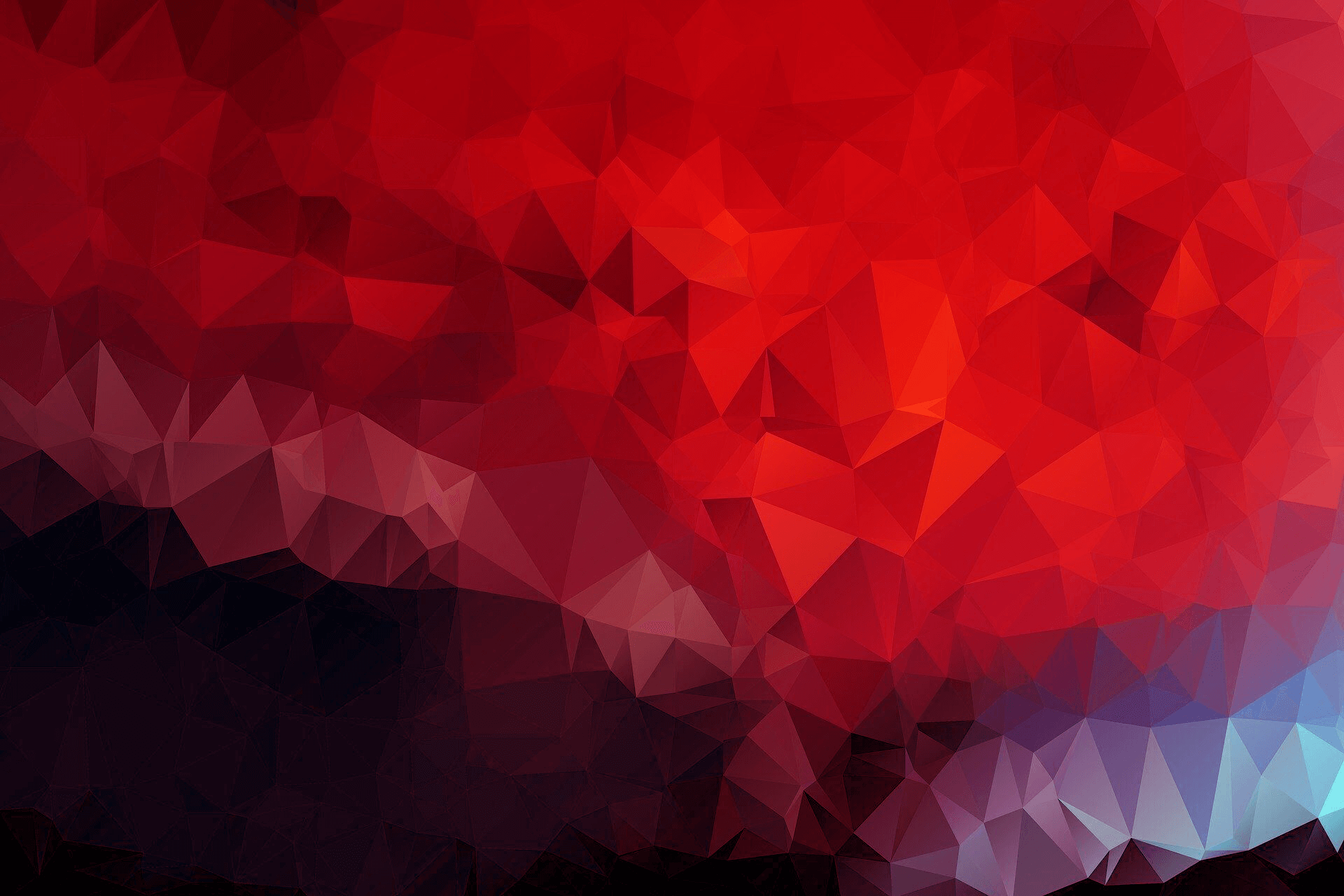Con la sentenza n. 32438 dello scorso 12 dicembre 2025, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema dell’esterovestizione, nel caso di specie per perimetrare con precisione i limiti entro cui può ritenersi integrato il presupposto della residenza fiscale in Italia di una società avente la propria sede fiscale all’estero.
In particolare, la Corte ha ribadito come il concetto di “sede dell’amministrazione” – contrapposto a quello di “sede legale” “non possa coincidere “sic et simpliciter” col luogo di svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo”, essendo per converso richiesto che la controllante “assuma il ruolo di vero e proprio amministratore indiretto della controllata usurpandone l’impulso imprenditoriale”.
Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad accertare d’ufficio i redditi prodotti da una società lussemburghese, assumendo che la sede effettiva della stessa si trovasse non in Lussemburgo, bensì in Italia.
In particolare, l’Ufficio fondava tale contestazione sulla circostanza che la società in parola fosse interamente posseduta da due fratelli residenti in Italia e che, a sua volta, essa partecipasse con questi ultimi al controllo di una società italiana.
La società impugnava l’avviso di fronte all’allora CTP, che lo annullava, ritenendo che l’Ufficio non avesse fornito prova idonea della localizzazione in Italia della direzione effettiva.
L’Amministrazione proponeva appello avverso tale decisione alla CTR, che confermava la decisione di primo grado, giudicando gli indizi di esterovestizione addotti dall’Ufficio non solo irrilevanti, ma anche e comunque puntualmente smentiti dalla documentazione prodotta dalla contribuente.
Contro la decisione dei giudici di seconde cure ha ricorso per cassazione l’Amministrazione, contestando il rilievo dato dalla CTR alla natura reale o fittizia della società lussemburghese e lamentando, inoltre, l’errata applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio.
Giova ricordare – come peraltro ribadito anche dalla Cassazione nella pronuncia in commento – che per esterovestizione deve intendersi “la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime interno”.
Naturalmente, il perimetro dell’esterovestizione è delimitato dal principio della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE che, specularmente, attribuisce alle società il diritto di svolgere la loro attività in uno degli Stati membri attraverso una controllata, una succursale, un’agenzia; da tale libertà consegue che – come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia nella storiche sentenze Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, causa C-196/04 – “la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà”, cosicché una misura nazionale che limiti la libertà di stabilimento è ammessa solo “se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato”.
D’altra parte, “quando può scegliere tra due operazioni, il contribuente non è obbligato a preferire quella che implica il pagamento di maggiori imposte, ma, al contrario, ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli consenta di ridurre la sua contribuzione fiscale” (cfr. Corte giust., 21 febbraio 2006, Halifax e a., causa C-255/02, punto 73).
Nel caso concreto, pertanto, la questione atteneva proprio alla natura reale ovvero fittizia della società lussemburghese, poiché solo nel secondo caso si sarebbe effettivamente verificato un fenomeno di esterovestizione nel senso anzidetto.
Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto non sufficiente dimostrare che le direttive strategiche provengano dalla controllante italiana, occorrendo piuttosto estendere l’indagine anche ad altri elementi che, invece, testimonino la genuinità ovvero la fittizietà della società estera.
In ciò, sembrano convergere nel medesimo senso tutte le fonti rilevanti sul tema: il TUIR, a livello nazionale, nel momento in cui ai fini della residenza attribuisce rilievo alla “sede dell’amministrazione”, da intendersi come “il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee”; il diritto dell’Unione, solidamente interpretato dalla Corte di Giustizia nel senso che “la nozione di sede dell’attività economica indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima”; ma anche la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Granducato del Lussemburgo, oltre alla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate e al Modello OCSE.
Ne discende, come evidenziato dalla corte, “che tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché finalizzata all’accertamento di un dato “effettivo”, non può non tenere conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali, in ipotesi, lo svolgimento dell’attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolge l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece pr l’effettiva riconduzione di quest’ultima ad un diverso contesto territoriale”.
Ha quindi operato correttamente la CTR, nel momento in cui non si è limitata a verificare ove si collocasse il centro d’impulso delle scelte gestionali, estendendo invece l’accertamento alla sede dell’amministrazione, in ciò valorizzando elementi fattuali e concreti – quali “località, residenza e cittadinanza degli amministratori, luogo di celebrazione delle assemblee e degli organi collegiali” – che hanno deposto proprio nel senso dell’effettività della residenza della società in Lussemburgo.