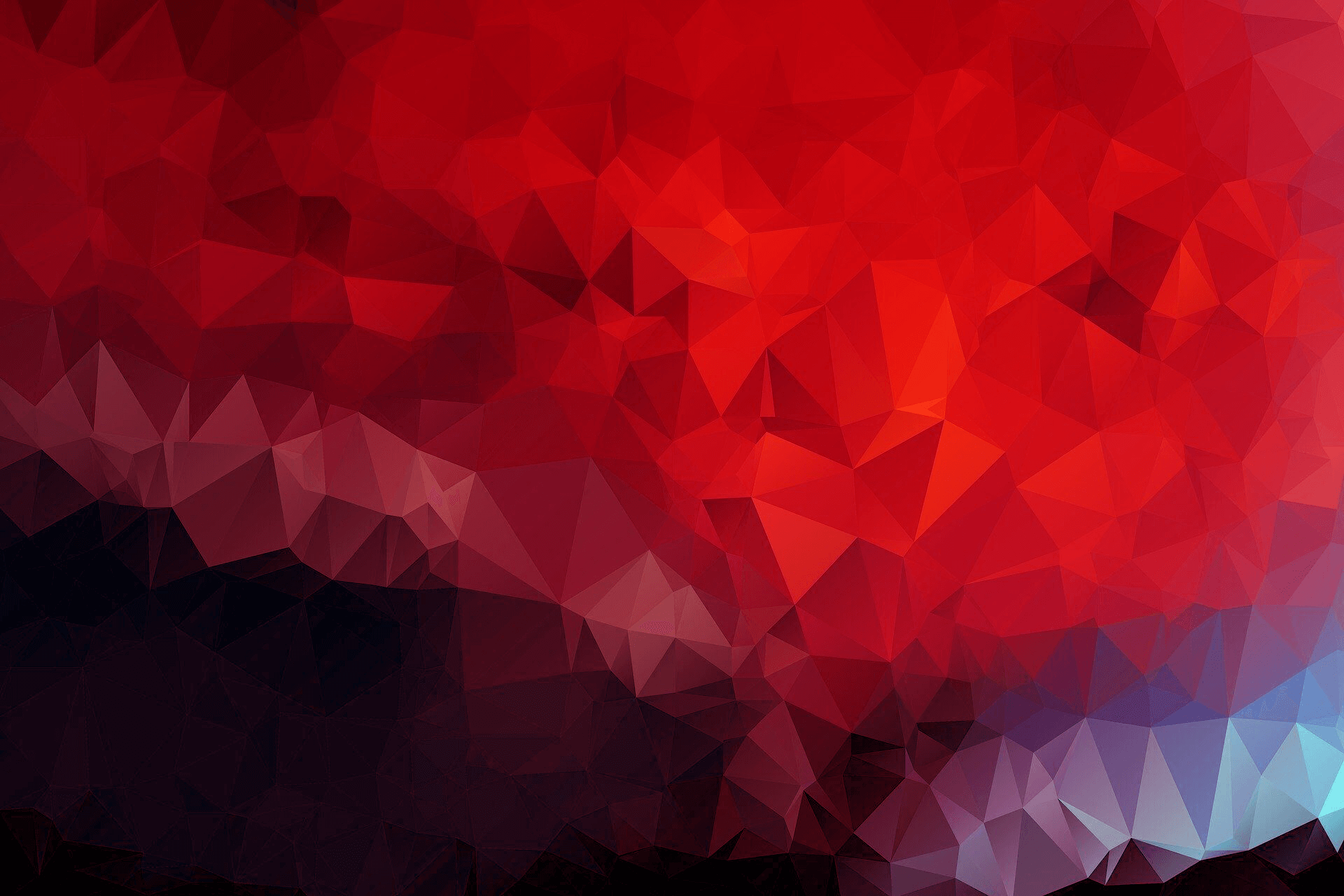Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19750 del 16 luglio 2025 (Pres. D’ascola, Est. Mercolino), si sono espresse sulla sorte, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, delle mere pretese o dei crediti incerti o illiquidi, per tali ragioni non incassati dalla società prima della sua estinzione.
Questo il principio di diritto espresso:
L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.
Il presupposto del ragionamento
Nell’ordinanza di rinvio e nella giurisprudenza contrastante richiamata non è contestato il principio di diritto cui erano già approntate le Sezioni Unite con la duplice pronuncia n. 29812/2024 e n. 3625/2025, relativamente all’efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese e alla trasmissione ai soci dei rapporti obbligatori già facenti capo alla società; la Corte ricorda inoltra che tali pronunce hanno peraltro precisato che:
- se prima della cancellazione la società abbia conferito a un avvocato procura speciale per la proposizione di un ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale conseguente all’estinzione non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione notificata alla controparte in epoca successiva, trovando applicazione il principio di ultrattività del mandato
- per altro verso che, ai fini della configurabilità della responsabilità dei soci per un debito tributario della società estinta, l’avvenuta riscossione di somme da parte degli stessi, in base al bilancio finale di liquidazione, integra una condizione dell’azione attinente non già alla legittimazione dei soci, ma all’interesse ad agire del Fisco, che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a dedurre con apposito avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci e del quale ha l’onere di fornire la prova in giudizio
Il contrasto giurisprudenziale
Il contrasto giurisprudenziale ricostruito dalle Sezioni Unite fa perno proprio sulla tipologia di crediti asseritamente ritenuti non trasmissibili ai soci dopo l’estinzione della società, ovvero i crediti incerti o illiquidi o le mere pretese, per le quali vi fosse o meno un giudizio in corso per il loro accertamento e quantificazione, ravvisando, a secondo dei casi, quale comportamento concludente riconducibile alla rinuncia al credito della società, o l’inerzia del liquidatore, o semplicemente la loro mancata inclusione nel bilancio di liquidazione.
In sintesi, questi i diversi indirizzi giurisprudenziali sinteticamente richiamati nella pronuncia, in parte motiva:
- alcune pronunce hanno ravvisato nell’inerzia del liquidatore un elemento idoneo a fondare una presunzione qualificata di rinuncia alle predette pretese, ancorché relative a crediti incerti ed illiquidi: si è affermato che in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società, il comportamento del liquidatore, che non si sia attivato per l’accertamento del credito, preferendo concludere il procedimento estintivo della società, consente di presumere che quest’ultima abbia tacitamente rinunciato alla propria pretesa, con la conseguenza che non si determina alcun fenomeno successorio nella pretesa sub judice, ed i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa (Cass., Sez. III, n. 15782/2016)
- parte della giurisprudenza successiva, ha a contrario affermato, in tema di cancellazione volontaria, che l’estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass., Sez. I, 9464/2020)
- in tema di cancellazione di ufficio, ai sensi dell’art. 2490, u. c. C.c., che l’estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso, poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 C.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass., Sez. VI, n. 30075/2020)
- alcune pronunce più recenti hanno nuovamente ribadito la tesi secondo cui l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex-soci non sono legittimati a farli valere in giudizio (Cass., Sez. III, 11411/2024).
La soluzione del contrasto sulle conseguenze per i crediti controversi dell’estinzione della società
Sotto il profilo dell’onere della prova, le Sezioni Unite ricordano che, se la regola fissata dal diritto vivente è quella della successione dei soci nella titolarità dei residui attivi, ogni eccezione alla stessa ed al conseguente passaggio in titolarità dei soci delle situazioni attive già facenti capo alla società dev’essere adeguatamente allegata e dimostrata da chi intenda farla valere, e che la rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio, ai fini del quale si richiede la volontarietà dell’atto e dei suoi effetti, una modalità espressiva idonea a trasmetterne il contenuto e la comunicazione a un destinatario determinato.
Ciò che accomuna le due tesi affermatesi nella giurisprudenza di legittimità è il rifiuto dell’automatismo insito nel meccanismo teorizzato dalle Sezioni Unite nelle citate pronunce, per cui, in caso di mere pretese e di crediti incerti o illiquidi, il mancato inserimento nel bilancio di liquidazione risulterebbe di per sé sufficiente ad escluderne la trasmissione ai soci, implicando una rinuncia al diritto, che comporterebbe una presunzione juris et de jure di estinzione, anche nel caso in cui sia pendente un giudizio promosso dalla società per il suo accertamento.
La differenza sostanziale tra i due orientamenti consiste nel fatto che:
- mentre per il primo la regola è che il diritto si trasmette ai soci, nonostante la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione, mentre l’estinzione costituisce un’eccezione, che dev’essere rigorosamente allegata e provata da chi intenda farla valere, e quindi dalla controparte dell’ex-socio
- per il secondo la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione rende applicabile, almeno per le mere pretese ed i crediti incerti o illiquidi, una presunzione (semplice) di estinzione, che pone a carico dell’ex socio che intenda azionare un diritto della società o proseguire un giudizio dalla stessa iniziato l’onere di allegare e provare di essere subentrato nella titolarità del diritto fatto valere.
Le Sezioni Unite, che propendono per la prima soluzione, sollevano le seguenti obiezioni alla seconda tesi:
- le incertezze applicative connesse all’individuazione dei diritti suscettibili di estinzione, in ragione dell’indeterminatezza della distinzione tra i diritti veri e propri e le varie categorie emergenti dalla terminologia di volta in volta adottata, quali le «mere pretese, ancorché azionate ed azionabili in giudizio», i «diritti litigiosi o illiquidi», i «diritti ancora illiquidi ed incerti» e le «ragioni di credito
- la difficoltà d’individuare le modalità d’iscrizione in bilancio delle “mere pretese”, al fine di evitarne l’estinzione e di garantirne la trasmissione ai soci:
- ove si ritenga che le stesse consistono in richieste economiche, che non si concretizzano in una attività giudiziale o stragiudiziale, l’iscrizione troverebbe infatti ostacolo nei principi contabili, che richiedono, ai fini dell’inclusione dei crediti in bilancio, la rilevazione in corrispondenza dei correlativi ricavi, se derivano da operazioni di vendita di beni e prestazioni, o l’indicazione del relativo titolo (non necessariamente giudiziario), se derivano da ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi (OIC n. 15), nonché una valutazione prudenziale (art. 2423-bis, n. 1 C.c.), fondata sul criterio del costo ammortizzato, che tenga conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (art. 2426, c. 1, n. 8 C.c.)
- trattandosi quindi di “attività potenziali“, cioè di attività connesse a situazioni già presenti alla data di bilancio, la cui esistenza è destinata ad essere confermata soltanto all’avverarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti, che non ricadono nell’ambito del controllo della società (OIC n. 31, par. 11), le stesse non possono essere rilevate in bilancio, in ossequio al principio della prudenza, in quanto, anche se probabili, possono comportare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati (OIC n. 31, par. 48)
- le difficoltà di ricondurre alla disciplina civilistica della rinuncia al credito o della remissione del debito, che richiede una manifestazione di volontà specificamente portata a conoscenza del singolo creditore, un comportamento meramente omissivo come la mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione: la remissione del debito, costituendo un atto abdicativo di natura negoziale, postula infatti che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, con la conseguenza che la volontà di rimettere il debito presuppone la consapevolezza della sua esistenza da parte del creditore; ciò esclude che possano considerarsi oggetto di rinuncia diritti dei quali i liquidatori o i soci, al momento della formazione e dell’approvazione del bilancio di liquidazione, non conoscevano neppure l’esistenza, o che, pur essendo conosciuti, non presentavano i requisiti necessari per l’iscrizione in bilancio
- ricollegare automaticamente alla mancata iscrizione in bilancio l’estinzione del credito significa esporre a pregiudizio i creditori sociali, i quali, pur vedendo ridotto il valore patrimoniale complessivamente destinato alla soddisfazione dei loro crediti, in misura pari al valore della pretesa o del credito incerto o illiquido, non hanno alcun mezzo di tutela a fronte della cancellazione della società, non potendo proporre reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, né domanda di revoca dell’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, e non disponendo di strumenti di conoscenza in ordine all’esistenza ed all’incasso da parte degli ex-soci di crediti originariamente spettanti alla società, che consentano loro di coltivare le sopravvenienze attive nei confronti dei terzi ed ottenere da questi ultimi o dagli ex-soci i relativi pagamenti.
In conclusione, per le Sezioni Unite è senz’altro preferibile l’orientamento contrario, che, escludendo l’operatività di una presunzione di estinzione in conseguenza della mancata inclusione del credito nel bilancio di liquidazione, pone a carico del soggetto convenuto in giudizio dall’ex-socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e dimostrare la mancata successione della controparte nella titolarità del credito originariamente spettante alla società.
Poiché infatti, in tema di cancellazione della società, la regola è costituita dalla sopravvivenza dei crediti della stessa, nei quali sono destinati a succedere i soci, salvo la remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 C.c., è la parte che resiste alla pretesa a dover far valere l’avvenuta estinzione del credito azionato nei suoi confronti, allegando e provando la sussistenza di un’inequivoca manifestazione di volontà remissoria, avente lei stessa come specifica destinataria.