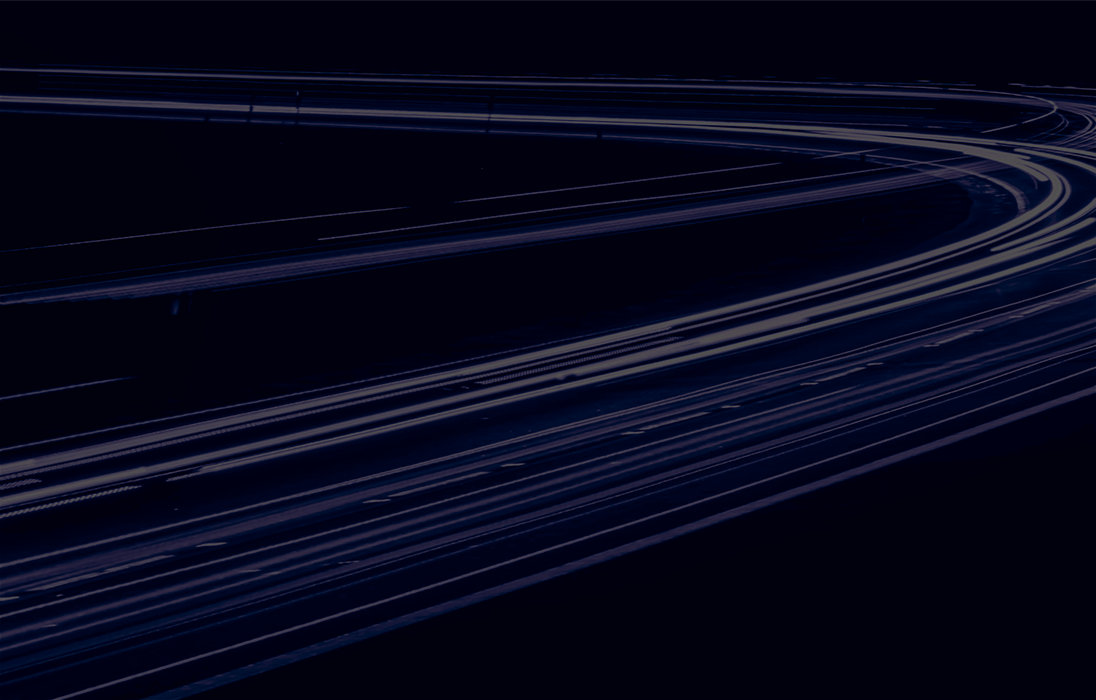Con la sentenza n. 18252/2025, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla rilevanza della delazione civilistica ai fini dell’imposta di successione avuto riguardo alla individuazione del relativo soggetto passivo, chiarendo che il presupposto del tributo non si realizza con l’accettazione dell’eredità, bensì con la sola chiamata all’eredità.
Nello specifico, si trattava di una vicenda successoria originatasi con il decesso della zia dei ricorrenti: più nel dettaglio, nell’atto di ultima volontà, la de cuius aveva indicato un’unica erede lasciando al fratello, secondo i principi che regolano la successione ex lege, la restante parte dell’asse ereditario.
Quest’ultimo, tuttavia, era deceduto il giorno successivo alla morte della sorella.
La nominata erede testamentaria presentava, dunque, una prima dichiarazione seppur incompleta, in relazione al contenuto del testamento pubblicato, indicando, in qualità di eredi, il fratello della de cuius (già defunto) ed i nipoti in linea collaterale.
Le imposte dovute venivano quindi correttamente versate.
Seguivano due ulteriori dichiarazioni di successione:
- la prima, modificativa, che sostituiva il fratello (deceduto) con i di lui figli;
- una seconda, integrativa, con la quale veniva aumentato l’asse ereditario.
In un terzo tempo, venivano presentate ulteriori dichiarazioni integrative.
L’Agenzia delle entrate provvedeva alla liquidazione l’imposta di successione notificando l’atto anche ai nipoti, in qualità di eredi del fratello della de cuius, ma questi ultimi impugnavano il provvedimento lamentandone la sostanziale infondatezza.
Invero, poiché il padre non aveva potuto accettare l’eredità della defunta sorella, essi dovevano essere considerati eredi “diretti” della zia e non già eredi del padre.
La tesi veniva accolta in entrambi i gradi del giudizio di merito mentre, in sede di legittimità, la Cassazione ha condiviso la ricostruzione propugnata dall’Ufficio.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha precisato che, ai fini dell’imposta di successione, il presupposto dell’imposizione non si realizza con l’atto di accettazione dell’eredità, bensì con la delazione, ovverosia con la chiamata all’eredità.
Ciò postula che, anche se un erede (nel caso di specie, il fratello della de cuius) decede prima di accettare – espressamente o tacitamente – l’eredità, i suoi eredi (ovverosia, i figli) sono comunque tenuti al pagamento dell’imposta relativa ad entrambe le vicende successorie: quella del defunto “originario” e quella del proprio genitore.
In altre parole, spiega il Giudice di legittimità, in ambito tributario, lo status di “chiamato all’eredità” acquista un significato peculiare che diverge dalla concezione accolta dalla disciplina civilistica; circostanza che fa discendere ex se l’acquisto dell’eredità a fini fiscali.
Deporrebbe in tal senso l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 346/1990, che qualifica “eredi” i chiamati che non hanno rinunciato, laddove, parallelamente, l’art. 28 del medesimo provvedimento di legge obbliga i chiamati a presentare la rituale dichiarazione di successione.