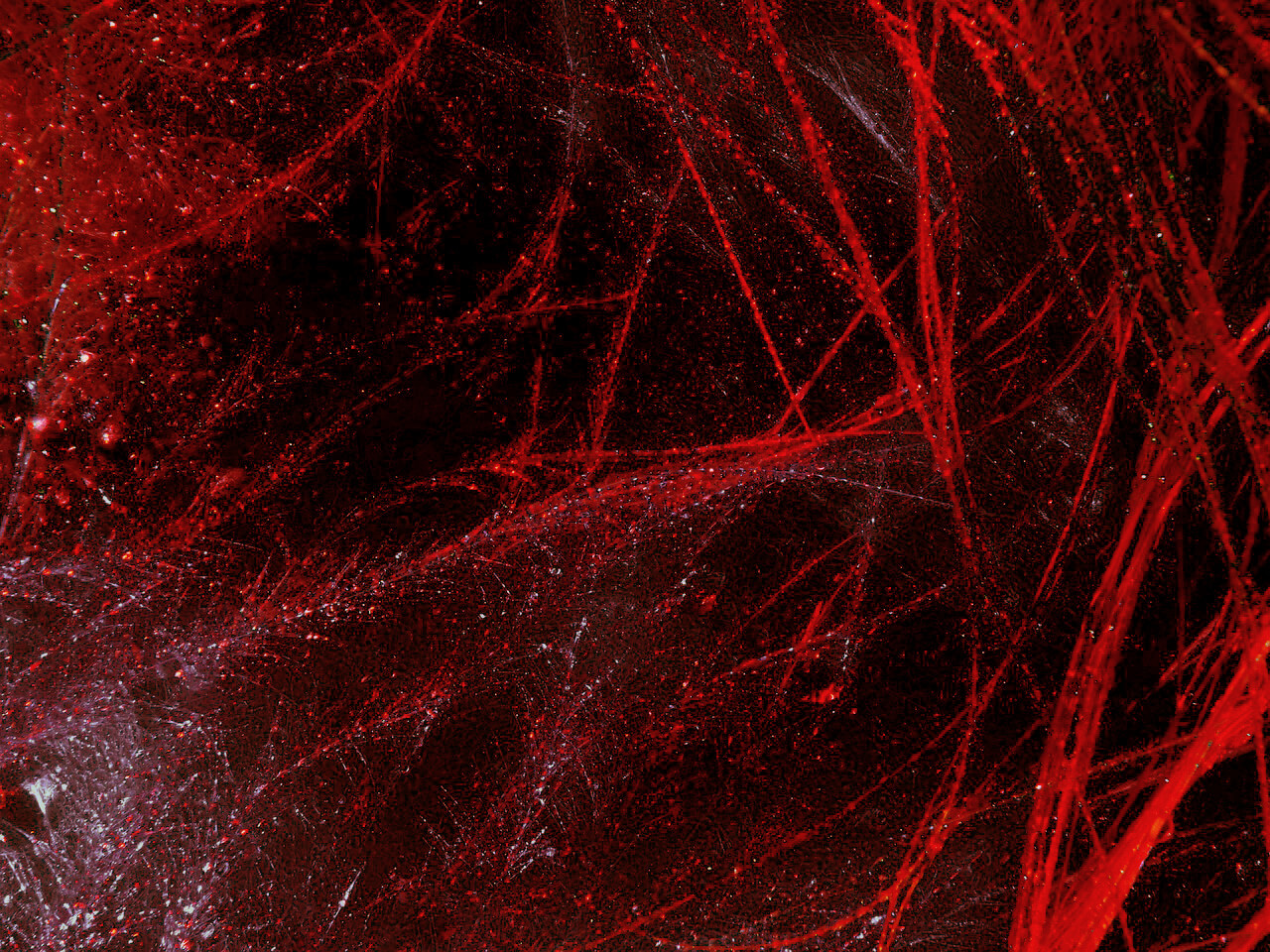Il contributo affronta il tema della parità di trattamento nei rapporti di lavoro, alla luce della normativa e della giurisprudenza sviluppatasi in materia.
1. Premessa
Il trattamento retributivo spettante al dipendente è un tema rilevante non solo nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro – specialmente se si tratta di assumere un lavoratore che già svolge la sua attività altrove – ma anche nella fase successiva, in quanto possibili rivendicazioni economiche trovano, frequentemente, la loro principale motivazione nel mero confronto con il (maggior) trattamento retributivo percepito da colleghi che svolgono analoghe mansioni (il presente contributo non tratterà il tema della parità di trattamento retributivo tra uomo e donna, eccettuato il breve richiamo nel paragrafo 2).
Per quanto qui rileva, si deve ricordare l’inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di parità di trattamento retributivo, concetto che, in qualche modo, conferma l’importanza dell’autonomia contrattuale delle parti.
Infatti si osserva, da un lato, che il contratto di lavoro è un atto di autonomia negoziale privata e, dall’altro, che l’art. 2077, comma 2, c.c., prevede la sostituzione delle clausole individuali difformi da quelle collettive solo se meno favorevoli al lavoratore, ammettendo, implicitamente, la possibilità di trattamenti individuali migliorativi e, quindi, di una possibile disparità di trattamento (solo per completezza di informazione, vale la pena ricordare che, a differenza del settore privato, nel pubblico impiego vige un esplicito principio di parità di trattamento, posto che l’art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale”, corollario del principio di imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione).
L’inesistenza di un principio di parità di trattamento è un baluardo giuridico che si tenta, talvolta, di superare adducendo l’esistenza di discriminazioni, che – ove dimostrate – potrebbero, effettivamente, determinare un esito favorevole delle richieste avanzate dal dipendente, posto che il limite dell’inesistenza di un principio di parità di trattamento retributivo è superabile con la dimostrazione di una discriminazione diretta o indiretta fra i lavoratori.
A tal riguardo, si ricorda che l’art. 2 del d.lgs. n. 216/2003 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) fornisce un’accurata descrizione di discriminazione diretta ed indiretta.
2. La parità di trattamento retributivo
L’inesistenza di un diritto del lavoratore alla parità di trattamento retributivo e/o di inquadramento rispetto ad altri colleghi che svolgono analoghe mansioni è stata ribadita nel tempo (tra le ultime, Cass. 25 giugno 2025, n. 17008).
D’altra parte, si ricorda che il datore di lavoro privato, in virtù della libertà di iniziativa economica garantita dall’art. 41 della Costituzione, non è certo tenuto ad attribuire a tutti i lavoratori che svolgono mansioni identiche/analoghe lo stesso trattamento economico.
Un’implicita ulteriore applicazione dei principi da ultimo evidenziati può desumersi dalla previsione, in alcuni CCNL, del c.d. “salario d’ingresso” (o “retribuzione di primo ingresso”), istituto di natura contrattuale che consente al datore di lavoro, in specifiche circostanze e per un periodo di tempo limitato, di corrispondere ad un lavoratore neo-assunto una retribuzione inferiore a quella ordinariamente prevista nel CCNL per il suo livello di inquadramento.
La retribuzione prevista dal contratto collettivo assume infatti una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza ai sensi dell’art. 36 Cost., ferma restando la possibilità di un trattamento differenziato – che deve essere fondato su un “dato oggettivo” – censurabile solo in caso di ipotesi di discriminazione vietata (tra le tante, Cass. 23 giugno 2020, n. 12356).
Pertanto, quanto a possibili tesi difensive finalizzate a superare principi consolidati, è stato evidenziato che “al di là del tentativo di formulare argomentazioni connonate dal carattere di novità”, l’attenzione del giudicante è volta alla sostanza della questione e, quindi, la soluzione della medesima non può che desumersi dai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, Cass. 12356/2020, cit.).
In particolare, si soggiunge che non si potrebbe neppure invocare il principio di uguaglianza – in assenza di dimostrate (e non semplicemente affermate) discriminazioni – per superare quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza.
Invero, è stato affermato che “l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati”, il che comporta, nella valutazione della sussistenza di un diritto al superiore inquadramento, l’irrilevanza del livello riconosciuto ad altri colleghi che svolgano mansioni analoghe (Cass. 17008/2025, cit.).
In buona sostanza, il richiamo al principio di uguaglianza (di rango costituzionale) è una “suggestione” il cui fine consisterebbe nel tentativo di aggirare altre norme giuridicamente rilevanti.
Tuttavia, non è giuridicamente condivisibile invocare un principio di rango costituzionale per tentare di sottrarsi agli oneri probatori previsti dalla legge o, comunque, per distogliere l’attenzione dal doveroso rispetto di tali oneri, poiché se un lavoratore ha diritto ad un maggior trattamento economico (pari a quello di altri colleghi che eventualmente svolgano analoghe mansioni, circostanza che deve essere altresì dimostrata), l’ordinamento gli garantisce la possibilità di ottenerlo adempiendo a precisi oneri di allegazione e di prova (tale considerazione riguarda anche il tema del diritto al superiore inquadramento, trattato nel paragrafo 3).
Da ultimo, anche in considerazione dell’attualità del tema, si ricorda che la parità di retribuzione tra uomini e donne nello svolgimento dello stesso lavoro è un principio fondamentale dell’Unione Europea, sancito dall’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE).
Il 6 giugno 2023 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro (o per un lavoro di pari valore) attraverso la trasparenza retributiva ed i relativi meccanismi di applicazione, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 7 giugno 2026.
3. Parità di trattamento e diritto al superiore inquadramento
Quanto alla “parità di trattamento”, si osserva che tale principio potrebbe essere invocato da un lavoratore non solo per fondare una richiesta di maggiore trattamento retributivo (come detto, pari a quello percepito da colleghi che svolgono analoghe mansioni), ma anche per rivendicare il riconoscimento di un superiore inquadramento.
Anche in tal caso, tuttavia, il richiamo alla “parità di trattamento” non sarebbe giuridicamente rilevante.
Infatti la giurisprudenza – ribadito l’obbligo del richiedente di dimostrare le mansioni effettivamente svolte (ovvero, il necessario e logicamente preliminare requisito per ottenere un superiore inquadramento ai sensi dell’art. 2103 c.c.) – ha evidenziato l’infondatezza di tale prospettazione.
In particolare, anche recentemente, è stato affermato che, al fine di ottenere un superiore inquadramento, non è sufficiente una “mera comparazione” con l’inquadramento dei soggetti controllati dal lavoratore richiedente, dovendo essere allegati e dimostrati gli elementi costitutivi del diritto rivendicato, ossia “specificare il contenuto delle mansioni svolte in concreto e raffrontarle con i profili e le mansioni propri della superiore qualifica rivendicata” (Cass. 17008/2025, cit.).
Nello stesso senso la (ancor più recente) giurisprudenza di merito, che – richiamando principi già affermati dalla Suprema Corte (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26236) – ha ricordato che “agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l’eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata” (Tribunale Bologna, 3 febbraio 2026, n. 113).
Nè, peraltro, il lavoratore potrebbe fondare il diritto ad un superiore inquadramento (aggirando gli inequivocabili oneri probatori su di lui gravanti) con un richiamo, ad esempio, al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost..
Infatti, sempre recentemente, è stato ribadito l’onere del lavoratore di descrivere con precisione le mansioni svolte; in particolare, è stata evidenziata la necessità di non limitarsi ad una descrizione generica ed “enfatica” di tali mansioni, condotta configurabile, ad esempio, laddove si affermi – come nella fattispecie esaminata dalla sentenza più avanti citata – che tra i compiti svolti vi sia la “creazione” di documenti, in luogo di ciò che sarebbe più corretto definire mera “compilazione” di un documento (su tali temi si legga quanto affermato dal Tribunale di Genova con sentenza 1° dicembre 2025, n. 1171).
Si può quindi sinteticamente concludere che il tentativo di superare gli oneri di allegazione e di prova, mediante il richiamo a principi dell’ordinamento di rilevanza costituzionale, non è attualmente destinato al successo.