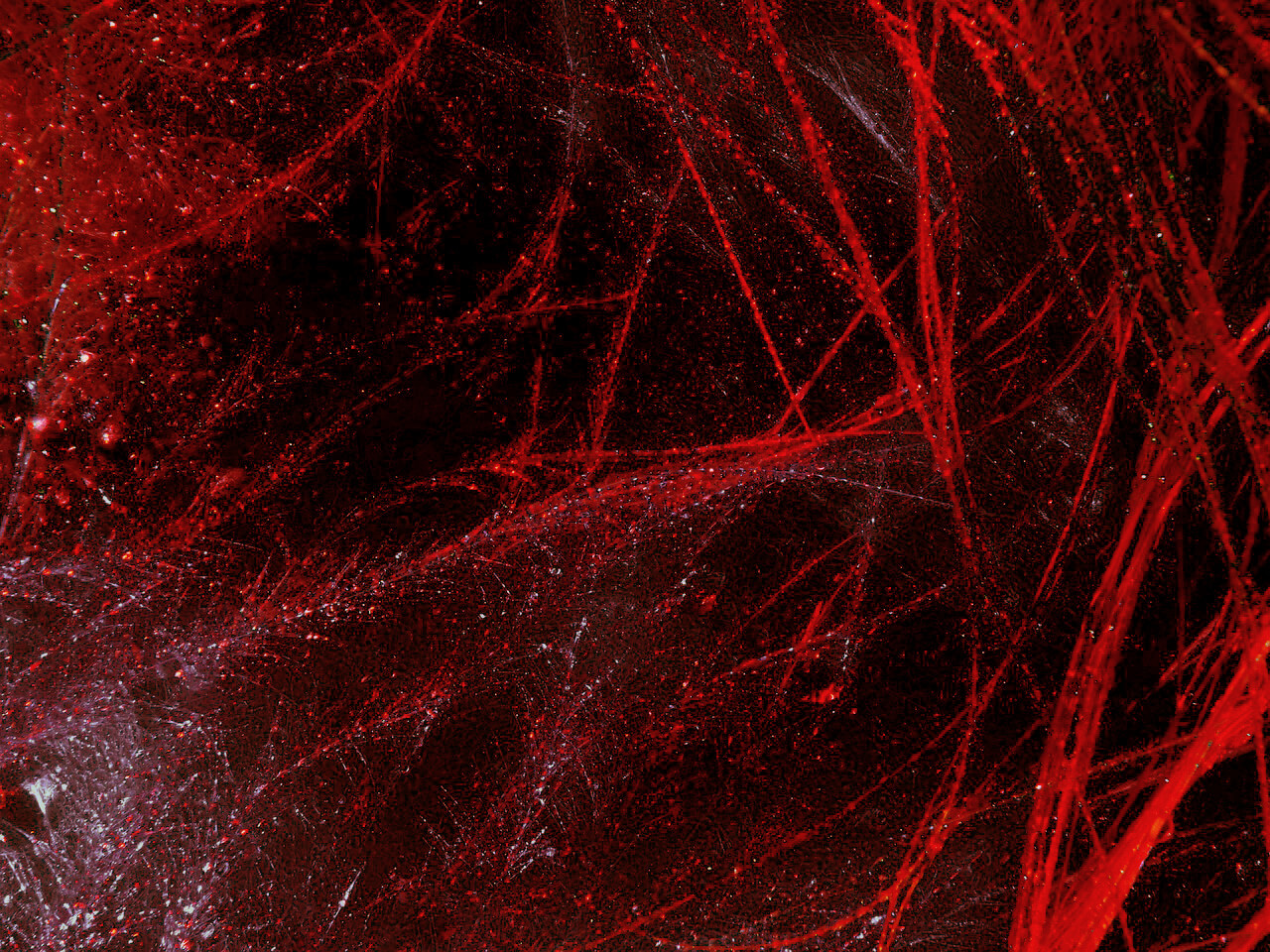Il presente contributo si propone di analizzare la disciplina applicabile ai Fondi Comuni di Investimento per i quali sia sopravvenuta una situazione di “crisi”.
1. Premessa. Descrizione della fattispecie ed individuazione dei profili problematici
Con una ordinanza depositata in data 16 luglio 2025 il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla istanza di conferma delle “misure protettive” rese applicabili dalla pubblicazione della relativa domanda nel Registro delle Imprese, unitamente all’accettazione dell’Esperto designato nell’ambito della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa (“CNC”) disciplinata dagli articoli 12 ss. del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (“CCI”).
L’istanza sottoposta al Tribunale poneva tre questioni preliminari: (i) i rapporti tra la valutazione compiuta dalla competente Commissione istituita ai sensi dell’articolo 13, co. 3, CCI – in merito alla legittimazione dell’istante a richiedere la nomina dell’Esperto designato ad “agevola[re] le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni” di “crisi“ di cui all’articolo 12, comma 1, CCI -, e la valutazione del Tribunale in merito alla legittimazione alla domanda di conferma delle “misure protettive del patrimonio” del soggetto ammesso alla CNC[1] che ne abbia fatto richiesta; (ii) la competenza del Tribunale a verificare la ammissibilità della domanda di conferma delle “misure protettive” da parte del ricorrente, nonostante il giudizio positivo già espresso dalla competente Commissione[2]; e (iii) in caso di esito positivo del precedente quesito, l’ammissibilità del ricorso da parte di una società di gestione del risparmio (“SGR”) all’istituto della Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa per il superamento della situazione di “crisi“ presentata da uno dei Fondi Comuni di Investimento (“FCI”) dalla stessa gestiti.
Solo a valle dell’eventuale soluzione in senso positivo di tali quesiti preliminari il Tribunale avrebbe potuto valutare, nel merito, l’accoglibilità della istanza di conferma delle “misure protettive”.
Il Tribunale risolve in senso positivo le questioni preliminari rappresentate (e, a valle, conferma le “misure protettive“): e tale risultato interpretativo deve essere incondizionatamente condiviso.
Il Tribunale, inoltre, getta le basi dell’approfondimento del problema interpretativo di carattere generale – già esaminato, seppure saltuariamente, nel contesto della previgente legge fallimentare, ma non ancora esaminato nel contesto dell’attuale Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza -, rappresentato dall’interrogativo di quale sia la disciplina delle situazioni di “crisi” che possono colpire (il patrimonio di) un Fondo Comune di Investimento, soprattutto nelle situazioni nelle quali non si potesse (ovvero, ove questa ipotesi si rivelasse formulabile[3], nelle situazioni nelle quali non si volesse) fare ricorso all’unica disposizione dettata dal diritto positivo in argomento, rappresentata dall’articolo 57, co. 6-bis, d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza: “T.U.F.”) – che peraltro riguarda esclusivamente le fattispecie nelle quali ”le attività del fondo… non consentono di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistono ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata”[4].
2. La competenza del Tribunale, adito per la conferma delle “misure protettive” nell’ambito della CNC, a valutare l’ammissibilità del ricorso all’istituto
Secondo il diritto positivo (art. 12, co. 1, CCI) la Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa si inizia con la nomina (previa richiesta del debitore interessato) di un “Esperto” da parte della competente Commissione istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L’avvio della CNC può essere seguito dalla istanza al Tribunale competente (quello presso la cui sede sono istituite le sezioni specializzate in materia di imprese: artt. 19, co. 1, e 27, co. 1, CCI) per la ”conferma o la modifica delle misure protettive” la cui applicazione sia stata richiesta dall’imprenditore con le modalità di quell’articolo 17, co. 1, CCI (quindi tramite l’utilizzo della piattaforma elettronica), e poi pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’Esperto.
Il diritto positivo dispone che “ il Tribunale .. fissa con decreto l’udienza…” nel corso della quale il Tribunale, “sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative …. procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione provvedimenti cautelari richiesti … ed ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”.
Apparentemente, quindi, il Tribunale sarebbe legittimato ad adottare provvedimenti di “conferma, revoca o modifica delle misure protettive”: non già, sembrerebbe, a dichiarare la eventuale inammissibilità dell’avvio della Composizione Negoziata, con quanto ne potrebbe conseguire (forse non tanto la “revoca“ delle misure protettive, quanto piuttosto la dichiarazione della loro inefficacia).
Il Tribunale di Milano dimostra di propendere per l’opposta soluzione: dal momento che, in via preliminare, sviluppa osservazioni “quanto all’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 12, co. 1, CCI”: e risponde positivamente al quesito preliminare rappresentato, osservando che:
- “la domanda è stata rappresentata da …… quale SGR che gestisce il Fondo di Investimento ….”
- “è con riferimento a…. SGR che l’esperto ha verificato la sussistenza di una capacità organizzativa adeguata a supportare il percorso di risanamento ..”
- Le trattative saranno volte al perfezionamento di un accordo tra la SGR e i creditori del Fondo….”.
L’analisi così condotta dimostra che il Tribunale ha ritenuto di essere legittimato a verificare in via preliminare l’ammissibilità del ricorso del soggetto interessato all’istituto della CNC, quale presupposto per il passaggio alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la conferma (ovvero la revoca; ovvero la modifica) delle “misure protettive”. La conclusione deve essere giudicata, di per sé, meritevole di condivisione, dal momento che non vi sono ragioni per concludere che la valutazione pur positiva della competente Commissione che ha designato l’Esperto abbia carattere assorbente rispetto alla valutazione giudiziale della legittimità giuridica del ricorso all’istituto.
3. La attribuibilità di una soggettività giuridica al Fondo Comune di Investimento in funzione della individuazione della disciplina delle situazioni di crisi applicabile al patrimonio del Fondo
L’ipotesi che al Fondo possa essere attribuita una propria soggettività è stata formulata, in dottrina e giurisprudenza[5]: anche se la mancanza di ogni diritto dispositivo (assegnato inequivocabilmente alla SGR) su ciò di cui “il soggetto” sarebbe “titolare” (se escludessimo la SGR stessa: tema sul quale ritorneremo) costituirebbe una evidente anomalia.
Come detto, per l’ipotesi di insufficienza delle attività del Fondo a soddisfarne le obbligazioni, e in una situazione nella quale il Tribunale ravvisi la sussistenza di un “pericolo di pregiudizio”, l’art. 57, co. 6-bis, T.U.F. dispone la liquidazione giudiziale del Fondo stesso, che – come meglio vedremo in appresso – apre una procedura informata ai caratteri della liquidazione coatta amministrativa (“L.C.A.”) della SGR (quindi, nella sostanza, alla L.C.A. bancaria), alla quale si ritiene corretto attribuire natura “concorsuale”[6], per quello che ne può derivare che non sia già ricavabile dalle disposizioni del T.U.F. e del Testo Unico Bancario (d. lgs. n. 385/1993: “T.U.B.”) rivolte a disciplinare le liquidazioni coatte amministrative di intermediari finanziari bancari e non bancari.
Tuttavia questa sorta di “insolvenza patrimoniale” del Fondo non è l’unica situazione nella quale si ponga l’esigenza dell’intervento di misure “straordinarie”, atte a prevenire la produzione di una situazione di “crisi”, ovvero ad evitarne la evoluzione in una condizione deteriore (poniamo, da “reversibile” a “irreversibile”).
Per le attività esercitate direttamente da una impresa; e per le stesse attività esercitate direttamente proprio da una SGR; numerose sono le misure di “prevenzione” della crisi; di “composizione giudiziale” della crisi; di “soluzione alternativa” della crisi, diverse dall’apertura di una procedura di L.C.A., con la inevitabile conseguenza della cessazione dell’attività d’impresa che ne deriva (cfr. art. 57, co. 1, T.U.F., che in presenza dei presupposti di assoggettamento della SGR alla L.CA. dispone la preventiva “revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività” da parte dell’Autorità di Vigilanza – Ministero dell’Economia e delle Finanze -).
Lo scioglimento del dubbio se la “crisi” di un FCI sia prevenibile, o affrontabile, o componibile attraverso il ricorso ad una delle misure disponibili in altre situazioni (per utilizzare una espressione quanto più possibile generale), presentanti corrispondenti caratteristiche patrimoniali-economiche-finanziarie, si gioverebbe molto della attribuibilità al Fondo di una qualificazione soggettiva tipica.
Se si trattasse di un “imprenditore”, gli si potrebbe consentire l’utilizzo delle misure volte a favorirne il superamento o la composizione della crisi, come il Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 CCI; e l’Accordo di Ristrutturazione ex art. 57 CCI[7].
Se si trattasse di un “imprenditore commerciale”, gli si potrebbe consentire l’accessibilità anche alla procedura di Concordato preventivo, ove si ritenesse di potere prescindere dalla esclusione disposta (non già per il FCI gestito, bensì) per la SGR che lo gestisce. [8]
Se si trattasse di un “debitore” presentante una situazione di sovraindebitamento non soggetta né assoggettabile alle procedure di crisi previste per le imprese, se ne potrebbe valutare l’accessibilità ad una delle cc.dd. procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (artt. 65 ss. CCI; artt. 268 ss. CCI).
Il fatto è che ci si trova di fronte ad un panorama caratterizzato da una evidente anomalia di fondo: da una parte, la immutabilità del soggetto “gestore” (necessariamente una SGR autorizzata ad esercitare l’attività di gestione del risparmio); dall’altra parte, la enorme variabilità dei soggetti nell’interesse dei quali l’attività viene esercitata (i “quotisti”, vale a dire i titolari delle quote, la sottoscrizione delle quali ha fornito i fondi per l’avvio delle attività di investimento poste in essere nell’interesse del Fondo: soggetti che possono essere: privati o pubblici; persone fisiche o persone giuridiche; consumatori o imprenditori; soggetti di diritto comune o “di diritto speciale”; eccetera eccetera).
In questo complesso contesto, va valutata con attenzione l’opinione di chi[9] invita a prescindere dallo (o per lo meno a soprassedere allo) scioglimento del dubbio se al Fondo Comune di Investimento debba o non debba essere riconosciuta, in termini generali e strutturali, una “soggettività giuridica”: per ripiegare sul più modesto obiettivo di individuare una risposta accettabile all’interrogativo se il FCI “sia o meno un soggetto di diritto ai fini dell’applicazione della disciplina di volta in volta rilevante”[10]; nonché – per quanto ci interessa in questa sede – una risposta accettabile all’interrogativo di quale sia la disciplina regolatrice dei conflitti fra i creditori di un Fondo Comune di Investimento versante in una situazione di “crisi”, e più in generale la disciplina di queste situazioni nel momento in cui investano un patrimonio gestito attraverso la costituzione di un Fondo Comune di Investimento[11].
4. (Segue). La attribuibilità della titolarità del patrimonio costituente l’oggetto del Fondo Comune di Investimento
Per definizione i FCI costituiscono “patrimoni autonomi, suddivisi in quote, istituiti e gestiti da un gestore . . . raccolti tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio del [Fondo] .., partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”: art. 1, co, 1, lett. j) e k) T.U.F.
Per definizione i FCI sono caratterizzati da una “separatezza patrimoniale” che viene giudicata “perfetta” [12]: nel senso che (i) le attività che fanno parte del Fondo non rispondono di obbligazioni diverse da quelle assunte “dal” Fondo, ovvero “nell’interesse” del Fondo; e (ii) la SGR non risponde delle obbligazioni assunte dal (o nell’interesse del) Fondo, quale che sia la natura (negoziale o extra negoziale) delle obbligazioni “estranee” [13]. Secondo l’art. 36, co. 4, T.U.F., infatti, “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”.
Se pare sufficientemente chiara la disciplina del profilo “oggettivo” del patrimonio assoggettabile alle disposizioni dettate per il Fondo Comune di Investimento, estremamente controversa si presenta invece la individuazione del profilo “soggettivo” di tale patrimonio: chi, cioè, ne sia il “titolare” (potremmo dire: il proprietario).
Fermo l’unanime consenso sulla qualificabilità dei beni e dei diritti facenti parte del “Fondo” come “patrimonio separato” rispetto a quello degli altri “soggetti” interessati – la SGR; i Partecipanti; gli altri Fondi -, è persino messo in dubbio che se ne possa individuare un “titolare”, prospettandosi la configurabilità di un patrimonio per c.d. “acefalo” .
Chi non si arrende a tale, mortificante conclusione, è diviso tra coloro che attribuiscono la proprietà dell’oggetto del Fondo ai partecipanti, alla stregua di quella che potremmo chiamare una “comunione legale” tra i sottoscrittori delle quote del Fondo; chi ne attribuisce la titolarità alla SGR che lo ha costituito (o alla SGR, che può essere diversa dalla prima, che – di volta in volta – lo gestisce) [14] ; chi, infine, esclude che “titolare” del Fondo (rectius: dei diritti che costituiscono l’oggetto del Fondo) sia la SGR che lo ha istituito (e/o che lo gestisce), attribuendo la proprietà di ciò che ne è l’oggetto – in termini evidentemente alquanto approssimativi – “ai Partecipanti al Fondo (o al Fondo) …. cioè il Fondo, o i suoi Partecipanti” [15].
L’evoluzione normativa registrata dall’istituto del FCI per ciò concerne la esclusione di eccezioni alla “separatezza” che ne caratterizza il patrimonio; il superamento delle possibili ambiguità sulla possibile individuazione (oggi negata in radice: art. 36, co. 4, T.U.F.) di una responsabilità sussidiaria della SGR per le obbligazioni assunte dal (o nell’interesse del) Fondo; la esclusione di ogni possibile attribuzione alla SGR degli eventuali “residui attivi di liquidazione” all’atto dello scioglimento del Fondo; l’instaurazione di prassi organizzative rivolte ad implementare il sistema di governance dei Fondi (con la previsione e la disciplina, nei relativi Regolamenti, di “Organi” coinvolti nella gestione del patrimonio separato: Assemblea dei Partecipanti; Comitati Consultivi; Comitati Tecnici; ecc.): rappresentano tutti indizi che, insieme ad altri argomenti – taluno dei quali molto convincenti – portano a prendere le distanze dal principio affermato nel passato dalla Corte di Cassazione[16], e poi ripreso da diverse decisioni di merito, sull’attribuzione della “proprietà” del Fondo – pur separatamente dalla proprietà del patrimonio sociale, nonché dalla proprietà degli altri patrimoni gestiti attraverso Fondi diversi – alla SGR[17].
Con riguardo alle problematiche passate in rassegna, l’ordinanza del Tribunale di Milano è chiara tanto nel propendere per la tesi secondo la quale al Fondo non può essere attribuita soggettività giuridica[18], quanto nell’ escludere che la titolarità del patrimonio gestito attraverso la costituzione di un Fondo Comune di Investimento spetti alla SGR (“non vi è dubbio che la SGR gestisce non un “proprio“ patrimonio, ma il patrimonio del Fondo…”): ed in forza di ciò riconosce alla SGR la legittimazione a ricorrere agli istituti deputati alla composizione delle situazioni di crisi per la (doverosa) migliore gestione del patrimonio del Fondo.
5. La natura giuridica della attività di gestione del Fondo Comune di Investimento
L’argomento della individuazione della disciplina del patrimonio gestito attraverso la costituzione del Fondo Comune di Investimento è interessato anche dalla soluzione del problema della individuazione della natura giuridica della attività che viene esercitata per la sua gestione. In dottrina, infatti, si è affermato che alla “attività di gestione del fondo” – che si è voluto tenere ben distinta da quella “di amministrazione della società di gestione” – deve essere attribuita “natura non imprenditoriale, e comunque non commerciale”, in quanto “per quanto organizzata, è diretta a produrre non già, come invece l’impresa, ricchezza (e cioè nuovi beni o nuovi servizi) per il mercato, quanto piuttosto, e soltanto, guadagno per i partecipanti, prestandosi, e proprio in quanto bensì lucrativa, ma in senso solo soggettivo, e non anche oggettivo, ad essere qualificata in termini di attività di investimento, non in quelli di attività di impresa ..”[19]. La conseguenza che ne discenderebbe, per quanto concerne la individuazione della disciplina delle situazioni di “crisi“ di un patrimonio gestito attraverso la costituzione di un FCI, sarebbe rappresentata dalla circostanza che “la crisi del Fondo non pare poter assumere la forma, tipicamente commerciale, di insolvenza, ma solo quella, civile, di incapienza: risultando, per ciò solo, estranea all’ambito di applicazione delle procedure concorsuali “commerciali“, ed idonea semmai ad essere sottoposta alle procedure, “civili”, volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento”[20].
6. La applicabilità della disciplina delle situazioni di crisi “d’impresa”(commerciale)
L’ordinanza in commento dà sostanzialmente per scontato che alla individuazione della disciplina delle situazioni di crisi di un Fondo Comune di Investimento, gestito da una SGR, debba procedersi con l’ occhio rivolto alle procedure di composizione delle crisi delle attività (i) imprenditoriali e più precisamente (ii) commerciali: orientano in questo senso i richiami dell’articolo 12, co. 1, c.c. (“ l’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto…..”; la SGR., nella richiesta di nomina dell’esperto, ha correttamente “rilasciato la prescritta dichiarazione…. che l’impresa può essere risanata ….”; “.. l’art. 57, comma 6-bis, T.U.F., ammette il fondo ad un procedura concorsuale, seppure a carattere amministrativo, al di là della sua soggettività giuridica ..”).
Da qui l’ammissibilità, secondo il Tribunale di Milano, almeno per quanto riguarda la natura giuridica dell’attività esercitata sul patrimonio investito dalla situazione di crisi, di una procedura riservata alle “imprese” (la CNC, per l’appunto).
Ferme restando le considerazioni che svilupperemo in prosieguo, possiamo esprimere in questa sede una condivisione di questa conclusione. La distinzione fra “attività organizzate“ rivolte a conseguire “guadagno per i partecipanti” attraverso una società “bensì lucrativa, ma in senso solo soggettivo” e attività ”diretta a produrre… ricchezza (e cioè nuovi beni o nuovi servizi) per il mercato”; così come la distinzione tra “attività di gestione del fondo” e “attività di amministrazione della società di gestione” – qualificata, quest’ultima, “invece, schiettamente imprenditoriale” -; e, infine la distinzione tra ”attività di investimento” e “attività di impresa “: non sembrano tali da giustificare la natura giuridica di “imprenditoriale” (ovvero di “commerciale”?)[21] soltanto alle prime, e non alle seconde, che dovrebbero pertanto vedersi disciplinate “dalle procedure “civili”, volte alla composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Basti a tale proposito un esempio: la SGR il cui oggetto sociale sia rappresentato dalla gestione di un unico Fondo Comune di Investimento: l’attribuzione all’attività di gestione del Fondo di una natura giuridica diversa dalla attività di gestione della SGR parrebbe poco convincente.
7. Le procedure di crisi di impresa (commerciale) applicabili alle situazioni di difficoltà dei Fondi Comuni di Investimento – La Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa
Con l’ordinanza depositata in data 16 luglio 2025 il Tribunale di Milano prende decisamente posizione sui problemi della (mancanza di) soggettività giuridica del FCI; e della legittimazione della SGR a ricorrere a procedure di composizione della crisi d’impresa nell’interesse del Fondo e con esclusivo riguardo al patrimonio dello stesso: in termini molto espliciti il Tribunale afferma che “ …. correttamente la composizione negoziata è stata avviata per il tramite di ……, in qualità di SGR del Fondo, soggetto che ha presentato l’istanza di accesso alla composizione negoziata, che ha successivamente depositato il ricorso ex articoli 18-19 CCII e che svolgerà le trattative e concluderà l’eventuale accordo con i creditori;
in altri termini, non avendo il Fondo soggettività giuridica ed essendo il Fondo rappresentato e gestito dalla SGR, non può non essere la SGR a depositare l’istanza di CNC e a condurre le trattative”. Più in generale l’ordinanza afferma che è percorribile “ la possibilità… per un Fondo in stato di crisi di accedere, tramite la SGR, a strumenti alternativi a procedure concorsuali, ossia la tutela anticipata del patrimonio concessa durante le trattative dirette al perfezionamento di un accordo …”: e ritiene che tra gli “strumenti“ in questione ben possa essere ricompreso anche quello della Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi d’Impresa, nell’ipotesi – come quella portata all’attenzione del Tribunale – nella quale la SGR intendesse avviare ”trattative volte al perfezionamento di un accordo tra la SGR e i creditori finanziari del fondo”.
La conclusione è condivisibile, in termini generali, perché la CNC rappresenta un istituto al quale può ricorrere qualsiasi impresa (commerciale; agricola; “ sopra soglia”; “sotto soglia”[22]; di diritto comune o “ di diritto speciale”[23]): e nulla impedisce che l’impresa vi faccia ricorso nell’attività avente ad oggetto un patrimonio di titolarità altrui, la gestione del quale costituisce però l’oggetto della propria attività, che proprio in considerazione di tale “alterità” deve essere svolta con la massima diligenza[24].
Naturalmente della disciplina della CNC devono ricorrere anche i “presupposti oggettivi” rappresentati dalla ricorrenza di una situazione di “crisi” presentante le caratteristiche descritte dall’articolo 12, co. 1, CCI (che oggi le comprende praticamente tutte: dal “pericolo di crisi “ alla insolvenza irreversibile), e – soprattutto – dalla perseguibilità del “risanamento”.
Quest’ultimo requisito è tutt’oggi considerato irrinunciabile[25]: e per quanto necessariamente soggetto ad adattamento – dovendo riguardare, nel caso considerato in questa sede, non tanto (come pure recita l’articolo 12, co. 1, CCI) “l’impresa”, quanto, piuttosto il (patrimonio gestito nell’interesse del) Fondo Comune di Investimento -, deve risultare presente anche nella Composizione Negoziata della SGR (agente l’interesse di un Fondo “in crisi”).
Ciò potrebbe incontrare un ostacolo nelle situazioni nelle quali l’intervento sul patrimonio gestito attraverso il Fondo non fosse rappresentato da una sua “ristrutturazione“, funzionale a consentire la prosecuzione della sua gestione a valle del superamento delle difficoltà incontrate in un determinato momento: bensì da una attività di proficuo e mirato efficientamento, funzionale al conseguimento di risultati finali più vantaggiosi per i creditori rispetto ad una liquidazione atomistica e disordinata, ma pur sempre liquidatori. La prospettiva del risultato della Composizione Negoziata rappresentato da una liquidazione sia pure “brillante”, piuttosto che da una continuazione dell’attività di gestione, potrebbe essere ritenuto contraddittorio con la funzione dell’istituto.
Il dubbio ragione di essere posto, ma nel caso della crisi del Fondo Comune di Investimento gestito da una SGR deve tenere conto di una circostanza che rappresenta una caratteristica della fattispecie considerata, laddove in contesti diversi non ha sino ad ora mai meritato di essere presa in considerazione: la scadenza del Fondo, che rappresenta una caratteristica dell’attività (d’impresa) esercitata dalla SGR. Tutti i Fondi gestiti hanno una scadenza: e (i) sovente la scadenza è relativamente ravvicinata rispetto alla istituzione del Fondo; inoltre (ii) raramente la scadenza viene prorogata, una volta giunto il termine originariamente stabilito.
In tale contesto deve ritenersi concepibile l’ipotesi del ricorso alla procedura di Composizione Negoziata rivolto ad un intervento sulla struttura del patrimonio gestito attraverso il Fondo Comune di Investimento rivolto ad ottimizzarne i risultati della liquidazione finale, tutte le volte nelle quali la situazione di crisi sopravvenga quando la durata della vita del Fondo sia prossimo alla scadenza.
D’altro canto, a tale proposito, appare significativo tenere presente che:
(i) per un verso, è perfettamente compatibile con la funzione dell’istituto della Composizione Negoziata il perseguimento dell’obiettivo che preveda la liquidazione del patrimonio dell’impresa in crisi entro 2 anni (cfr. art. 23, co. 1, lett. a) CCI, che tra le “soluzioni idonee“ al superamento della situazione di crisi dell’impresa ammessa alla Composizione Negoziata indica la conclusione di un contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale “per un periodo non inferiore a due anni” – dopodiché, l’impresa potrebbe anche cessare l’attività -);
(ii) per un altro verso, si ritiene che non dovrebbe essere esclusa l’ammissione alla Composizione Negoziata di una impresa in situazione di crisi, che mirasse a recuperare l’equilibrio economico-finanziario per continuare l’attività anche fino all’esaurimento della propria vita, ma la cui scadenza statutaria (con conseguente obbligo di liquidazione del patrimonio) si presentasse però relativamente prossima rispetto alla data di avvio della Composizione Negoziata.
8. La Convenzione di Moratoria e il Piano Attestato di Risanamento
La Convenzione di Moratoria può essere conclusa “tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori “, ed è “diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi“: essa ha per oggetto “la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito “. A determinate condizioni essa “è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria “ (cfr. art. 62 CCI).
La circostanza che una situazione di crisi investa soltanto una porzione del patrimonio dell’imprenditore (per esempio: un ramo d’azienda; oppure, un cantiere), non impedirebbe certamente a costui di ricorrere all’istituto della Convenzione di Moratoria per prevenire possibili azioni esecutive o cautelari dei relativi creditori. Lo “imprenditore”, che rappresenta il presupposto soggettivo di applicabilità dell’istituto, è, in realtà, ”il soggetto che esercita l’attività di impresa”: e per quanto sopra osservato, alla SGR tale definizione non può essere negata. Ne consegue, ad avviso di chi scrive, la pacifica ricorribilità all’istituto, in funzione della protezione del patrimonio del Fondo gestito.
Il “Piano Attestato di Risanamento”, disciplinato essenzialmente dall’art. 56 CCI, è costituito dal compimento di uno o più atti giuridici, rivolti a “consentire il risanamento della esposizione debitoria” e ad “assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’impresa“, integrato dalla “Attestazione” di un esperto indipendente (i cui requisiti sono contestualmente precisati) circa la veridicità dei dati aziendali posti alla base del “Piano” e la sua fattibilità economica. Gli effetti sono principalmente rappresentati dalla esenzione dall’azione revocatoria degli atti, pagamenti, garanzie (costituite su beni del debitore) posti in essere in esecuzione del Piano; e dalla esimente dalla responsabilità penale astrattamente attribuibile al compimento di quegli atti come possibile presupposto dei reati di bancarotta (ai sensi e nei limiti di cui all’art. 324 CCI).
Il “Piano” non costituisce pertanto una “procedura”: né costituisce necessariamente un “Accordo” (nonostante l’espressione del comma 1 dell’articolo 56)[26]. Esso può anche essere rappresentato da uno o più contratti traslativi (cessioni di asset); da operazioni societarie straordinarie (fusioni o scissioni); da atti unilaterali (conferimento).
Si deve ritenere che il soggetto che fosse investito di un mandato gestorio sufficientemente ampio da consentirgli il compimento di atti anche di straordinaria amministrazione, potrebbe esercitarlo validamente per predisporre un “Piano Attestato di Risanamento” volto a superare la situazione di crisi del patrimonio amministrato.
Non pare che vi possano essere dubbi nel ritenere che anche la SGR possa procedere in tal senso, con effetti circoscritti ai beni ed ai diritti ricompresi nel Fondo Comune di Investimento interessato da una situazione di crisi, allo scopo di superarla.
In tale ipotesi sembra di potere persino prescindere dalla risposta alla domanda sulla (maggiore o minore) “soggettività” del Fondo. Si può cioè considerare legittimata la SGR stessa a porre in essere quegli atti; a concludere quei contratti; a predisporre quel “Piano”, funzionali a conseguire (il “risanamento” del Fondo e, con l’integrazione apportata dalla “Attestazione” qualificata di cui si è detto) gli effetti protettivi connessi all’istituto.
A riprova della correttezza della conclusione si può addurre la circostanza che certamente la SGR potrebbe predisporre e concludere, nell’interesse del “Fondo”, un accordo stragiudiziale con i creditori dello stesso, volto a regolarne un processo di riequilibrio economico-finanziario. La predisposizione di un “Piano” ex art. 56 CCI non è (necessariamente) più di questo, con la integrazione – che costituisce però un fattore del tutto “esterno” – della “Attestazione qualificata” prevista dalla norma richiamata.
A nulla rileva pertanto, a parere di chi scrive, a tale proposito, la discussione se il FCI abbia o non abbia soggettività giuridica; e chi sia il “titolare” (ammesso che ve ne sia uno) dei rapporti giuridici facenti capo al Fondo. La legittimazione a disporne è comunque riservata alla SGR: e la SGR ben può disporne attraverso il compimento di atti giuridici e/o la conclusione di contratti (integrati dalla “Attestazione speciale”) volti al superamento della situazione di difficoltà del Fondo.
Ma vi è di più.
Potendo disporre dell’istituto in esame per comporre la situazione di “crisi” (finanziaria) del “Fondo” agendo all’interno di un “contesto protetto”, che favorisca la stabilità degli effetti degli atti giuridici posti in essere, potrebbe esporsi ad una responsabilità omissiva per inadeguato assolvimento della “funzione” assegnatale dalla disciplina di settore, la SGR (e per essa i suoi organi amministrativi) che, sussistendone i presupposti, omettesse di porre in essere questa misura di tutela del patrimonio del “Fondo”[27]
9. Lo “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 57 CCI (del Fondo Comune di Investimento e della SGR)
9.1. Lo “Accordo di Ristrutturazione” disciplinato dall’art. 57 CCI è correttamente qualificabile una “procedura”: esso è qualificabile come tale, infatti (e non come semplice accordo stragiudiziale, pur essendo proprio questo), solo in virtù della conclusione (positiva) di un procedimento giudiziale, che è la “procedura” di omologazione.
In prima battuta potrebbero essere riproposte per lo “Accordo” le considerazioni formulate per il “Piano”: potendo disporre la SGR dei rapporti giuridici inerenti il “Fondo”, ben potrebbe farli oggetto di un accordo con i creditori, funzionale a superare il momento di difficoltà, sottoponendolo all’ omologazione del Tribunale.
Il giudizio di omologa postula però un “ricorrente“; ed è condizionato alla presenza di presupposti anche soggettivi.
Solo “l’imprenditore” può ricorrervi: e se il “Fondo” venisse riconosciuto “titolare” del patrimonio separato che ne costituisce l’oggetto, si potrebbe dubitare che esso Fondo sia legittimato a ricorrere a tale istituto: come si potrebbe dubitare che potesse farlo la SGR, in grado di qualificarsi “imprenditore”, allo scopo di conseguire effetti destinati a trovare applicazione nei confronti di un patrimonio il cui titolare – il Fondo – risultasse invece (perché non qualificabile “imprenditore”) non legittimato a conseguirli.
Se tuttavia si prescinde dal prendere posizione sulla questione di portata generale (e addirittura “sistematica”) se ed in quali limiti il Fondo Comune di Investimento possa qualificarsi “proprietario” (o “titolare”) dei rapporti giuridici che ne costituiscono l’oggetto, e si ripiega sul più circoscritto interrogativo se la disciplina dello “Accordo” possa trovare applicazione nei confronti dei rapporti giuridici facenti capo al Fondo, la risposta più convincente è la risposta positiva.
A tale proposito l’ordinanza del Tribunale di Milano, qui commentata, finisce per esprimere una valutazione negativa, nel momento in cui, ricordando gli unici precedenti conosciuti (dello stesso Tribunale) in materia di ammissibilità (della SGR che gestisce il patrimonio) del Fondo Comune di Investimento alla procedura di Accordo di Ristrutturazione[28], precisa che il presupposto sul quale tale precedente si fondava – presupposto rappresentato dalla esclusione della natura di “procedura concorsuale “ dello “Accordo “, “ora non [è ] più condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità e del successivo CCI “
Il giudizio negativo manifestato dall’ordinanza del Tribunale di Milano circa la ricorribilità da parte di una SGR (nell’interesse di un Fondo gestito) allo Accordo di Ristrutturazione disciplinato dall’art. 57 CCI, a causa della natura di “procedura concorsuale” attribuibile all’istituto, potrebbe essere collegata alla circostanza che tale genere di società – come gli altri intermediari bancari e finanziari – non è soggetto alle “procedure concorsuali” di diritto comune (cfr. per le banche l’ art. 80, comma 6, T.U.B., richiamato dall’art. 57, comma 3, T.U.F., per gli intermediari finanziari non bancari): e qualora all’Accordo di Ristrutturazione venisse attribuita tale natura giuridica, il dubbio, per l’appunto, si potrebbe porre.
Ad avviso di chi scrive anche nell’ipotesi di attribuzione all’Accordo di Ristrutturazione della natura giuridica di “procedura concorsuale“ non vi sarebbe ragione per precluderne l’accesso alla SGR che intendesse, con il ricorso a tale istituto, sovvenire alla situazione di crisi di un Fondo Comune di Investimento gestito: ma su questo argomento ritorneremo in un secondo momento[29] .
Il fatto è che, in via preliminare, deve negarsi la natura giuridica di “procedura concorsuale“ all’Accordo di Ristrutturazione: e ciò, riprendendo l’espressione della stessa ordinanza qui commentata, proprio “alla luce …. del successivo [alla legge fallimentare] CCI “.
In primo luogo, nell’Accordo di Ristrutturazione difettano della disciplina tipica delle “procedure concorsuali” alcuni profili essenziali, quali – principalmente – (i) la indisponibilità del patrimonio da parte dell’imprenditore interessato (che può continuare a disporne, con atti – anche di straordinaria amministrazione – sicuramente opponibili ai creditori, quantunque in ipotesi contradditori rispetto agli impegni derivanti con la sottoscrizione dello “Accordo” – con l’unica, eventuale conseguenza della esposizione dello stesso al rischio della risoluzione contrattuale – ); e (ii) la mancanza di una qualsiasi “cristallizzazione” delle passività “concorsuali” (al punto che – ad esempio – ben potrebbe il creditore anteriore al perfezionamento dello “Accordo” opporre in compensazione all’imprenditore una propria obbligazione sorta in epoca successiva)[30].
In secondo luogo, proprio l’entrata in vigore del CCI ha rappresentato la dimostrazione della insussistenza dei presupposti di una equiparazione dell’Accordo di Ristrutturazione alle “procedure concorsuali”, nel momento in cui ha vistosamente disatteso il proposito di accomunare l’Accordo di ristrutturazione al Concordato preventivo, la cui natura di procedura concorsuale è invece innegabile.
Se si confrontano le proposte di articolato contenuta nel c.d. “Progetto Rordorf” (dal nome del Presidente della Commissione incaricata della riforma della legge fallimentare) – articoli 50 e 105 – con il dettato normativo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza poi entrato in vigore (articoli 46 e 100) risulta palese la “correzione di tiro“ imposta dal legislatore.
I testi richiamati sono così raffrontabili:
| Art. 50 CCII – “Progetto RORDORF”
Effetti del decreto di concessione dei termini per l’accesso al Concordato Preventivo o al giudizio per l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione. 1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il Tribunale dispone a revoca del decreto di cui all’articolo 44, comma 1. 3. I crediti sorti per effetto degli atti legittimamente compiuti dal debitore sono prededucibili. 5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto di creditori anteriori. |
Art. 46 CCII in vigore
Effetti della domanda di accesso al Concordato preventivo o al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione 1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il Tribunale dispone a revoca del decreto di cui all’articolo 44, comma 1. 4. I crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. 5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto di creditori anteriori. |
| Articolo 105 (“Progetto Rordorf”)
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi . 1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 48 e 92 può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori . 2. La disciplina di cui al comma precedente si applica al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale se il debitore concordatario, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 3. Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 48, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, alle condizioni e termini di cui al primo comma e al secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria disciplinata dal presente codice. |
Art.182 quinquies l. fall.
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi. 5. Il debitore che presenta una domanda di ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale anche ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. (omissis) 6. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al primo comma si applica, in deroga al disposto dell’articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, 3º comma, lettera di, attestante che il credito garantito potrebbe essere soddisfatte integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 7. Il debitore che presenta la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67. |
Articolo 100 CCII
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi. 1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 14 e 87, quando è prevista la continuità aziendale, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il Tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. 2. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non vedi diritti degli altri creditori. |
In prima battuta, è sufficiente confrontare quanto disponeva (all’art. 50) il Progetto di riforma della legge fallimentare, che avrebbe dovuto sfociare nel CCI (c.d. “Progetto Rordorf”, dal nome del presidente della Commissione originariamente incaricata della riforma): e quanto ha finito per disporre, invece (all’art. 46), il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza poi effettivamente entrato in vigore.
L’articolo 50 del “Progetto Rordorf” disponeva tre fondamentali “effetti concorsuali”:
(i) la limitazione della gestione dell’imprenditore ai soli atti di ordinaria amministrazione;
(ii) la collocazione in prededuzione dei crediti derivanti da “atti legittimamente compiuti”; e
(iii) il divieto di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti: e ne dispone la produzione tanto in conseguenza dell’accesso al Concordato preventivo, quanto a seguito dell’accesso al giudizio per l’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione.
L’articolo 46 CCI dispone gli stessi “effetti concorsuali”, collegandoli però esclusivamente alla “domanda di accesso al concordato preventivo”, tanto nella rubrica della disposizione – “Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo” –, quanto nel disposto del comma introduttivo – “Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo…” –.
A questa stregua, è improponibile l’idea che Concordato preventivo e Accordo di Ristrutturazione abbiano la stessa natura giuridica, quando il primo è caratterizzato dai quei tre “effetti concorsuali” tipici delle procedure concorsuali propriamente dette, mentre il secondo ne è totalmente esentato (dopo che era stato ipotizzato, invece, di disciplinarlo nel medesimo modo).
In seconda battuta, identica conclusione deve essere ricavata dal confronto della disciplina del pagamento dei crediti pregressi: pagamento che nel Concordato preventivo è vietato (nel senso di rendere inopponibile l’atto ai creditori concorrenti), mentre nell’Accordo di Ristrutturazione è certamente consentito (nel senso di produrre effetti perfettamente opponibili agli altri creditori).
Esemplare sotto questo profilo è il confronto tra la disciplina del pagamento dei cc.dd. “fornitori strategici”, oggi regolato soltanto nel Concordato preventivo[31], per subordinarne la legittimità alla autorizzazione del Tribunale (art. 100 CCII), ed invece totalmente ignorato per quanto riguarda l’Accordo di Ristrutturazione (artt. 57 ss. CCI).
La ragione della mancata previsione, nella disciplina dell’Accordo di Ristrutturazione, della necessità dell’autorizzazione giudiziale per il pagamento di crediti pregressi dovuti a “fornitori strategici” – mentre nell’ambito del Concordato preventivo detto pagamento è subordinato alla autorizzazione giudiziale – non può ovviamente essere costituita dalla circostanza che tali pagamenti non siano mai consentiti, nell’Accordo di Ristrutturazione, neppure con l’autorizzazione del Tribunale: essa consiste, piuttosto, nella circostanza che il pagamento dei crediti pregressi, nell’Accordo di Ristrutturazione, è certamente consentito senza limitazioni, e addirittura dovuto, con riguardo ai creditori non aderenti.
Ciò precisato, l’opinione favorevole ad ammettere la possibilità del ricorso all’istituto dello “Accordo” ex art. 567 CCI, da parte di una SGR, nell’interesse di un Fondo Comune di Investimento (con specifico riguardo proprio ai Fondi Comuni Immobiliari di tipo chiuso), può fondamentalmente essere espressa sulla scorta del disposto di diritto positivo rappresentato dall’art. 57, co. 6 bis, T.U.F.[32].
Tale norma, infatti, delinea una Procedura, assimilabile alla Liquidazione Coatta Amministrativa degli Intermediari Finanziari – tanto più dopo essere stata integrata dalla modifica conseguente all’attività di adeguamento del T.U.F. alla Direttiva Comunitaria 2014/59/UE, che ha portato all’introduzione di una inedita seconda parte[33], che investe esclusivamente il Fondo Comune di Investimento in stato di insolvenza -, che è certamente una “procedura concorsuale”; e che – ciononostante – ben può essere aperta su istanza – anche – della SGR che gestisce il Fondo.
La norma attesta che una procedura concorsuale può essere disposta nei confronti del FCI, per iniziativa della SGR che lo gestisce, (i) nonostante il dubbio se tale patrimonio abbia soggettività giuridica; e (ii) nonostante la sottrazione della SGR – in quanto tale – a “procedure concorsuali” diverse dalla L.C.A. “bancaria”: e sulla scorta di tale constatazione si è già ritenuto (e sin deve continuare a ritenere) che non sussistano ostacoli ad ipotizzare che tale patrimonio possa costituire oggetto anche di una procedura di composizione della “crisi” come quella delineata dall’art. 182-bis, l.fall. – oggi art. 57 CCI -.[34]
Se mai può essere interessante aggiungere che il problema preso in considerazione dalla dottrina dianzi citata non si pone soltanto in presenza di una situazione di “crisi” circoscritta ad uno (o più) dei Fondi Comuni di Investimento (immobiliari di tipo chiuso) gestiti da una SGR. Esso si pone anche in relazione all’ipotesi della emersione di una situazione di “crisi” della stessa SGR, allorquando essa sia provocata dalla condizione di “crisi” di un “Fondo” (o di più Fondi).
I ricavi della SGR, infatti, sono costituiti unicamente – come detto – dalle commissioni percepite per la gestione del “Fondo”, a carico del patrimonio in ché esso consiste: ed in una situazione di insolvenza (o anche di illiquidità) del “Fondo”, è inevitabile rappresentarsi la possibilità che anche la SGR vada incontro a serie difficoltà economiche – tanto nell’ipotesi nella quale il “Fondo” non abbia oggettivamente le disponibilità liquide per corrispondere alla SGR le commissioni di gestione; quanto nell’ipotesi nella quale le disponibilità sussistano, ma la SGR assuma la determinazione di non utilizzarle per pagare le commissioni di gestione (cioè per auto-soddisfarsi), nella giusta considerazione dei possibili effetti pregiudizievoli di tali pagamenti (oggettivamente) “preferenziali” – .
In tale situazione, considerato che per il ricorso all’istituto dello “Accordo di Ristrutturazione” ex art. 57 CCI sussisterebbero tanto il presupposto soggettivo (soggetto di diritto – la SGR – avente la qualità di “imprenditore”), quanto il presupposto oggettivo (“stato di crisi”), diventa necessario stabilire, in presenza di un soggetto che sia titolare di più patrimoni separati, a quale di tali patrimoni fare riferimento per fare corretta applicazione delle norme che disciplinano l’istituto, con particolare riguardo:
- a) ai creditori da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del presupposto del “consenso allargato” – tanti aderenti rappresentanti il 60% delle passività-; e
- b) alle passività di cui verificare la possibilità del “soddisfacimento integrale”, per consentire allo “Accordo” di produrre gli effetti ad esso attribuiti dalla legge (cfr. art. 57, co. 3, CCI).
Il problema non sarebbe molto diverso se ci trovasse di fronte allo “stato di crisi” di una società per azioni di diritto comune, la quale fosse titolare di più “patrimoni destinati” costituiti ai sensi dell’art. 2447-bis cod. civ., e la cui “crisi” fosse determinata dalle vicende negative concernenti uno dei patrimoni di cui fosse titolare (per esempio, quello originariamente posseduto, al netto delle porzioni di patrimonio costituite in “patrimonio destinato” in un momento successivo, in applicazione della norma richiamata).
La legge consente ad un soggetto giuridico che abbia una determinata forma (quella di S.P.A.) di essere titolare di più patrimoni separati (cfr. il richiamato art. 2447-bis cod. civ.).
Addirittura, la legge prevede che un determinato soggetto giuridico (la Società di Gestione del Risparmio: SGR) sia costituito proprio in funzione della assunzione della titolarità di più patrimoni separati, per provvedere alla loro gestione (individuale ed indipendente).
Nulla autorizza a concludere che a tali soggetti sia vietato fare ricorso a tutta una serie di istituti giuridici, per il solo fatto che la disciplina di questi sia impostata sulla “regola” della sussistenza in capo ad un soggetto di un unico patrimonio, senza disciplinare espressamente la “eccezione” rappresentata dalla presenza di un soggetto giuridico titolare di più patrimoni separati (ma talora facendolo, e così dimostrando l’accettabilità del fenomeno da un punto di vista giuridico e concettuale: cfr. art. 57, co. 6 bis, T.U.F.). Il problema è piuttosto stabilire come debbano essere applicate, nei casi rappresentati dalle “eccezioni”, le norme pensate per una applicazione alle fattispecie costituenti la “regola”.
Come sarebbe seriamente necessario domandarsi perché dovrebbe essere vietato ad una S.p.A. di diritto comune “in stato di crisi” di fare ricorso all’istituto di cui all’art. 57 CCI, per il solo fatto di avere (legittimamente) costituito un “patrimonio separato” ai sensi dell’art. 2447-bis cod. civ.; nello stesso modo non appare condividibile l’idea che alla S.p.A. rappresentata da una SGR risulti vietato fare ricorso all’istituto richiamato, in conseguenza del fatto (per lei connaturato alla tipologia dell’attività svolta) di avere costituito uno o più patrimoni separati nell’esercizio dell’attività istituzionale di Società di Gestione del Risparmio.
Il problema che si pone, pertanto, a ben vedere, come detto, non è quello di stabilire se la S.p.A. con “patrimoni destinati” ex art. 2447-bis cod. civ., ovvero la SGR che gestisce i patrimoni separati dei FCI, possa o non possa fare ricorso all’istituto dell’art. 57 CCI: ma – piuttosto– come le disposizioni che disciplinano l’istituto debbano essere applicate, perché esso possa produrre gli effetti che la legge gli attribuisce.
Pare evidente che la risposta debba essere nel senso che le disposizioni in questione vadano applicate con riguardo ai rapporti giuridici facenti capo al patrimonio separato nel contesto del quale si sono prodotte le difficoltà che determinano lo “stato di crisi” della società (S.p.A. con “patrimoni destinati” o SGR che sia), e sui quali si intende intervenire con il ricorso all’istituto dello “Accordo”.
È evidente infatti che se la S.p.A. che avesse costituito un “patrimonio destinato” versasse in stato di crisi per l’andamento negativo della attività di impresa originaria (cioè diversa da quella, per il cui esercizio fu costituito il “patrimonio destinato”), essa dovrebbe coinvolgere nello Accordo di Ristrutturazione esclusivamente i creditori “sociali” (ed i relativi rapporti giuridici), e non dovrebbe coinvolgere i creditori (e i rapporti giuridici) relativi al “patrimonio destinato”.
A questa stregua, nel momento in cui lo stato di crisi della SGR fosse rappresentato dalle conseguenze delle difficoltà del “Fondo” gestito (o di uno dei FCI gestiti); e la rimozione della “crisi” dovrebbe passare attraverso un intervento sui rapporti giuridici determinanti le difficoltà del “Fondo” – e la cui ristrutturazione potesse comportare il superamento di tali difficoltà -; è inevitabile dovere concludere che la SGR debba coinvolgere esclusivamente i creditori – e i rapporti giuridici – originati dall’attività di gestione del “Fondo”.
In conclusione:
- nell’ipotesi nella quale la situazione di “crisi” dipenda dai rapporti giuridici instaurati dalla SGR come tale nei confronti dei terzi – per esempio, rapporti derivanti da finanziamenti bancari assunti dalla Società per il sostegno finanziario della propria attività di gestione di Fondo Comuni di Investimento -, sarà nei confronti di costoro che dovrà essere apprestata la “Proposta” di Accordo di Ristrutturazione e predisposto il “Piano” funzionale ad eseguirla (restandovi indifferenti i rapporti giuridici instaurati nell’interesse di questo o quell’altro “Fondo” gestito);
- laddove la “crisi” della SGR dipenda dalla condizione di difficoltà economico-patrimoniale–finanziaria di uno dei “Fondi” gestiti, e non possa essere rimossa se non attraverso la ristrutturazione dell’indebitamento assunto nell’interesse di quel “Fondo” – in quanto, per esempio, da questa ristrutturazione dipenda l’esigibilità e la riscuotibilità dei crediti della SGR a carico del patrimonio gestito nell’ambito del “Fondo”, a titolo di commissioni di gestione o ad altro titolo (anticipazione di spese per la gestione dei cespiti costituenti il patrimonio gestito nell’ambito del “Fondo”) -, saranno i rapporti giuridici instaurati nell’interesse di quel “Fondo” che dovranno costituire l’oggetto della “Proposta” e del “Piano”;
- lo stesso deve dirsi – si deve ritenere – allorché fossero soltanto i rapporti giuridici facenti capo ad uno dei “Fondi” gestiti a richiedere una ristrutturazione complessiva in funzione della prevenzione della dichiarazione giudiziale di insolvenza del “Fondo” prevista dall’art. 57, co. 6 bis, T.U.F. (ipotesi che potremmo definire “crisi del Fondo”, e per la quale non pare coerente escludere l’applicabilità di procedure di composizione della “crisi” del “Fondo”, in una situazione nella quale risulta normativamente applicabile una procedura concorsuale di liquidazione dello stesso “Fondo”, allorché “incapiente”).
Nei primi due casi (“crisi della SGR” per indebitamento diretto; “crisi della SGR” conseguente all’indebitamento di un “Fondo” gestito), come si dirà meglio in appresso, si può dubitare che la Società di Gestione del Risparmio possa richiedere l’ammissione al Concordato preventivo, stante il divieto di massima del ricorso alle procedure concorsuali di diritto comune per gli intermediari bancari e finanziari – e non sia costretta invece a fare ricorso alle misure di “risoluzione” delle crisi previste dalla normativa finanziaria di settore -.
Ma almeno nel terzo caso la conclusione – come si dirà – potrebbe dovere essere diversa, trattandosi di una procedura concorsuale che (benché necessariamente richiesta, nel caso di specie, da un intermediario finanziario), non investirebbe rapporti giuridici instaurati con “risparmiatori”, o con “investitori” finanziari, o con fruitori di “servizi di investimento”, bensì attività e passività di natura squisitamente commerciale (nei casi dei FCI immobiliari, attività e passività tipiche di una impresa commerciale operante nel settore immobiliare).
9.2. La soluzione alla quale si aderisce – soluzione secondo la quale ben può una SGR affrontare la situazione di “crisi” di un FCI, dalla stessa gestito, mediante il ricorso allo “Accordo” ex art. 57 CCI con i creditori del Fondo stesso –, era stata sostenuta, come si è detto, dalle uniche decisioni pubblicate, che risultino pronunciate in materia[35]. Maggiori incertezze sono individuabili in dottrina[36].
A tale proposito, può avere contribuito a pervenire alla soluzione positiva, per quanto concerne la giurisprudenza citata, la considerazione che, al postutto, la stessa SGR avrebbe potuto ricorrere alla misura dello “Accordo” ex art. art. 57 CCI[37], in virtù della ritenuta inapplicabilità del divieto di accesso a “procedure concorsuali” diverse dalla L.C.A. di diritto speciale (bancario) – cfr. art. 80, co. 6, T.U.B., reso applicabile (anche) alla SGR dall’art. 57, co. 3, T.U.F. -, grazie alla negazione della natura di “procedura concorsuale” alla figura dell’Accordo di Ristrutturazione[38]. E’ da valutare allora se a diversa conclusione debba pervenirsi, allorché si passi a considerare il contenuto di alcune decisioni della Corte di Cassazione[39], le quali affermano l’appartenenza dello “Accordo” ex art. 182-bis l.fall. (oggi art. 57 CCI) “agli istituti del diritto concorsuale” – salvo precisare subito dopo che si trova al limite estremo di quel sistema di “cerchi concentrici” in cui si risolverebbe “la sfera della concorsualità”[40] – . Tanto più è necessario porsi questo dubbio, laddove si consideri come lo stesso Tribunale di Milano precedentemente citato oggi giudichi “ora non più condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità e del successivo CCII” la conclusione alla quale esso era pervenuto in precedenza, ovverossia di negare la natura di “procedura concorsuale“ all’Accordo di Ristrutturazione[41].
A parere di chi scrive la risposta al quesito se la originaria soluzione interpretativa debba essere modificata deve essere comunque negativa, per due principali ragioni:
- le decisioni richiamate non convincono (o non convincono più) nel “giustificare” la innovativa presa di posizione sul delicato e rilevante problema interpretativo della natura giuridica dell’Accordo di Ristrutturazione [42]; e
- a tutto concedere, sottratta alle “procedure concorsuali” di diritto comune sarebbe la regolazione della “crisi” della SGR (disciplinata per l’appunto nell’art. 57 co. 3, T.U.F.): non già la regolazione della “crisi” del Fondo.
A tale proposito occorre sottolineare che la disciplina della crisi della SGR in quanto tale è integrata dal rinvio (cfr. art. 57, co. 3, T.U.F.) ad una serie di norme del Testo Unico Bancario, fra le quali è compreso “l’articolo 80, comma da 3 a 6“.
La disciplina della “crisi” del FCI gestito da una SGR già assoggettata ad una serie di norme del T.U.B. è integrata da un analogo rinvio (cfr. art. 57, co. 3-bis, T.U.F) ad una serie di altre norme, tra le quali non compare (proprio e soltanto) l’art. 80, comma 6, T.U.B. (la disposizione cioè che esclude la applicabilità agli intermediari bancari e finanziari delle “procedure concorsuali” di diritto comune)[43].
La disciplina della crisi del FCI, quando ne ricorra il presupposto di legge (insufficienza delle attività a soddisfare le passività), è ricavata dall’art. 57, co. 6-bis, per rinvio al comma 3 – bis), e non – al postutto – al comma 3. Se ne desume che il FCI non è sottratto, di per sé, “alle procedure concorsuali” di diritto comune, perché non deve registrare l’applicabilità dell’art. 80, co. 6, T.U.B.[44].
10. Il Concordato Preventivo
Una volta acquisito il principio secondo il quale l’art. 57, co.6-bis, T.U.F. “apre nettamente lo scenario di un impiego – sempre per il solo Fondo… – di strumenti alternativi di soluzione della crisi, senza che si debba affermare in alcun modo come presupposto necessario lo stato di crisi della SGR medesima (che quindi ben può attuare tali strumenti quando la crisi investa il Fondo in sé e non la SGR)” [45], si pone il problema se tra tali “strumenti alternativi” possa annoverarsi anche il Concordato preventivo.
Si oppongono a pervenire ad una conclusione positiva almeno due argomenti:
- la indubbia natura di “procedura concorsuale” del Concordato preventivo, con conseguente possibilità di operatività del “divieto” di cui all’art. 80, co. 6, T.U.B.; e
- la previsione normativa, per lo meno nelle situazioni di crisi caratterizzate da “incapienza patrimoniale”, della procedura – diciamo così – di C.A. del “Fondo“, disciplinata dall’art. 57, co. 6-bis, T.U.F..
Trattasi di argomenti indubbiamente solidi, rispetto ai quali qualche considerazione critica è tuttavia formulabile.
Quanto al primo argomento, abbiamo già osservato (supra, n. 9) che il rinvio dell’art. 56, co. 6-bis, T.U.F., alla disciplina del comma 3 – bis della norma (e non a quello del comma 3) non ricomprende il richiamo (nel comma 3 – bis effettivamente assente) all’art. 80, co. 6, T.U.B., cioè al “divieto” illustrato. La crisi del F.C.I. non risulta quindi sottratta alle “procedure concorsuali” diverse dalla L.C.A. bancaria, per cui non sarebbe precluso alla SGR chiedere l’ammissione del Fondo – inter alia – al Concordato preventivo.
Quanto al secondo argomento, occorre tenere in considerazione due circostanze: la prima, rappresentata dal fatto che l’ammissione al Concordato non è prevista per il solo caso di insolvenza (o di “incapienza”), ma anche per il meno grave “stato di crisi” (anche reversibile); la seconda, rappresentata dal principio generale di diritto concorsuale, secondo il quale “se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di Concordato preventivo…” (art. 296 CCI): per cui, in assenza del richiamo dell’art. 80, co. 6, T.U.B.; alla luce dell’ambito di applicazione della Procedura di Concordato; e constatata la mancanza di norme che dispongano diversamente dal richiamato art. 296 CCI, l’ammissione al Concordato preventivo del Fondo dovrebbe essere consentita:
- nelle situazioni di “crisi” diverse dalla incapienza patrimoniale (tipicamente, le crisi di liquidità, caratteristiche, tra l’altro, dei F.C.I. immobiliari dei nostri tempi); e
- anche nelle situazioni di “crisi” contemplate dall’art. 56, co. 6-bis, T.U.F., nonostante l’assoggettabilità a L.C.A. (diciamo così) del Fondo, allorché tale procedura non sia ancora stata aperta.
Depongono per una lettura del complesso apparato normativo propensa a favorire l’ammissibilità del FCI al Concordato preventivo, piuttosto che a negarla, almeno tre considerazioni di fondo:
- la duttilità, la modernità e la speciale attenzione a tutelare il valore della “continuità aziendale” – pur sempre in funzione del maggiore soddisfacimento dei creditori – che caratterizzano la disciplina dell’odierno Concordato preventivo, di cui parrebbe opportuno consentire di giovarsi al maggior numero di “operatori” possibile;
- la mancanza, nelle situazioni di “crisi” dei F.C.I., delle esigenze di carattere generale che giustificano una disciplina delle procedure di crisi “di diritto speciale”. Le banche, le SGR, le SIM, eccetera, sono oggetto di una disciplina (anche) concorsuale speciale, perché coinvolgono – inter alia – l’interesse costituzionalmente protetto della tutela del risparmio (anche nelle forme del risparmio gestito con modalità collettive, o “in monte”). La tutela di tale valore può rimanere affidata al mantenimento di una disciplina speciale della gestione (e della stessa “liquidazione”) della SGR: mentre non giustifica una disciplina concorsuale speciale (delle situazioni di crisi) dei patrimoni separati facenti capo ai singoli Fondi. Sono questi patrimoni, se si considera la fattispecie giudicata di maggior interesse – quella dei Fondi immobiliari -, impegnati nell’esercizio di attività d’impresa di diritto comune (le attività immobiliari nelle diverse declinazioni dell’investimento funzionale al conseguimento di un reddito – gli affitti – ; dell’investimento funzionale a sviluppare una attività industriale propriamente detta – la edificazione e successiva vendita del costruito -; dell’investimento funzionale all’attività di intermediazione immobiliare): attività alla soluzione delle cui situazioni di crisi ben può attagliarsi il ricorso agli istituti di diritto comune, anziché il (necessario ed impeditivo) ricorso agli istituti concorsuali di diritto speciale, per la semplice ragione che i creditori coinvolti nel tentativo di superamento della “crisi” non sono per niente riconducibili ai “risparmiatori”;
- la circostanza che identico risultato (l’ammissibilità del Fondo al Concordato preventivo) può essere conseguito dalle SGR attraverso il conferimento del patrimonio del Fondo a una società di capitali di diritto comune, ed il successivo deposito di una domanda di Concordato preventivo da parte di quest’ultima. La situazione di crisi già manifestatasi in capo al Fondo potrebbe in questo modo venire indubitabilmente affrontata con lo strumento del Concordato preventivo (della società conferitaria). Non si vede allora perché escludere il ricorso all’istituto in questione in via diretta, con quanto di più accentuata efficacia ciò potrebbe assicurare in termini di maggiore celerità, minore complessità “organizzativa”, risparmio di costi inutili (specialmente fiscali).
[1] Dal momento che presupposto della domanda di conferma delle “misure protettive” è rappresentato dalla pubblicazione della “accettazione dell’esperto” (articolo 18, co. 1, CCI), si può affermare che la ammissibilità della domanda stessa è condizionata all’intervenuta valutazione positiva della legittimazione del richiedente ad avviare la procedura di CNC, ad opera della competente Commissione.
[2] Supra, Nota 1): se la competente Commissione ha proceduto alla nomina dell’Esperto, ciò implica un giudizio positivo sull’ammissibilità del richiedente ad avviare la Composizione Negoziata, comprensiva della facoltà di richiedere la conferma delle “misure protettive” prodotte dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese.
[3] Nei termini che saranno rappresentati in appresso: infra. n. 10.
[4] “Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d’Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d’Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d’Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l’articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l’amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione”.
[5] Trib. Milano, 10 giugno 2016, n. 7232, in Diritto bancario, ottobre 2016; BARBANTI SILVA, Alcune riflessioni in merito alla natura dei Fondi Comuni di Investimento, in Diritto bancario, marzo 2013. In argomento v. anche BASILE, La soggettività dei Fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano, in Riv. Dir. Banc., 2017 (1), 2 ss. – testo e note 4)-8) -.
[6] CARRIERE, op. loc. ultt. citt.
[7] Postulandone l’estraneità alla categoria delle “procedure concorsuali”: infra, n. 7.
[8] Art. 80, co. 3, T.U.B., richiamato dall’art. 75, co. 3, T.U.F.: in argomento infra, n. 10.
[9] PAOLINI, Fondi Comuni di Investimento, SGR e trascrizione, Studio n 90-2012/I, in Diritto bancario, gennaio 2013
[10] Utilizzando questo approccio l’A. citata alla nota precedente risolve in senso positivo il quesito della “soggettivizzazione“ del Fondo al fine di dare applicazione alla disciplina della trascrizione immobiliare, con riguardo alla pubblicità concernente gli atti di disposizione di beni immobili acquistati nell’interesse del Fondo, ovvero venduti, sempre nel suo interesse.
[11] In argomento v. BASILE, La soggettività dei Fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano, in Riv. Dir. Banc., 2017 (1), 8 ss. – testo e nota 20) -.
[12] PAOLINI, Fondi Comuni di Investimento, SGR e trascrizione, Studio n 90-2012/I, in Diritto bancario, gennaio 2013, p. 7.
[13] Difformemente, pertanto, da quanto previsto per i “patrimoni destinati”: cfr. art. 2447 quinqiues, co.3, seconda parte, c.c.
[14] Cfr. Cass., 15 luglio 2010, n. 16605
[15] Trib. Milano, 10 giugno 2016, n° 7237, in Diritto bancario, ottobre 2016
[16] Cass. 15 luglio 2010, n. 16605 : “I fondi comuni d’investimento (nella specie un fondo immobiliare chiuso) costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio che li ha istituiti, con la conseguenza che, in caso di acquisto immobiliare operato nell’interesse di un fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla suindicata società di gestione”. In argomento v. BONFATTI, La situazione di “crisi” dei Fondi Comuni di Investimento (immobiliare) e le conseguenze della scadenza del “Fondo”, Riv. Dir. Banc., 2018 (ottobre/dicembre), 791 ss.; ID., La disciplina particolare della liquidazione coatta amministrativa delle SGR. La liquidazione giudiziale del fondo o del comparto insolvente, in Riv. Dir. Banc., 2013 (settembre).
[17] In questo senso, sia pure accompagnata da importanti precisazione, la conclusione, in dottrina, di G. Ferri junior, Soggettività giuridica e autonomia patrimoniale dei Fondi comuni di investimento, in Orizzonti del Diritto Commerciale: “In altri termini, il fondo comune, e proprio in quanto sprovvisto di soggettività giuridica, risulta inidoneo ad assumere la posizione di titolare di situazioni giuridiche soggettive, tanto attive quanto passive: quella di gestione è infatti una attività svolta dalla società bensì per conto del fondo, e cioè nell’interesse dei suoi partecipanti, ma pur sempre in nome proprio, con la conseguenza che la titolarità tanto dei diritti acquistati, quanto degli obblighi assunti (come pure della relativa responsabilità) nel corso della gestione deve riferirsi, in via esclusiva, alla medesima società; lo dimostra, ancora una volta, l’art. 36, comma 6, T.U.F., nella parte in cui, al fine di individuare le obbligazioni da esso garantite, non solo si riferisce a quelle “contratte” (ma sarebbe stato meglio dire “assunte”) dalla società “per conto del fondo”, e dunque in nome pur sempre proprio: ma dispone che di esse è la società (e non il fondo, come invece avrebbe potuto far ritenere, se letteralmente intesa, la formulazione introdotta con il citato D. L. n. 78 del 2010), a rispondere, e proprio in veste di (unico) debitore, per quanto “esclusivamente con il patrimonio del fondo” (un’espressione, quest’ultima, che allora si presta ad essere intesa nel significato di patrimonio “costituito” dal fondo, non anche in quello di patrimonio ad esso “appartenente”); né, del resto, appare possibile invocare, in contrario, la circostanza che il fondo risulta comunque dotato di una denominazione (art. 37, comma 2, lett. a, T.U.F.): quest’ultima, infatti, non indica affatto il nome del fondo, come tale destinato ad essere speso dalla società come nome altrui nei confronti dei terzi, ma rappresenta un mero strumento per identificare l’interesse per conto del quale è stato posto in essere (pur sempre in nome proprio) il singolo atto di gestione e, conseguentemente, la relativa massa patrimoniale.
[18] “.. non avendo il fondo soggettività giuridica ….”
[19] G. Ferri junior, Soggettività giuridica e autonomia patrimoniale dei Fondi comuni di investimento, in Orizzonti del Diritto Commerciale.
[20] G. Ferri junior, op. ult. cit.
[21] L’A. in commento giustifica la propria conclusione in un primo momento mettendo in dubbio la ” natura non imprenditoriale, e comunque non commerciale, dell’attività di gestione del fondo”: per poi contrapporre la “attività di investimento” alla ” attività di impresa”: dove pertanto non è del tutto chiaro se la “carenza” denunciata, a proposito dell’attività di gestione del Fondo Comune di Investimento posta in essere dalla SGR sia rappresentata dalla mancanza di imprenditorialità ovvero dalla mancanza di commercialità.
[22] Cfr. art. 25-quater CCI)
[23] In argomento BONFATTI, La flessibilità dello strumento (della “Composizione Negoziata”), in Il ruolo dell’Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, a cura di S. Bonfatti, R. Guidotti, M. Tarabusi, coordinato da G. Barvas, II^ edizione, Milano, 2023,7 ss.
[24] “La SGR, pur libera nella scelta dei singoli atti gestori, è però vincolata anzitutto nel fine, trattandosi di una gestione “nell’interesse dei partecipanti” [artt. 36 comma 4, 40 comma 1 lett. a) e comma 2 TUF], ma anche nei “metodi”, trattandosi di gestione connotata dall’assunzione degli obblighi e delle responsabilità del mandatario (art. 36 comma 5 TUF), e nei “contenuti”, segnati dal regolamento” (Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 10 giugno 2016, n.7232)
[25] Da ultimo BONFATTI, La flessibilità dello strumento (della “Composizione Negoziata”), in Il ruolo dell’Esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, a cura di S. Bonfatti, R. Guidotti, M. Tarabusi, coordinato da G. Barvas, cit., 10 ss.
[26] BONFATTI, Il Piano Attestato di Risanamento, in S. Bonfatti – P.F. Censoni, Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza, Pisa, 2025, 71 ss., in corso di pubblicazione.
[27] Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 10 giugno 2016, n.7232, cit: “La SGR, pur libera nella scelta dei singoli atti gestori, è però vincolata anzitutto nel fine ….. ma anche nei “metodi”, trattandosi di gestione connotata dall’assunzione degli obblighi e delle responsabilità del mandatario (art. 36 comma 5 TUF) ……”.
[28] L’ordinanza ricorda che “questo stesso Tribunale con decreto emesso in data 5.12.2015 ha accolto, sotto la vigenza della previgente legge fallimentare, l’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 182 bis comma 6 l.f.. depositata dalla società SGR s.p.a. in relazione ad un fondo chiuso d’investimento immobiliare nel corso delle trattative che precedono l’accordo ex art. 182 bis disponendo “nei confronti e a beneficio del Fondo gestito dalla società SGR s.p.a., … il divieto per i creditori e per i terzi di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui suoi beni o di acquisire titoli di prelazione se non concordati”, e sempre questo stesso Tribunale, successivamente, con il decreto emesso in data 10.11.2016, ha accolto la domanda di omologazione dell’accordo ex art. 182-bis l.fall., presentata dalla società di gestione del fondo chiuso di investimento immobiliare; ebbene dalla lettura di entrambi i provvedimenti si evince che la SGR ha agito nell’interesse del fondo e che entrambe le decisioni hanno riguardato la situazione di crisi del fondo, come nel caso di specie; non solo ma dalla lettura di entrambi i provvedimenti emerge che le decisioni sono state adottate in presenza di strumenti disciplinati, la richiesta di “protezione” di cui all’ art. 182 bis co. 6 e l’ADR di cui all’art. 182 bis l.f., così come sarebbe l’accoglimento del presente ricorso in presenza di un percorso stragiudiziale di CNC disciplinato dal CCII; in particolare con il primo provvedimento, per quanto qui interessa, è stata accordata al fondo che si trovava in uno stato di crisi una tutela anticipata del patrimonio nel corso delle trattative che precedevano l’accordo ex art. 182 bis l.f., così come prevista dall’art. 182 bis co. 6 l.f.; con il secondo provvedimento è stato poi omologato l’ADR , disciplinato dall’art. 182 bis l.f., del fondo comune d’investimento; ma a ben vedere è proprio l’ ultimo dei due provvedimenti citati, seppur fondato sul presupposto – ora non più condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità e del successivo CCII – che l’accordo di ristrutturazione non ha natura di procedura concorsuale, ad affermare espressamente quanto qui rileva, ossia che “la …previsione di cui all’art. 57, comma 6-bis, T.U.F., nell’ammettere il Fondo (e non la sola SGR) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (e quindi nel delineare una procedura che investe il Fondo al di là della sua soggettività giuridica), apre nettamente lo scenario di un impiego – sempre per il solo Fondo (ed al di là della sua autonomia soggettiva) – di strumenti alternativi di soluzione della crisi, senza che si debba affermare in alcun modo come presupposto necessario lo stato di crisi della SGR medesima (che quindi ben può attivare tali strumenti quando la crisi investa il Fondo in sé e non la SGR), ed anzi dovendosi concordare con chi lamenta che, diversamente opinando, si dovrebbe rilevare una lacuna normativa nel caso in cui la situazione di crisi che interessasse il Fondo, non fosse pienamente sussumibile nell’art. 57, comma 6-bis; che, in conclusione, deve ritenersi che un Fondo chiuso che si trovi in stato di crisi ben possa – attraverso la SGR che lo rappresenta – fare ricorso allo strumento dell’accordo di ristrutturazione la cui omologa, conseguentemente, potrà avvenire una volta verificato lo stato di crisi del Fondo (e non della SGR) e previa adesione di almeno il 60% dei creditori del Fondo medesimo, considerata la evidente natura imprenditoriale dell’attività che tramite il Fondo viene svolta”.
[29] Infra, n. 10.
[30] La esclusione della natura di “procedura concorsuale” dello “Accordo di Ristrutturazione” anche alla luce di successive modifiche legislative è stata confermata da FABIANI, L’Ipertrofica legislazione concorsuale tra nostalgie e incerte contaminazioni ideologiche, in www.ilcaso.it. In precedenza v. per tutti INZITARI, La disciplina della crisi nel testo Unico Bancario, in Quaderni di Ricerca Giuridica della Banca d’Italia, n. 75, Roma, 2014; e D’AMBROSIO, Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale, in G. Fauceglia e L. Panzani (diretto da), Fallimento e altre procedure concorsuali, IV, Torino 2009, 1802 ss. In argomento v. più diffusamente infra.
[31] La limitazione al solo Concordato preventivo della disciplina che condiziona la legittimità del pagamento di crediti pregressi alla preventiva autorizzazione del tribunale era molto evidente nella previgente versione dell’articolo 100 CCI, che subito all’esordio recitava: ” il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87 ……“. A seguito delle modifiche apportate dal “terzo correttivo” (d. lgs. n. 136/2024) la conclusione è meno immediata, dal momento che viene fatto rinvio in modo più generico alla disciplina della ” domanda di accesso …”, senza ulteriori precisazioni. Tuttavia la limitazione della disciplina in questione al solo Concordato preventivo è facilmente ricavabile dalle circostanze che: (i) tale disciplina è dettata, all’interno del Titolo IV del CCI, nell’ambito della Sezione III del Capo III, intitolato al “Concordato preventivo”; e (ii) tuttora la norma (comma 2) menziona esclusivamente il Concordato (“quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica… al rimborso.. delle rate a scadere del contratto di mutuo… se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato… ha adempiuto alle proprie obbligazioni…”).
[32] CARRIERE, Fondi comuni di investimento tra liquidazione giudiziale e soluzioni negoziali di crisi d’impresa, in Fallimento, 2014 (6), 617 ss..
[33] Lo Schema di Decreto Legislativo recante modifiche del T.U.F. in attuazione della Direttiva CEE 2014/59/UE ha comportato che al comma 6-bis dell’art. 57 sia stato aggiunto il seguente periodo: “Quando il fondo o il comparto sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla fine della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell’incarico dei liquidatori, le spese per l’accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell’attivo, per l’esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico della società stessa. Non si applica l’articolo 92-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del T.U. bancario; il comma 6 del medesimo articolo si applica nel caso in cui non vi siano prospettive di utile realizzo dei beni del fondo o del comparto”.
[34] Trib. Milano, 3 dicembre 2015, in Fallimento, 2016, p. 958 ss. con nota di GRIGO’, Accordi di ristrutturazion dei debiti e fondi comuni di investimento: una possibile “diversa” lettura?; Trib. Milano, 10-17 novembre 2016, n. 20/2016 R.G.
[35] Trib. Milano, 3 dicembre 2015, cit.; Trib. Milano, 10-17 novembre 2016, cit.
[36] CARRIERE, Fondi comuni di investimento tra liquidazione giudiziale e soluzioni negoziali della crisi d’impresa, in Fallimento, 2014 (6), p. 617 ss. Secondo GRIGO’, Accordi di ristrutturazione dei debiti e fondi comuni di investimento: una possibile “diversa” lettura?, in Fallimento, 2016 (8-9), p. 659 ss., la conclusione della prima decisione del Tribunale di Milano (3 dicembre 2015, cit.) potrebbe essere messa in discussione dalla considerazione congiunta: a) del rilievo attribuito da quella decisione all’iniziativa assunta dalla SGR in funzione della anticipazione di una possibile situazione di “crisi” anche propria; b) dalla possibile attribuzione allo “Accordo” della natura di “procedura concorsuale”; e c) dalla sottrazione della SGR alle “procedure concorsuali” di diritto comune (cfr, art. 57, co. 3, T.U.F., che rende applicabile alla L.C.A. degli intermediari finanziari l’art. 80, co. 6, T.U.B., secondo il quale “le banche [e gli intermediari assimilati] non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente Sezione“). Tuttavia, al di là del dissenso che deve essere espresso relativamente alla prospettazione di cui alla lettera b) – cfr. infra – , si deve subito precisare che la seconda (e successiva; e più articolata) pronuncia del Tribunale di Milano – resa nell’ambito dello stesso procedimento omologatorio – conclude che (i) “debba ritenersi condivisibile la ricostruzione dogmatica che nega all’accordo di ristrutturazione la natura di procedure concorsuali“; e (comunque) che la previsione dell’art. 57, co. 6-bis T.U.F., “nell’ammettere il Fondo (e non la sola SGR) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa…apre nettamente lo scenario di un impiego – sempre per il solo Fondo (ed al di là della sua autonomia soggettiva) – di strumenti alternativi di soluzione della crisi“. In argomento anche la già ricordata opinione di BASILE, La soggettività dei Fondi comuni di investimento: appunti a margine della pronuncia del Tribunale di Milano, in Riv. Dir. Banc., 2017 (1), 2 ss. – testo e note 4)-8) -.
[37] Cfr. Trib. Milano, 3 dicembre 2015, cit.
[38] Ex multis, in particolare, Trib. Milano, 10-17 novembre 2016, cit.
[39] Cass., 18 gennaio 2018, n° 1182, in Diritto bancario, gennaio 2018, con nota di BONFATTI, La natura giuridica degli accordi di ristrutturazione; Cass., 25 gennaio 2018, n° 1896, in www.ilcaso.it, gennaio 2018, con nota di BONFATTI, La natura giuridica dei “Piani di Risanamento Attestati” e degli “Accordi di Ristrutturazione”; Cass., 12 aprile 2018, n. 9087.
[40] Cass., 12 aprile 2018, n. 9087
[41] Trib. Milano, 16 luglio 2025: “… è proprio l’ultimo dei due provvedimenti citati, seppur fondato sul presupposto – ora non più condivisibile alla luce della giurisprudenza di legittimità e del successivo CCII – che l’accordo di ristrutturazione non ha natura di procedura concorsuale….”
[42] BONFATTI, La natura giuridica degli “Accordi di Ristrutturazione”, cit.
[43] Tale circostanza è ammessa dalla stessa decisione del Tribunale di Milano, 16 luglio 2025, la quale riconosce che “altrettanto vero è che l’art. 57, co. 3-bis, TUF, cui fa espresso rinvio l’art. 57, co. 6-bis TUF (liquidazione del Fondo), non richiama l’art. 80, co. 6 TUB”.
[44] Contra CARRIERE, op. cit., p. 625, testo e nota 35, in virtù di una interpretazione sistematica volta a considerare applicabile alla L.C.A. del Fondo anche il comma 3, dell’art. 57 T.U.F., e con esso le norme del T.U.B. richiamate (tra le quali l’art. 80 comma 6).
[45] Trib. Milano, 10-17 novembre 2016, cit.