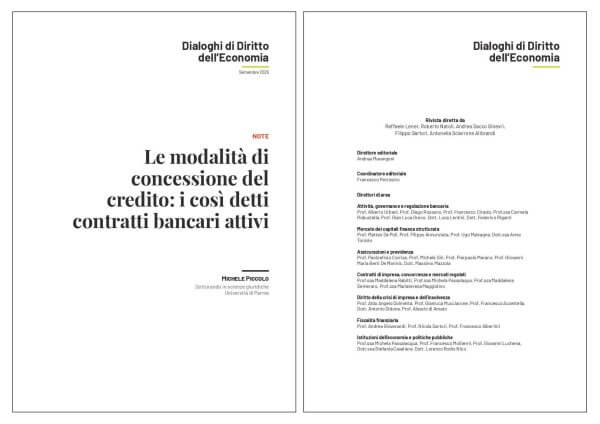SOMMARIO: Dopo una breve introduzione riguardante la forma dei contratti bancari in generale, il presente saggio si preoccupa di analizzare le modalità, a disposizione degli istituti bancari, per esercitare il credito e concederlo alla clientela; in particolare, tra i c.d. contratti bancari attivi, vengono passati in rassegna: il mutuo, con un approfondimento sulla sua necessaria – o meno – realità; l’apertura di credito, della quale viene messa in luce la flessibilità nello svolgimento del rapporto contrattuale; l’anticipazione bancaria, di cui si evidenziano le differenze con il mutuo; infine, lo sconto bancario, del quale viene ricostruita la struttura giuridica, confrontandola con quella di altri contratti quali l’anticipazione al salvo buon fine e il factoring.
ABSTRACT: After a brief introduction concerning the form of banking contracts in general, this essay analyses the methods available to banking institutions for exercising credit and granting it to customers. In particular, among the so-called active banking contracts, the following are reviewed: mortgages, with an in-depth analysis of their necessary – or unnecessary – reality; credit facilities, highlighting their flexibility in the performance of the contractual relationship; bank advances, highlighting the differences with mortgages; and finally, bank discounts, reconstructing their legal structure and comparing it with that of other contracts such as advance payments subject to successful completion and factoring contracts.
1. La forma delle operazioni bancarie. I c.d. contratti mono firma.
Gli artt. 115 ss., D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) contengono la normativa generale in materia di trasparenza bancaria[1].
In particolare, l’art. 117, primo comma, T.U.B. regolamenta la forma dei contratti bancari, stabilendo che essi siano redatti per iscritto, e che un loro esemplare venga consegnato ai clienti[2]; tale forma è prescritta ad substantiam, poiché il terzo comma della disposizione in esame sanziona la sua inosservanza con la nullità del contratto[3].
Tale nullità è relativa, cioè protettiva del cliente, poiché l’art. 127 T.U.B. prevede che essa operi soltanto a vantaggio di quest’ultimo, pur potendo anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, T.U.B., il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (c.d. C.I.C.R.) può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma; tale facoltà è stata sfruttata, ad esempio, in tema di apertura di credito, consentendo la conclusione di quest’ultima in forma orale ove essa si inscriva entro la cornice più generale di un contratto di conto corrente bancario che già contempli, a determinate condizioni, la possibilità di stipularla[4].
Sempre a proposito della forma del contratto, bisogna evidenziare che, in passato, si discuteva in merito alla validità dei c.d. contratti mono firma, cioè di quei contratti sottoscritti dal cliente, ma non dall’istituto di credito; la questione è stata risolta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, prima in materia di intermediazione finanziaria[5], e poi con riferimento ai contratti bancari[6], ha affermato che il requisito di forma possa ritenersi soddisfatto anche senza la sottoscrizione dell’istituto finanziario, essendo sufficiente la redazione per iscritto del contratto, la sua sottoscrizione da parte del cliente e la consegna, ad egli, di una copia del contratto stesso, potendo desumersi, il consenso della banca, anche da comportamenti concludenti, poiché, come sopra ricordato, la sanzione della nullità opera solo in un’ottica di protezione del cliente, il quale, avendo firmato il contratto e ricevuto una copia di esso, non abbisogna, sul punto, di una ulteriore tutela[7].
2. Il mutuo: caratteristiche e disciplina. Approfondimento del mutuo come contratto reale.
Nell’immaginario collettivo, il contratto di mutuo[8] è, non a torto, la principale modalità di concessione del credito, nonché la più diffusa tra le operazioni bancarie attive; queste ultime formano l’esercizio del credito da parte delle banche, il quale, insieme alla raccolta del risparmio tra il pubblico a mezzo delle c.d. operazioni bancarie passive, dà luogo, ai sensi dell’art. 10, primo comma, T.U.B., all’attività bancaria.
Nonostante il fatto che il campo di utilizzo in assoluto più frequente sia di certo quello bancario, in realtà, in astratto, un contratto di mutuo potrebbe essere stipulato anche tra due soggetti, per così dire, privati; in altri termini, non è necessario, per la stipulazione di tale contratto, che una delle parti sia un istituto bancario. La conferma di ciò si trae dal Codice civile, il quale disciplina il mutuo, che è, quindi, un contratto tipico, al Libro IV, Titolo III, Capo XV, e non al successivo Capo XVII, il quale è dedicato espressamente ai contratti bancari e fornisce, invece, la disciplina dei contratti di cui ai paragrafi successivi.
Venendo alla nozione di mutuo, l’art. 1813 cod. civ. lo definisce come il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e quest’ultima si obbliga a restituire alla prima altrettante cose della stessa specie e qualità[9]; sebbene nel contesto bancario l’oggetto della consegna sia sempre il denaro, in astratto, però, il mutuo può prevedere la traditio anche di altre cose fungibili, intendendosi, per queste ultime, quei beni che vengono in rilievo solo in funzione della loro appartenenza ad un genere: lo stesso denaro, bene fungibile per eccellenza, viene considerato, com’è noto, in quanto appartenente ad una certa valuta, e non con riferimento alla singola banconota.
Un elemento centrale del mutuo è il suo inquadramento all’interno dei contratti ad effetti reali: la proprietà del denaro, o della quantità di cose fungibili, oggetto di consegna, ai sensi dell’art. 1814 cod. civ., si trasferisce dal mutuante al mutuatario, il quale dovrà restituire, nel primo caso, un’egual somma, e, nel secondo caso, il c.d. tantundem eiusdem generis et qualitatis[10].
Una questione altrettanto fondamentale, ma dibattuta, attiene alla realità del mutuo[11]; in particolare, ci si chiede se tale contratto si caratterizzi per essere sempre un contratto reale. La distinzione da tenere presente, quindi, è quella tra contratti consensuali e reali: i primi, tra i quali rientra ad esempio la vendita, sono quelli in cui, ai sensi dell’art. 1376 cod. civ., la proprietà, un diritto reale, o un altro diritto, si trasmette, o si acquista, solamente per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato; i secondi, invece, sono quei contratti che, ai fini del loro perfezionamento, richiedono, oltre allo scambio dei consensi dei contraenti, anche la consegna del bene oggetto del negozio.
L’art. 1813 cod. civ., facendo espresso riferimento all’elemento della traditio, mostra di considerare il mutuo quale contratto reale; d’altra parte, l’art. 1822 cod. civ., in tema di promessa di mutuo, contempla l’ipotesi nella quale le parti si accordano, senza che ancora vi sia la consegna del denaro, nel senso che una di esse dovrà corrispondere all’altra, a titolo di mutuo, una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili: chi promette di dare a mutuo potrà rifiutare l’adempimento della sua obbligazione ove le condizioni patrimoniali dell’altro contraente diventino tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non vengano offerte idonee garanzie in merito alla restituzione medesima[12]. Secondo l’interpretazione prevalente e preferibile, tuttavia, l’art. 1822 cod. civ. non contempla l’ipotesi di una variante consensuale del mutuo, ma prevede il caso del contratto preliminare di mutuo, intendendosi, per quest’ultimo, quel negozio, di cui all’art. 1351 cod. civ., con il quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo, nella specie, per l’appunto, di mutuo[13].
Per rispondere all’interrogativo riguardante la necessaria realità del mutuo è opportuno domandarsi quale sia la ratio sottesa al perfezionamento del contratto mediante la traditio del denaro: infatti, ove quest’ultima rispondesse ad un interesse di carattere pubblicistico, sarebbe pressoché impossibile ammettere la variante consensuale di tale contratto; sembra, invece, che l’interesse tutelato abbia una matrice, solamente, privatistica: normalmente, la consegna del denaro, dal mutuante al mutuatario, è accompagnata dalla concessione di una garanzia reale o personale, quanto alla restituzione, da parte di quest’ultimo nei confronti del primo, della somma mutuata, e, dunque, ancorando il perfezionamento del contratto alla traditio, si permette al mutuante di vincolarsi solo in questo momento, nel quale, per l’appunto, si ha la concessione di una garanzia in suo favore[14].
Dunque, la questione che occorre porsi diventa se le parti, nella loro autonomia contrattuale, possano concludere un mutuo, nel singolo caso di specie, solamente per effetto del loro consenso, dove, quindi, la consegna del denaro, ad opera della parte mutuante, diventa solo un momento esecutivo di un rapporto contrattuale già instauratosi. Secondo l’interpretazione preferibile[15], la possibilità di concludere un mutuo consensuale non connotato da realità si ricaverebbe dai principi generali: un siffatto contratto atipico, da un lato, sicuramente rientrerebbe nella nozione di contratto di cui all’art. 1321 cod. civ. e possiederebbe gli elementi di cui all’art. 1325 cod. civ., e, dall’altro lato, non avrebbe difficoltà a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 1322 cod. civ. per la stipulazione dei contratti atipici, ovvero la liceità e la meritevolezza degli interessi perseguiti[16]; una diversa interpretazione[17], argomentando dalla lettera dell’art. 1813 cod. civ., ritiene invece che il mutuo debba essere sempre connotato da realità, potendosi, al più, optare per una modalità di consegna del denaro piuttosto che per un’altra, contando, effettivamente, solo che il mutuatario consegua la disponibilità giuridica di tale somma, la quale, di solito, viene realizzata con l’accredito di quest’ultima, da parte della banca, sul conto corrente intestato al cliente[18].
A proposito della realità del mutuo, in tema di credito immobiliare ai consumatori, l’art. 120-quinquies, primo comma, lett. c), T.U.B., nel definire il contratto di credito, contempla sia l’ipotesi della concessione immediata del denaro e sia il caso in cui l’istituto di credito si impegna a consegnare tale somma al cliente, prefigurando, di fatto, una vera e propria variante consensuale del contratto di mutuo[19]; con riferimento alle due tesi sopra riportate, si potrebbe sostenere: da una parte, che tale norma apra ad una configurabilità più generalizzata del mutuo consensuale; dall’altra parte, al contrario, che questa disposizione sia sintomatica dell’ammissibilità di tale figura nei soli casi eccezionalmente previsti dalla legge.
Collegato al tema in esame è il c.d. mutuo di scopo[20], nel cui regolamento negoziale sussiste una vera e propria clausola di destinazione della somma mutuata: l’utilizzo che verrà fatto del denaro prestato assume un preciso rilievo causale; in base alla fonte dell’obbligo di destinare il capitale ad una certa finalità, si distingue tra mutui di scopo legale e convenzionale: nei primi il vincolo di scopo è imposto dalla legge, mentre nei secondi è fissato dalle parti[21]. Normalmente, tale tipologia di mutuo si atteggia quale contratto consensuale: infatti, di regola il contratto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, e la consegna della somma attiene unicamente alla successiva esecuzione del rapporto[22].
Con riferimento all’affermazione per cui la consegna del denaro può realizzarsi in qualsiasi modo, purché il mutuatario ottenga la disponibilità giuridica del denaro, occorre sottolineare che tale conclusione è stata riaffermata da due recenti sentenze della Suprema Corte: la prima pronuncia riguarda il c.d. mutuo solutorio, intendendosi, per esso, il contratto di mutuo, solitamente fondiario[23], nel quale la banca accredita la somma sul conto corrente del cliente, ma quest’ultima è immediatamente destinata all’estinzione di una pregressa esposizione debitoria nei confronti della banca medesima[24]; la seconda sentenza, invece, riguarda il caso in cui si convenga, da un lato, l’erogazione della somma al mutuatario e, dall’altro lato, il contestuale versamento di essa alla banca a titolo di pegno o di deposito irregolare, con l’obbligo per quest’ultima di svincolare il denaro, in futuro, a favore del cliente, al verificarsi delle condizioni concordate[25]. Sia nell’uno che nell’altro caso, la Corte afferma che si è in presenza di un vero e proprio contratto di mutuo perfezionatosi mediante la consegna della somma, nonostante le particolari modalità con le quali viene effettuata quest’ultima, poiché, come più volte ricordato, conta solo che il cliente ottenga la disponibilità giuridica del denaro.
Dopo che il mutuante ha consegnato il denaro al mutuatario, su quest’ultimo grava, come detto, l’obbligo di restituire per equivalente la somma concessagli; tuttavia, l’art. 1815 cod. civ. prevede una presunzione di onerosità del contratto di mutuo, nel senso che il mutuatario, salva una diversa volontà delle parti, deve corrispondere al mutuante, in aggiunta al capitale da restituire, gli interessi c.d. corrispettivi.
Gli interessi sono annoverati tra i frutti civili[26], i quali, ai sensi dell’art. 820, terzo comma, cod. civ.[27], sono definiti come quei frutti che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia; essi, ai sensi dell’art. 821, terzo comma, cod. civ., si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (rectius: rapporto).
Il pagamento degli interessi corrispettivi da parte del mutuatario rientra nella normale fisiologia del rapporto e ha la funzione di remunerare la concessione del prestito da parte del mutuante[28]; quanto alla determinazione della misura degli interessi dovuti dal mutuatario, l’art. 1815 c.c., da un lato, rinvia all’art. 1284 cod. civ.[29] e, dall’altro lato, sanziona la eventuale usurarietà degli interessi medesimi con la nullità della clausola che li prevede, di modo che il mutuatario non li debba corrispondere in toto[30].
Un elemento essenziale nello svolgimento del rapporto di mutuo è la presenza di un termine per la restituzione della somma mutuata; difatti, ove il mutuatario fosse tenuto a restituire immediatamente la somma consegnatagli, verrebbe frustrata la funzione del contratto medesimo e l’interesse delle parti, il quale, sul punto, deve essere declinato diversamente a seconda che il mutuo sia oneroso oppure gratuito. Nel primo caso, ai sensi dell’art. 1816 cod. civ., il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti, poiché, da un lato, il mutuatario ha interesse a non poter essere costretto a restituire la somma prima di una certa data, in modo da poterne usufruire e godere, ma, dall’altro lato, è interesse anche del mutuante quello di non vedersi restituito il denaro prima di una certa data, di modo che gli interessi maturino nel tempo e che gli possa lucrare sul capitale come prefiguratosi; nel caso del mutuo gratuito, invece, in forza della norma richiamata e di quanto appena detto, dato che non devono essere corrisposti gli interessi, il termine per la restituzione della somma si presume fissato a favore del solo mutuatario.
L’essenzialità del termine per la restituzione nella struttura del contratto si evince anche da un’altra disposizione: l’art. 1817 cod. civ. stabilisce che, ove le parti non prevedano il termine medesimo, esso venga stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze; tale norma deroga rispetto alla regola di cui all’art. 1183 cod. civ., in base alla quale, ove non sia determinato il tempo in cui la prestazione debba essere eseguita, il creditore possa esigerla immediatamente. Tale deroga si giustifica in ragione di quanto prima ricordato: il termine, nell’economia del mutuo, è fondamentale, e non può mai mancare, venendo, altrimenti, irrimediabilmente compromessa la struttura di tale contratto.
Le obbligazioni, assunte dal mutuatario, di restituire il capitale e di pagare gli interessi sono pecuniarie e, in quanto debiti di valuta, soggiacciono al principio nominalistico di cui all’art. 1277, primo comma, cod. civ.[31], in base al quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e, soprattutto, per il suo valore nominale; ciò significa che il mutuatario deve restituire il capitale nella stessa entità monetaria prestatagli, senza che la somma mutuata debba essere rivalutata alla luce dell’inflazione, e lo stesso vale per gli interessi. Di conseguenza, il rischio dell’inflazione grava per intero sulla banca mutuante, poiché il mutuatario deve restituire il medesimo importo nominale di moneta, a prescindere dal suo diminuito potere di acquisto[32]. Per far fronte alla svalutazione monetaria, gli istituti di credito si avvalgono delle c.d. clausole di indicizzazione, le quali consentono di rivalutare, sulla base di determinati parametri[33], il capitale che il mutuatario deve restituire, oppure, più modernamente e frequentemente, le banche praticano dei tassi di interesse che consentono loro sia di ottenere la remunerazione per il capitale prestato al mutuatario e sia di evitare le conseguenze negative derivanti dall’inflazione monetaria[34].
Infine, è opportuno soffermarsi sulla c.d. portabilità del mutuo[35], disciplinata dall’art. 120-quater T.U.B.[36]: trattasi di un istituto che consente al mutuatario di sostituire la banca mutuante durante il corso del rapporto, e quindi una volta che il contratto di mutuo è già stato stipulato; l’obiettivo del legislatore, dunque, sul punto, è duplice: da un lato, rendere il mutuo già perfezionato un prodotto sostituibile e creare, per così dire, un mercato dei mutui, in modo da stimolare la concorrenza tra le banche non solo nella fase che precede la conclusione di tali contratti, ma anche nel periodo di tempo successivo; dall’altro lato, avvantaggiare il mutuatario, consentendogli di ricercare e accedere a condizioni economiche più vantaggiose, anche dopo aver già stipulato il contratto. La portabilità del mutuo utilizza e riadatta l’istituto della surrogazione per volontà del debitore di cui all’art. 1202 cod. civ., in base al quale, il debitore, che prende a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo, alle seguenti condizioni, valevoli, quindi, anche nel contesto dell’art. 120-quater T.U.B.: il nuovo mutuo deve essere destinato espressamente ad estinguere il precedente, e deve risultare da un atto avente data certa; l’originaria banca deve rilasciare quietanza dell’avvenuto pagamento della somma di cui era creditrice, e anch’essa deve avere data certa; all’interno della quietanza medesima, deve essere obbligatoriamente riportata la dichiarazione del debitore relativa alla provenienza della somma utilizzata per estinguere il vecchio mutuo, il quale, quindi, deve comunicare di aver contratto un mutuo di scopo finalizzato alla chiusura del precedente rapporto; indi, è necessario che il mutuatario dichiari espressamente di voler surrogare il nuovo istituto bancario nelle ragioni del vecchio. Concretamente, la surrogazione per volontà del debitore nel contesto di un’operazione di portabilità di un mutuo bancario può realizzarsi secondo due modalità: può essere concluso un nuovo contratto di mutuo a scopo, con relativa dichiarazione di surrogazione del debitore, e, successivamente e separatamente, si raccoglie la quietanza di pagamento del vecchio istituto di credito; oppure, può confezionarsi un’operazione trilaterale, dove, nel contesto del medesimo atto, si trovano sia il nuovo mutuo, con relativa dichiarazione di surroga, e sia la quietanza della vecchia banca. Un effetto importante della surrogazione è il subentro, ai sensi dell’art. 120-quater, secondo comma, T.U.B., da parte della nuova banca mutuante, nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce; tale previsione è rilevante in specie con riferimento alla garanzia ipotecaria: difatti, rimanendo, l’ipoteca, quella originaria del vecchio mutuo, ecco che all’istituto di credito subentrante non potranno essere opposte eventuali formalità pregiudizievoli trascritte o iscritte sul bene ipotecato prima del perfezionamento dell’operazione di surrogazione[37]. Come anticipato, la portabilità del mutuo riadatta l’istituto della surrogazione per volontà del debitore, rendendolo maggiormente snello e fruibile per il mutuatario; in particolare, da un lato, ai sensi del primo comma della norma in esame, l’utilizzo di tale operazione non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore e, dall’altro lato, per il debitore, la surrogazione dovrà avvenire a costo zero, non potendo comportare alcun onere o spesa a suo carico[38], e, infine, la complessiva operazione di surrogazione deve perfezionarsi entro tempi brevi[39]. Infine, giova porre in evidenza che, fermo restando quanto sopra esposto, la nuova banca alla quale si rivolge il mutuatario è del tutto libera di decidere, col limite generale del principio di buona fede, se surrogarsi o meno al precedente istituto di credito; in questo senso, non sussiste, per il cliente, un diritto alla surrogazione: la banca, come per la stipulazione di qualsiasi contratto di mutuo, valuta il merito creditizio del mutuatario e, poi, decide se finanziare quest’ultimo o meno[40].
3. L’apertura di credito: regolamentazione, peculiarità e flessibilità nell’utilizzo del credito.
L’art. 1842 cod. civ. definisce l’apertura di credito[41] come il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato; il cliente, dal canto suo, ha la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, la somma messagli a disposizione, con l’obbligo, trattandosi di un contratto oneroso[42], di remunerare l’istituto di credito già solo per tale tenuta a disposizione. Essendo espressamente disciplinata, nel Codice civile, all’interno del Capo dedicato ai contratti bancari, l’apertura di credito si caratterizza per essere un contratto tipico.
Trattasi, alla pari del mutuo, di un contratto mediante il quale la banca realizza l’attività di concessione del credito, ma con delle caratteristiche strutturali del tutto diverse: mentre quest’ultimo, come ricordato, è, di norma, un contratto reale che si perfeziona con la dazione del denaro, invece l’apertura di credito è un contratto consensuale, e cioè che si perfeziona in forza del solo accordo tra l’istituto di credito e il cliente[43]; mentre il mutuo, quindi, ha una struttura rigida, il contratto in esame è improntato alla massima flessibilità: il cliente potrà, con la più assoluta libertà e discrezionalità, decidere se avvalersi, o meno, della somma oggetto dell’apertura[44].
Nell’ambito del contratto in esame, il legislatore si è preoccupato di regolamentare in modo approfondito la tematica della remunerazione della banca; quali unici oneri che possono essere imposti dall’istituto di credito al cliente, l’art. 117-bis, primo comma, T.U.B. contempla: da un lato, una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell’affidamento[45]; dall’altro lato, un tasso di interesse debitore da calcolarsi sul denaro effettivamente utilizzato dal cliente. Nel caso in cui il beneficiario dell’apertura superi i limiti dell’affidamento e utilizzi una somma maggiore rispetto a quella tenutagli a disposizione, il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce che si possano prevedere, quali unici oneri a suo carico, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento[46]. Infine, il terzo comma sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito dai due commi appena esaminati, senza che, però, ciò comporti la nullità dell’intero contratto di apertura di credito[47].
Ai sensi dell’art. 1843 cod. civ., nel negozio in esame si distingue tra apertura di credito in conto corrente e apertura di credito semplice[48]; ove le parti non convengano altrimenti, si rientra nella prima fattispecie, la quale è perfettamente in linea con la flessibilità del tipo contrattuale in esame: se il cliente, dopo aver prelevato delle somme, le restituisce alla banca, ecco che egli ripristina la disponibilità in suo favore, potendo, in seguito, nuovamente prelevarle. Qualora l’apertura di credito sia semplice, il cliente, al contrario, non potrà riutilizzare più volte le somme restituite, avendo, la corresponsione di queste ultime, funzione satisfattoria del diritto al rimborso dell’istituto di credito.
4. L’anticipazione bancaria: analisi delle peculiarità contrattuali e dell’utilizzo di titoli o merci come garanzie.
L’anticipazione bancaria non è espressamente definita dal legislatore, ma gli interpreti, concordemente, ritengono che si tratti di quel contratto bancario mediante il quale l’istituto di credito concede una somma di denaro a favore del cliente, e quest’ultimo, a sua volta, a garanzia dell’obbligo di restituirla con gli interessi e con ogni accessorio convenuto, concede in pegno alla banca titoli, merci o depositi di denaro[49]; tale contratto, nella recente prassi bancaria, non trova largo impiego, poiché gli vengono preferiti altri istituti, come, ad esempio, un’apertura di credito garantita.
Una delle connotazioni essenziali dell’anticipazione bancaria è la sua flessibilità, la quale emerge dal disposto dell’art. 1849 cod. civ.: il cliente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i beni dati in pegno alla banca, previo rimborso proporzionale del denaro anticipato da quest’ultima e delle altre somme ad essa spettanti[50]; dunque, il debitore ha una possibilità che, normalmente, non spetta a chi concede in pegno dei beni, e cioè quella di realizzare in modo agevole lo svincolo, anche solo parziale, dei beni oggetto della garanzia pignoratizia, e ciò senza che venga interrotto il rapporto di credito instaurato con la banca.
L’anticipazione bancaria, a seconda delle modalità con le quali viene erogato il credito, può atteggiarsi quale contratto consensuale o reale: nel primo caso, l’istituto bancario si limita a tenere a disposizione del cliente una certa somma, e quest’ultimo è titolare del diritto potestativo di utilizzarla, o meno; laddove, invece, si preveda nel contratto l’effettiva consegna del denaro al momento della sua conclusione, dovrebbe trattarsi di un contratto reale[51].
Trattasi di un contratto bancario bilaterale, cioè che comporta l’insorgenza di obbligazioni sia per l’istituto di credito anticipante che per il cliente anticipato: da un lato, il primo eroga una determinata somma nei confronti del secondo o si impegna a tenergliela a disposizione; dall’altro lato, il debitore deve, in primis, concedere i beni in pegno alla banca e, in secundis, rimborsarle il denaro concretamente utilizzato e pagarle gli interessi, le commissioni e gli accessori dell’operazione, la quale, quindi, si sostanzia in un contratto oneroso. Normalmente, l’anticipazione bancaria è a tempo determinato, poiché, di regola, viene convenuto un termine decorso il quale il debitore deve restituire all’istituto di credito il capitale effettivamente utilizzato.
Nel contratto in esame si deroga al principio di accessorietà delle garanzie: il pegno è un elemento essenziale indefettibile nell’architettura negoziale dell’anticipazione bancaria, e assume un preciso rilievo causale. L’art. 2794, primo comma, cod. civ. prevede che colui che ha costituito il pegno non può esigere la restituzione dei beni oppignorati, ove non siano stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non siano state rimborsate le spese relative al debito e al pegno; in aggiunta, l’art. 2799 cod. civ. stabilisce che il pegno è indivisibile e che garantisce il credito finché quest’ultimo non viene integralmente soddisfatto, ancorché il debito, o la cosa data in pegno, sia divisibile. Tali disposizioni vengono derogate nell’ambito del negozio in esame, poiché, come accennato, ai sensi dell’art. 1849 cod. civ., il cliente ha la possibilità di rimborsare parzialmente e anticipatamente la somma concessa dall’istituto bancario, in modo tale da ottenere la restituzione di parte dei beni concessi in garanzia, purché, come ricordato, venga rispettato il principio di proporzionalità tra il valore della somma anticipata non ancora restituita e quello dei beni che permangono in garanzia.
Il legislatore restringe l’ambito dei beni che possono essere concessi in garanzia ai titoli, alle merci e ai depositi di denaro, con l’obiettivo di far sì che il pegno possa avere ad oggetto solo beni facilmente negoziabili, di modo che la banca possa agevolmente determinarne il valore di mercato nella valutazione della finanziabilità del cliente[52]. L’istituto di credito deve provvedere alla custodia dei beni consegnatigli, ma le spese sostenute verranno rimborsate dal cliente[53].
In merito alle modalità con le quali l’istituto di credito eroga il denaro, l’anticipazione bancaria può essere semplice oppure regolata in conto corrente: nel primo caso, il contratto prevede che la banca eroghi al cliente l’intero capitale e, come anticipato, si discute in merito alla realità, o meno, di tale schema contrattuale[54]; ove l’anticipazione bancaria, invece, venga regolata in conto corrente, il contratto è consensuale e si caratterizza per una maggiore dinamicità e flessibilità, poiché l’istituto bancario mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ed egli può effettuare uno o più prelievi e ripristinare la disponibilità in suo favore con dei successivi versamenti[55].
Un’altra distinzione significativa è tra anticipazione bancaria propria e impropria[56], e attiene alla forma della garanzia concessa dal cliente: nella prima, si ha un pegno regolare e i beni concessi in garanzia non sono nella disponibilità della banca, mentre nella seconda viene costituito un pegno irregolare col quale l’istituto di credito consegue la disponibilità, e, anzi, la proprietà, dei beni concessi in garanzia dal cliente; dall’art. 1846 cod. civ. si ricava che l’anticipazione sia impropria in due casi: nell’ipotesi in cui la banca non rilasci un documento nel quale le cose date in pegno siano individuate precisamente, e nel caso in cui vi sia, sul punto, una precisa pattuizione, da provarsi per iscritto. Ove si opti per l’anticipazione bancaria impropria, come ricordato, il cliente non dovrà rimborsare alla banca le spese per la custodia dei beni concessi in garanzia, poiché essi sono di proprietà di quest’ultima[57].
5. Lo sconto bancario: natura giuridica e disciplina contrattuale. Esame del contratto di sconto come modalità di finanziamento e differenze con il factoring.
Ai sensi dell’art. 1858 cod. civ., lo sconto[58] è il contratto con il quale l’istituto bancario, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito medesimo; dunque, in questo contratto bancario vi è un sinallagma rappresentato dallo scambio tra una liquidità attuale e un’altra futura: da un lato, la banca, trattenendo gli interessi e quindi remunerandosi subito, anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora divenuto esigibile e, dall’altro lato, il cliente le cede pro solvendo il credito medesimo.
Pur trattandosi di un contratto normativamente previsto, lo sconto non è disciplinato in modo organico dal legislatore codicistico; dunque, la sua regolamentazione è affidata in via principale alla prassi negoziale.
Sebbene un’interpretazione abbia sostenuto che lo sconto bancario possa atteggiarsi quale contratto consensuale, l’opinione tradizionale, e preferibile, ritiene che si tratti di un contratto reale, il cui perfezionamento richiede la consegna della somma di denaro dall’istituto di credito scontante al cliente scontatario[59].
Quanto alla sua natura giuridica, sono state formulate diverse interpretazioni[60]: una prima tesi ha sostenuto che lo sconto rappresenti una compravendita di crediti, ma la funzione creditizia dello sconto mal si concilia con la sua qualificazione in termini di semplice cessione onerosa di crediti; una seconda prospettazione qualifica tale negozio come un mutuo garantito da una cessione di crediti pro solvendo, ma, in realtà, da un lato, al contrario di quello che accade nel mutuo, nello sconto la banca non viene pagata dal cliente, ma dal debitore ceduto, e, dall’altro lato, la cessione del credito non ha una mera funzione di garanzia, ma è essenziale nel meccanismo negoziale dello sconto; infine, l’interpretazione preferibile rileva che non si è tenuti a ricondurre il negozio in esame entro degli schemi già noti, trattandosi, infatti, di un autonomo contratto tipico[61].
Il meccanismo sul quale poggia il funzionamento dello sconto bancario, come anticipato, è quello della cessione di credito, con conseguente applicazione della disciplina che regolamenta quest’ultima; in specie, l’art. 1264, primo comma, cod. civ. prevede che la cessione medesima abbia effetto nei confronti del debitore ceduto quando quest’ultimo l’abbia accettata o quando gli sia stata notificata[62].
La necessità di osservare tutte queste formalità riconnesse alla cessione di credito mal si concilia con le esigenze di certezza e di speditezza dei rapporti tra banca e cliente; di conseguenza, potrebbe rivelarsi utile impiegare, al posto dello sconto bancario, la c.d. anticipazione (o finanziamento) al salvo buon fine: trattasi di un contratto atipico, ma socialmente diffuso, nel quale, da una parte, la banca anticipa al cliente l’importo di un certo credito di cui egli è titolare e, dall’altra parte, quest’ultimo conferisce alla prima un mandato in rem propriam, cioè concesso nell’interesse anche della stessa banca, e quindi irrevocabile, alla riscossione di quel credito[63]. Dunque, a differenza dello sconto, la remunerazione della banca è successiva e, soprattutto, agendo quest’ultima come semplice mandataria del cliente, non sussiste la necessità di rispettare le citate formalità riconnesse alla cessione del credito[64].
Piuttosto che stipulare un singolo contratto di sconto bancario, è più probabile che, a monte, l’istituto di credito e il cliente predispongano un c.d. castelletto di sconto: si tratta di una cornice entro la quale si collocano le singole operazioni di sconto. Più tecnicamente, trattasi di un contratto normativo con il quale la banca si obbliga a scontare al cliente, dopo averne verificato la bancabilità, i crediti non ancora scaduti che egli via via le presenterà, dietro cessione di questi ultimi[65].
La disposizione di cui all’art. 1267, primo comma, cod. civ. prevede, da un lato, che il cedente non risponda della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia[66], e, dall’altro lato, che, qualora tale assunzione vi sia, il medesimo cedente risponda solo nei limiti del corrispettivo ottenuto dalla cessione; invece, nello sconto bancario: in primis, la cessione avviene necessariamente pro solvendo, con il cliente che garantisce alla banca l’esistenza del credito e la solvibilità del debitore ceduto; in secundis, qualora, alla scadenza del credito, la banca chieda al debitore il pagamento ed egli non adempia, ella potrà rivolgersi al cliente domandandogli la corresponsione, non solo e non tanto della somma anticipatagli, ma dell’intero importo del credito, il cui pagamento è stato chiesto al debitore ceduto. Ove quest’ultimo non adempia e una volta che, al suo posto, lo scontatario abbia corrisposto alla banca l’importo del debito, si perfeziona la retrocessione del credito in favore del cliente, ed egli potrà agire nei confronti del debitore; dunque, è come se la cessione del credito tra lo scontatario e la banca fosse risolutivamente condizionata al mancato pagamento del debitore ceduto e all’adempimento, in sua vece, del cliente, il quale torna ad essere titolare del credito, potendolo in tal modo azionare nei confronti del debitore inadempiente.
Infine, giova confrontare lo sconto bancario con il factoring[67]: quest’ultimo è il contratto col quale una banca, o un intermediario finanziario, il c.d. factor, si obbliga ad acquistare da un imprenditore i crediti di quest’ultimo, anticipandone l’importo, previa deduzione di una somma pari agli interessi e alla commissione per la futura gestione dei crediti medesimi; questo istituto, nell’ordinamento italiano, è parzialmente disciplinato dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52, concernente la cessione di crediti da parte delle imprese. Sebbene il meccanismo negoziale di funzionamento dei due contratti sia, a grandi linee, sovrapponibile, diverse sono le peculiarità che contraddistinguono il factoring rispetto allo sconto[68]: in primis, come emerge dalla nozione appena riportata, diverso è il campo di applicazione[69]; in secundis, mentre lo sconto può riguardare anche un solo credito, invece, in linea di principio, con il factoring si cede la globalità, o comunque una parte, dei crediti dell’imprenditore, esistenti o futuri, anche in massa e, potenzialmente, anche sorgenti da contratti non ancora stipulati[70]; in aggiunta, solitamente il factor, quale cessionario, si impegna a gestire il credito, provvedendo, oltre che alla riscossione, anche alla generale tenuta dei rapporti con i debitori, mentre questa componente gestoria difetta nello sconto bancario; ancora, mentre nello sconto il cliente garantisce la banca pro solvendo con riferimento all’intero importo del credito ceduto, nel factoring il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo pattuito per la cessione, con la possibilità, tra l’altro, che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, a tale garanzia[71]; infine, con riferimento all’opponibilità ai terzi della cessione, mentre nello sconto devono essere osservate le descritte formalità di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., nel factoring, invece, è sufficiente che il cessionario paghi, in tutto o in parte, il corrispettivo della cessione, e che il pagamento abbia data certa[72].
[1] In argomento, v. S. Mazzamuto, I contratti bancari: un’introduzione, in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, Torino, 2016, pp. XIX ss.
[2] L’art. 20, comma 1-bis, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. C.A.D.) afferma che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l’efficacia prevista dall’art. 2702 cod. civ. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato attraverso un processo avente i caratteri descritti dalla disposizione in esame. In tutti gli altri casi, si aggiunge, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. Sul punto, cfr. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, in Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Bologna, 2024, pp. 144-146; in generale, sulla forma, si veda P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 138-140.
[3] In connessione con il requisito di forma, si prevedono, sempre nel disposto dell’art. 117 T.U.B.: al quarto comma, il c.d. principio di completezza, in base al quale i contratti debbono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; al sesto comma, il divieto di rinvio agli usi e il c.d. principio di conformità del contratto alle condizioni pubblicizzate, poiché si statuisce che sono nulle, e si considerano come non apposte, le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli, per i clienti, di quelli pubblicizzati. Il settimo comma della medesima disposizione, infine, stabilisce quali siano le conseguenze in caso di violazione dei commi quarto e sesto, con un meccanismo che prevede la nullità parziale del contratto, con riferimento alle clausole in contrasto con tali regole, e l’integrazione coattiva ex lege di esso con condizioni di sfavore per l’istituto bancario.
[4] Infatti, il C.I.C.R., con la delibera del 4 marzo 2003, n. 286, relativa alla Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari, ha previsto che la Banca d’Italia può individuare forme diverse da quella scritta, tra l’altro, per l’ipotesi in cui si tratti di operazioni e servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto; disposizione, questa, riprodotta nelle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 24 luglio 2003 (Sez. 3ª, n. 2, lett. a)). In questi termini, v. R. Teti, Dell’apertura di credito bancario. Artt. 1842-1845, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2005, p. 63.
In merito alla possibilità, o meno, di stipulare un’apertura di credito per fatti concludenti, si veda R. Teti, Dell’apertura di credito bancario. Artt. 1842-1845, cit., pp. 70-79.
[5] V. Cass., Sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, in DeJure, a proposito dell’art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.).
[6] Cfr.: Cass., 29 novembre 2018, n. 30885, in DeJure; Cass., 2 aprile 2021, n. 9196, in DeJure.
[7] In tal senso, si veda P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 140-141, testo e nota 207.
[8] In argomento, v.: S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, Torino, 2016, pp. 169 ss.; M. Tatarano, Il mutuo bancario, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, pp. 1133 ss.; P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., passim.
[9] Cfr. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 1 ss.
[10] In questo senso, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 171-172.
[11] Sul punto, v. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 85 ss.
[12] Per tutti, v. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 724 ss.
[13] In questi termini, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., p. 174.
[14] Cfr. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 176-177.
[15] Cfr. M. Tatarano, Il mutuo bancario, cit., pp. 1144-1147, dove si enuclea anche la figura, piuttosto diffusa nella prassi, del c.d. mutuo unilaterale, espressione con la quale non si intende fare riferimento allo schema di cui all’art. 1333 c.c., ma ad una proposta contrattuale di mutuo, proveniente dall’istituto bancario, portata all’attenzione del notaio, davanti al quale compare solamente il mutuatario, che, mediante la sottoscrizione dell’atto notarile che riproduce il contenuto della proposta medesima, la accetta ai sensi dell’art. 1326 c.c.
[16] In tal senso, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 175-176.
[17] Cfr. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., p. 176, in cui si afferma che tale opinione sia ancora quella prevalente.
[18] In questi termini, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 177-178.
[19] Cfr. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., p. 179, testo e nota 35.
[20] In argomento, v.: S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 194 ss.; M. Tatarano, Mutuo di scopo e mutuo fondiario tra patologie e rimedi, Napoli, 2022, passim.
[21] Tale distinzione assume un rilievo particolare durante un’eventuale fase patologica del rapporto: ove lo scopo sia legale e i contraenti si accordino nel senso di non impiegare le somme per l’utilizzo previsto dalla legge, la causa del contratto sarebbe illecita ai sensi dell’art. 1343 cod. civ. e, quindi, il contratto sarebbe nullo in forza dell’art. 1418, secondo comma, cod. civ.; dall’altra parte, per tutte le tipologie di mutuo di scopo, ove il mutuatario non utilizzi il denaro per il fine previsto, si giustifica l’utilizzo del rimedio della risoluzione del contratto di cui all’art. 1453 cod. civ.
Dunque, la differenza sta in questo: mentre, a fronte del mancato utilizzo della somma da parte del mutuatario per lo scopo prefissato, la risoluzione del contratto può essere invocata in tutti i mutui di scopo; invece, la questione dell’illiceità della causa può sorgere solo nel caso in cui venga stipulato, tra le parti, un patto di distrazione del denaro dallo scopo individuato dal legislatore.
[22] Un esempio classico del contratto in esame è il c.d. mutuo a stato avanzamento lavori (o mutuo S.A.L), dove la somma viene erogata per la costruzione, o la ristrutturazione, di un fabbricato, non in un’unica soluzione, ma in più tranches; per consentire all’istituto bancario di controllare efficacemente che il denaro prestato venga effettivamente utilizzato per la finalità concordata, ogni successiva erogazione avviene solo se, volta per volta, le opere siano arrivate al punto stabilito.
[23] In questo senso, v. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 129-130; di regola, il nuovo mutuo è fondiario, ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B., poiché, in tal modo, la banca può contare sul fatto che, decorsi solamente dieci giorni dall’iscrizione, in suo favore, dell’ipoteca a garanzia del proprio credito, quest’ultima, ai sensi degli artt. 39, quarto comma, T.U.B. e 166, quarto comma, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. C.C.I.I.), si consolida e non può essere assoggettata all’azione revocatoria di cui alla disposizione da ultimo menzionata.
In argomento, per la questione relativa alla sorte del mutuo fondiario accordato per un ammontare eccedente il limite di cui all’art. 38 T.U.B., si veda P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 314 ss.
[24] Cfr. Cass., Sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, in DeJure, dove si afferma il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Dunque, con la sentenza in questione, da una parte, si ammette la validità del mutuo solutorio medesimo e, dall’altra parte, si riconosce che esso possa costituire un valido titolo esecutivo; per un commento alla pronuncia, si veda Cass., Sez. un., 5 marzo 2025, n. 5841, in Giurisprudenza Notarile, con nota di G. Brighina, Mutuo solutorio, passim.
[25] Cfr. Cass., Sez. un., 6 marzo 2025, n. 5968, in DeJure, nella quale viene formulato tale principio di diritto: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
[26] L’altra tipologia di frutti è rappresentata da quelli naturali, i quali, ai sensi dell’art. 820, primo comma, cod. civ., provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere; essi, finchè non avviene la separazione dalla cosa della quale formano parte, costituiscono parte integrante di quest’ultima.
[27] Altri esempi di frutti civili richiamati dalla norma in questione, oltre agli interessi sui capitali, sono: i canoni di locazione, quelli enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita.
[28] Essi, quindi, differiscono dagli interessi moratori, i quali, invece, sono dovuti nell’eventualità patologica di un ritardo nell’adempimento da parte del mutuatario.
[29] La disposizione prevede che il Ministro del tesoro, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può determinarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno; qualora entro la data indicata non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. La norma aggiunge, da una parte, che allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, ove le parti non ne abbiano determinato la misura e, dall’altra parte, che gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto, altrimenti essi sono dovuti nella misura legale.
Con riferimento alle diverse tipologie di mutuo, dal punto di vista delle modalità di corresponsione degli interessi (mutui a tasso fisso, a tasso variabile ecc.), v.: S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 184 ss.; P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 444 ss. e 649 ss.
[30] In merito al modo con cui si determina se gli interessi previsti in un contratto siano usurari o meno, v. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 474 ss.
[31] In questo senso, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., p. 182.
[32] In astratto, sul mutuatario grava il rischio opposto, ossia quello della deflazione, in base alla quale egli si ritroverebbe a restituire una somma di denaro di valore nominale pari a quella prestatagli, ma con un potere di acquisto più elevato; tuttavia, mentre, nella storia economica, l’inflazione è la regola, la deflazione è l’eccezione.
[33] Esempi di clausole di indicizzazione sono: la “clausola oro”, dove la restituzione della somma mutuata viene agganciata al variare del valore dell’oro; la “clausola valuta estera”, nella quale si parametra il capitale da restituire ad una certa quantità di moneta estera; la “clausola merci”, in cui la somma da restituire viene rivalutata alla luce delle oscillazioni del valore di un paniere di merci, dove il più utilizzato è il “paniere Istat”.
[34] In questi termini, v. S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 183-184.
[35] In argomento, v.: S. Cherti, Il mutuo (tra Codice civile e legislazione speciale), cit., pp. 190 ss.; P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., pp. 566 ss.
[36] Ai sensi del primo e del nono comma, il campo di applicazione ricomprende i contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o microimprese e, anche, i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti, mentre sono esclusi i contratti di locazione finanziaria.
Al quinto comma, la disposizione in esame fa comunque salva la c.d. rinegoziazione, e cioè la possibilità del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.
[37] Ai sensi dell’art. 120-quater, terzo comma, secondo periodo, T.U.B., l’annotamento della surrogazione, a margine dell’ipoteca iscritta a favore dell’originaria banca mutuante, può essere richiesto al conservatore dei registri immobiliari senza formalità, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.
[38] Nello specifico, l’art. 120-quater T.U.B.: al terzo comma, prevede che la surrogazione comporti il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura; al quarto comma, si stabilisce che non possano essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di surrogazione; al sesto comma, si prevede la nullità di ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione, senza che la nullità del patto comporti la nullità del contratto; infine, all’ottavo comma si aggiunge che la surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
[39] Nello specifico, ai sensi del settimo comma della norma in oggetto, entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di trenta giorni lavorativi, per cause dovute al finanziatore originario, aggiunge la disposizione, quest’ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’uno per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
[40] In questi termini, v. P. L. Fausti, Art. 1813-1822. Mutuo, cit., p. 582.
Seppur in altro ambito, di recente la Suprema Corte ha ribadito l’importanza di una corretta valutazione del merito creditizio, evidenziandone il collegamento con la diligenza qualificata, che deve essere tenuta dall’istituto bancario, di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.; sul punto, cfr. Cass., 8 ottobre 2024, n. 26248, in DeJure.
[41] In argomento, v.: R. Teti, Dell’apertura di credito bancario. Artt. 1842-1845, cit., passim; C. Verde, L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria, in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, Torino, 2016, pp. 71 ss.; G. Porcelli, L’apertura di credito bancario, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, pp. 1215 ss.
[42] Dal punto di vista delle obbligazioni insorgenti per le parti, si tratta di un contratto bilaterale: da un lato, la banca deve tenere a disposizione del cliente una certa somma ed erogargliela ove egli ne faccia richiesta; dall’altro lato, il cliente medesimo è tenuto a remunerare l’istituto di credito sia per la provvista messagli a disposizione che per il denaro effettivamente utilizzato.
A ciò è collegata la rilevanza, nel contesto dell’apertura di credito, dell’intuitus personae: la banca concede la disponibilità della provvista sulla base di valutazioni che ineriscono la persona del cliente.
[43] Si sottolinea che, anche qualora il mutuo si perfezioni in ragione del solo consenso delle parti, come nel caso del mutuo di scopo, la sua struttura differisce, ad ogni modo, da quella dell’apertura di credito: nel primo, la banca si obbliga a consegnare la somma pattuita, la quale, quindi, verrà sicuramente consegnata al cliente; nella seconda, invece, la corresponsione della somma è meramente eventuale, obbligandosi unicamente, l’istituto di credito, a tenere il denaro a disposizione del cliente, il quale, esercitando un diritto potestativo, potrà scegliere liberamente di fruire, o meno, in tutto o in parte, della provvista messagli a disposizione.
L’apertura di credito differisce, altresì, dalla promessa di mutuo di cui all’art. 1822 cod. civ.: quest’ultima si sostanzia in un preliminare col quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto di mutuo in forza del quale la banca consegnerà la somma al cliente; invece, la prima costituisce un contratto già definitivo, in ragione del quale l’istituto di credito di obbliga a tenere il denaro a disposizione del cliente e ad erogarglielo a sua richiesta.
[44] Comunque, la descritta flessibilità non si attaglia, per forza di cose, alle esigenze di tutte le persone: un cliente che volesse prendere in prestito una somma per l’acquisto, ad esempio, della sua casa di abitazione, non sarà portato a stipulare un’apertura di credito; viceversa, tale contratto diventa molto utile nel contesto, più fluido, dell’attività di impresa, dove, con la sua stipulazione, l’imprenditore può fare affidamento sulla somma di denaro tenutagli a disposizione per affrontare le eventuali ed imprevedibili fasi avverse dei cicli economici.
[45] La disposizione in esame aggiunge: da una parte, che nel singolo contratto di apertura di credito la commissione debba essere determinata in coerenza con quanto stabilito dal C.I.C.R.; dall’altra parte, che, ad ogni modo, il suo importo non possa superare lo zero virgola cinque per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
[46] In tema di sconfinamento nel credito al consumo: da un lato, l’art. 125-octies T.U.B. prevede che si applichi il medesimo art. 117-bis T.U.B.; dall’altro lato, l’art. 1, comma 1-ter, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62, stabilisce che la commissione di cui all’art. 117-bis, secondo comma, T.U.B. non si applichi alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a cinquecento euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.
[47] Il quarto comma della norma prevede che il C.I.C.R. adotti disposizioni applicative dello stesso art. 117-bis T.U.B.; l’art. 27-bis, primo comma, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevede la nullità delle clausole contrattuali che contemplino commissioni, a favore delle banche, in contrasto con tali disposizioni applicative.
[48] Sul punto, v. C. Verde, L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria, cit., pp. 79-80.
[49] In argomento, v.: C. Verde, L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria, cit., pp. 98 ss.; V. Farina, L’anticipazione bancaria, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, pp. 1433 ss.
[50] Nel contesto dell’anticipazione bancaria, è essenziale il rispetto di un principio di proporzionalità tra il valore dei beni oppignorati e quello della somma anticipata; tale proporzione deve rimanere costante durante tutto il corso del rapporto, anche se, ai sensi dell’art. 1850 cod. civ., sussiste una soglia di tolleranza del dieci per certo, il c.d. scarto, all’interno della quale un’eventuale alterazione non è rilevante.
[51] Tuttavia, un’altra interpretazione ritiene che il contratto resti consensuale e che la traditio del capitale costituisca un mero momento esecutivo di un rapporto già sorto in seguito alla stipulazione del contratto medesimo; sul punto, v. C. Verde, L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria, cit., p. 99. Ad ogni modo, la rilevanza pratica del problema è assai modesta, poiché, come ricordato, l’anticipazione bancaria può essere conclusa nella variante meramente consensuale.
[52] In questo modo, tra l’altro, sarà facile, per il cliente, rientrare nella disponibilità dei beni concessi in garanzia e non sarà complicato, per la banca, liquidarli qualora si tratti di tutelare le proprie ragioni.
Quanto ai titoli, normalmente vengono concessi in pegno dei titoli di massa, come le azioni e le obbligazioni delle società, i titoli di stato e le quote dei fondi comuni di investimento; quanto alle merci, trattasi di beni fungibili non facilmente deteriorabili, potendo essere oggetto di pegno, tra l’altro, anche i titoli che le rappresentano, come una polizza di carico o una fede di deposito.
[53] L’art. 1847 cod. civ. specifica che la banca deve provvedere per conto del contraente all’assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l’ubicazione di esse, l’assicurazione risponde alle cautele d’uso. D’altra parte, l’art. 1848 cod. civ. prevede che, come anticipato, l’istituto di credito, oltre al corrispettivo dovutogli, abbia diritto anche al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità; quest’ultimo inciso sottolinea che le spese accessorie sostenute dall’istituto di credito non debbano essere rimborsate, dal cliente, nel caso di anticipazione bancaria impropria, poiché, come si vedrà, in quest’ultima la banca diventa proprietaria dei beni che le vengono consegnati dal debitore.
[54] Anche nel contratto di mutuo la restituzione del capitale prestato può essere garantita dalla concessione di un pegno, ma la differenza, rispetto all’anticipazione bancaria, è che nel primo valgono le regole generali di cui agli artt. 2794 e 2799 cod. civ., in base alle quali, come ricordato, il pegno non è divisibile e i beni oppignorati non possono essere restituiti in conseguenza di un rimborso parziale del capitale da parte del cliente, ma devono restare vincolati per l’intero fino alla integrale restituzione del capitale, degli interessi e degli accessori; viceversa, la peculiarità del contratto in esame è proprio la possibilità di un ritiro parziale delle cose concesse in garanzia a fronte di un rimborso, altrettanto parziale, effettuato dal cliente.
[55] Dato che viene tenuta a disposizione del cliente una certa somma di denaro, l’anticipazione bancaria in conto corrente assomiglia all’apertura di credito, in particolare ove quest’ultima sia garantita da un pegno; nondimeno, permangono delle evidenti differenze tra di esse: in quest’ultima, la garanzia non è un elemento essenziale, cioè potrebbe esserci un’apertura di credito anche allo scoperto; inoltre, come previsto dall’art. 1844, primo comma, cod. civ., la garanzia concessa rimane ferma per l’intera durata del rapporto contrattuale, indipendentemente dal fatto che vengano effettuati, o meno, dei prelievi o dei rimborsi parziali. Al contrario, come ricordato, nell’anticipazione bancaria il pegno, quale elemento indefettibile nell’economia del contratto, assume un preciso rilievo causale e il cliente può ottenere lo smobilizzo di parte dei beni concessi in garanzia tramite delle restituzioni parziali.
Inoltre, diversa è la disciplina nel caso in cui i beni oppignorati vedano ridotto il loro valore: nell’apertura di credito, l’art. 1844, secondo comma, cod. civ. stabilisce che, se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di quest’ultima o, a seconda dei casi, la sostituzione del garante e, se il cliente non ottempera alla richiesta, ella può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto; viceversa, in tema di anticipazione bancaria, l’art. 1850 cod. civ., ponendo maggiore enfasi sulla proporzione che deve sussistere tra il valore dei beni pignorati e quello della somma concessa dalla banca, prevede che, ove il valore della garanzia diminuisca almeno di un decimo rispetto a quello che sussisteva al tempo della stipulazione del contratto, l’istituto bancario possa chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso, aggiungendo, da un lato, che, se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma dell’art. 2797, secondo e quarto comma, cod. civ. e, dall’altro lato, che quest’ultima ha comunque il diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita medesima.
[56] Sul punto, v. C. Verde, L’apertura di credito e l’anticipazione bancaria, cit., pp. 104-105.
[57] Un’altra differenza di disciplina riguarda l’ipotesi in cui il valore dei beni concessi in garanzia diminuisca oltre lo scarto: nell’anticipazione bancaria propria, come ricordato, l’istituto di credito può chiedere un supplemento di garanzia e, ove il debitore non vi ottemperi, egli potrà procedere alla vendita in via coattiva dei beni oppignorati e domandare il rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita. Nell’anticipazione bancaria impropria, ferma restando la possibilità di chiedere un supplemento di garanzia, la banca, invece, ove il cliente non vi dia seguito, non avrà la necessità di procedere con la vendita coattiva delle cose consegnatele, poiché ella si è già soddisfatta mediante l’acquisto della proprietà dei beni; ad ogni modo, resta salva, anche in tal caso, l’azione per il valore residuo del credito non soddisfatto.
Il legislatore non regolamenta l’ipotesi in cui il valore delle cose concesse in garanzia, invece che diminuire, aumenti; si ritiene che, in tal caso, il cliente possa domandare alla banca lo smobilizzo dell’eccedenza dei beni rispetto al valore del debito, senza dover procedere ad alcun rimborso.
Infine, un’ulteriore differenza attiene a ciò che accade al momento della scadenza del termine del contratto: nell’anticipazione propria, da un lato il cliente corrisponde alla banca il capitale, gli interessi e ogni accessorio dovuto, e, dall’altro lato, quest’ultima riconsegna al primo i beni oppignorati; nell’anticipazione impropria, invece, essendo la banca proprietaria delle cose ricevute in consegna, allora, all’esito del rapporto, si verifica una vicenda latamente compensatoria tra il valore del debito e quello dei beni oppignorati, cosicchè l’istituto di credito debba effettuare la restituzione delle cose al cliente solo nella misura dell’eccedenza del loro valore rispetto all’ammontare della somma anticipata.
In ragione, probabilmente, della sua complessità, l’anticipazione bancaria impropria è poco diffusa nella prassi.
[58] In argomento, v.: R. Marseglia, Lo sconto, in I contratti bancari, a cura di F. Piraino e S. Cherti, Torino, 2016, pp. 107 ss.; G. W. Romagno, Dello sconto bancario. Artt. 1858-1860, in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2017, passim; E. Capobianco, Lo sconto bancario, in Contratti bancari, a cura di E. Capobianco, Milano, 2021, pp. 1471 ss.
[59] Sul punto, cfr. R. Marseglia, Lo sconto, cit., pp. 119 ss.
[60] Per una più ampia ricostruzione del dibattito, v. R. Marseglia, Lo sconto, cit., pp. 113-119.
[61] In senso analogo, v. E. Capobianco, Lo sconto bancario, cit., pp. 1478-1481.
[62] L’art. 1264, secondo comma, cod. civ. aggiunge che, comunque, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo fosse a conoscenza dell’avvenuta cessione; inoltre, l’art. 1265, primo comma, cod. civ. prevede che, ove il medesimo credito abbia formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata accettata per prima da quest’ultimo con atto avente data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
[63] Cfr. G. W. Romagno, Dello sconto bancario. Artt. 1858-1860, cit., pp. 142 ss.
[64] Anche lo sconto di cambiali, previsto dall’art. 1859 cod. civ., permette di evitare tutti gli impacci derivanti dalla cessione del credito di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., essendo sufficiente effettuare, al fine del trasferimento del credito medesimo, la consegna della cambiale alla banca con la relativa girata in suo favore e la precedente serie continua di girate.
[65] L’equivalente del castelletto di sconto, nel contesto dell’anticipazione al salvo buon fine, è l’affidamento per lo smobilizzo dei crediti, con il quale la banca si obbliga ad anticipare al cliente l’importo dei crediti che egli le esibirà volta per volta, dietro conferimento, per ciascuno di essi, del mandato in rem propriam al loro incasso. In entrambe le tipologie di contratto normativo, l’istituto di credito potrà successivamente rifiutarsi di corrispondere al cliente l’importo del credito presentato solo qualora ricorra un giustificato motivo, e cioè nel caso in cui la verifica della bancabilità del credito medesimo abbia condotto ad un esito negativo.
[66] In altre parole, la regola generale è che la cessione del credito, salva una diversa pattuizione, avvenga pro soluto, e che quindi il cedente, ai sensi dell’art. 1266, primo comma, cod. civ., garantisca al cessionario la sola esistenza del credito al tempo della cessione.
[67] Per una trattazione approfondita di questo istituto, si veda A Natale – P. Piccoli, Il factoring, in Le vicende traslative del credito, a cura di A. Natale, Milano, 2020, pp. 257 ss.
[68] A tal proposito, v. R. Marseglia, Lo sconto, cit., pp. 135 ss.
[69] L’art. 1, primo comma, L. 21 febbraio 1991, n. 52 fa riferimento alle cessioni di crediti nelle quali: il cedente è un imprenditore; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; il cessionario è una banca o un intermediario finanziario. Lo sconto, invece, ha, quali parti, da un lato un istituto bancario e, dall’altro lato, un cliente, senza ulteriori specificazioni, e, in particolare, senza che quest’ultimo debba per forza essere un imprenditore.
Il secondo comma della disposizione precisa che, per le cessioni di credito prive dei requisiti illustrati, resta salva l’applicazione delle norme del Codice civile.
[70] L’art. 3, terzo comma, L. 21 febbraio 1991, n. 52 precisa che la cessione in massa di crediti futuri possa avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
[71] Questo, ai sensi dell’art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 52. Nel caso dello sconto, quindi, si dice che la garanzia offerta dal cliente è satisfattoria, mentre, nel caso del factoring, come più in generale per la cessione pro solvendo di cui all’art. 1267 cod. civ., essendo la garanzia limitata al corrispettivo ricevuto, si afferma che quest’ultima sia restitutoria.
[72] In tal modo, ai sensi dell’art. 5, primo comma, L. 21 febbraio 1991, n. 52, la cessione è opponibile: agli aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi anteriormente alla data del pagamento; al creditore del cedente che abbia pignorato il credito dopo la data del pagamento; alla liquidazione giudiziale del cedente dichiarata dopo la data del pagamento. Tale normativa è agevolante, soprattutto nel caso in cui i crediti da cedere in blocco siano molti. In aggiunta, la restante parte della disposizione in esame prevede: al comma 1-bis, che, ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento, sia sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente; al secondo comma, che è fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal Codice civile; al terzo comma, che viene fatta salva l’efficacia liberatoria, secondo le norme del Codice civile, dei pagamenti eseguiti dal debitore a terzi.