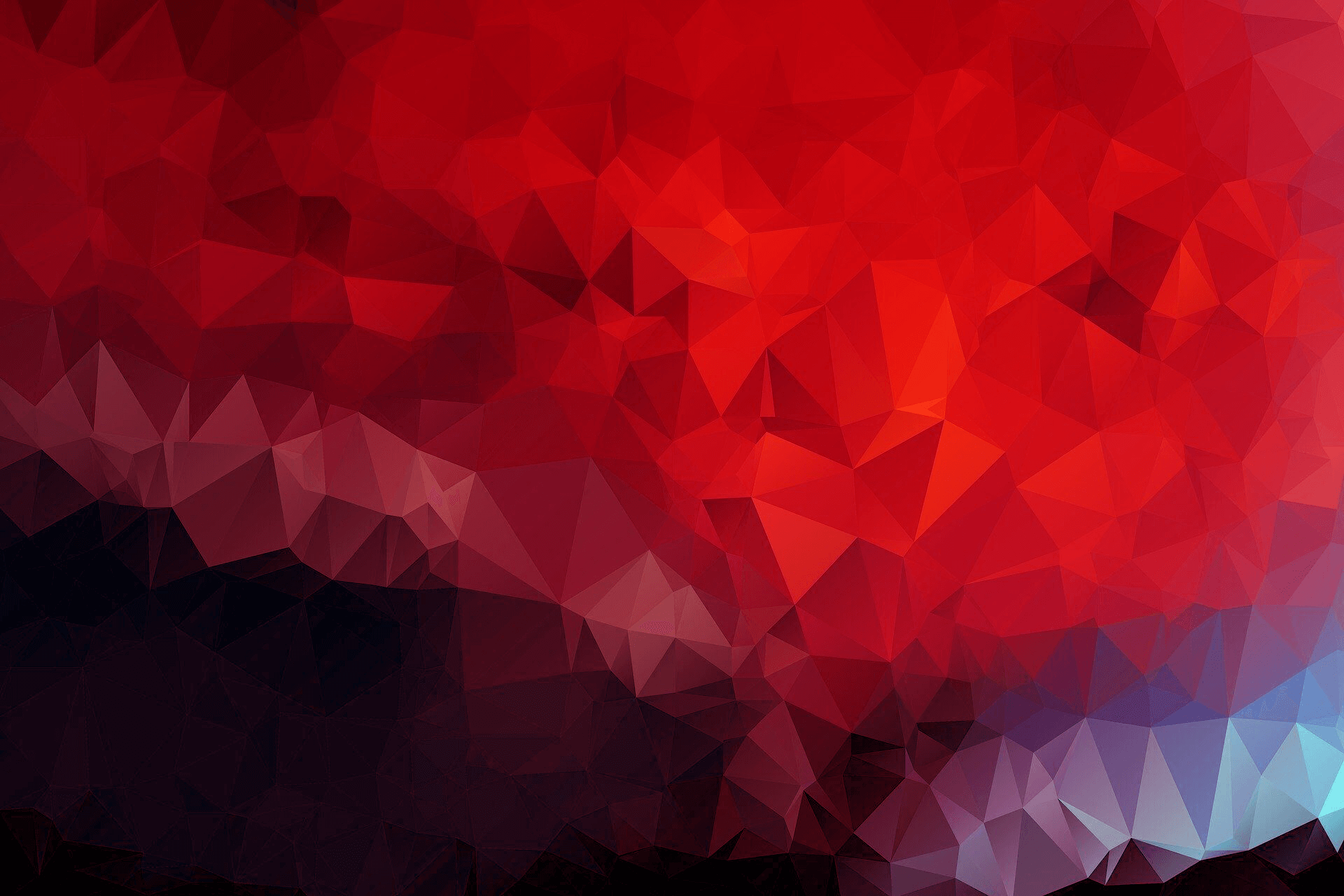Il presente contributo fornisce un quadro di sintesi delle recenti vicende legate al tema dei golden power, da ultimo interessato dalla notizia dei giorni scorsi dell’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione delle norme sulla concorrenza.
1. La lettera di costituzione in mora e l’apertura della procedura di infrazione
Il 21 novembre 2025 la Commissione Europea ha reso note con una sintesi panoramica per settori dall’ambiente al lavoro, agli affari marittimi, all’immigrazione una serie di decisioni rilevanti assunte a novembre su infrazioni commesse da diversi Stati Membri.
L’Italia è fatta oggetto di una procedura di infrazione (INFR(2025)2152) avviata dalla Commissione UE nell’ambito del settore finanziario (“Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali”) per violazione del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio sulla competenza della BCE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, della direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE), e degli articoli 49 e 63 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Gli articoli 49 e 63 del TFUE vietano rispettivamente le restrizioni alla libertà di stabilimento e le limitazioni alla libertà di movimento dei capitali tra gli Stati Membri.
Strumento di tale paventata violazione è il d.l. n. 21/2012, come modificato nel 2021 e nel 2022, recante la disciplina del cosiddetto “Golden Power” che – detto sinteticamente – conferisce alcuni poteri interdittivi e conformativi al governo italiano (analogamente a quanto accade anche in altri paesi europei e segnatamente Francia e Germania), in sede di controllo dell’afflusso di investimenti esteri, e quindi di operazioni societarie, di acquisizione o trasferimento di partecipazioni significative o di controllo o anche di complessi di beni e di singoli assets, in diversi settori industriali e finanziari qualificati come strategici, al fine di garantire la sicurezza pubblica nazionale.
2. Il caso concreto: l’OPS di Unicredit su BPM
Il caso specifico che ha dato luogo all’intervento della Commissione è, come noto, il decreto del 18 aprile 2025 (d’ora in poi anche il “Decreto”) con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (“PCM”) ha esercitato i poteri speciali mediante penetranti prescrizioni, dettate ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 21/2012, in relazione alla offerta pubblica di scambio (“OPS”) promossa da Unicredit e avente ad oggetto la totalità delle azioni di Banco BPM. La novità del provvedimento e l’ampio dibattito che ne è seguito, ha riguardato sia il contenuto specifico delle prescrizioni dettate dalla PCM sia il fatto stesso che oggetto dell’intervento pubblico fosse un investimento di una società italiana in altra società italiana e quindi di un investimento intra-UE oltre che tutto nazionale sia quanto alla società target (BPM) sia quanto alla società offerente (Unicredit), definendosi italiana qualsiasi società che abbia in Italia il luogo della propria costituzione o la propria sede principale (articolo 25 della legge n. 218/1995 e indirettamente art. 2508 c.c.).
Su ricorso di Unicredit, il Decreto è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio che si è pronunziato con sentenza del 12 luglio 2025 sostanzialmente confermando l’impianto e la motivazione del provvedimento governativo, caratterizzato da alta discrezionalità, salvo alcuni aspetti di minore importanza, come in appresso si vedrà.
Appena due giorni dopo il 14 luglio 2025, la Commissione europea ha inviato al Governo Italiano una lettera contenente una “valutazione preliminare” a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del protocollo 21 dell’accordo SEE. Il menzionato articolo 21 prevede infatti che la Commissione UE – che ha di regola competenza esclusiva nella valutazione della compatibilità delle concentrazioni di imprese – possa e debba valutare se ulteriori restrizioni alle concentrazioni che siano adottate dagli Stati Membri, quali ad esempio i poteri speciali di cui alla normativa “Golden Power”, siano compatibili con il diritto dell’Unione.
Il provvedimento della Commissione UE si concludeva con l’invito all’Italia a presentare le sue osservazioni entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della lettera della stessa Commissione.
Pervenute le osservazioni dell’Italia, la Commissione ha evidentemente ritenuto insoddisfacenti i chiarimenti forniti dalle autorità italiane e ha deciso di intraprendere una procedura di infrazione che contesta la violazione degli articoli 46 e 63 TFUE oltre che della competenza della BCE (art. 127(6) TFUE).
Nel mentre, dopo la decisione sostanzialmente sfavorevole del TAR Lazio il Consiglio di Amministrazione di Unicredit in data 21 luglio 2025 decideva di rinunciare all’OPS.
Nei giorni scorsi, l’11 novembre 2025, la stampa ha dato notizia del deposito dinanzi al Consiglio di Stato del ricorso in appello di Unicredit avverso la menzionata sentenza del TAR Lazio del 12 luglio 2025 che, come si è accennato, ha confermato la legittimità di buona parte della decisione del governo censurando solo due prescrizioni contenute nel Decreto: a) la durata quinquennale dell’obbligo di mantenere invariato il rapporto impieghi/depositi; b) la durata indeterminata dell’obbligo di conservare il portafoglio di project finance della BPM.
3. I contorni dell’infrazione del diritto UE
i. Il quadro normativo interno
Al momento non sono noti né il contenuto del ricorso di Unicredit né, per quanto più direttamente interessa, il contenuto della lettera di costituzione in mora che la Commissione UE ha inoltrato all’Italia ma è possibile ripercorrere alcune tappe del dialogo istituzionale tra autorità al fine di meglio comprendere il nucleo concettuale e normativo dell’infrazione che viene imputata all’Italia.
Si impone un breve excursus storico solo per ricordare che dal momento della sua introduzione nel 2012 il “Golden Power” consisteva in poteri speciali incidenti, come evidente dalla rubrica stessa del decreto legge n. 21/2012, “sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni” e quindi operanti in settori specifici, particolarmente delicati sotto il profilo della sicurezza difensiva e informativa. Solo con il d.l. n. 23/2020[1] in via transitoria e quindi stabilmente con il d.l. 21/2022[2] si prevede che siano soggette a notifica tutte le operazioni anche intracomunitarie o nazionali[3] in ulteriori settori, considerati strategici quali salute, agro-alimentare e finanziario (ossia bancario e assicurativo)[4].
Il d.p.c.m. n. 179/2020 stabilisce quindi quali assets rientrino tra quelli strategici con riferimento al settore creditizio e finanziario e, per quello che qui interessa, prevede all’articolo 8[5], comma 1, lettera c): “le attività economiche di rilevanza strategica finanziarie, creditizie e assicurative, anche se svolte da intermediari, esercitate da imprese che realizzano un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro e aventi un numero medio annuale di dipendenti non inferiore a duecentocinquanta unità.” Si tratta di una disposizione che nel reiterare in modo pleonastico, tautologico, che gli attivi finanziari strategici sono le attività economiche “di rilevanza strategica” include di fatto nel campo di operatività dei poteri speciali e delle operazioni da notificare tutte quelle che abbiano ad oggetto imprese del settore finanziario con fatturato non inferiore a 300 milioni di euro e con un numero medio di dipendenti non inferiore a 250.
Già questo profilo lascia intuire una possibile sovrapposizione di competenze con altre autorità in linea di principio scongiurata dalla diversità funzionale e di competenza tra i controlli della Commissione, sotto il profilo concorrenziale, quelli della BCE, quale autorità competente a rilasciare le autorizzazioni alle acquisizioni bancarie sotto il profilo prudenziale e quelli speciali del governo italiano che invece mirano a prevenire “una minaccia di grave pregiudizio agli interessi nazionali dello Stato ovvero un pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico[6]”.
ii. Il contenuto del Decreto
In concreto, il Decreto del 18 aprile 2025 di esercizio del Golden Power sull’OPS di Unicredit imponeva alla banca offerente il rispetto dei seguenti obblighi, quale condizione dell’approvazione dell’operazione:
- non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impieghi/depositi praticato da BPM e Unicredit in Italia con l’obbiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e PMI nazionali;
- non ridurre il livello del portafoglio attuale di project finance di BPM e Unicredit;
- (i) per almeno cinque anni non ridurre il peso attuale degli investimenti di Anima Holding (gestore del risparmio acquisito da BPM) in titoli di emittenti italiani e (ii) supportare lo sviluppo di Anima Holding;
- cessare tutte le attività in Russia (raccolta, impieghi, collocamento fondi, prestiti transfrontalieri) entro nove mesi dalla data del provvedimento stesso.
La mancanza di una perimetrazione temporale quanto al vincolo sub b) e un difetto di ragionevolezza quanto alla durata quinquennale della prescrizione sub c) sarebbero stati dichiarati illegittimi dalla menzionata sentenza del TAR del 12 luglio 2025 che imporrà al governo la necessità di una più meditata rimodulazione cronologica. Il resto del provvedimento rimarrà intatto decretando di fatto un’incertezza radicale sull’operazione che peserà nella decisione di Unicredit di rinunciare all’OPS.
Più penetranti e diffuse sono le critiche al Decreto sollevate dalla Commissione UE nella “valutazione preliminare“ del 14 luglio 2025.
Come accennato, la Commissione UE, pur competente a vagliare le operazioni di concentrazione sotto il profilo della tutela della concorrenza, non esclude che le medesime operazioni siano scrutinate dagli Stati Membri per la tutela di interessi legittimi dello Stato, tali interessi legittimi essendo: “sicurezza pubblica, pluralità dei mezzi di informazione, le norme prudenziali” (art. 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004). L’autorità deputata a valutare se le misure adottate da uno stato membro riflettono tali interessi anziché costituire un mezzo indiretto per discriminazioni intra-UE, è proprio la Commissione UE.
Inoltre, quanto allo specifico settore degli investimenti diretti che rappresentano all’interno dell’UE una forma di esercizio della libertà di movimento dei capitali ex articolo 63 TFUE, limitazioni nazionali sono possibili se giustificate da ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, così come interpretate dalla Corte di Giustizia e comunque non con lo scopo di perseguire finalità economiche[7].
Osserva la Commissione, quanto alla vigilanza prudenziale sugli istituti di credito, che è noto come il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 attribuisca alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi centralizzandole presso la BCE e così istituendo lo SSM (Single Supervisory Mechanism) deputato ad autorizzare l’acquisizione e i processi di aggregazione di soggetti finanziari vigilati assicurando il rispetto dei requisiti prudenziali[8].
La Commissione UE ha individuato quindi due violazioni, una di carattere procedurale e una di natura sostanziale. La prima consiste nel fatto che l’Italia avrebbe dovuto inviare alla Commissione il Decreto prima che esso entrasse in vigore di modo che il contenuto e gli effetti fossero previamente valutati dalla medesima Commissione. La seconda investe il contenuto del provvedimento che contrasterebbe con le norme sulla circolazione dei capitali, la competenza esclusiva della BCE e del SSM nonché delle normative di cui alla CRD, alla direttiva OICVM, alla direttiva MiFID II e alla direttiva GEFIA.
Difatti, ad avviso della Commissione e per quanto concerne il contenuto del provvedimento, l’Italia non ha fornito le ragioni per cui le prescrizioni sopra riassunte nei punti da a) a d) fossero sorrette da ragioni di tutela della pubblica sicurezza.
Come anticipato, la nozione di pubblica sicurezza, alla luce dell’insegnamento della Corte di Giustizia, è nozione ristretta alla “minaccia effettiva e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società”[9].
Appare arduo sostenere, alla luce di questa cornice normativa, che il semplice cambiamento degli assetti azionari di BPM in cui nuovo socio di controllo diviene Unicredit, seconda banca italiana, operante in Italia da molto tempo[10] e che vanta una corrente operatività con diversi enti pubblici italiani, di per sé, generi una “minaccia effettiva e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società”.
Esaminando partitamente i vincoli introdotti dall’esercizio del Golden Power, la riduzione del rapporto tra depositi/impieghi di cui al precedente punto a) sembra esprimere da parte del governo italiano il timore di una diminuzione dei prestiti a famiglie e PMI. Al di là della restrizione temporale già censurata dal TAR, è difficile comprendere perché una riduzione dei prestiti, quand’anche si verificasse, comprometterebbe la sicurezza nazionale tanto più che, come nota la Commissione, il mercato italiano non manca di altri operatori bancari che alimentano la concorrenza, area su cui ogni competenza appartiene proprio alla Commissione. La stessa rigidità con cui si vorrebbe preservare un rapporto stabile depositi/impieghi, rapporto che non può non risentire dei cicli di mercato, rappresenta un’ingerenza penetrante nell’autonomia d’impresa che richiederebbe, per il principio di proporzionalità, una severa compromissione della sicurezza pubblica.
Queste stesse considerazioni valgono per le restrizioni di cui ai punti b) e c).
Quanto alle attività russe di Unicredit, la Commissione non rinviene nel provvedimento del governo italiano una motivazione per cui le prescrizioni già dettate dalla BCE sul progressivo abbandono degli attivi in Russia, impugnate da Unicredit e confermate dalla Corte di Giustizia, non siano sufficienti data la competenza tecnica esclusiva della BCE in materia prudenziale e dato che l’acquisizione di BPM da parte di Unicredit, contrariamente a quanto sembra sostenere il provvedimento di esercizio del Golden Power, non mette a rischio i fondi e gli attivi di BPM.
Questa sintesi consente di affermare che le prescrizioni dettate dal Decreto, in quanto ingiustificate alla luce della nozione di “pubblica sicurezza” si risolvono in un limite alla circolazione dei capitali siccome precludono o rendono più difficoltoso il percorso dell’OPS pregiudicando l’interesse degli azionisti di Unicredit e della stessa BPM.
Nella parte in cui il Decreto si preoccupa di profili attinenti al rapporto depositi/impieghi, al vincolo di mantenimento di investimento in titoli italiani o di portafoglio project finance o ancora di dismissione di attività in Russia, esso non solo introduce una restrizione alla libera circolazione dei capitali ma invade la competenza del SSM ingerendosi in valutazioni di carattere prudenziale già assolte con puntuali prescrizioni e con l’autorizzazione all’OPS da parte della BCE.
Tutto questo è tanto più vero, ad avviso della Commissione, considerando che analoghe prescrizioni non sono state dettate né per altre operazioni di altre banche (la Commissione cita esplicitamente MPS/Mediobanca) né per altre operazioni della stessa Unicredit.
Nel caso specifico del vincolo di mantenimento di un portafoglio con titoli italiani detenuti da Anima Holding, la valutazione preliminare della Commissione riscontra anche una violazione dell’articolo 25 della direttiva OICVM[11] che obbliga le società di gestione ad operare nell’interesse degli investitori indipendentemente dalla nazionalità degli emittenti dei titoli[12]. Lo stesso ragionamento è da seguire per la direttiva GEFIA [13] sui gestori di fondi alternativi, il cui articolo 12 impone, inter alia, ai gestori di agire: “nel miglior interesse dei FIA o degli investitori dei FIA che gestiscono e dell’integrità del mercato”, interesse che potrebbe essere sacrificato da dettami basati esclusivamente sulla nazionalità degli emittenti dei titoli e per la MiFID II[14] il cui articolo 24 prescrive alle imprese di investimento: “…quando prestano servizi di investimento o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui al presente articolo e all’articolo 25.”
Quanto in particolare all’imposizione di un’uscita integrale dalla Russia nell’arco di 9 mesi, essa chiaramente interferisce con le indicazioni in merito già comunicate a Unicredit dalla BCE e confermate dalla Corte di Giustizia[15] le quali tengono conto, ciò che il provvedimento del governo non farebbe, della necessaria gradualità del disinvestimento dalla Russia secondo un programma finalizzato alla salvaguardia dei requisiti prudenziali della banca. Vi sarebbe un effetto paradossale se Unicredit, nell’adeguarsi alle più stringenti, drastiche prescrizioni del Decreto, giungesse in tal modo a deteriorare la propria condizione finanziaria e a violare gli obbiettivi fissati dalla BCE mediante azioni più graduali e prudenti. Anche in questo caso, inoltre, sfugge la correlazione tra la dismissione degli assets russi e l’acquisizione di BPM la quale non comporta sotto questo specifico profilo l’acquisizione di nuovi rischi rispetto a quelli già ora esistenti.
4. Sintesi e prospettive
Si è cercato in questo modo di offrire una sintesi, invero un po’ brutale, della congerie di argomentazioni utilizzate dalla Commissione per negare che il fondamento del Decreto risiedesse nella necessità di tutelare la pubblica sicurezza e per affermare che, destituito di questa motivazione, il Decreto contenga prescrizioni volta per volta in contrasto con la libertà di movimento dei capitali, le competenze tecniche esclusive della BCE e la regolamentazione generale unionale sui servizi finanziari.
Dalla comunicazione del 21 novembre 2025, citata all’inizio, risulta chiaro che la risposta dell’Italia alla “valutazione preliminare” della Commissione non ha dato i risultati sperati al punto che questa ha formalmente messo in mora il nostro Paese. Si apre ora un processo di mediazione che dovrà condurre verosimilmente a una circoscrizione più chiara e delimitata delle modalità procedimentali dell’esercizio del Golden Power ma anche dell’interesse che presiede all’utilizzo dei poteri speciali. Senza un accordo, la Commissione potrebbe dare un parere motivato finale sull’infrazione e, in caso di inottemperanza, rivolgersi alla Corte di Giustizia per ottenere la condanna dell’Italia.
È questa quindi la fase delicata in cui le parti possono raggiungere un compromesso da sancire con la modifica della normativa nazionale in tema di “Golden Power” in modo da superare le obbiezioni della Commissione e giungere a una più chiara delimitazione delle rispettive competenze e segnatamente di quelle del governo italiano onde evitare sovrapposizioni. Qualunque soluzione si raggiunga, essa non inciderà sull’OPS di Unicredit, oramai tramontata, ma dovrebbe offrire in prospettiva un dettato normativo nazionale auspicabilmente più chiaro, meno arbitrario e maggiormente conforme alla normativa UE eliminando un’opacità che danneggia la fluidità del mercato.
Sul piano più squisitamente teorico, il nodo della vicenda giuridica esaminata, almeno finora, esplicita la tensione più generale che si avverte con pressante attualità a livello geopolitico tra le istanze mercatiste e quelle protezionistiche, una dialettica che si scarica sul concetto di “pubblica sicurezza”[16] che, a livello europeo, dove preme salvaguardare la libertà di circolazione dei capitali, è solo “minaccia effettiva e sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società” laddove a livello nazionale appare strumento generale, invasivo ed eclettico di allocazione di risorse sullo scacchiere degli interessi nazionali e internazionali.
[1] Già prima nel 2019 allorché si procede all’approvazione del regolamento UE n. 452, il novero dei settori strategici si amplia a ricomprendere altri ambiti tra cui, ad esempio, il settore agroalimentare o le biotecnologie.
[2] In via definitiva e con effetto dall’1 gennaio 2023.
[3] L’articolo 2, comma 2-bis del d.l. n. 21/2012 estende l’applicazione dell’obbligo di notifica alle cessioni: “anche a favore di un soggetto appartenente all’Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o residenti in Italia,” con lo scopo di sottrarre la norma al vizio di discriminazione intracomunitaria ma ponendosi in contrasto con lo scopo originario di controllo dell’investimento estero.
[4] Questo ampliamento trova fondamento nel regolamento (UE) 2019/452 del 19 marzo 2019 il cui articolo 4 contempla i seguenti settori strategici ai fini del controllo dell’investimento estero: “Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, gli Stati membri e la commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l’altro, a livello di:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (15), tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
c) sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o
e) libertà e pluralismo dei media.”
[5] Rubricato: “Beni e rapporti nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari”
[6] Art. 2, comma 6, d.l. 2172012.
[7] Il provvedimento della Commissione cita in proposito la sentenza della Corte di Giustizia del 14 marzo 2000 nella causa C-54/99 Association Eglise de scientologie, ECLI:EU:C:2000:124, punto 17 e nella causa 36/75, Rutili contro Ministre de l’interieur, [1975], Racc. 1219, ECLI.EU:C:1975:137, punto 30.
[8] Requisiti fissati nel regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) e nella direttiva (UE) 2013/36 (“CRD”).
[9] In proposito il provvedimento della Commissione al paragrafo (98) e nella nota 46 cita Corte di giustizia, sentenza C-463/00 Commissione/Spagna, del 13 maggio 2003, ECLI:EU:C:2003:272, punto 72.
[10] La Commissione fa risalire l’origine di Unicredit alla Banca di Genova del 1870 (nota 49, p. 22).
[11] Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
[12] Scrive la Commissione al paragrafo (200) della “valutazione preliminare”: “Ai sensi dell’articolo 25 della direttiva OICVM, una società di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, gestisce l’OICVM esclusivamente nell’interesse dell’OICVM e degli investitori dell’OICVM. L’obbligo di mantenere un certo livello di investimento in titoli degli emittenti italiani viola l’obbligo della società di gestione di investire esclusivamente nell’interesse degli investitori in un OICVM, in quanto possono esistere circostanze economiche che impongono alla società di gestione di adottare decisioni di investimento che ridurranno l’esposizione verso titoli emessi da emittenti italiani al di sotto del livello vigente al momento dell’adozione del Decreto.” (dove per Decreto si intende il provvedimento della PCM).
[13] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011
[14] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014
[15] Decisione ECB-SSM-2-24-ITUNI-17 del 22 aprile 2024.
[16] Sul punto si vedano Luca Picotti, La legge del più forte – Il diritto come strumento di competizione tra stati, LUISS University Press, 2023; e Linee invisibili. Geografie del potere tra confini e mercati, Egea, 2025.