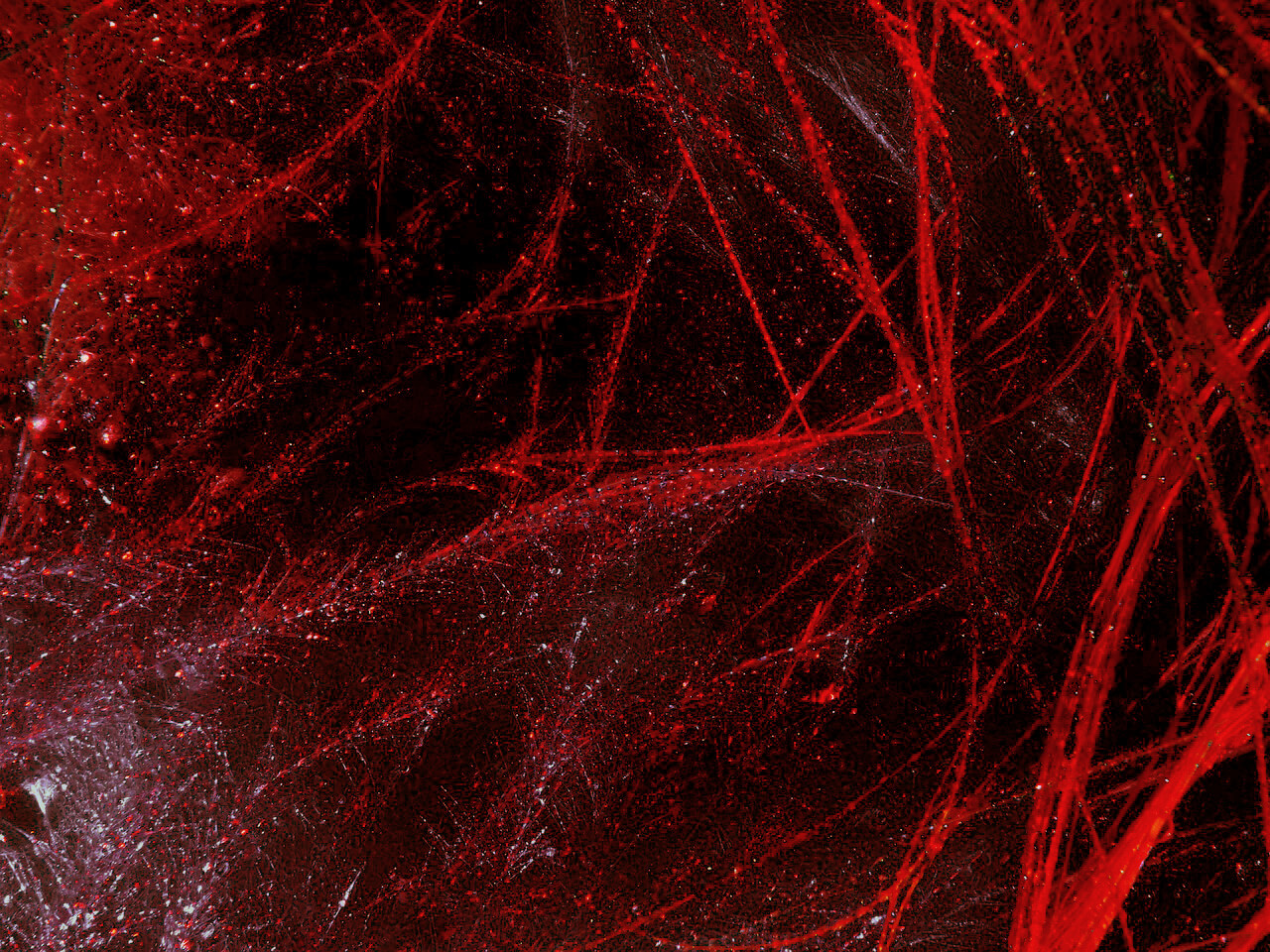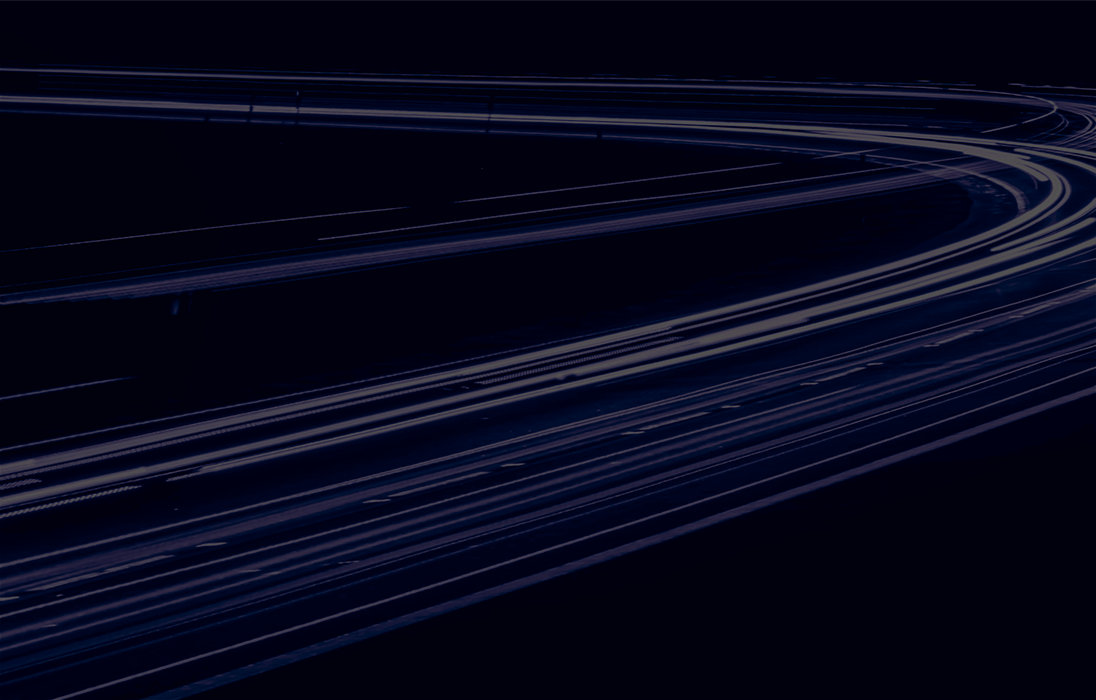La Prima Sezione della Cassazione si è di recente pronunciata, con la sentenza del 17 febbraio 2026 n. 3559 (Pres. Di Maurizio, Rel. Falabella), su alcune questioni concernenti un contratto di leasing immobiliare, con peculiare riferimento alla corretta indicazione del tasso di leasing applicato.
Si è inoltre soffermata sulla necessità di una doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, nonché in merito alla verifica dell’usurarietà degli interessi.
Nel caso di specie la società utilizzatrice dell’immobile, fornitogli tramite contratto di leasing immobiliare dalla banca, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che, sulla scorta di quanto previsto dal tribunale di primo grado, aveva accertato la risoluzione del contratto.
In relazione alla dedotta questione della mancata indicazione del tasso di leasing, la ricorrente aveva sostenuto la violazione del principio di trasparenza bancaria (ex art. 117 TUB) per indeterminatezza o indeterminabilità degli interessi corrispettivi.
A tal proposito la Cassazione ha invece chiarito che la mancata indicazione del tasso di leasing non determina la violazione dell’art 117 c. 4 del TUB quando viene operato un rinvio a criteri individuabili senza incertezza e margini di discrezionalità, ovvero anche tramite dati di natura tecnica ma che abbiano carattere oggettivo, tali da integrare i requisiti di determinatezza ex art. 1346 C.c.
Inoltre, la società ricorrente aveva lamentato l’assenza di una doppia sottoscrizione della clausola vessatoria relativa alla competenza territoriale, in esso contenuta. Nel caso di specie, infatti, erano state sottoposte ad una seconda sottoscrizione differenti clausole, sia vessatorie che non, tra loro raggruppate.
La Cassazione, in conformità con quanto precisato dalla Corte d’appello, ha precisato che l’approvazione della clausola vessatoria è legittima anche se menzionata in maniera sintetica e anche se indicata insieme a clausole non vessatorie.
In aggiunta, riconosce la liceità anche del mero richiamo numerico della clausola purché non cumulativo: in quest’ultima ipotesi, deve esservi l’indicazione del contenuto della clausola, sempre che la legge non richieda espressamente la forma scritta.
La ricorrente infine, ha poi denunciato l’erronea verifica dell’usurarietà degli interessi di mora.
La Cassazione, pur ritenendolo un accertamento in fatto dalla stessa non sindacabile, ha aderito alla ricostruzione della Corte d’Appello, ritenendo che, in realtà, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel contratto di leasing immobiliare vi fosse una specifica clausola di salvaguardia volta ad evitare che la banca applicasse interessi in misura superiore alla misura massima consentita per legge; sul punto, richiamando la giurisprudenza prevalente, ricorda che “La «clausola di salvaguardia» trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge: conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto“.
Da ultimo, ha precisato che, per la verifica dell’usura, non deve procedersi al cumulo degli interessi corrispettivi e quelli moratori, poiché i due hanno funzioni diverse: i due interessi vanno calcolati, quindi, separatamente; pertanto, in relazione al caso di specie, la Cassazione concorda con la ricostruzione del TEGM operato dalla Corte d’Appello, e non ritiene quindi integrata la dedotta ipotesi di usura del tasso concretamente applicato al contratto di leasing.