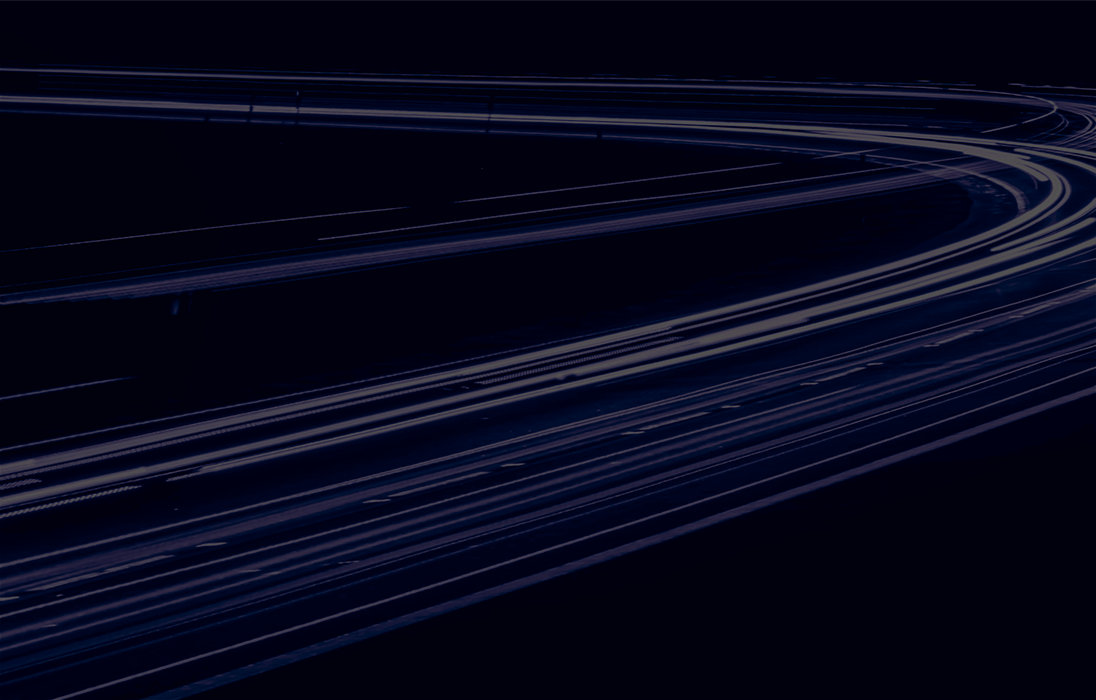Con la sentenza n. 30657 del 20 novembre 2025, le Sezioni Unite della Cassazione si esprimono sul regime fiscale dei fondi immobiliari, e, in particolare, sul cumulo delle quote tra familiari oltre la soglia del 5% e sulla legittimità costituzionale dell’imposta sostitutiva transitoria per il 2011.
Questo il principio di diritto affermato:
“In tema di fondi comuni di investimento immobiliare, l’art. 32, comma 3-bis, quinto periodo, d.l. n. 78 del 2010, ha una finalità antielusiva ed integra una presunzione legale relativa, la cui prova contraria incombe su colui che ne contesta l’applicazione. A tal fine, la parte ha l’onere di provare l’effettività e l’autonomia della propria quota di partecipazione al fondo rispetto a quelle degli altri familiari, dimostrando l’originarietà delle fonti di investimento, il godimento dei guadagni e dei benefici derivanti dal fondo, nonché l’autonomia delle scelte sull’an e sul quomodo dell’investimento”.
Il caso di specie concerneva la detenzione, da parte di due stretti familiari (padre e figlio), di quote in fondi immobiliari oltre la soglia del 5%, se considerate complessivamente, e che avevano richiesto il rimborso dell’imposta sostitutiva ex art. 32, c. 4-bis, D.L. 78/2010: i giudici di merito avevano ritenuto irrilevante il cumulo delle quote, in ragione della diversa residenza anagrafica, non accogliendo la contraria impostazione dell’amministrazione finanziaria.
Sul “cumulo” delle quote dei fondi immobiliari in capo ai familiari
Preliminarmente, le Sezioni Unite individuano il quadro giuridico di riferimento della disciplina in materia di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare.
L’art. 1, lett. j, del TUB fornisce la nozione di “fondo comune di investimento”, che costituisce un patrimonio autonomo, formato dalle quote sottoscritte dalla pluralità dei partecipanti e gestito da un gestore; come tale, tuttavia, è distinto sia dal patrimonio della società che lo gestisce che da quello dei sottoscrittori.
Il regime fiscale per i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare ha trovato la sua prima specifica disciplina nell’art. 7 D.L. 351/2001, che ha previsto una ritenuta del 20% sull’ammontare dei proventi distribuiti di ciascuna quota in costanza di partecipazione.
Con la riforma di cui all’art. 32 D.L. 78/2010 si è poi distinto fra investitori istituzionali (come lo Stato, enti pubblici, organismi d’investimento collettivo del risparmio, forme di previdenza complementare, imprese di assicurazione e altri, tutti analiticamente specificati), che continuano a fruire del generale regime agevolativo, e gli investitori non istituzionali, che ha onerato di un più gravoso regime fiscale, ovvero l’applicazione del regime per trasparenza, ove partecipi di una quota “qualificata” del fondo di investimento, superiore al 5% del patrimonio del fondo: i redditi derivati dal fondo sono quindi imputati ai singoli partecipanti non istituzionali qualificati e, nei loro confronti, concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’individuazione dei partecipanti qualificati non istituzionali è stata rafforzata con la previsione di alcune ipotesi, tipizzate, volte ad evitare l’artificiosa frammentazione della detenzione della quota tra soggetti che, pur tra loro in stretto collegamento, figuravano come partecipanti distinti: pertanto in caso di stretti rapporti parentali fra quotisti, per la verifica della percentuale di partecipazione del 5% si deve tenere conto anche delle partecipazioni (ai singoli fondi immobiliari) imputate ai familiari elencati nell’art. 5, c. 5 del TUIR (coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo),
La norma mira, come si è espressa la Corte costituzionale, ad evitare che i fondi immobiliari siano trasformati da strumento di gestione collettiva del risparmio ad interposta intestazione o amministrazione di beni, finalizzata ad un improprio godimento di benefici fiscali concepiti per diverse fattispecie.
La presunzione fissata dal quinto periodo del comma 3 bis risponde quindi ad un dato di esperienza che giustifica la fissazione della presunzione con l’inclusione delle quote detenute dai familiari stretti ai fini della verifica della soglia della percentuale “rilevante” del 5%.
Per la Cassazione tale presunzione ha natura relativa: consente di dimostrare che, nonostante lo stretto rapporto familiare dei quotisti investitori, non si sia realizzata, in realtà, una condotta elusiva.
Ciò, incoerenza al quadro disegnato dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 53 Cost.: la norma mira ad assicurare la “giusta imposizione”, ancorata non ad una impropria tassazione del “nucleo familiare” ma tesa proprio ad evitare che questa fondamentale struttura della società sia, artificiosamente, impiegata come schermo per la corretta imposizione e contribuzione del singolo, arrecando un detrimento alle finalità di gestione collettiva del risparmio (necessariamente di una pluralità di investitori) e di sviluppo e promozione del mercato immobiliare a vantaggio dell’interesse, individuale, all’amministrazione di patrimoni personali.
Il contenuto della prova contraria
In caso di presunzione legale relativa, l’onere della prova contraria, secondo i principi generali, incombe su colui che ne contesta l’applicazione: dunque, al contribuente nei cui confronti si esplicano gli effetti ex art. 32, comma 3-bis, d.l. n. 78/2010.
La Cassazione esclude preliminarmente, che possa essere incluso fra gli indici che consentono di assolvere o non assolvere tale onere della prova, la semplice convivenza, la residenza o l’appartenenza al medesimo stato di famiglia tra i soggetti facenti parte dello stesso gruppo familiare, ossia il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo.
Si tratta di una circostanza di fatto priva di rilievo: non fornisce alcun elemento concreto idoneo a dimostrare (o meno) l’effettività e l’autonomia delle singole partecipazioni e a superare od escludere la presunzione di riferibilità delle intestazioni delle quote di partecipazioni ai familiari.
La verifica che l’intestazione non ha carattere fittizio va articolata, pertanto, per le Sezioni Unite, su una pluralità di indici, tali da rivelare che la partecipazione alla singola quota risponde ai caratteri dell’effettività e dell’autonomia.
Infatti, tenuto conto che viene in rilievo un investimento in un prodotto finanziario da parte di un soggetto che ne gode dei proventi, i parametri da considerare sono necessariamente i seguenti:
- la fonte dell’investimento: la provenienza effettiva delle risorse finanziarie per il loro acquisto
- il godimento di guadagni e benefici: la destinazione finale dei guadagni e benefici derivanti dall’investimento
- l’attività di gestione: a chi e in quale modo siano riferibili gli atti di effettiva gestione dell’investimento: vengono in considerazione le decisioni legate:
La convergenza dei tre indici, adeguatamente provati e documentati, nell’attestare l’originarietà delle fonti dell’investimento, la divaricazione dei flussi dei proventi, nonché la sostanziale autonomia delle scelte sulle sorti e la gestione (esterna) dell’investimento, appare suscettibile di far ritenere che il singolo investimento sia effettivo e autonomo rispetto a quelli degli altri quotisti, sì da poter costituire prova idonea a superare la presunzione di fittizietà della titolarità delle partecipazioni nel medesimo fondo comune di investimento, imputate ai familiari indicati dall’art. 5, comma 5, TUIR.
Sul contrasto con i principi costituzionali della norma transitoria
L’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, ha previsto l’introduzione di una imposta sostitutiva del 5% del valore medio della quota posseduta per gli investitori non istituzionali qualificati (con cumulo delle quote dei fondi ex art. 32, c. 3-bis) in luogo del più favorevole regime, previsto dall’art. 7 d.l. n. 351/2001, della ritenuta del 20% limitata ai proventi dei fondi in sede di distribuzione.
Le Sezioni Unite, tuttavia, escludono l’illegittimità costituzionale della disciplina transitoria, confermando e ribadendo la precedente sentenza della Corte n. 16921/2023.
A differenza delle disposizioni penali, non sussiste un limite costituzionale teso a vietare l’adozione da parte del legislatore di norme retroattive nella materia fiscale.
Inoltre, richiama la prenuncia della Corte costituzionale n. 285/2004, con riferimento ad interventi in senso peggiorativo su regimi fiscali di favore, che ha chiarito come sia erroneo ritenere che un beneficio previsto dalla pregressa disciplina normativa di settore non possa subire modificazioni in negativo per l’affidamento creato nei contribuenti, e che al legislatore sarebbe impedito di effettuare nuove valutazioni al fine di ripartire più equamente il carico fiscale.
Infatti, la circostanza che il contribuente abbia goduto del beneficio per un protratto lasso temporale non comporta affatto che si sia consolidata in lui una posizione soggettiva di intangibilità, anche per l’avvenire, della situazione di vantaggio conseguita.
Né, ad avvalorare la tesi della violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità può richiamarsi l’esigenza del rispetto dell’aspettativa alla intangibilità del beneficio ricevuto, che la precedente normativa avrebbe creato nei contribuenti, atteso che nessuna aspettativa di tal genere può considerarsi oggetto di protezione dall’ordinamento.
Pertanto, anche con riguardo alle modifiche in peius di una disciplina di favore non sussiste un limite alla potestà di intervento del legislatore ove la scelta risponda a criteri di razionalità e non leda l’affidamento del contribuente, tenuto quindi conto della durata e del consolidamento del regime oggetto della modifica e della prevedibilità e conoscibilità dell’intervento modificativo.
La Corte ricorda come la norma transitoria si inserisse in un complessivo intervento normativo volto a rafforzare le originarie finalità di incentivazione della funzione economica di raccolta del risparmio tra una pluralità di soggetti e di investimento di fronte a fenomeni anomali, consentendo un graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema: da ciò, la ragionevolezza della disciplina.
L’intervento – prosegue la Corte – trovava la sua giustificazione, sul piano prognostico, nelle plurime importanti segnalazioni degli anni precedenti da parte di Banca d’Italia, della dottrina specialistica e del Consiglio nazionale del Notariato, che avevano evidenziato gli usi impropri dei fondi immobiliari, specie in relazione alle plurime partecipazioni di familiari, da cui desumevano l’insussistenza di un affidamento tutelabile, trattandosi di situazione già da tempo oggetto di specifica attenzione.
Inoltre, per le Sezioni Unite non sussiste neppure la violazione del principio di capacità contributiva, posto che ad essere incisa è l’effettiva detenzione delle partecipazioni, ossia un indice di concreta capacità contributiva, in quanto le partecipazioni detenute dagli altri familiari non contribuiscono all’individuazione del presupposto d’imposta ma determinano solo l’operatività del comma 3-bis.