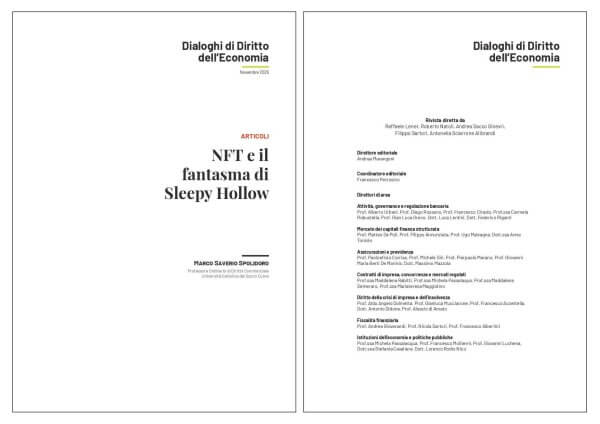SOMMARIO: La febbre degli NFT è stata violenta, ma passeggera. Resta una scia di questioni che, nel momento apicale, erano rimaste sullo sfondo: in che senso gli NFT, che di per sé sono registrazioni in una blockchain, sono da considerare “beni”, quale sia il rapporto tra la registrazione ciò che è oggetto della registrazione, se la registrazione nella blockchain surroghi la registrazione in un registro pubblico, quali interferenze possano esistere tra NFT e diritti IP, quale sia il regime delle opere “NFT native”, se il mercato degli NFT debba essere regolato come un mercato di asset finanziari o come una casa da gioco d’azzardo. Molte di tali questioni sono state affrontate da un punto di vista errato in passato. Ciò ha alimentato l’interesse per gli NFT, ammantandoli di mistero, e ha contribuendo a gonfiare una bolla speculativa. Oggi, l’onda è passata e si possono risolvere tali questioni in modo più chiaro e semplice.
ABSTRACT: The NFT craze was intense but short-lived. It leaves behind a trail of questions that, at its peak, remained in the background: in what sense are NFTs, which are essentially entries on a blockchain, to be considered “assets”; what is the relationship between the record and the subject of the record; does recording on the blockchain replace recording in a public register; what interference may exist between NFTs and IP rights; what is the regime for “native” NFTs; should the NFT market be regulated as a financial asset market or as a gambling house? Many of these questions have been addressed from the wrong perspective in the past. This has fueled interest in NFTs, shrouding them in mystery and helping to inflate a speculative bubble. Today, the hype has passed and these issues can be resolved more clearly and simply.
1. NFT e spigolature semi-storiche.
Nel 1820, Washington Irving pubblicò una novella, la “Leggenda di Sleepy Hollow”, di cui è protagonista il fantasma dello Headless Horseman, un cavaliere di un reggimento tedesco, al servizio della Corona Inglese durante la rivoluzione americana, decapitato da una palla di cannone mentre caricava nel corso di una battaglia, e che continuava ogni notte la sua corsa per le campagne, alla ricerca del suo capo perduto[1].
Anche gli NFT (“non fungibile tokens”) continuano a esistere e a far parlare di sé dopo che la NFT Craze si è calmata, almeno di fatto[2]. Non diversamente è accaduto per molti oggetti di speculazioni euforiche nei mercati: per esempio si pensi ai tulipani nel caso della “tulipomania” che, nel Seicento, scatenò pazze e rovinose follie nei Paesi Bassi[3].
Come è successo ai tulipani, anche gli NFT non sono scomparsi del tutto dalla circolazione. Ma il loro fascino è assai diminuito, perché perfino gli sprovveduti sanno ora che la loro maggiore utilità, almeno oggi, è di essere usati per giocare, non solo per guadagnare facilmente (e perdere) denaro, ma anche per noia o per divertimento. Leggiamo in Internet che il cantante Justin Bieber avrebbe perso il 95% di quanto avrebbe investito per acquistare un NFT delle “Bored Apes” a causa del “declino” (ma piuttosto si direbbe un crollo!) del mercato del 2022[4]: ma dalle stesse fonti sappiamo che non è andata meglio ad altre personalità come Madonna e altri[5]. Residuano gli NFT usati come gadget nelle feste, alle sfilate e nel mondo della moda. Ma il loro sfolgorio è appannato dalle disavventure capitate alle pop star che ci hanno rimesso le penne.
2. Duplicità o molteplicità della natura degli NFT.
La caratteristica fondamentale degli NFT è di esser unici, seppure artificialmente, perché unica e non replicabile è la loro registrazione di una blockchain[6].
Tale unicità e non fungibilità della registrazione è il presupposto empirico della creazione di un incentivo a giocare con gli NFT, e quindi, eventualmente a scommettere sugli NFT.
Allo stesso tempo, gli NFT sono inevitabilmente una registrazione di qualche cosa che può essere (ed anzi normalmente è)[7] al di fuori di loro, sia esso il “Tondo Doni”[8] di Michelangelo, o una lettera di un epistolario famoso, oppure un personaggio della fantasia come “Zorro”, un marchio come “Ferrari”, eccetera.
Chiaramente, è il contenuto della registrazione che la rende interessante e appetibile: ma anche questo dato è equivoco, perché possedere la registrazione di una cosa non è lo stesso che possedere la cosa. Per esempio, chi ha pagato profumatamente l’NFT del “Tondo Doni” non possiede affatto il famoso dipinto, che è rimasto agli Uffizi, ma soltanto una registrazione che ha comprato per soddisfare un diverso bisogno: nel migliore dei casi, quello di sentirsi “unico” grazie all’unicità irreplicabile della registrazione acquistata, o altrimenti quello di giocare speculativamente in un mercato metafisico del tutto aleatorio. Nel quale, tuttavia, si guadagnano o perdono soldi reali[9].
Quindi, la natura degli NFT è duplice o molteplice: gli NFT sono registrazioni, sì, ma pur sempre registrazioni di “altro”. Un NFT che non registra nulla, se non sé stesso, può forse esistere in natura, ma non merita attenzione.
3. NFT e teoria dei beni.
In quanto mera registrazione nella blockchain, l’NFT non sarebbe un bene, né tanto meno una “cosa”. Non sarebbe un “bene”, perché una registrazione non è in grado di soddisfare alcun interesse umano (e quindi non è in grado di suscitare una domanda a fronte di un’eventuale offerta), e non è neppure una “cosa” perché non cade sotto i nostri sensi e non occupa uno spazio fisico di cui un uomo si possa appropriare.
Tuttavia, gli NFT sono beni nei limiti in cui sono negoziabili, cioè possono essere oggetto di contratti (normalmente, ma non necessariamente, si tratta di smart contracts)[10]. E sono beni incorporali, perché, non occupando uno spazio fisico apprezzabile per l’uomo, per l’uomo sono inafferrabili. Tuttavia, non sono beni immateriali, perché il loro possesso conferisce solo diritti contrattuali creati dagli smart contract che li regolano e la legge non riconosce alla registrazione nella blockchain efficacia costitutiva di alcun diritto di esclusiva sul quid che è oggetto della registrazione.
A ben vedere, come in altri casi avviene, la questione se gli NFT siano o no beni, ed eventualmente in che senso, dipende dalla prospettiva e dal contesto. Le teorie generalizzanti falliscono o si mostrano inadeguate[11] e, in tali condizioni, è preferibile un atteggiamento che guardi al problema che deve essere risolto qualificando in un modo o nell’altro gli NFT.
Se la conclusione che precede sembrasse semplicistica[12], basterebbe dire che, in pratica, il fatto stesso che gli NFT abbiano avuto un mercato (seppur somigliante a una bisca) e siano tutt’ora oggetto di negoziazioni, dimostra che essi sono “beni” in uno dei significati giuridici più ovvi della parola.
4. Prezzo e valore degli NFT (con un riferimento alla possibilità di conferirli in una società di capitali).
In quanto consistente in un’unica e irreplicabile registrazione, ogni NFT è quantomai “raro”, cioè privo di alternative fungibili. Se vi fosse – rispetto a questo bene così raro – una domanda sufficientemente motivata, tale bene avrebbe un prezzo: vale a dire il prezzo che sarebbe concordato tra chi domandasse e chi offrisse.
Diversa è la questione se l’NFT abbia anche un valore oggettivamente determinabile: tale questione è cruciale ai fini della questione sceverata in uno scritto recente[13], relativa alla conferibilità degli NFT nelle società di capitali. Infatti, il prezzo di emissione delle azioni o quote di s.r.l. offerte in sottoscrizione – se non sia liberato in contanti – non può essere superiore al valore stimato indipendentemente da un esperto e deve, quindi, essere «suscettibile di valutazione economica».
Nel discutere su questo tema, si deve però tenere conto che la difficoltà della valutazione oggettiva degli NFT non è però qualitativamente o quantitativamente diversa da quella della valutabilità oggettiva dei beni scambiati sui mercati volatili o estremamente speculativi e, se del caso, dei beni di cui non esiste una domanda competitiva. Si tratta dei beni il cui prezzo non riflette un valore oggettivo facilmente determinabile, ma che non per questo sono assolutamente privi di valore.
La questione riguardante il conferimento a capitale degli NFT è perciò da risolvere dal punto di vista dell’esperto che, in sede di valutazione, debba attestare che il prezzo di emissione delle azioni o delle quote sottoscritte da chi apporta gli NFT sia o no interamente coperto, nella parte del capitale e in quella dal sopraprezzo. E non deve essere dimenticata, almeno nel caso delle s.p.a., la verifica successiva degli amministratori e di sindaci.
In conclusione, se, anche nel bel mezzo di una bolla speculativa, fossero conferiti NFT, l’esperto dovrebbe prendere in considerazione la probabilità di un crollo del mercato o del permanere della bolla nell’immediato futuro.
5. Coniazione di NFT e libertà d’espressione del pensiero.
Gli NFT possono essere registrazioni di qualsiasi oggetto “tokenizzato”[14] che sia registrabile in una blockchain, e tale registrazione sarebbe, rispetto alla blockchain, unica ed originale anche se l’oggetto di tale registrazione (inteso come oggetto intelleggibile al di fuori della catena) fosse già esistente, come il “Tondo Doni” di Michelangelo, o registrato in un altro registro, come un terreno censito al catasto o un brevetto d’invenzione, oppure in un’altra blockchain, e perfino nella medesima blockchain.
In tale contesto, si pone la questione se gli NFT possano essere protetti come marchi.
Un punto è da considerare fermo: allo stato attuale, la registrazione di un NFT in una blockchain non è idonea a svolgere alcuna delle funzioni della registrazione del marchio negli appositi registri. Nella misura in cui la registrazione degli atti di trasferimento di un marchio registrato non abbia altri effetti che quello di rendere opponibile tale trasferimento nei confronti di un successivo avente causa, la registrazione di un simile atto nella blockchain potrebbe costituire prova del contratto (a prescindere dalla registrazione del marchio nella blockchain).
Inoltre, in un sistema il cui marchio non registrato è protetto soltanto se ha acquisito per effetto del suo uso, una notorietà qualificata, ed è riconosciuto del pubblico come segno distintivo, la registrazione come NFT non surroga il difetto di tale notorietà e la mancata prova dell’uso.
Non contrasta con queste conclusioni la giurisprudenza che accorda la tutela dei marchi registrati agli NFT registrati, appunto, come marchi negli appositi registri (oltre che nella blockchain) o comunque protetti sulla base di un diverso sistema di costituzione del diritto[15].
Infatti, secondo tale giurisprudenza, l’NFT è il prodotto, non il marchio del prodotto. Nel caso delle “Bored Apes”, le “scimmie annoiate”, oggetto di registrazione come NFT, erano anche protette dal Lanham Act come segni idonei a contraddistinguere l’origine del prodotto e dal common law come segni distintivi di fatto e come tali sono state valutate.
Il convenuto aveva coniato una nuova collezione di “scimmie annoiate” visibilmente identiche a quelle di chi aveva registrato per primo i corrispondenti NFT: visualmente identiche, si diceva, perché le registrazioni sulla blockchain sono e restano non fungibili. Le “scimmie annoiate” di nuovo conio erano offerte nel sito del contraffattore con l’avvertenza che la loro offerta in vendita avveniva con “intenti educativi”, cioè come «una protesta e un commento satirico».
La Corte non ha affatto accertato la violazione dei pretesi marchi dell’attrice, ma ha respinto alcune difese del convenuto, fatte valere in limine litis.
La Corte d’Appello Federale per il Nono Circuito ha infatti ritenuto che gli NFT siano “beni” e che possano essere protetti dalla legislazione sui marchi, ricorrendone le condizioni. La Corte in particolare, ha respinto l’eccezione del convenuto secondo cui, l’uso di un marchio altrui in funzione distintiva dei propri prodotti sia giustificato dalla dottrina del fair use (cioè, in termini europei, dal ricorrere di una limitazione del diritto di marchio), anche se tale uso sia diretto a criticare o a commentare il prodotto del titolare del marchio o i suoi usi sul mercato, allorché l’uso del marchio altrui, al di là delle intenzione del convenuto, funzioni come source identifier. Tuttavia, la Corte, ha ritenuto di dover rimettere al trial – cioè all’istruttoria – la questione se, in concreto l’uso del convenuto interferisse con la funzione distintiva del marchio dell’attore[16]. Pertanto, la decisione conferma che gli NFT possono costituire “beni-merci” e che possono essere contraddistinti da marchi che possono coincidere con l’immagine cui rinvia la registrazione dell’NFT, se quell’immagine è registrata ed è idonea (o è diventata idonea) a contraddistinguere il prodotto NFT.
Altro e separato accertamento riguarda l’interferenza fra tale marchio e un successivo uso di esso come NFT o in altra maniera (per esempio su abbigliamento, gadget, tazze da thè ecc.) di cui si possa asserire, nelle circostanze, l’idoneità a interferire con le funzioni del marchio.
6. Coniazione di NFT e interferenza con i diritti di proprietà industriale e intellettuale.
Alla stessa stregua, ci pare, occorre risolvere il problema della “tokenizzazione” (cioè della registrazione come NFT) di qualsiasi marchio o opera dell’ingegno protetta in quanto tale.
Se infatti è vero che gli NFT sono beni e che la loro vendita o il loro commercio è un uso del contenuto cui la registrazione rinvia, o che essa rappresenta, è del tutto ovvio che lo sfruttamento economico degli NFT (compresa evidentemente la loro compravendita all’asta) possa interferire con un diritto di proprietà industriale o intellettuale.
È il caso deciso con l’ordinanza del Tribunale di Roma nel caso “Juventus”, in cui il marchio della famosa squadra di calcio torinese è stato ritenuto violato dalla «produzione, commercializzazione e promozione on line delle carte da gioco digitali NFT (“non fungible token”) riproducenti i segni distintivi in questione in quanto riportanti la figura dell’ex calciatore Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus e l’indicazione della squadra»[17]. Il Giudice ha infatti ritenuto che, anche in considerazione del carattere rinomato del marchio “Juventus”, il suo uso descritto nei termini sopra riportati da parte di un terzo non autorizzato potesse interferire con le funzioni protette del marchio.
Alla stessa stregua, la tokenizzazione di una serie di immagini protette dal diritto d’autore senza il consenso del titolare del diritto, dà luogo a una illecita violazione del diritto di sfruttamento economico dell’opera, essendo tale operazione tipicamente diretta a una futura commercializzazione dell’NFT, come nel caso deciso dalla Huangzhou Internet Court il 22 aprile 2022, Shenzen Qice Diechu Cultural Creation Co., Ltd v. Huangzhou Yuanyuzhou Technology Company[18], che ha ravvisato nel comportamento dell’intermediario che aveva caricato sulla sua piattaforma degli NFT che riproducevano immagini delle “Fat Tigers” (probabilmente un clone cinese delle “Bored Apes”) una violazione del diritto d’autore spettante al creatore di tale serie.
7. Opere dell’ingegno “NFT Native”.
Se è certo che l’idea di tokenizzare un’opera non sia di per sé creativa (con l’ulteriore conseguenza che l’NFT di un’opera protetta non è un’opera derivata nel senso del diritto d’autore), può darsi che un’opera sia creata e “nasca” come NFT[19].
In tal caso, però, a essere protetta è l’opera, non l’NFT che ne costituisce la registrazione.
Se nel contratto (tipicamente uno smart contract) che trasferisce la titolarità dell’NFT è previsto che siano trasferiti anche i diritti di sfruttamento economico dell’NFT, o alcuni di essi il trasferimento della registrazione incide sulla titolarità di tali diritti. Tuttavia, ciò non è affatto necessario, poiché il diritto sull’NFT e sull’opera da esso rappresentata possono restare separati.
8. NFT e disciplina dei mercati (o del gioco d’azzardo)?
Gli NFT ai quali è riferito il presente scritto sono esclusi, correttamente, dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/1114 sulle ctipto-attività, che riguarda un fenomeno diverso[20].
Ma il mercato degli NFT è, come si è visto, assai pericoloso, si possono perdere molti soldi e ci sono non pochi “pescecani” in agguato, tra cui le piattaforme. Potrebbe esserci qualche affinità con i casinò, ma vale la pena di far d’ogni erba un fascio e di vietare (con che risultati, poi?) il mercato degli NFT? O di subordinarlo a qualche vigilanza?
Io credo che tra coloro che giocano e speculano sul mercato degli NFT (o su quel che ne resta) e i ludopatici siano percepibili empiricamente delle differenze. Le folle si sono cautelosamente tenute lontane dagli NFT e non mi risulta, da quel che ho letto, che il loro commercio sia un problema socialmente rilevante.
Per tale ragione, non credo che sia necessario impiegare (almeno per adesso) risorse e tempo per regolare il fenomeno e, in definitiva, per proteggere una sottile fascia di super-ricchi, come Justin Bieber o Madonna, da loro stessi.
[1] La fantasiosa storia del cavaliere decapitato di Washington Irving divenne realtà il 6 agosto 1870, nella carica dei corazzieri francesi contro l’artiglieria montata e la fanteria prussiana (e del Baden) durante la battaglia di Reichshoffen – Wœrth. Il colonnello Henri Lafutsun de Lacarre si trovò decapitato a metà dell’ordine “Chargez!” da un colpo di cannone, ma il suo cavallo, imbizzarrito, lo trascinò sul campo di battaglia, ancora ritto in sella, nello spasimo della morte improvvisa, con la sciabola in pugno: v. A. Scarlatti, Le morti strane nella storia, in Et ab hic et ab hoc, rist. Torino 1941, vol. VII, p. 181. La corazza dello sventurato Lacarre è esposta al Musée de la Cavalerie di Saumur. Naturalmente, i cantori delle gesta eroiche si impadronirono di questo orribile avvenimento e lo trasformarono in un atto di (involontario) eroismo.
[2] Dopo che la febbre degli NFT si è ridotta e si è quasi estinta, proseguono, da un lato, alcune vertenze giudiziarie e, dall’altro, gli studi accademici. In questo scritto prenderò in considerazione solo le “novità” rispetto a M.S. Spolidoro, Dal metaverso ad Acchiappa–citrulli? Riflessioni in tema di NFT¸ in AIDA, 2022, 518 e ss.
[3] Per i riferimenti storici, v. M.S. Spolidoro (nt. 2). 547, spec. in nota 98.
[4] V. The Fall of NFTs: How Much are They Worth in 2025?, 13 marzo 2025, in https://ceo-na.com/ceo-life/art-culture/the-fall-of-nfts-how-much-they-worth-in-2025/.
[5] V. NFT auctions from Beeple, Madonna flop amid crypto crash, 24 maggio 2022, in https://nypost.com/2022/05/24/nft-auctions-from-beeple-madonna-flop-amid-crypto-crash/.
[6] Tutto ciò è spiegato con grande chiarezza, da ultimo, nelle pagine iniziali della recentissima sentenza d’appello sulle bored apes (proprio loro!): Yuga Labs Inc. v. Ryder Ripps, 9th Circuit Court of Appeals, No. 24–879, Op., 6 e ss. (July 23, 2025). V. anche A. Guaccero – G. Sandrelli, Non fungible tokens (NFT), in Banca, borsa tit. cred., 2022, I, 824 e ss.
[7] A. Guaccero – G. Sandrelli, op. cit., 840.
[8] M.F. Tommasini, NFT o Crypto art. Inquadramento giuridico e prospettive di tutela nel mercato digitale, in Jus civile, 2013, fasc. 3, 615 e ss.
[9] A. Guaccero – G. Sandrelli, op. cit., 863.
[10] Nulla vieta, infatti, che gli NFT siano oggetto di contratti tradizionali: cfr. M.F. Tommasini, op. cit., 620. La scelta di un contratto tradizionale è tuttavia non ottimale e inefficiente. Pertanto, l’eventualità che gli NFT siano oggetto di contratti diversi dagli smart contracts e di diritti previsti in tali contratti. In tema, v. anche B. Sergiovanni, Il Non Fungible Token nella cripto-arte: la “recinzione” dell’oggetto digitale, in Nuove leggi civ. comm., 2024, 232.
[11] A. Guaccero – G. Sandrelli, op. cit., 841-856.
[12] In verità, cito la sostanza di un manuale ancora molto apprezzato: A Torrente – P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII ed., Milano, 2017, 184–185. Ovviamente, ciò non vuol dire che la proprietà di una cosa (e anche quella “non proprietà” che è l’esser titolare di un bene immateriale: cfr. S. Pugliatti, La proprietà e le proprietà in La proprietà nel nuovo diritto, rist., Milano, 1964, 247 e ss.) sia in alcun modo assimilabile alla titolarità di un credito, seppur negoziabile.
[13] S. Lopopolo, Sull’ammissibilità del conferimento dei Non–Fungible Tokens, nelle Società di capitali, in Giur. comm., 2025, I, 94 e ss.
[14] Il verbo “tokenizzare” e i suoi derivati possono sembrare brutti, ma lo sono meno dell’orrendo “conionizzare”, disgraziatamente utilizzato (con “conionizzazione”) nel suo scritto da B. Sergiovanni, op. cit., 249. Se si volesse tradurre il verbo inglese “to mint” in italiano, si potrebbe usare il verbo “coniare” e il sostantivo, meno osceno, “coniazione”.
[15] Yuga Labs Inc. v. Ryder Ripps, 9th Circuit Court of Appeals, No. 24–879;
[16] Yuga Labs Inc. v. Ryder Ripps, 9th Circuit Court of Appeals, No. 24–879.
[17] Trib. Roma (ord.) 20 luglio 2022, in Il diritto industriale, 2022, 487, con nota di A. Rainone, Uso illecito del marchio altrui sulla blockchain: il principio di neutralità tecnologica e la rivoluzione mancata dei registri distribuiti.
[18] Su cui vedi B. Sergiovanni, op. cit., 243.
[19] Su cui si veda M.F. Tommasini, op. cit., 614.
[20] Si veda un cenno su questo punto in B. Sergiovanni, op. cit., 233.