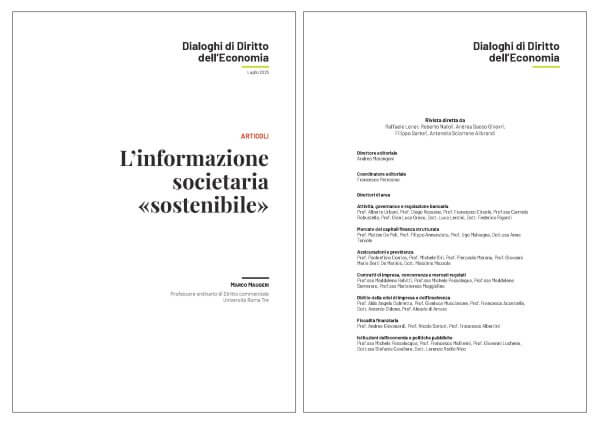[*] SOMMARIO: L’articolo analizza la disciplina dell’informazione societaria sostenibile alla luce della direttiva europea CSRD e del decreto legislativo italiano n. 125/2024, evidenziando le implicazioni del nuovo impianto normativo sia per il mercato finanziario sia per il governo societario. Specifiche riflessioni sono dedicate al problema dell’incidenza che la gestione «sostenibile» dell’impresa potrebbe avere sulla responsabilità degli amministratori, nonché al tema del bilanciamento tra istanze di trasparenza del mercato ed esigenze di riservatezza aziendale. L’articolo si chiude, infine, con alcuni cenni sulla funzione della società per azioni nell’era della sostenibilità.
ABSTRACT: The article analyzes the regulation of corporate sustainability reporting in light of the European CSRD Directive and Italian Legislative Decree No. 125/2024, highlighting the implications of the new regulatory framework for both the financial market and corporate governance. Specific considerations are devoted to the issue of the impact that ‘sustainable’ corporate management could have on the liability of directors, as well as to the balance between market transparency requirements and corporate confidentiality needs. The article concludes with some remarks on the role of corporations in the era of sustainability
1. Premessa
Una analisi degli obblighi di trasparenza in materia di sostenibilità impone anzitutto di interrogarsi sul fondamento di tale disciplina. Qualunque dovere pubblicitario imposto dalla legge comporta, infatti, un costo per l’impresa tenuta al suo adempimento: un costo che può misurarsi sia in termini di oneri «diretti» concernenti la raccolta, l’elaborazione e la divulgazione delle informazioni, sia in termini di oneri «indiretti», concernenti tanto il potenziale danno reputazionale ove l’informazione abbia un contenuto negativo (se non un vero e proprio rischio di sanzioni civili, amministrative e penali, ove si tratti di comunicare condotte suscettibili di integrare una violazione di norme imperative), quanto il potenziale svantaggio concorrenziale, ove le informazioni riguardino piani, investimenti e strategie e quindi informazioni sulla crescita prospettica dell’impresa.
Questi costi impongono all’interprete, e prima ancora al legislatore, di selezionare la specifica esigenza informativa che si vuole soddisfare e che deve essere di rilevanza tale da giustificare il sacrificio imposto alla legittima istanza di riservatezza dell’impresa, nonché di ritagliare conseguentemente il perimetro dei destinatari dell’informazione[1].
Nel diritto societario e nel diritto del mercato finanziario lo scopo degli obblighi di trasparenza è chiaro: per un verso, quello di consentire ai soci un esercizio informato dei diritti sociali (a partire dal voto in assemblea); per altro verso, quello di porre l’investitore in condizione di prendere decisioni ponderate di acquisto o vendita dei titoli trattati.
Quando si passa, invece, ad analizzare la materia dell’informazione sostenibile l’individuazione delle finalità perseguite diviene ambigua perché ambiguo è il disegno coltivato dal legislatore. In parte ciò può dipendere dalla natura stessa del “problema” della sostenibilità e dalla sua idoneità a interessare un gran numero di persone e quindi a sollecitare un gran numero di teorie (favorevoli, contrarie o “intermedie”)[2], le quali tuttavia non poggiano su metodi scientifici sufficientemente condivisi[3]. L’ambiguità appare, in realtà, radicata nella stessa impostazione normativa. Sebbene, infatti, la direttiva n. 2022/2464 del 14 dicembre 2022 (c.d. “CSRD”) – e conseguentemente anche la disciplina domestica di recepimento dettata dal d. lgs. 6 settembre 2024, n. 125 – attengano formalmente solo al piano dell’informazione sulle «questioni di sostenibilità»[4], il complesso di obblighi di trasparenza delineati al riguardo solleva l’interrogativo se le imprese tenute ad osservarli siano ancora libere nella selezione degli assetti organizzativi deputati a garantire una rendicontazione conforme agli standard normativi o se esse siano ormai “indirizzate” dalla legge alla realizzazione di più generali obiettivi di politica ambientale o sociale, se non messe al servizio dell’adozione di un vero e proprio sistema «eco-sociale di mercato»[5]. Questa dicotomia assiologica appare radicata già a livello del Trattato sull’Unione Europea il cui art. 3, par. 3, contiene un riferimento allo scopo di promuovere sia «un’economia sociale di mercato fortemente competitiva», sia «un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente». Essa traspare anche nella Carta costituzionale: se è vero infatti che l’art. 41, comma 2, erige l’ambiente a valore che non può essere pregiudicato dalla iniziativa economica privata, e il successivo terzo comma attribuisce al legislatore ordinario il potere di stabilire programmi e controlli per «indirizzare» l’attività economica privata a «fini ambientali e sociali», è altrettanto vero che la proprietà assurge al rango di bene parimenti protetto ai sensi dell’art. 42 Cost.[6]. E se non vi è dubbio che la proprietà privata, e quindi anche la proprietà «azionaria», possa subire limitazioni per assicurarne l’orientamento a una funzione sociale, è quanto meno dubbio, almeno nell’attuale assetto della costituzione economica italiana ed europea, che gli eventuali vincoli imposti con legge ordinaria all’investimento possano spingersi sino a sacrificare il nucleo essenziale dell’istituto della s.p.a.: come avverrebbe se l’ordinamento contemplasse un potere – o addirittura un obbligo – degli amministratori di perseguire istanze ambientali o sociali anche quando collidano con l’obiettivo del conseguimento di utili o della creazione di valore monetario per gli investitori sotto forma di incremento del prezzo di mercato delle azioni.
2. La rendicontazione sostenibile «volontaria»
La adozione della CSRD segna sul punto una «metamorfosi funzionale» del diritto della sostenibilità[7]. Per rendersene conto è sufficiente muovere dall’impianto originario della direttiva n. 2014/95/UE del 22 ottobre 2014 sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (direttiva attuata con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254) la quale si imperniava sui seguenti capisaldi: (i) natura volontaria delle politiche in materia di sostenibilità e previsione di un obbligo di “comply-or -explain” caratteristico delle fonti di soft law[8]; (ii) possibilità di allocare la dichiarazione non finanziaria in un documento separato dalla relazione sull’andamento della gestione; (iii) intervento del revisore circoscritto al solo compito di confermare l’esistenza della dichiarazione non finanziaria e a una “limited assurance” in ordine alla conformità del documento a quanto richiesto dalla legge e dagli standard di rendicontazione applicati dall’emittente (ancorché il Regolamento Consob del 18 gennaio 2018 consentisse poi all’organo amministrativo di chiedere al revisore una “reasonable assurance”, e cioè una attestazione piena, sulla conformità alla legge della dichiarazione «in tutti gli aspetti significativi»).
In tale assetto normativo l’unico vincolo sostanziale al comportamento degli amministratori finiva con l’identificarsi nel dovere di descrivere le politiche adottate e i risultati conseguiti o di spiegare le ragioni alla base della scelta di non adottare alcuna policy. Si trattava, pertanto, di un contesto caratterizzato da una ampia discrezionalità degli amministratori, governata dalla vigenza della business judgment rule, e da una chiara prevalenza di logiche di mercato (miglioramento dell’immagine della società, accresciute possibilità di collocamento dei propri prodotti su mercato, motivazione dei dipendenti, etc.). Un contesto che sembrava riposare sull’assunto di fondo secondo cui il rispetto di elevati standard ESG avrebbe garantito “automaticamente” anche la realizzazione dell’interesse finanziario dei soci all’incremento di valore delle azioni e che manifestava la consapevolezza del legislatore europeo in ordine all’impossibilità (o comunque alla inopportunità) della scelta di limitare la libertà delle imprese di valutare se attenersi “solamente” all’osservanza delle norme imperative in materia di ambiente, diritti umani ed eguaglianza sociale o aderire eventualmente a standard di tutela più elevati.
3. La rendicontazione sostenibile «imperativa»
La recente evoluzione della disciplina europea in materia di informazione sostenibile segna, come ben noto, l’abbandono del regime opzionale. Con l’entrata in vigore della CSRD (e la conseguente modifica recata alla direttiva contabile 2013/34/UE del 26 giugno 2013 mediante l’introduzione dei nuovi artt. 19-bis e 29-bis), diviene stringente il collegamento sistematico con l’informazione di bilancio: (i) la rendicontazione di sostenibilità individuale o consolidata va inserita in apposita sezione della relazione sull’andamento della gestione (artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del d. lgs. 125/2024), (ii) gli organi amministrativi e il dirigente preposto devono attestarne la conformità agli standard di rendicontazione approvati a livello unionale mentre (iii) un revisore appositamente “abilitato” ai sensi dell’art. 14-bis del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il c.d. «revisore della rendicontazione di sostenibilità») deve a sua volta esprimere le proprie conclusioni in ordine alla conformità della rendicontazione alle norme che ne disciplinano la redazione[9]. La scelta di assoggettare inderogabilmente la trasparenza climatica alle regole caratteristiche dell’informazione contabile assolve allo scopo di promuovere l’omogeneità della comunicazione sostenibile al mercato dei diversi emittenti e di agevolare la comparabilità dei dati[10], contrastando sia fenomeni di «selezione avversa» (indotti dall’eventualità che imprese concorrenti si propongano al mercato come sostenibili pur non rispettando i parametri del Regolamento europeo n. 2020/852 in materia di tassonomia: c.d. “greenwashing”) sia fenomeni di «azzardo morale» (indotti dall’eventualità che le imprese possano destinare la raccolta derivante dalla emissione di prodotti finanziari “verdi” a impieghi che poco o nulla hanno a che vedere con la realizzazione di obiettivi ecosostenibili)[11].
Tuttavia, l’introduzione di obblighi di trasparenza così pervasivi, gravando le imprese di significativi svantaggi competitivi sui mercati internazionali e di rilevanti costi di compliance[12], accresce ancor più l’esigenza di individuare gli interessi tutelati da quegli obblighi e di ricostruirne il fondamento sistematico. Ed è sotto questo essenziale profilo che si manifesta la già segnalata ambiguità degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione e la difficoltà di rintracciare alla base della CSRD una spiegazione coerente che sia idonea a sorreggerne tutte le concrete implicazioni. Per rendersene conto è necessario orientare l’attenzione verso la cerchia dei destinatari dell’informazione sostenibile: solo così, infatti, appare possibile fornire una motivazione ricostruttiva persuasiva del principio di trasparenza in materia ESG, almeno se si muove dall’assunto secondo cui gli obblighi di pubblicità nel diritto commerciale e nel diritto del mercato finanziario non sono mai un fine a sé ma valgono a consentire l’assunzione di decisioni consapevoli da parte di determinati soggetti il cui interesse si reputa prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza dell’impresa[13]: beneficiari che si tratta però allora di identificare.
Ebbene, in proposito il considerando n. 9 della CSRD identifica il nucleo di soggetti destinatari della somministrazione di informazioni sostenibili in «due gruppi principali di utenti»: quello degli «investitori», i quali «desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l’impatto di tali investimenti sulle persone e sull’ambiente»; e quello degli «attori della società civile», incluse le organizzazioni non governative e le parti sociali, «che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull’ambiente»[14]. In altri termini, la rendicontazione sostenibile viene giustificata dalle istituzioni europee sia in ragione della sua rilevanza per il mercato finanziario – come accade tradizionalmente per l’informativa contabile e societaria – sia enfatizzandone il significato per gli interessi diffusi della società civile[15].
La natura funzionalmente ancipite della trasparenza sostenibile non è tuttavia priva di conseguenze pratiche; essa genera, anzi, una immanente tensione sistematica di cui l’interprete deve essere consapevole. Si pensi al contenuto della rendicontazione di sostenibilità e alla sua “scissione” tra informativa concernente l’incidenza che i rischi ESG hanno sulla redditività dell’impresa e informativa concernente l’impatto che l’attività di impresa produce sull’ambiente, i diritti umani e la società nel suo complesso. E si pensi altresì al problema della selezione del perimetro di applicazione della disciplina e al tentativo della CSRD di coniugare due criteri tra loro alternativi sul piano concettuale: da un lato, quello delle dimensioni dell’impresa, l’unico davvero compatibile con una prospettiva “outside-in”[16]; dall’altro, quello offerto dalla negoziazione dei titoli in un mercato regolamentato il quale, però, prescinde dalle dimensioni o dal grado di rischio che l’impresa rappresenta per l’ambiente e proprio in quanto, questa volta, è la prospettiva “finanziaria” dell’investimento ad assumere rilievo[17].
Conviene, dunque, articolare le restanti riflessioni distinguendo tra lo scenario in cui la categoria dei fruitori dell’informazione sostenibile sia popolata da «investitori» e l’ipotesi in cui la rendicontazione di sostenibilità sia destinata alla «società civile» e verificarne alcune implicazioni per il diritto societario e del mercato finanziario.
4. Informazione sostenibile e mercato finanziario
Anche a prescindere dal dibattito generale sullo scopo perseguito da una s.p.a.[18], è coerente immaginare che un emittente titoli negoziati su un mercato regolamentato abbia interesse a divulgare informazioni in materia ESG nella misura in cui ciò serva a ottimizzare il costo del capitale. In altri termini, la trasparenza climatica può provocare una trasformazione in senso “sostenibile” dell’attività dell’emittente se si assume che gli investitori siano disposti a pagare un premio per sottoscriverne le azioni o gli strumenti di debito[19]. La natura di tale premio, e quindi anche l’entità del conseguente beneficio finanziario, dipende a sua volta dalla funzione di utilità dell’investitore. L’investitore «ragionevole», che opera con l’obiettivo di massimizzare il rendimento di un portafoglio titoli a parità di rischio, terrà conto del profilo di sostenibilità di un emittente solo in quanto esso sia suscettibile di incidere sul «valore fondamentale delle azioni» del singolo emittente, ad es. influenzandone la capacità di generare flussi di cassa futuri o l’esposizione al rischio ambientale o di contestazioni salariali[20]. Ciò pone il problema del rapporto tra la nozione di informazione «sostenibile» e quella di informazione privilegiata[21]. Non vi è dubbio che la prima presenti una estensione concettuale maggiore tanto sul piano «oggettivo» (poiché non tutto il contenuto della relazione di sostenibilità potrà qualificarsi price sensitive ai sensi dell’art. 7, par. 1, di MAR), quanto sul piano «soggettivo» (atteso che, come già osservato, la disciplina della CSRD si applica agli enti di interesse pubblico indipendentemente dalla ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF). Tuttavia, non si può escludere che le informazioni concernenti le questioni ESG, se rese note al mercato, siano tali da influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari dell’emittente: sia nel caso di informazione pertinente a un singolo evento (ad es., in caso di miglioramento del rating ESG dell’emittente o, all’opposto, di un suo downgrading), sia nel caso in cui essa riguardi un processo prolungato (si pensi alla programmazione d’impresa, inclusi «i piani finanziari e di investimento», che deve essere articolata in modo da garantire l’eco-compatibilità della strategia aziendale).
Al tempo stesso, l’obbligo di inserire nella relazione sulla gestione anche le «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità» presuppone l’esistenza di una categoria di investitori che sia incline a combinare preferenze finanziarie con aspettative eco-sociali e a sacrificare allora anche una parte dell’utilità monetaria ritraibile dall’investimento ove ciò sia propedeutico a realizzare obiettivi ESG. Ci si è già diffusamente intrattenuti in altra sede sulle caratteristiche tipologiche di questa platea di investitori «responsabili» e sulle principali implicazioni ricostruttive che la sua considerazione normativa comporta in termini di efficienza del mercato finanziario e di dilatazione del novero di informazioni da somministrare agli investitori[22].
In questa sede ci si può limitare a sottolineare due aspetti. Il primo attiene all’obiettivo di politica del diritto perseguito dal legislatore europeo. Se si legge – come si deve – la CSRD in connessione con il Regolamento (UE) n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e con il Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020 sulla tassonomia delle attività di impresa emergerà in modo evidente come il fine ultimo del complesso di regole unionali in esame vada ben oltre quello di informare il mercato finanziario sull’impatto che l’esercizio dell’impresa può avere sui temi ambientali e sociali identificandosi piuttosto con la volontà di stimolare attivamente la ricerca di tali informazioni da parte degli investitori istituzionali e quindi, indirettamente, le imprese a orientarsi verso risultati ambientalmente e socialmente sostenibili[23]. Questo «interesse pubblico» a una direzione eco-sociale dell’impresa (industriale e finanziaria) spiega la scelta europea di abbandonare una strategia normativa fondata su regimi opzionali, malgrado in favore di tale strategia si lascino tuttora addurre validi argomenti, soprattutto in presenza di una chiara individuazione della disciplina c.d. “di default” (ossia delle norme che si applicherebbero in mancanza di una diversa scelta dei soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza)[24].
Il secondo profilo, che appare una inevitabile conseguenza di quanto appena osservato, attiene all’esigenza di individuare un criterio per comporre il conflitto che può determinarsi tra l’interesse pubblico alla trasparenza climatica e l’interesse dell’emittente alla riservatezza. Sul punto l’art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 125/2024, dopo aver precisato che rimangono fermi «gli obblighi derivanti dall’ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione», aggiunge che, «previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa», a condizione tuttavia che ne venga fatta «menzione nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente comma» e che l’omissione non sia tale da «pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività» in relazione alle questioni di sostenibilità[25]. La norma sembra assegnare, pertanto, una chiara prevalenza all’istanza di trasparenza verso il pubblico rispetto all’interesse sociale al riserbo sull’informazione sostenibile[26] atteso che l’omissione è legittima solo «in casi eccezionali» e sempre che essa non impedisca ai destinatari della rendicontazione una «corretta» ed «equilibrata» comprensione sia dell’andamento e dei risultati dell’impresa sia, e soprattutto, del suo impatto sulle questioni di sostenibilità. Si realizza, in questo modo, un allineamento delle regole sulla trasparenza sostenibile al regime giuridico stabilito da MAR per le informazioni aventi natura privilegiata anche nelle ipotesi in cui l’informazione ESG non sarebbe di per sé rilevante sotto il profilo finanziario in quanto insuscettibile di determinare, una volta nota al mercato, effetti significativi sulla quotazione delle azioni. Come appena osservato, infatti, l’art. 3, comma 5 del d. lgs. n. 125/2024 fa salvi «gli obblighi derivanti dall’ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato», mostrando così di circoscrivere il proprio ambito di operatività alle sole ipotesi in cui le informazioni sostenibili omesse non siano di per sé qualificabili come informazioni privilegiate ai sensi dell’art. 7 MAR e non risulti già invocabile, pertanto, il criterio di bilanciamento tra interesse pubblico alla trasparenza e interesse sociale alla riservatezza realizzato dall’art. 17 MAR (e dagli orientamenti interpretativi dell’ESMA) mediante l’istituto del ritardo[27]. Si può aggiungere, anzi, che la facoltà dell’emittente di posporre la comunicazione al pubblico delle informazioni sostenibili sia subordinata a condizioni ancora più rigorose di quelle previste da MAR per differire la pubblicazione di una informazione (finanziaria) privilegiata. Non solo, infatti, l’omissione è consentita solo «in casi eccezionali» e solo ove l’informazione attenga a «sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione», ma l’esercizio di tale facoltà presuppone una deliberazione «motivata» dell’organo amministrativo, sentito l’organo di controllo, e addirittura che ne sia data «menzione» nella rendicontazione di sostenibilità con esplicito rinvio alla norma dell’art. 3, comma 5, d. lgs. n. 125/2024: un requisito, quest’ultimo, che non avrebbe senso evidentemente postulare in caso di ritardo nella divulgazione al mercato di una informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7 MAR e che vale a segnare ulteriormente la distanza che separa gli obiettivi della disciplina sulla rendicontazione sostenibile da quelli tradizionalmente ascritti alla trasparenza dell’informazione finanziaria.
5. Informazione sostenibile e governo societario
La nuova disciplina dell’informazione sostenibile appare gravida di implicazioni ricostruttive e operative anche in rapporto al governo societario. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. lgs. n. 125/2024, infatti, la rendicontazione di sostenibilità deve tra l’altro includere: (a) una descrizione del «modello e della strategia aziendali» che l’emittente intende allestire al fine di garantirne la compatibilità con la transizione verso una economia sostenibile e con obiettivi di limitazione del riscaldamento globale e indicare «il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell’impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interessi e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità»; (b) una descrizione degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall’impresa; (c) una descrizione del «ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo»; (d) una descrizione delle politiche dell’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità; (e) informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivazione per gli amministratori connessi alle questioni di sostenibilità; (f) una descrizione delle procedure di dovuta diligenza, «dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore», come pure «di eventuali azioni intraprese dall’impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni».
Soprattutto quest’ultima prescrizione – a maggior ragione ove filtrata alla luce degli artt. 5 ss. della direttiva (UE) n. 2024/1760 del 13 giugno 2024 sui doveri di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. “CSDDD”)[28] – segnala l’esistenza di un vero e proprio dovere organizzativo degli amministratori di pianificare l’attività in modo da isolarne, monitorarne e neutralizzarne, o comunque mitigarne, le conseguenze negative sull’ambiente e la società civile (c.d. “Climate Change Compliance”). Si può discutere in ordine al reale carattere di novità di un simile dovere. Certo è che, anche a voler ammettere che la CSRD abbia esplicitato un comportamento doveroso già immanente nel generale obbligo di diligenza professionale di cui all’art. 2392, comma 1, c.c., la sua articolata declinazione integra in misura significativa il contenuto precettivo dell’art. 2086, comma 2, c.c., ampliando il novero dei «principi di corretta amministrazione» dell’impresa[29] e correlativamente restringendo il margine di discrezionalità degli amministratori[30], i quali sono ormai tenuti a considerare gli interessi dei c.d. “stakeholder” e ad adottare quindi tanto misure che prevengano i potenziali impatti negativi dell’attività, quanto misure che ne attenuino l’intensità una volta che quegli impatti si siano verificati[31].
In tale cornice l’interrogativo sistematico di fondo è se l’evoluzione della disciplina ESG determini un ampliamento dei confini della responsabilità degli amministratori, da attivarsi non solo in ipotesi di violazione degli obblighi di informazione societaria riferiti alle questioni di sostenibilità[32] ma anche in caso di violazione del dovere di dotare l’impresa di un assetto organizzativo «adeguato» alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi che l’esercizio dell’impresa può generare a detrimento dell’ambiente e dei diritti umani[33]. Sotto questo profilo, in particolare, la riflessione futura della dottrina dovrà concentrarsi sui termini entro i quali sia ipotizzabile (e opportuna) una nuova fattispecie di responsabilità degli amministratori verso la società che sia stata condannata al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie o al risarcimento del danno inferto a eventuali stakeholders[34], nonché verso i terzi che siano stati direttamente danneggiati da quegli effetti ambientali o sociali pregiudizievoli che un sistema articolato di risk management avrebbero consentito di prevenire o comunque di attenuare[35]. Ed è evidente che il tenore della risposta a questo interrogativo dipenderà dall’ampiezza che si sia disposti ancora a riconoscere alla business judgment rule nella definizione dei «modelli e delle strategie aziendali»; o, per guardare allo stesso problema in una prospettiva speculare, dalla misura nella quale si ritenga che il nuovo impianto di doveri tracciato dalla disciplina della CSRD appartenga ancora all’alveo concettuale del generale obbligo di diligenza o sia ormai attratto nell’area dei «doveri di legalità» degli amministratori e, in quanto tale, si sottragga all’efficacia esimente della BJR[36].
6. Conclusione: quale funzione per la s.p.a. eco-sostenibile?
Un’ultima considerazione è necessaria al termine di questo intervento. Essa riguarda il futuro stesso della società per azioni, almeno nella sua configurazione di forma giuridica della grande impresa emittente titoli quotati in borsa. La marcata rilevanza che le finalità ambientali e sociali vanno assumendo nella più recente legislazione ESG[37] induce a chiedersi se in questo modo non sia messo in discussione il dogma stesso della neutralità “politica” del diritto azionario[38]; se, in altri termini, il diritto azionario non venga funzionalizzato al servizio di obiettivi di interesse pubblico o di politica economica, ambientale e sociale[39]. La disciplina della rendicontazione societaria sostenibile amplia gli scopi dell’informazione di bilancio e assegna alla pubblicità d’impresa il compito di realizzare non solo gli interessi dei partecipanti al mercato finanziario ma anche istanze ecologiche, sociali e umanitarie[40]. Che la formulazione di tali istanze si accompagni talvolta a una marcata critica del «valore sociale» del profitto, così tendendo a scardinare un assunto fondamentale della concezione tradizionale dell’impresa[41], appare difficile da escludere[42]. Che le questioni di sostenibilità fondino però un obbligo degli amministratori di gestire l’impresa anche nell’interesse degli stakeholders è quanto meno discutibile in mancanza di norme di diritto positivo che affermino una responsabilità diretta degli amministratori verso i terzi danneggiati da assetti organizzativi inadatti a minimizzare l’impatto ambientale e sociale dell’attività d’impresa e, soprattutto, in mancanza di una modifica della struttura organizzativa della s.p.a. e di regole che assegnino ai portatori di interessi che non siano puramente lucrativi il potere di concorrere all’assunzione di decisioni fondamentali per il controllo della società (come le delibere di nomina e revoca degli amministratori o di destinazione dell’utile di bilancio). Qualunque sia la risposta a questi interrogativi è comunque certo, almeno per chi scrive, che il futuro della s.p.a. «eco-sostenibile» non potrà prescindere dal ruolo del mercato finanziario e dal peso che in esso assumerà la figura dell’investitore «responsabile», animato da preferenze ambientali o sociali e quindi disposto a finanziare piani di sviluppo “verde” dell’impresa anche quando suscettibili di ridurne la redditività.
[*] Il lavoro riproduce il testo delle considerazioni svolte nel corso del Convegno in tema di “Dottrine generali della sostenibilità. Verso una teoria del «diritto privato sostenibile»?”, organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia a Viterbo il 24-26 ottobre 2024, e ulteriormente sviluppate nell’ambito del Seminario su “L’informazione societaria di sostenibilità, fra obblighi di trasparenza e vincoli di sostenibilità” tenutosi presso la Sapienza Università di Roma il 3 luglio 2025.
[1] W. Schön, Informationspflichten der Unternehmensleitung zwischen Aktionärsinteresse, Kapitalmarktinformation und sozialer Verantwortung, in Festschrift für K. Schmidt, II, München, Beck, 2019, 391 ss.
[2] Una teoria “intermedia” che ha riscosso un certo successo è, ad es., quella che va comunemente sotto il nome di “enlightened shareholder value”: non mancano però le perplessità in dottrina (v., ad es., L.A. Bebchuk – K. Kastiel – R. Tallarita , Does Enlightened Shareholder Value Add Value?, in ECGI Working Law Paper, May 2022, specie 18 ss.).
[3] Si pensi alla difficoltà di raggiungere un accordo generale sull’esistenza di un nesso empiricamente dimostrabile tra eco-sostenibilità di una impresa e sua performance finanziaria. Il tasso di condivisione è forse ancora minore nella letteratura giuridica per quanto attiene alla individuazione della concreta portata applicativa del vincolo che le «questioni di sostenibilità» imprimerebbero al potere imprenditoriale degli amministratori: laddove formule che traducono quella portata in un «limite esterno alla gestione dell’impresa» (M. Onza, “Attività funzionale” ed “interessi degli altri” nella gestione dell’impresa (entificata): annotazioni dalla direttiva (UE) 2022/2464, in Banca, borsa, tit. cred., 2023, I, 757 ss., 761) o, all’opposto, in un vero e proprio «dovere di gestione sostenibile» inteso come «il dovere e il potere di proteggere interessi alieni lesi dalle esternalità» generate dall’attività d’impresa (A. Genovese, Rendiconto di sostenibilità e gestione sostenibile dell’impresa azionaria (anche di gruppo), in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, con prefazione di M. Libertini, Firenze, Passigli, 2025, 187 ss.,, 218), pur teoricamente ineccepibili, non offrono un criterio operativo per stabilire, nel singolo caso pratico, come gli amministratori debbano bilanciare l’interesse lucrativo dei soci con l’aspettativa al conseguimento di utilità non finanziarie coltivata dai differenti gruppi di stakeholders, e ancor meno come possano contemperarsi le diverse esigenze ambientali, sociali o umanitarie quando suscettibili di entrare in conflitto tra loro.
[4] Identificate dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d. lgs. n. 125/2024 con i «fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019».
[5] P. Hommelhoff, Nachhaltige Unternehmensfinanzierung: ein Meilenstein auf dem Weg zur ökosozialen Marktwirtschaft, in Festschrift für B. Grunewald, Köln, O. Schmidt, 2021, 389 («öko-soziale Marktwirtschaft»). E altrettanto può predicarsi per la posizione degli investitori istituzionali ai quali si rivolge il pacchetto legislativo europeo in materia di “finanza sostenibile”: cfr., solo per menzionare gli esempi più significativi, il Regolamento (UE) n.2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. “SFDR”), al Regolamento delegato (UE) n. 2021/1253 del 21 aprile 2021 sull’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento, e il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1288 del 6 aprile 2022 recante norme tecniche di regolamentazione a integrazione del SFDR e successivamente emendato dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/363 del 31 ottobre 2022.
[6] V. M. Libertini, Prefazione, in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, cit., 11 (rimarcando l’esigenza di bilanciamento delle istanze ESG «con altri valori costituzionali»).
[7] Cfr. J. Ekkenga, Unternehmenspublizität versus Diskretions- und Wettbewerbsschutz im Handels-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, in ZHR 188 (2024), 471 ss., 474 s.
[8] Cfr., per la dichiarazione non finanziaria, l’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 (di recepimento in Italia della direttiva 2014/95/UE del 22 ottobre 2014, c.d. “NFRD”); medesima impostazione si rintraccia, per l’ambito dell’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, nell’art. 4, par. 1, lett. b), del Regolamento n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 (c.d. “SFDR”), il quale consente ai «partecipanti ai mercati finanziari» (come individuati nell’art. 1, n. 1, del medesimo Regolamento) di motivare le ragioni della «mancata considerazione» degli effetti negativi dispiegati dalle proprie decisioni di investimento sui «fattori di sostenibilità» (a loro volta, definiti nell’art. 1, n. 24, in termini di «problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva»). V., per una analisi di tale cornice regolamentare, M. Maugeri, Informazione non finanziaria e interesse sociale, in Riv. soc., 2019, 992 ss.; M. Rescigno, Note sulle «regole» dell’impresa «sostenibile». Dall’informazione non finanziaria all’informativa sulla sostenibilità, in Anal. giur. econ., 2022, 165 ss.; G. Racugno, Informazione non finanziaria e rendicontazione societaria di sostenibilità, in Giur. comm., 2025, I, p. 19 ss.
[9] Ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. n. 125/2024 l’incarico di rendere la relazione di conformità può essere svolto anche dalla società incaricata della revisione legale del bilancio a condizione che essa sia resa però da un revisore abilitato ai sensi del d. lgs. n. 39/2010.
[10] Cfr. European Commission, Questions and Answers: Corporate Sustainability Reporting Directive proposal, 21 April 2021, ove il rilievo secondo cui «reported information can be hard to compare from company to company, and users of the information are often unsure whether they can trust it».
[11] M. Maugeri, voce «Società e mercato finanziario», in Enc. Dir., I tematici, IX, Società, diretto da C. Angelici con G. Ferri jr e M. Stella Richter jr, Milano, Giuffrè, 2025, 1027 ss., 1037 s.; cfr. anche M. Siri, Finanza sostenibile e greenwashing, in La s.p.a. nell’epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica, II, Milano, Giuffrè, 2024, 761 ss.
[12] Le preoccupazioni indicate nel testo sono state avvertite dalle istituzioni europee al punto tale da indurle a posporre l’entrata in vigore sia della direttiva 2022/2464 sia della direttiva 2024/1760 per larga parte delle società destinatarie dei rispettivi precetti: v. la direttiva n. 2025/794 del 14 aprile 2025 il cui secondo considerando non a caso motiva questa scelta con l’«impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività» delle imprese (c.d. “stop-the-clock directive”). Si v. anche il mandato conferito dal Consiglio Europeo alla Commissione per la negoziazione con il Parlamento Europeo di alcune proposte di semplificazione sia della CSRD, sia della CSDDD (il testo del documento è reperibile al seguente indirizzo: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10276-2025-INIT/en/pdf). Eguali preoccupazioni di fondo (oltre al mutato contesto politico) hanno indotto oltreoceano anche la SEC a ritirare la propria guidance in materia di trasparenza climatica ponendo fine a un aspro contenzioso avviato da Stati e imprese private: v. il press release SEC, 27 marzo 2025, reperibile all’indirizzo https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2025-58.
[13] Naturalmente l’interesse dei destinatari dell’informazione sostenibile, come si osserverà anche oltre nel testo, non è protetto in quanto tale: trattandosi pur sempre di istanze privatistiche non vi sarebbe ragione, infatti, per sacrificare l’interesse dell’impresa alla riservatezza sull’altare dell’interesse di investitori, consumatori, dipendenti, comunità locali, etc. se non nella misura in cui la realizzazione di tale secondo interesse non fosse funzionale al conseguimento di un più ampio interesse pubblico: quello, appunto, all’affermazione di modalità eco-sostenibili di gestione dell’impresa e alla diffusione sul mercato finanziario di prodotti conformi agli schemi pensati dalla legislazione europea in materia di tassonomia.
[14] In realtà questa suddivisione non esaurisce il novero di soggetti potenzialmente interessati a conoscere l’orientamento sostenibile dell’impresa. Vanno infatti considerati almeno i concorrenti, che potrebbero trarre dalla rendicontazione climatica utili indicazioni sui piani futuri di altri operatori presenti nel loro segmento di mercato e adattare conseguentemente le proprie scelte commerciali, nonché gli eventuali acquirenti che attribuiscano rilievo al rating ESG nella selezione di ipotetiche società target e nella determinazione del prezzo di acquisizione: su quest’ultimo aspetto v. L. Hollerung, Sustainable Mergers & Acquisitions – Eine Bestandaufnahme, in ZHR 188 (2024), 148 ss.
[15] Cfr. A. Genovese, Rendiconto di sostenibilità, cit., 196 ss., distinguendo tra una funzione «finanziaria» della rendicontazione di sostenibilità, in quanto diretta a completare l’informazione di bilancio rivolta ai soci e agli investitori, e una funzione «non finanziaria», in quanto volta a introdurre «vincoli di mitigazione attiva dei rischi di sostenibilità (ambientale e sociale) alimentati dalla società» e ricostruibile, in questa prospettiva, come misura tendente a indirizzare l’attività economica privata verso fini ambientali e sociali ai sensi dell’art. 41, comma 3, Cost.
[16] W. Schön, op. cit., 408.
[17] Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 125/2024 , infatti, la disciplina della rendicontazione di sostenibilità si applica alle «imprese di grandi dimensioni» nonché alle «piccole e medie imprese quotate» (per tali dovendosi intendere le imprese che riflettano i parametri indicati nell’art. 1, comma 1, lett. m) del d. lgs. n. 125/2024). Quanto osservato nel testo merita, peraltro, una duplice precisazione. Per un verso, il criterio dimensionale interferisce con (e attenua la portata) del dato oggettivo rappresentato dalla quotazione in borsa atteso che, in forza dell’art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 125/2024, «non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto le micro-imprese, anche qualora abbiano valori ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea» (per micro-imprese dovendosi intendere le imprese che non eccedano i parametri dimensionali indicati nell’art. 1, comma 1, lett. l) del d. lgs. n. 125/2024). Per altro verso, non ogni impresa, ancorché dimensionalmente significativa, viene attratta nell’alveo di applicazione della disciplina in esame bensì soltanto le imprese organizzate in forma di società di capitali (o di società in nome collettivo o in accomandita semplice che abbiano come soci le società indicate nell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE o con forma giuridica comparabile a quelle comprese nel predetto allegato). Sul punto v. A. Caprara, I soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità (individuale e consolidata) , in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, cit., 21 ss.
[18] Ai fini del discorso svolto nel testo non rileva precisare ulteriormente il concetto di «scopo lucrativo» e stabilire se esso debba identificarsi con la massimizzazione del valore di mercato delle azioni, con la massimizzazione dell’utile distribuibile o con la garanzia di un rendimento «equo» per i soci. Il problema è semmai quello di stabilire se la gestione dell’impresa organizzata in forma di s.p.a. possa risolversi in un sacrificio delle aspettative di guadagno dei soci (comunque ricostruite) per il conseguimento di obiettivi sociali, ecologici o umanitari e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti.
[19] T. Tröger, Corporate Governance und Klimawandel, in Festschrift für A. Cahn, München, Beck, 2024, 461 ss., 462 s.
[20] Si pensi all’ipotesi di un emittente con rating ESG elevato e alla possibilità che tale classificazione segnali una maggiore capacità di innovazione dell’impresa o una migliore qualità delle condizioni di lavoro e che queste caratteristiche siano percepite come elementi in grado di assicurare una redditività più elevata rispetto ai concorrenti provvisti di rating ESG inferiori.
[21] Cfr. M. Siri, Finanza sostenibile e greenwashing, cit., 769 ss. (ove anche un richiamo alle incertezze del concetto di “doppia materialità” dell’informazione sostenibile quando utilizzato nel contesto di MAR).
[22] Cfr. M. Maugeri, Le obbligazioni “verdi”: problemi e prospettive, in Riv. dir. comm., 2024, I, 373 ss., specie 387 ss., ove il riferimento, tra l’altro, all’eventualità che, in presenza di un aggregato sufficientemente ampio di investitori socialmente responsabili, il prezzo delle azioni si modifichi indipendentemente dall’impatto che l’informazione sui fattori ESG abbia sulla redditività futura dell’emittente. Un contesto di questo tipo induce a rimeditare il concetto di efficienza degli scambi o almeno a riconsiderarlo per tener conto della rapidità con la quale il prezzo riesce a incorporare informazioni nuove le quali, pur non avendo nulla a che vedere con il valore «finanziario» dell’impresa, sono in grado di segnalarne una migliore (o minore) capacità di conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale o sociale (su questo aspetto si v. anche M. Siri, Finanza sostenibile e greenwashing, cit., 778 s.). Inoltre, in un mercato caratterizzato dalla prevalenza di investitori «responsabili», ci si potrebbe spingere sino a presumere la rilevanza price sensitive delle informazioni sostenibili, se non anche la legittimità di una loro comunicazione selettiva ad azionisti “istituzionali” (gestori di patrimonio, compagnie di assicurazione, fondi pensione, etc.) ai sensi dell’art. 10 MAR, nel presupposto che l’emittente abbia uno specifico interesse a instaurare un dialogo con tali investitori anche solo al fine di promuovere la propria immagine sul mercato o che comunque la comunicazione selettiva sia indispensabile per consentire agli investitori istituzionali di far fronte ai propri obblighi di engagement (v. M. Maugeri, Sostenibilità ed Engagement degli azionisti istituzionali, in Riv. soc., 2021, 1350 ss.).
[23] P. Hommelhoff, op. cit., 396.
[24] Cfr. B. Alemanni, Finanza comportamentale3, Milano, Egea, 2024, 172 s. Per una proposta di applicazione della strategia opzionale alla materia dell’informativa ESG consistente nel devolvere agli investitori la decisione se consentire o meno all’emittente di derogare agli obblighi di trasparenza climatica v. S. Hirst, Saving Climate Disclosure, ECGI Law Working Paper, April 2023, specie 22 ss. Persino chi sostiene la legittimità giuspolitica di una impostazione che vincoli gli amministratori di una s.p.a. al bilanciamento tra lo scopo lucrativo e la considerazione degli interessi dei c.d. “stakeholders” e comunque l’ammissibilità di una gestione eco-sostenibile dell’impresa ammette che il perseguimento di tali obiettivi non rende strettamente necessario il ricorso a indicazioni prescrittive del legislatore, in quanto le imprese sarebbero comunque indotte alla adozione di politiche ambientalmente compatibili dall’ambiente in cui operano (e cioè dai concorrenti, dalle forze manageriali e di lavoro, dagli investitori, dagli utenti dei beni e servizi collocati sul mercato): v. P. Hommelhoff, op. cit., 400 s.
[25] Si tratta della trasposizione letterale nell’ordinamento domestico di quanto previsto dall’art. 19-bis, par. 3, quarto cpv., della direttiva 2013/34/UE (come emendata dalla CSRD).
[26] J. Ekkenga, Unternehmenspublizität versus Diskretions- und Wettbewerbsschutz, cit., 486 s. È evidente che questa gerarchia valutativa pone problemi particolarmente delicati nell’ipotesi in cui l’informazione sostenibile attenga al segreto aziendale: per un tentativo di bilanciamento tra le opposte istanze v. A. Genovese, Rendicontazione di sostenibilità e segreto, in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, cit., 83 ss., specie 89 ss.; e M. Libertini, Rendicontazione di sostenibilità, direttiva CSDDD e tutela dei segreti commerciali, ivi, 241 ss., 244, ad avviso del quale «l’impresa dovrà spesso almeno ‘menzionare’ in maniera sintetica, alcuni fatti o circostanze rilevanti, senza per questo dover arrivare a divulgazioni distruttive del segreto».
[27] Sulle modifiche recate alla disciplina del processo prolungato dal c.d. “Listing Act” cfr. M. Ventoruzzo, Interrogativi preliminari sulla nuova formulazione dell’art. 17 MAR: la nozione di processo prolungato in Riv. soc.., 2024, 1148 ss.; H.-D. Assmann, Die Ad-Hoc Publizität von Zwischenschritten in gestreckten Sachverhalten nach den Änderungen von Art. 17 MAR durch den sog. Listing Act, in ZHR 189 (2025), 14 ss.
[28] Come noto, la CSDDD impone vincolanti prescrizioni in ordine alla integrazione del c.d. «dovere di diligenza» nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione del rischio al fine di individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e l’ambiente dell’attività esercitata nonché a prevenire gli impatti negativi potenziali e ad arrestare, minimizzare o comunque riparare gli impatti negativi effettivi sulle questioni di sostenibilità.
[29] A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria, Bologna, Il Mulino, 2023, 134 ss., ad avviso della quale, in una dimensione di gruppo, sarebbe possibile ricomprendere nella nozione di «correttezza imprenditoriale» contemplata dall’art. 2497, comma 1, c.c. l’interesse degli stakeholders interni ed esterni all’impresa e finanche istanze ambientali e sociali (reinterpretando così il concetto in chiave di «correttezza ambientale e sociale», contrapposta alla «correttezza societaria», prevista dalla stessa norma, che opererebbe limitatamente ai soci, ai creditori e alla società). La logica conseguenza di questa impostazione dovrebbe essere però anche il superamento di una concezione puramente finanziaria dell’interesse sociale della eterodiretta e la possibilità di affermare una responsabilità della capogruppo per violazione della clausola di correttezza ambientale non solo quando determini, appunto, una lesione del valore del patrimonio sociale della eterodiretta ma anche quando l’esternalità negativa colpisca unicamente i terzi (non spiegandosi altrimenti la ragione per la quale la violazione dei principî di correttezza “ambientale e sociale” così delineati legittimi ad agire nei confronti della capogruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c. solo i soci e i creditori della eterodiretta, e non anche i suoi dipendenti o i componenti della più ampia società locale incisa dal comportamento dannoso della controllata indotto dalle direttive della controllante). Una conclusione, questa, sulla quale è però legittimo nutrire più di un dubbio.
[30] Ma anche la libertà dei soci di conformare liberamente gli assetti statutari della società o di articolare la composizione del consiglio di amministrazione e i piani di remunerazione degli organi delegati: v. ancora A. Genovese, Rendiconto di sostenibilità e gestione sostenibile dell’impresa azionaria (anche di gruppo), in La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile, a cura di A. Genovese, cit., 190 e 199 (evocando le ripercussioni che la disciplina della trasparenza di sostenibilità può avere non solo sulla discrezionalità imprenditoriale degli amministratori ma anche sulle «prerogative di indirizzo dei soci e dell’assemblea»).
[31] E v., infatti, J. Ekkenga, Externe Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der neuen CSRD, in ZHR, 187 (2023), 228 ss., 256.
[32] Cfr. C. Osterloh-Konrad, Haftung von Emittenten und Intermediären für Nachhaltigkeitsinformationen, in ZHR, 187 (2023), 309 ss.; M. Maugeri, Le obbligazioni verdi: problemi e prospettive, in La s.p.a. nell’epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica, II, Milano, Giuffrè, 2024, 915 ss., specie 931 ss.
[33] A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria, cit., 143 ss. Cfr. anche M. Onza, “Attività funzionale” ed “interessi degli altri”, cit., 763 ss.
[34] M.-P. Weller-N.Benz, Klimaschutz und Corporate Governance, in ZGR, 2022, 563 ss., 583. Nel caso di società quotata, ove la violazione del dovere di gestione sostenibile si traduca in una riduzione del prezzo di mercato delle azioni, andrebbe altresì esaminata la possibilità di affermare una fattispecie di responsabilità degli amministratori verso gli azionisti che dimostrino, oltre al danno, anche il nesso di causalità con l’inadempimento.
[35] A. Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria, cit., 144 e 177 ss., la quale sembrerebbe rinvenire il fondamento di tale responsabilità, tra l’altro, nella circostanza che le scelte gestorie siano “disallineate” rispetto ai criteri tassonomici previsti dal Regolamento 852/2020 e dai successivi atti delegati. Il che, tuttavia, desta qualche perplessità perché al Regolamento sulla Tassonomia e al Regolamento delegato n. 2021/2178 (come, prima ancora, al d.lgs. n. 256/2014) è estraneo un intento “punitivo”, risolvendosi tali complessi normativi piuttosto nell’individuare criteri oggettivi funzionali a una classificazione delle attività di impresa in termini di sostenibilità. Il fondamento di una eventuale responsabilità degli amministratori – per chi intenda affermarla – va semmai riportato alla filosofia che pervade sia la CSRD sia la CSDDD, le quali si propongono di conformare il diritto azionario materiale attraverso l’obbligo di adottare politiche di gestione e mitigazione del rischio ambientale e, in tale contesto, di formulare un vero e proprio «piano» che assicuri la conformità dell’agire imprenditoriale agli obiettivi della lotta al cambiamento climatico. Nel novero dei precetti in materia di governance della sostenibilità rientra, d’altra parte, anche la disciplina della remunerazione degli amministratori esecutivi di società quotate, la cui componente variabile può – e, assecondando la tendenza legislativa appena evocata, ormai deve – essere almeno in parte ancorata al conseguimento di obiettivi ESG (cfr. M. Maugeri-M. Pompili, I compensi degli amministratori, nel Trattato Donativi, II, Torino, Utet, 2022, 1866, 1883 ss.).
[36] In questo senso v., ad es., T. Kuntz, How ESG is Weakening the Business Judgment Rule, in www.ssrn.com, 2023, specie 13 ss. (sottolineando come l’incremento delle norme da osservare implichi un dilatazione degli obblighi di vigilanza del consiglio di amministrazione la cui inosservanza non è coperta dalla BJR). Cfr. anche M. Libertini, Prefazione, cit., 12 ove il rilievo secondo cui le norme della CSRD «trasformano in doveri giuridici quelli che, finora, erano programmi di ‘responsabilità sociale d’impresa’, assolutamente facoltativi».
[37] E v. ancora T. Kuntz, op. cit., 6 (discorrendo di una “Verrechtlichung” degli interessi non finanziari dei terzi).
[38] Solleva questo interrogativo, risolvendolo in senso negativo, G. Bachmann, Zielsetzung und Governance von Unternehmen im Lichte der Klimaverantwortung, in ZHR 187 (2023), 166 ss., 173 ss. e 208; M.-P. Weller-N.Benz, Klimaschutz und Corporate Governance, cit., 567 s. (osservando come il perseguimento di interessi pubblici attraverso il diritto privato sia considerato un «corpo estraneo» anche nell’esperienza comparatistica).
[39] V. ancora M. Libertini, Prefazione, cit., 7 (qualificando la CRSD come «fondamentale tappa del programma politico volto ad affermare il dovere di gestione sostenibile delle imprese»).
[40] J. Ekkenga, E Unternehmenspublizität versus Diskretions- und Wettbewerbsschutz, cit., 513.
[41] Su questo significato del profitto «come corrispettivo dell’opera e del rischio dell’imprenditore» v. G. Minervini, L’evoluzione del concetto d’impresa (spunti per una ricerca), in Riv. soc.. 1976, 496 ss., 503.
[42] In alcuni casi la critica si fa esplicita sino al punto di individuare la causa primaria della crisi climatica nel sistema capitalistico in sé di cui si propone allora il superamento: v. ad es., per un tentativo di recuperare il pensiero di Marx in una logica di «decrescita», S. Kohei, Il capitale nell’antropocene (trad. it. di Alessandro Clementi degli Albizzi), Torino, Einaudi, 2024, specie 80 ss.