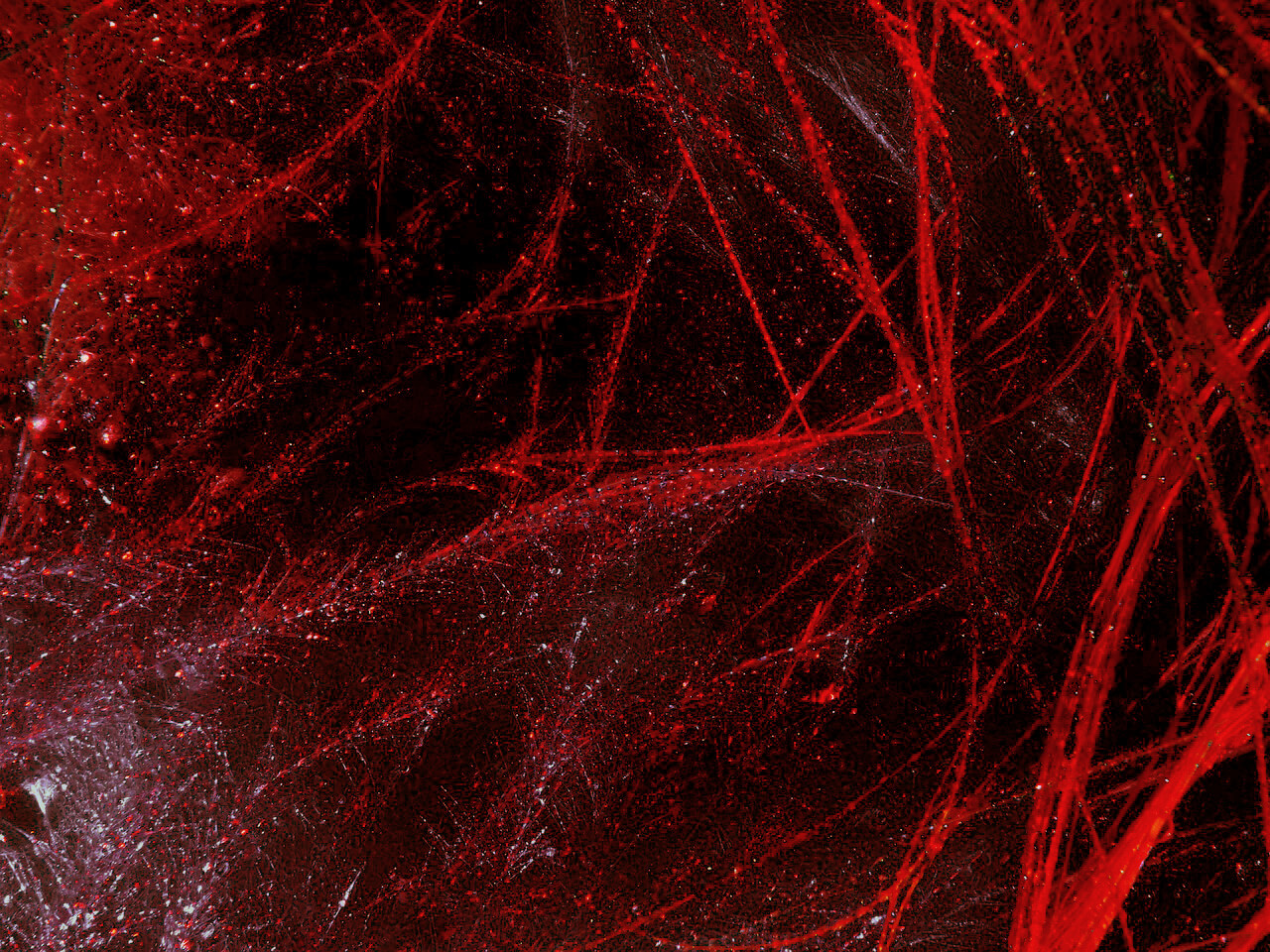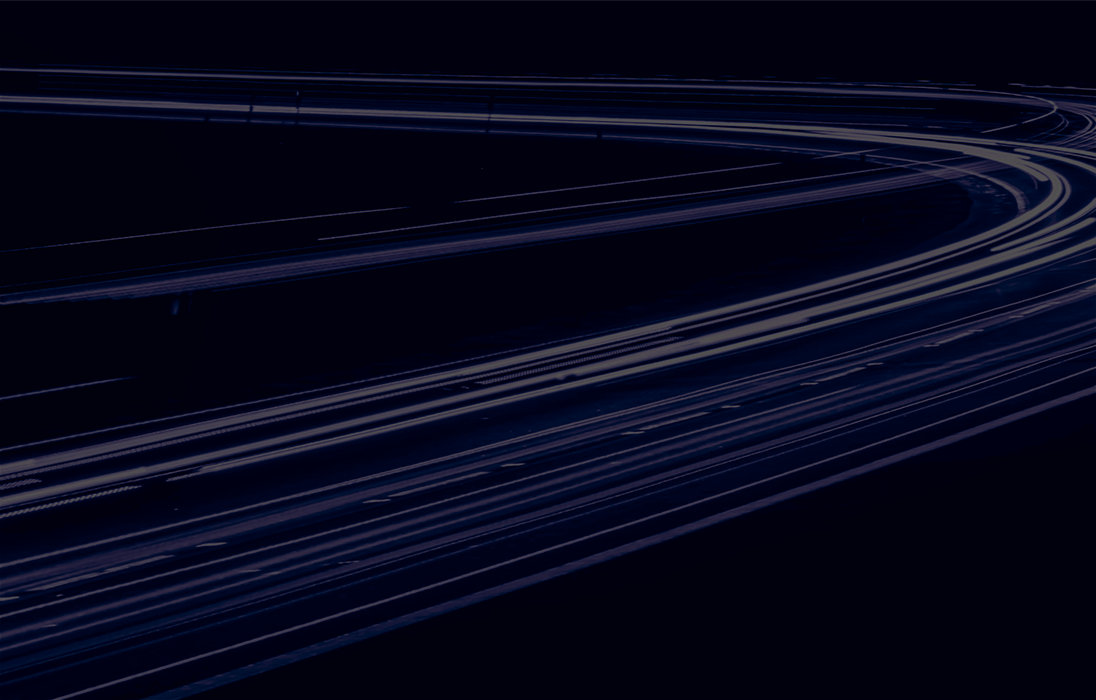Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 23093 dell’11 agosto 2025 (Pres. D’Ascola, Rel. Scarpa), si sono pronunciate sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare.
Questi i principi di diritto affermati:
- La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall’art. 832 cod. civ., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e non nell’adesione di un ‹‹altro contraente››.
- Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall’art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato.
Nel caso di specie era stato rogato e successivamente trascritto in Conservatoria l’atto di rinuncia alla proprietà di alcuni fondi siti in un comune, sostanzialmente inservibili e privi di valore economico in quanto sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo.
Nel corso di un procedimento instaurato dal MEF e dall’Agenzia del demanio per ottenere la declaratoria di nullità, o comunque di inefficacia nei confronti dello Stato dell’atto notarile, il Tribunale di L’Aquila aveva pronunciato ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis C.p.c., riferendo che le amministrazioni
avevano dedotto la non configurabilità nel nostro ordinamento di una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, perciò sostenendo la illiceità o non meritevolezza della causa dell’atto impugnato, ovvero la illiceità del motivo determinante, o la frode alla legge, o ancora l’abuso del diritto.
Analogo rinvio pregiudiziale aveva pronunciato il Tribunale di Venezia, per una questione analoga relativa ad un immobile sito in provincia di Belluno, afferente in sostanza a immobili sottoposti a vincoli conformativi della proprietà privata, finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico alla stabilità e alla difesa dell’assetto idrogeologico del territorio, che comporta la prescrizione di limiti ed obblighi alle rispettive facoltà dominicali.
Sul diritto di disporre del bene, insito al diritto di proprietà
Le questioni rimesse dai Tribunali di L’Aquila e di Venezia hanno indotto preliminarmente a riflettere la Corte sulla portata del “diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo“, ex art. 832 C.c., e sulla configurabilità di un “limite”, da rinvenire nella legge, a norma dell’art. 42, c. 2 Cost., alla possibilità giuridica di rinunciare alla titolarità dell’immobile, che permei il contenuto del diritto stesso e così ricada sulla rilevanza dell’atto abdicativo.
L’esercizio della facoltà di disporre della proprietà non implica necessariamente lo scambio con un suo corrispettivo: si pensi alla donazione, oltre che alla rinuncia del diritto.
La Corte evidenzia, in ogni modo, che l’idoneità di una cosa a formare oggetto del diritto di proprietà implica essenzialmente che essa possa essere sia trasferita a terzi, ovvero scambiata con altre cose, sia rinunciata da parte del titolare.
Il tema in esame coinvolge, dunque, anche la concorrente facoltà di “godere” delle cose, elevata dall’art. 832 C.c. a contenuto della proprietà, e che si spiega come attuazione, ad opera del titolare, dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione di attribuzione tra soggetto e bene.
Tale facoltà non può essere scissa da quella di disporre della cosa, consistendo nel potere di scegliere la destinazione economica da imprimere ad essa e di utilizzarla in modo oggettivamente apprezzabile.
Sulla funzione sociale della proprietà come asserito limite alla meritevolezza della scelta di destinazione del bene
Nel valutare la meritevolezza della scelta di destinazione e di utilizzazione del singolo bene operata dal proprietario, la Corte muove le proprie considerazioni proprio dal principio dettato dall’art. 42, c. 2, Cost., che chiede alla legge di riconoscere e garantire la proprietà privata determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la “funzione sociale”: la Corte ricorda che tale precetto costituzionale ha richiesto alla legge ordinaria di disciplinare l’intera materia della proprietà privata, riferendosi tanto ai “modi d’acquisto”, quanto a quelli di godimento ed infine ai limiti (che fanno rinvio alla conformazione del contenuto del diritto di proprietà realizzato dalla legge).
La concezione della funzione sociale della proprietà come strumento attuativo della soddisfazione di interessi generali, e non dell’interesse economico individuale del titolare, svolge il suo ruolo mediante limitazioni legali delle facoltà di disposizione e di godimento che si giustificano per intere categorie di beni, inserendosi nella struttura del diritto e vincolandolo indissolubilmente ad un esercizio conformato.
Se la “funzione sociale” esprime, accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali, non vi è, comunque, un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale” legati alla affermazione della responsabilità per l’uso dannoso del bene.
Dalla cornice ordinamentale non emerge, dunque, per la Corte, un generale potere-dovere del proprietario di esercitare i suoi poteri in maniera “funzionale” al sistema socio-economico: il godimento del bene resta forma di esercizio del diritto di proprietà appartenente al titolare, per il soddisfacimento di un interesse patrimoniale da lui disponibile.
Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non residua alcuna utilità patrimoniale per il dominus, viene meno la medesima proprietà, non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell’interesse collettivo.
Sull’inapplicabilità della disciplina del c.d. “abbandono liberatorio”
Per la Corte è da ritenersi estraneo alla questione oggetto di giudizio anche il dibattito sulle fattispecie di c.d. “abbandono liberatorio” (artt. 882, 963, 1104, 1070 C.c.), la quale persegue una funzione che va oltre l’abdicazione e consiste nella liberazione da un’obbligazione connessa alla cosa, la quale deve essere adempiuta dal titolare del medesimo diritto reale che si dismette, e nasce a carico di quest’ultimo nel momento in cui si verifica la circostanza prevista dalla legge per il suo sorgere: venuto meno lo ius ad rem che consente l’identificazione del soggetto debitore, vien meno anche la causa obligandi.
Pur convenendo con l’impostazione che la liberazione dall’obbligo di contribuire alle spese costituisce pur sempre un effetto e non la causa di queste fattispecie abdicative, quel che connota le stesse è l’interesse rilevante di altri soggetti (il comproprietario, il concedente, il proprietario del fondo dominante), i quali sono investiti a loro volta di un autonomo diritto reale ad utilizzare il medesimo bene.
L’abbandono liberatorio costituisce una rinuncia qualitativamente diversa dalla rinuncia alla proprietà esclusiva, incidendo esse inevitabilmente, mediante acquisto o “accrescimento” ope legis, nella sfera giuridica di un altro soggetto del rapporto reale: tali ipotesi realizzano, dunque, prioritariamente (e non come mero effetto riflesso della rinuncia al diritto reale) una funzione satisfattiva rispetto ad obbligazioni che sono a carico del rinunciante, e si connotano come vicenda estintiva, e non anche mediatamente traslativa, di una posizione soggettiva complessa del dichiarante stesso.
Sulla natura della rinuncia abdicativa delle proprietà immobiliare
La Corte afferma che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto essenzialmente unilaterale, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto.
L’unilateralità e non recettizietà dell’atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell’interesse individuale che essa realizza con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo.
Tale dichiarazione va manifestata nel mondo esterno perché produca il suo effetto mediante atto pubblico o scrittura privata e va trascritta perché sia opponibile a determinati terzi, ma non deve rivolgersi ad una determinata persona perché ne abbia conoscenza, seppure si tratti di persona interessata alla rinuncia.
L’adempimento della trascrizione ex art. 2643, n. 5, C.c. della rinuncia alla proprietà immobiliare contro il suo autore, in quanto atto abdicativo unilaterale, non ha efficacia costitutiva e nemmeno svolge, in realtà, la funzione tipica, disposta dall’art. 2644 C.c., di dirimere i possibili conflitti tra più acquirenti a titolo derivativo dal medesimo dante causa, producendosi il conseguente acquisto dello Stato, stabilito dall’art. 827 cod. civ., a titolo originario, ove sia dimostrata la situazione di fatto della vacanza del bene.
Essendo l’acquisizione a titolo originario al patrimonio disponibile statale un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, della rinuncia abdicativa, eseguire la formalità anche in favore dello Stato, nelle forme della pubblicità dichiarativa prevista per gli atti traslativi, si motiva solo in relazione all’operatività del principio di continuità e per l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi.
Inoltre, la prescrizione di un onere comunicativo in capo al rinunciante, che si aggiunga all’adempimento dell’onere della trascrizione, inerisce non al campo delle regole di validità e di efficacia della rinuncia, quanto a quello delle regole di comportamento, che possono essere soltanto fonte di eventuale responsabilità.
In quanto atto unilaterale diretto ad estinguere un diritto patrimoniale, nella specie modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall’art. 832 C.c. l’unico interesse e l’unico intento che hanno rilievo giuridico sono quelli dell’autore della dichiarazione di rinuncia.
Pertanto, la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare “trova causa” (ed è quindi “meritevole” l’interesse perseguito) in sé stessa e non nell’atto di un altro contraente cui sia destinata, né, del resto, produce un vincolo contrattuale: trattasi di una forma attuativa del potere di disposizione del proprietario che non è soggetta dalla legge ad alcun espresso limite di scopo.
La tesi per cui la proprietà sia essenzialmente disponibile e contemporaneamente irrinunciabile, perché indissolubilmente collegata a doveri, obblighi, limiti e funzioni, non può negare che la proprietà, allora, dovrebbe tutelare altresì un interesse altrui, o di un interesse collettivo, diverso se non opposto rispetto a quello del titolare.
L’art. 2 Cost. giustifica tuttavia la prescrizione al proprietario di obblighi e di comportamenti in funzione di salvaguardia di interessi fondamentali aventi rilevanza collettiva, quali, in particolare, la tutela della salute e dell’ambiente, ma non anche l’imposizione della proprietà privata in sé.
Sugli effetti riflessi della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Non nell’atto di rinuncia, ma nell’effetto riflesso essenziale che esso provoca, trova poi causa l’art. 827 C.c., in base al quale i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato: trattasi di un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto, quale la vacanza del bene immobile, ovvero come ipotesi di acquisto a carattere chiaramente originario.
Per al Corte, l’art. 827 C.c. non è argomento dirimente per affermare l’ammissibilità o l’inammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, che persegue l’unica finalità tipica di dismettere il diritto e regola unicamente l’interesse patrimoniale del proprietario, senza che abbiano rilievo interessi pratici del dominus diversi dall’intenzione puramente abdicatoria, e senza richiedere che alcun altro soggetto controinteressato alla rinuncia ne abbia conoscenza o vi presti assenso, altrimenti costringendo il rinunciante a rimanere proprietario.
L’atto di rinuncia alla proprietà di un immobile non è causalmente rivolto alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico in cui la titolarità del bene è attribuita all’amministrazione statale: lo Stato diventa proprietario dopo che è venuta meno la precedente relazione di attribuzione tra il soggetto e la situazione giuridica di proprietà.
L’acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato trova, perciò, il proprio titolo costitutivo nella vacanza, e non nella rinuncia.
È il legislatore che, per i beni immobili, a differenza di quanto stabilito dall’art. 923 C.c. per le cose mobili abbandonate (ove l’acquisto a titolo originario postula un comportamento apprensivo che si sostanzia nell’occupazione), fa seguire alla rinuncia alla proprietà ed al suo effetto dismissivo del diritto la condizione dell’acquisizione legale a titolo originario in favore dello Stato, senza che quest’ultimo sia chiamato a svolgere alcuna attività positiva di accettazione o di impossessamento.
Il che non impedisce, tuttavia, per la Corte, che il legislatore possa altrimenti rimodulare il vigente art. 827 C.c., in modo da trovare un diverso assetto di equilibrio nei rapporti tra pubblico e privato, operando una riforma di sistema in ordine al regime dei beni immobili vacanti e del correlato acquisto al patrimonio dello Stato e scegliendo i mezzi che riterrà così più idonei a realizzare la tutela dei fini costituzionalmente necessari nella composizione della pluralità degli interessi in gioco, evincibili pure dalle esigenze prospettate nelle difese delle amministrazioni attrici.
La tutela dell’interesse generale non giustifica l’inammissibilità della rinuncia abdicativa
L’acquisizione al patrimonio pubblico dei beni immobili che non sono proprietà di alcuno si spiega, quindi, come espressione della sovranità dello Stato, come sintesi dei valori essenziali della comunità che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali, nella specie in materia di governo del territorio, quelli paesaggistici, ambientali, archeologici e di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, e, prima ancora, quelli collegati alla tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone.
Questo nucleo fondamentale di valori, si impone su qualsiasi pretesa soggettiva di dominio, e non è dunque influenzato dal venir meno dell’interesse particolare del proprietario rinunciante e dalla soggezione dello stesso agli oneri relativi, né è temperato da verifiche caso per caso afferenti alla convenienza economica dell’acquisto statale.
Del resto, se il fondamento della irrinunciabilità della proprietà degli immobili si voglia spiegare per le asserite prevalenti ragioni di tutela dell’interesse generale, è indimostrato che una migliore tutela dell’interesse della collettività sia garantita dalla preclusione dell’effetto dismissivo “antisociale” e dalla permanente titolarità imposta al rinunciante.
Rispetto alle prerogative della sovranità statale in tema di sicurezza e governo del territorio, la prospettazione della nullità di una rinuncia alla proprietà immobiliare mossa dal solo fine egoistico di trasferire in capo all’Erario, per effetto dell’art. 827 C.c., i costi e i danni dei terreni con problemi di dissesto idrogeologico, o inquinati, o gli edifici inutilizzabili, dà vita ad un singolare principio di sussidiarietà orizzontale di compiti nel rapporto fra privati proprietari, investiti prioritariamente del perseguimento di interessi generali a vocazione sociale, e autorità pubblica, la quale subentrerebbe nella titolarità del bene solo se tali interessi siano stati previamente soddisfatti dai rinuncianti.
Il perimetro del sindacato giudiziale sull’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare
Per la Corte non è in discussione la possibilità per i creditori del rinunziante alla proprietà di un immobile di proporre un’azione revocatoria per domandare che sia dichiarato inefficace nei loro confronti l’atto abdicativo di rinuncia, importando esso una pregiudizievole modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore.
Il dibattito si incentra, piuttosto, sulla verifica della “meritevolezza e/o illiceità della causa” dell’atto di rinuncia alla proprietà immobiliare, o della “illiceità del motivo”, o della “frode alla legge”, o della “nullità per contrasto col divieto di abuso del diritto”.
A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, c. 2 Cost., sia pure inteso quale specificazione con riferimento alla proprietà privata dell’art. 2 Cost., per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
La rinuncia alla proprietà immobiliare animata dal “fine egoistico” di accollare allo Stato le spese e i danni dei fondi in dissesto idrogeologico, inquinati o inutilizzabili, analizzata in base alla funzione obiettiva che il rinunciante intenzionalmente attribuisce al negozio, per alcuni sarebbe contraria ad una norma imperativa, oppure il mezzo per frodare l’applicazione di una siffatta norma, o ispirata da un motivo illecito determinante obiettivizzato nell’atto abdicativo.
Tuttavia, la Corte rileva che:
- sotto un profilo formale, l’applicazione diretta da parte del giudice del principio della “funzione sociale” ex art. 42, c. 2 Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti; il precetto costituzionale contempla una riserva di legge relativa, rafforzata dall’indicazione dello scopo della funzione sociale, per cui le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore, e non dal giudice
- sotto un profilo sostanziale, per la Corte non è possibile ritenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare possa realizzare un contrasto con tale precetto, in quanto tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per “motivi di interesse generale”, essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall’apprezzabile valore economico dello stesso.
Consistendo, la rinuncia abdicativa alla proprietà, in un atto di esercizio del dominio realizzatore dell’interesse patrimoniale protetto dalla relazione assoluta di attribuzione tra soggetto e bene, non si presta ad un impiego come strumento diretto ad eludere norme imperative per ottenere un risultato vietato dalla legge, né può pensarsi finalizzata esclusivamente al perseguimento di scopi riprovevoli ed antisociali: la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l’effetto di farne ricadere gli oneri sullo Stato, poiché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale discende non dall’autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma, come già affermato, dall’acquisto ex lege stabilito dall’art. 827 C.c.
Non è sostenibile quindi un controllo giudiziale che preluda ad una tutela demolitoria dell’atto contro gli abusi di cui siano rimasti vittime terzi interessati, per la salvaguardia di scopi generali e di ragioni di efficienza economica: l’esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile.
In presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un “sindacato di costituzionalità” della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile.