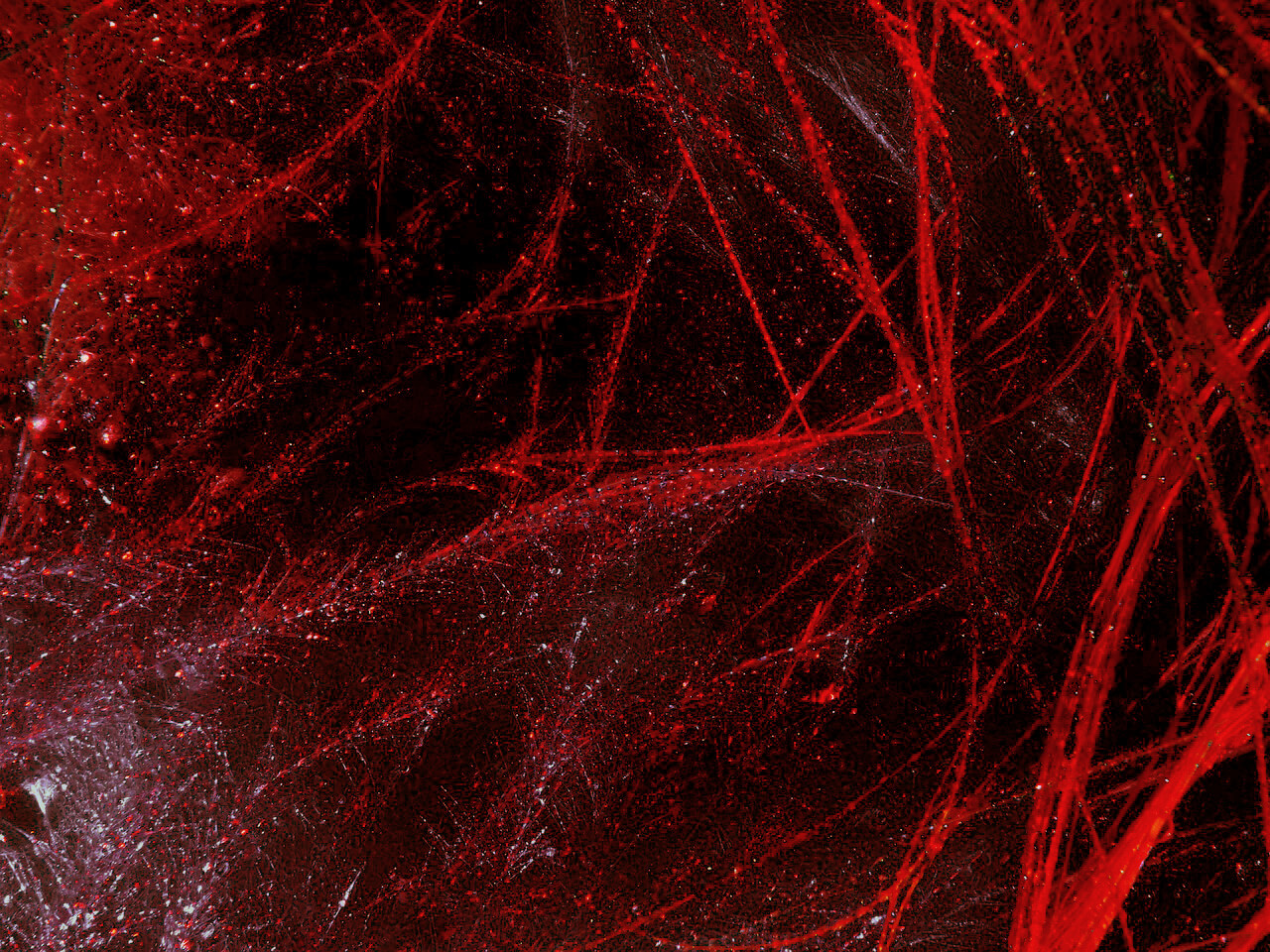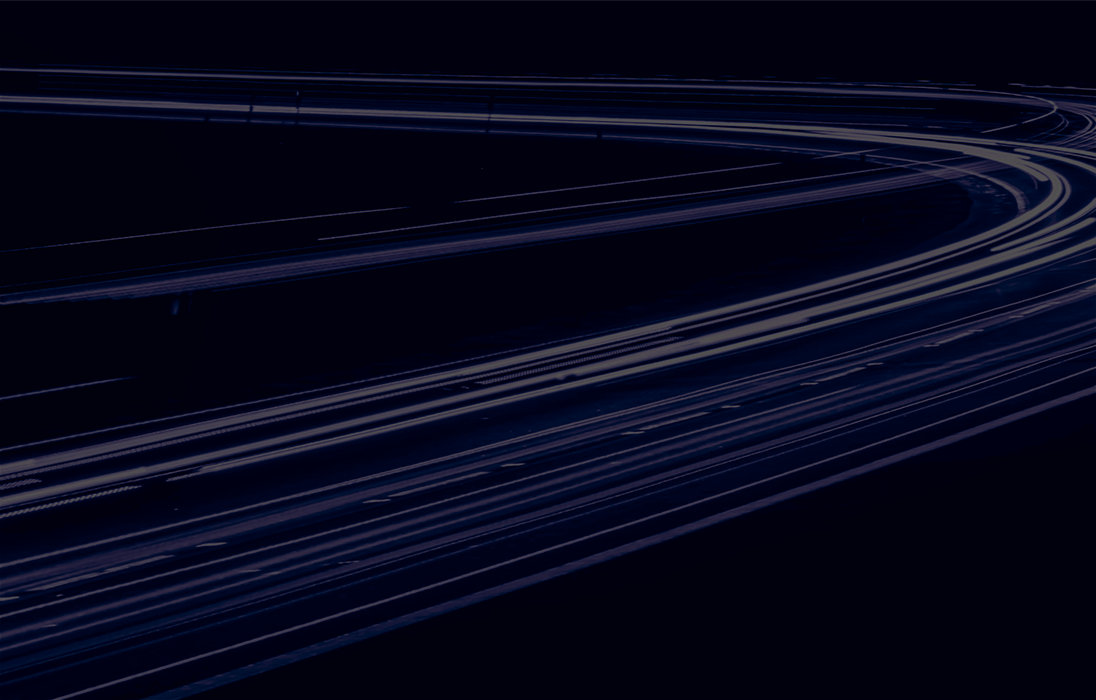Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, in tema di giudicato implicito interno su questioni processuali, si è espressa sulla sussistenza o meno del potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio la questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, ed in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa.
Si ricorda che il principio del giudicato implicito relativo a questioni processuali, prevede che il giudice, nel pronunciarsi su una determinata questione nel merito, risolva “implicitamente” anche le altre preliminari in rito.
Questo il principio di diritto affermato:
Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
Nella specie, la questione pregiudiziale di rito concerneva all’inammissibilità della domanda di responsabilità aggravata, proposta al di fuori del giudizio in cui era maturata la condotta illecita, sulla quale il giudice di primo grado non si era pronunciato, rigettando nel merito la pretesa risarcitoria della società attrice; inammissibilità che, però, è stata rilevata d’ufficio dal giudice di appello in assenza di gravame incidentale della parte vittoriosa nel merito.
Il contrasto giurisprudenziale in tema di giudicato interno implicito
La Cassazione, con pronuncia n. 9297/2007, aveva già affermato che la questione della proposizione dell’azione ai sensi dell’art. 96 C.p.c. al di fuori del processo cui la relativa responsabilità si riferisce, configurandosi come questione inerente alla stessa proponibilità dell’azione, si connota come questione di diritto rilevabile d’ufficio, per cui, ove non decisa in primo grado, non deve essere oggetto di deduzione a pena di decadenza ai sensi dell’art. 346 c.p.c., potendo essere rilevata anche da parte del giudice d’appello.
Tuttavia, proprio su tale potere del giudice di secondo grado sono maturate opinioni contrastanti tra le Sezioni semplici, integrando due opposti orientamenti:
- un primo indirizzo (Cass., S.U., n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7940/2019; Cass. n. 7941/2020; Cass. n. 10361/2022; Cass. n. 25934/2022; Cass. n. 10641/2023) ritiene che la reiezione nel
merito di una domanda riconvenzionale da parte del giudice di primo grado non comporti alcuna statuizione implicita sull’ammissibilità della domanda medesima, con la conseguenza che non è predicabile l’attitudine della decisione di merito a formare giudicato implicito sulla questione di rito pregiudiziale - un secondo orientamento (Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 20315/2021; Cass. n. 26850/2022; Cass. n. 3352/2024) afferma, invece, che il giudice di primo grado deve pronunciarsi d’ufficio su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; se, invece, detto giudice abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d’ufficio sulla questione, resterebbe precluso l’esercizio del potere di rilievo d’ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta: si sarebbe infatti formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame, come previsto dall’art. 161 c.p.c.
L’ambito di configurabilità del giudicato interno implicito e gli obblighi del giudice
Le Sezioni Unite, dopo aver percorso le argomentazioni giurisprudenziali e dottrinali in ordine ai contrapposti orientamenti formatisi sulla questione sottoposta al loro vaglio, delimitano preliminarmente l’ambito della configurabilità del giudicato implicito e gli strumenti di reazione di cui la parte disponga per evitarne la formazione.
Pertanto, estromette preliminarmente da tale esame le ipotesi di decisioni del merito che prescindono dall’esame di questioni di rito rilevabili in ogni stato e grado del giudizio: la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale, che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, è strettamente correlata alla circostanza che il vizio discenda da una violazione che determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorrono a definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad una nullità assoluta.
Si tratta di vizi qualificati, poiché riguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo, che possono derivare:
- dalla violazione di norme processuali preposte alla tutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile del processo, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, in una prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU e 47 CDFUE): si traducono in una definitiva menomazione del contraddittorio, in quanto producono un pregiudizio in re ipsa nei confronti della parte che le subisca; il contraddittorio si presume irrimediabilmente compromesso quando, in particolare, vengono violate norme che disciplinano la partecipazione al giudizio di soggetti in relazione ai quali si configura il litisconsorzio necessario
- dal difetto di potestas iudicandi in capo al giudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale: si tratta di violazioni che minano in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza; le violazioni riguardano:
- il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019)
- il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016)
- il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007)
- il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016)
- le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021)
- il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016)
- l’inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).
L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate.
Tali questioni sono dunque estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dall’esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo.
Escluse le ipotesi anzidette, le Sezioni Unite passano all’esame dei casi in cui una decisione sul merito sia stata adottata pretermettendo l’esame di una questione pregiudiziale di rito (non “fondante”) rilevabile d’ufficio dal giudice, limitatamente al grado in cui essa si sia manifestata: in relazione a tali questioni processuali è possibile che si formi il giudicato implicito, istituto al quale sono insite istanze di garanzia della certezza della tutela giurisdizionale in tempi ragionevoli.
Ove il merito sia stato deciso nel senso dell’accoglimento della domanda di parte, senza alcuna specificazione in ordine alla soluzione della questione di rito a monte, la statuizione di merito sottende necessariamente una decisione della questione di rito in senso non ostativo alla decisione di merito.
Non così nelle ipotesi in cui la decisione di merito abbia rigettato la domanda: la possibilità di ravvisare una decisione implicita sulla questione di rito è subordinata al valore che il giudice abbia inteso assegnare alla “non decisione”.
Infatti, proprio sul presupposto che non sia possibile attribuire valore cogente alla scansione rito-merito prevista dall’art. 276 c.p.c. e che il giudice possa validamente avvalersi del criterio
decisorio della ragione più liquida, è possibile che la decisione del merito sia avvenuta per saltum, ad esito di una scelta legittima di sovvertire l’ordine logico, neutralizzando il rapporto di presupposizione necessaria tra pregiudiziali di rito ed esame del merito.
Tuttavia, l’applicazione del criterio della ragione più liquida, in quanto efficace strumento di cui il giudice può avvalersi per ottimizzare le risorse a sua disposizione all’interno del singolo
processo, garantendo una speditezza del suo svolgimento, deve accompagnarsi a doverose cautele:
- per minimizzare i rischi connessi all’appesantimento in termini di oneri procedimentali, attività istruttorie e risorse processuali del giudizio d’impugnazione, il giudice che si avvalga del criterio della ragione più liquida deve, quindi, ponderare la decisione sulla questione di pronta soluzione, non solo nell’attualità del grado in cui si trova ad esercitare la potestas iudicandi, ma altresì in una dimensione prospettica, verificando la tenuta della decisione espressa con riferimento ai potenziali gradi successivi
- il giudice nella motivazione della decisione, deve dare conto dell’applicazione di tale criterio decisorio: l’opzione per l’impiego del criterio della ragione più liquida, esercitata in sede decisoria, deve essere esplicitata, rendendo la motivazione trasparente in ordine alla scelta di assorbimento.
In questa prospettiva, le Sezioni Unite concludono che condizione necessaria e sufficiente affinché possa ravvisarsi una decisione implicita delle questioni di rito, idonea al giudicato interno e implicito, è che possa ritenersi sussistente quel rapporto di presupposizione necessaria tra rito e merito: quel rapporto strutturale non deve essere stato neutralizzato per effetto di un’esplicita statuizione contenuta nella motivazione della sentenza che dia atto che il giudice abbia ritenuto di pretermettere l’esame delle questioni processuali a favore della più pronta soluzione di una questione di rito.
L’obbligo di impugnazione dell’omessa decisione in rito
Quanto allo strumento di reazione di cui può avvalersi la parte vittoriosa nel merito per far valere la patologia della sentenza per l’esistenza di un vizio processuale, oggetto di una questione decisa implicitamente, il nodo interpretativo da sciogliere riguarda l’individuazione del mezzo più appropriato per il quale questa possa optare:
- la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., volta ad estendere la cognizione del giudice dell’impugnazione ad una questione sottoposta in primo grado, ed in questa dimensione esaurisce i propri effetti
- l’impugnazione
Le Sezioni Unite danno continuità all’orientamento che individua l’impugnazione quale mezzo di reazione idoneo a far riemergere una questione processuale oggetto di decisione implicita: la censura passa attraverso la contestazione della violazione delle norme che disciplinano l’attività processuale implicata, mentre l’interesse a farla valere si apprezza con riferimento alla soccombenza su una statuizione implicita avente ad oggetto un’autonoma questione di tipo processuale.
Sicché, per il tramite dell’impugnazione incidentale la parte vittoriosa nel merito può scegliere:
- se far valere il vizio processuale, sul quale la sentenza si sia basata, e per l’effetto, far riemergere nel giudizio di gravame la questione che tale vizio aveva ad oggetto
- prestare acquiescenza alla “non decisione”, che si traduce, per la dipendenza strutturale che lega il merito al rito, in decisione (implicita) in senso non ostativo all’esame del merito: in tal caso il vizio sarà sanato e la questione non potrà riemergere, poiché oggetto di giudicato interno e implicito.