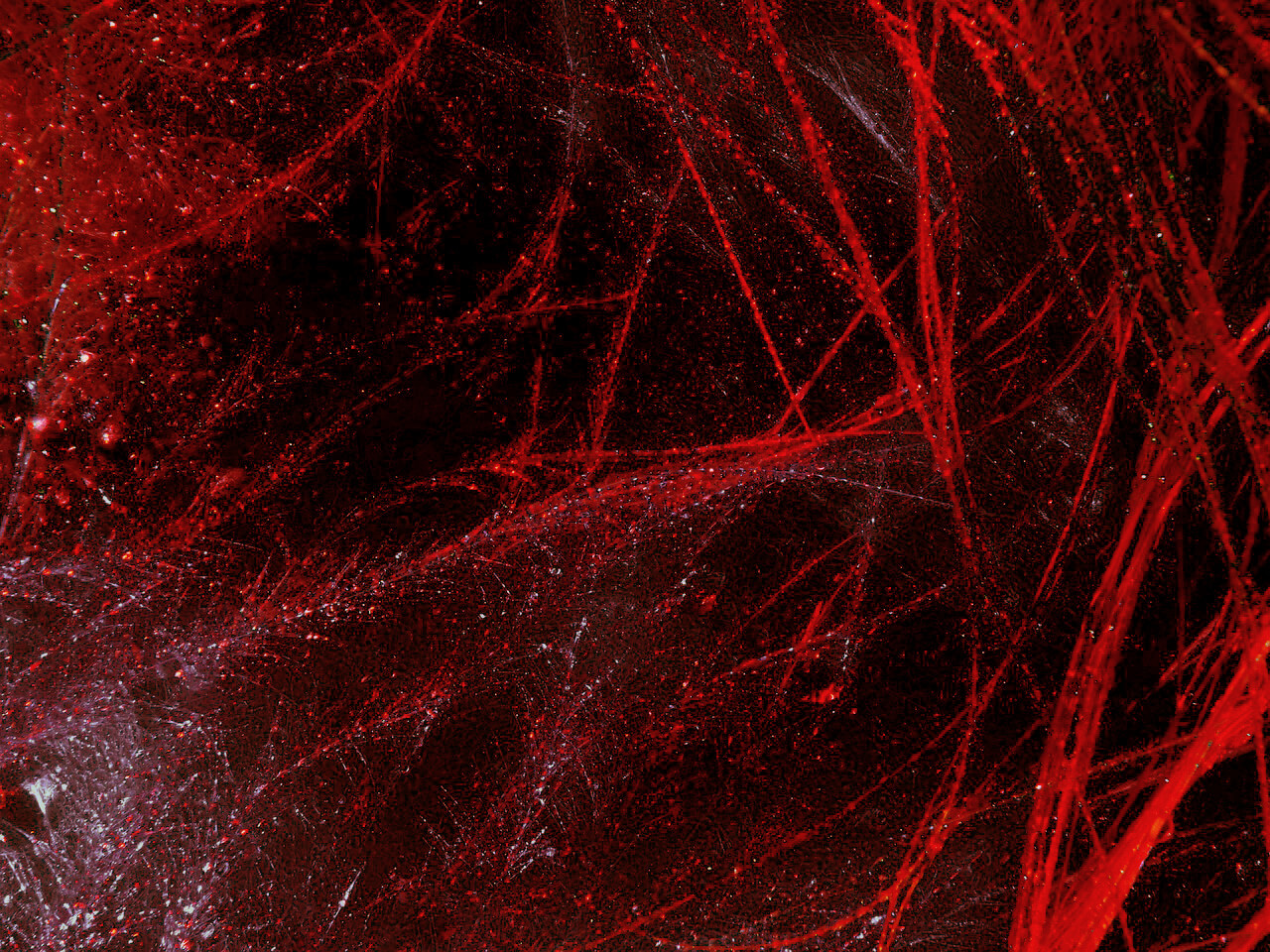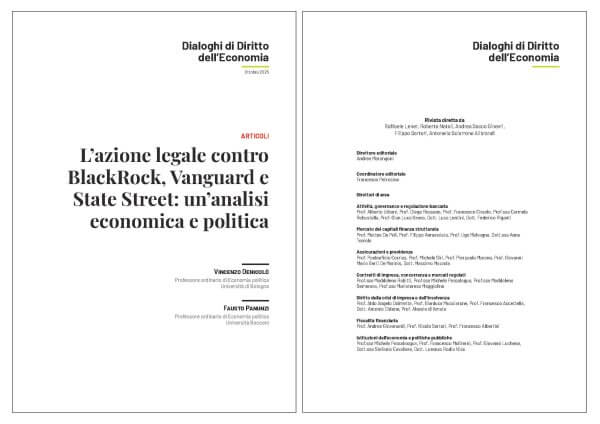SOMMARIO: L’azione legale promossa da undici Stati americani contro i tre maggiori gestori patrimoniali mondiali solleva interrogativi cruciali sull’applicazione del diritto antitrust in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale. Questo contributo analizza le implicazioni economiche e giuridiche della controversia, collocata all’incrocio di due fenomeni strutturali: l’ascesa dell’attivismo azionario orientato alla sostenibilità e la diffusione della common ownership tra imprese concorrenti. Entrambe le dinamiche possono arrecare danno ai consumatori, seppur per ragioni diverse. La controversia mette in luce anche le implicazioni politiche dell’esercizio di un potere “para-legislativo” da parte dei grandi gestori patrimoniali globali. L’esito del procedimento potrà incidere non solo sull’evoluzione della politica antitrust in materia di common ownership, ma anche sul futuro delle strategie ESG (Environmental, Social and Governance), ridefinendo il rapporto tra massimizzazione del profitto, responsabilità sociale d’impresa e tutela della concorrenza nell’economia del XXI secolo.
ABSTRACT: The legal action brought by eleven U.S. states against the world’s three largest asset managers raises critical questions about the application of antitrust law in a context of increasing focus on environmental and social sustainability. This contribution analyzes the economic and legal implications of the dispute, situated at the intersection of two structural phenomena: the rise of sustainability-oriented shareholder activism and the growing prevalence of common ownership among competing firms. Both dynamics may harm consumers, albeit for different reasons. The controversy also highlights the political implications of the “quasi-legislative” power exercised by large global asset managers. The outcome of the case could affect not only the development of antitrust policy regarding common ownership, but also the future of ESG (Environmental, Social, and Governance) strategies—potentially reshaping the relationship between profit maximization, corporate social responsibility, and competition policy in the 21st-century economy.
1. Introduzione
L’11 novembre 2024, un gruppo di undici Stati americani a guida repubblicana, capeggiati dal Texas, ha promosso un’azione legale nei confronti delle tre maggiori società di gestione patrimoniale al mondo – BlackRock, Vanguard e State Street – comunemente note come i Big Three. Il ricorso, presentato dinanzi alla Corte Distrettuale per il Distretto Orientale del Texas, si fonda sull’asserita violazione della Sezione 7 del Clayton Act,[1] in materia di concentrazioni potenzialmente lesive della concorrenza, nonché della Sezione 1 dello Sherman Act,[2] che vieta gli accordi restrittivi del commercio. In particolare, l’ipotesi accusatoria prospetta un coordinamento strategico tra i tre fondi, giustificato in apparenza da considerazioni ambientaliste, volto a orientare le politiche industriali delle imprese partecipate operanti nel comparto carbonifero verso una riduzione dell’output, con conseguente incremento dei prezzi.
Il caso, noto come States v. BlackRock, ha ricevuto una notevole attenzione mediatica e accademica sia per il profilo dei soggetti coinvolti che per gli importanti interrogativi che solleva. La controversia rappresenta un banco di prova per l’evoluzione del diritto antitrust in un contesto in cui alle imprese è richiesto di tener conto, nella definizione delle proprie strategie, sia degli interessi di azionisti comuni – quali i grandi fondi di investimento – che di istanze di carattere sociale e ambientale. Questo intreccio può generare tensioni tra obiettivi come la mitigazione del cambiamento climatico e il rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. La portata della controversia travalica i confini del settore carbonifero statunitense. I Big Three amministrano complessivamente oltre 22 trilioni di dollari, una cifra paragonabile al prodotto interno lordo degli Stati Uniti, e la loro influenza si estende, direttamente o indirettamente, alla quasi totalità dei settori dell’economia globale.[3]
Questo articolo si propone di offrire una lettura critica del caso, che si colloca all’intersezione di due tendenze di lungo periodo emerse negli ultimi decenni: da un lato, la crescente sensibilità degli azionisti alle problematiche ESG (Environmental, Social and Governance),[4] e dall’altro il fenomeno della common ownership, ovvero la presenza di azionisti comuni in imprese che operano negli stessi mercati. [5] Entrambe le dinamiche, sebbene attraverso meccanismi differenti, possono condurre a una riduzione dell’output: nel primo caso, per effetto dell’internalizzazione, da parte delle imprese, di esternalità negative quali i danni ambientali; nel secondo, in ragione dell’interesse degli azionisti comuni ad attenuare l’intensità della concorrenza tra le imprese partecipate.
L’esito del procedimento è destinato a incidere tanto sull’evoluzione della politica antitrust in materia di common ownership quanto sul futuro delle tematiche ESG a livello globale. Il caso fa emergere una serie di interrogativi di fondo. Come adattare la disciplina delle concentrazioni al fenomeno della common ownership che, pur non integrando una fusione orizzontale in senso tradizionale, può produrre effetti analoghi sul piano concorrenziale? Come distinguere tra finalità sociali legittimamente perseguibili e strategie collusive? Come rimodulare i principi della politica della concorrenza in un contesto in cui le imprese non perseguono più, in via esclusiva, l’obiettivo della massimizzazione del profitto? E come tener conto, nella definizione delle regole della concorrenza, dell’eterogeneità delle preferenze espresse dagli azionisti? L’analisi risulta ulteriormente complicata dalla valenza politica e simbolica del caso, legata, come vedremo, sia al settore economico interessato – il carbone – sia alla connotazione ideologica delle parti in causa.
In questo articolo non ci proponiamo di fornire risposte definitive a tali interrogativi (pur concedendoci talvolta di esprimere opinioni personali), bensì di illustrarne la genesi, le connessioni con i fatti del caso e le potenziali implicazioni.
2. States v. BlackRock: ricostruzione e contesto
L’azione legale si concentra su un gruppo specifico di imprese del settore carbonifero: Peabody Energy, Arch Resources, CONSOL Energy e altre società quotate che operano nella produzione e commercializzazione del carbone. BlackRock, Vanguard e State Street detengono partecipazioni in ciascuna di queste imprese, che congiuntamente raggiungono valori compresi tra il 25% e il 35%, e, secondo l’accusa, le avrebbero utilizzate per esercitare pressioni coordinate verso una riduzione della produzione.
Le pratiche contestate includono:
- il voto sistematico contro la rielezione di dirigenti non allineati con gli obiettivi ambientali dichiarati dalle società di investimento;
- la richiesta alle imprese partecipate di adesione a iniziative come Climate Action 100+ e Net Zero Asset Managers Initiative;
- la richiesta di presentare piani di disclosure ambientale e transizione climatica;
- la minaccia, implicita o esplicita, di disinvestimento in caso di mancata conformità ai criteri ESG;
- l’utilizzo di proxy advisor e consulenti ESG per coordinare le strategie di voto;
- la partecipazione a conferenze e forum in cui venivano discusse strategie comuni di engagement ambientale.
Secondo l’accusa, tali condotte avrebbero determinato una contrazione dell’offerta di carbone, con conseguente aumento dei prezzi e dei profitti per le imprese coinvolte – un risultato analogo a quello di un cartello. Gli Stati promotori della causa sostengono che i comportamenti posti in essere dalle società di gestione patrimoniale violino i principi fondamentali della concorrenza, richiedendo l’adozione di rimedi strutturali quali disinvestimenti forzati, nonché il risarcimento dei danni.
L’accusa ha presentato prove documentali di comunicazioni che sono intervenute tra i manager delle tre società, incluso scambi di e-mail e memorandum interni, che suggerirebbero un coordinamento esplicito delle strategie di condizionamento delle politiche delle imprese partecipate. Questi documenti costituiscono il cuore probatorio della controversia legale e rappresentano un elemento distintivo rispetto ad altri casi simili, dove il coordinamento era solo inferito dagli effetti di mercato.
La difesa delle società di gestione patrimoniale si articola su diversi piani. In primo luogo, esse sostengono che le loro azioni riflettono i doveri fiduciari verso i clienti, molti dei quali hanno esplicitamente richiesto strategie di investimento sostenibile. In secondo luogo, affermano che la considerazione dei rischi climatici è parte integrante di una prudente gestione del rischio finanziario. Infine, contestano l’applicabilità delle norme antitrust a decisioni di investimento che rientrano nell’esercizio legittimo dei diritti di proprietà.
Dunque, i convenuti non contestano che vi sia stata una contrazione dell’output. Il punto è se tale riduzione sia il frutto di una collusione illecita oppure di un legittimo adattamento delle strategie aziendali agli obiettivi di azionisti che perseguono finalità diverse dalla massimizzazione del profitto individuale dell’impresa.
3. La dimensione politica del caso
Uno degli aspetti più rilevanti della causa States v. BlackRock è la sua natura dichiaratamente politica. Tutti e undici gli Stati firmatari della denuncia – oltre al Texas figurano Alabama, Arkansas, Indiana, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, West Virginia e Wyoming – sono a guida repubblicana; molti hanno una lunga storia di opposizione alle politiche federali in materia ambientale. La loro economia dipende in misura significativa dal settore carbonifero. Questi Stati rappresentano il cuore dell’America rurale e industriale, territori dove l’estrazione e l’utilizzo di combustibili fossili non sono solo attività economiche, ma elementi costitutivi dell’identità locale.
In questo senso, il caso States v. BlackRock rappresenta qualcosa di più di un semplice caso antitrust: esso diventa la spia di un conflitto profondo che attraversa la società americana e, più in generale, il moderno sistema capitalistico. La linea di frattura ideologica riguarda la legittimità dell’attivismo ESG come forma di governance. Per i promotori dell’azione legale, le pratiche ESG costituirebbero una modalità di regolamentazione “privata” priva di legittimazione democratica: attori di straordinaria potenza economica – i grandi fondi di investimento – eserciterebbero una pressione sistematica sulle società partecipate, orientandone le strategie verso obiettivi non espressamente approvati né dagli elettori né dai consumatori. L’accusa, in altri termini, è quella di esercitare un potere para-legislativo in assenza di qualsiasi investitura politica.
Nessuno nutre l’illusione che un’economia di mercato possa essere del tutto immune dall’influenza del potere finanziario sulle dinamiche politiche e sociali. Tuttavia, nel caso di specie, la compenetrazione tra finanza e politica si presenterebbe in forme talmente manifeste da rendere necessaria una riflessione critica.
Per i conservatori americani, questa problematica si inserisce in un più ampio movimento di resistenza al “capitalismo woke,” termine utilizzato per descrivere l’adozione da parte delle grandi imprese di posizioni progressiste su temi sociali e ambientali. Una governance caratterizzata dai valori ESG rappresenta, da questo punto di vista, il dominio di un’élite finanziaria globalizzata che impone i propri valori a comunità locali che non li condividono e ne subiscono i costi economici.
I sostenitori delle strategie ESG ribattono che esse rispecchiano le preferenze degli investitori e mirano a proteggere il valore delle imprese nel lungo periodo, tenendo conto dei rischi climatici, reputazionali e normativi che potrebbero comprometterne la redditività futura.
Il conflitto tra i “red states” a guida repubblicana e i grandi gestori patrimoniali globali riflette quindi una contesa ideologica e politica più ampia: da un lato un capitalismo radicato nei territori, attento ai posti di lavoro e alle filiere locali; dall’altro un capitalismo finanziario senza cittadinanza, che ragiona in termini di rischio globale, reputazione e transizione climatica. È, con una formula forse abusata ma ancora efficace, la contrapposizione tra Main Street e Wall Street. In gioco non vi è soltanto un diverso modello di responsabilità d’impresa, ma due visioni alternative del sistema economico e della società. Uno scontro che, in senso proprio, è politico.
Non sorprende, dunque, che nella migliore tradizione del forum shopping l’azione sia stata incardinata presso il Distretto orientale del Texas, foro noto per l’orientamento conservatore e pro-business della sua magistratura.[6] Tale scelta, tuttavia, potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: la controversia, infatti, non investe soltanto le tematiche ESG, ma anche quelle connesse alla common ownership. Poiché la politica antitrust in questo ambito risulta ancora priva di contorni definiti, i giudici di orientamento conservatore, tradizionalmente inclini a un approccio più permissivo, potrebbero essere propensi a considerare la common ownership quale fenomeno fisiologico del mercato, che in quanto tale non dovrebbe essere oggetto di interventi restrittivi.
4. Il terreno di gioco
Un ulteriore aspetto preliminare meritevole di attenzione riguarda la scelta del settore del carbone: perché proprio questo combustibile fossile è divenuto il terreno privilegiato dello scontro?
Nell’immaginario collettivo, il carbone incarna il paradigma dell’energia “sporca”: è responsabile di un’elevata quota delle emissioni globali di CO₂, comporta rilevanti impatti ambientali tanto nella fase di estrazione quanto in quella di combustione[7] e presenta, non di rado, condizioni lavorative degradate lungo la sua filiera produttiva. Indipendentemente dal fatto che l’adozione di strategie ESG sia frutto di un impegno autentico o di un calcolo strumentale, è difficile individuare un contesto più favorevole alla loro giustificazione. In tale ambito, infatti, una contrazione della produzione può agevolmente essere presentata come un atto di responsabilità e una misura socialmente progressiva.
Va detto che il carbone costituisce già oggi una delle fonti energetiche più monitorate e regolamentate. Negli Stati Uniti, il suo peso relativo nel mix energetico nazionale è progressivamente diminuito, sostituito principalmente dal gas naturale e dalle fonti rinnovabili, [8] e la sua rilevanza economica si concentra ormai in specifiche aree geografiche, quali il bacino del Powder River o le regioni degli Appalachi. Ciononostante, l’azione pubblica in materia climatica continua a essere considerata, da una parte consistente dell’opinione pubblica, inefficace e insufficiente. Ciò ha reso il settore particolarmente esposto alle pressioni esterne, alimentando la percezione di un vuoto nella regolamentazione che gli investitori privati si sono sentiti legittimati a colmare. In tale contesto, le società di gestione patrimoniale, attraverso l’adozione di logiche ESG, finiscono per assumere, de facto, un ruolo di regolatori ambientali, supplendo alle presunte carenze dell’azione pubblica.
Il fatto che gli oppositori delle strategie ESG abbiano scelto di sfidarle proprio sul loro terreno d’elezione è indicativo della rilevanza dello scontro. Al tempo stesso, anche gli Stati promotori della causa possono individuare nel settore del carbone elementi a loro favorevoli. Anzitutto, a differenza di altri comparti in cui le considerazioni ambientali si intrecciano con complesse valutazioni tecnologiche e di innovazione, nel caso del carbone la strategia ESG si traduce essenzialmente in una riduzione della produzione, rendendola così più facilmente attaccabile come possibile copertura di condotte collusive. Vi è, inoltre, una dimensione redistributiva: le strategie ESG, tipicamente promosse da azionisti abbienti, possono determinare un incremento dei prezzi che, nel settore carbonifero, grava in misura regressiva sulle componenti più vulnerabili della popolazione. Scegliendo questo settore come campo di battaglia, gli oppositori delle strategie ESG possono dunque presentarsi come i paladini degli strati sociali più deboli.
5. ESG e common ownership
Come anticipato, il caso States v. BlackRock coinvolge due dinamiche strutturali che hanno progressivamente preso forma negli ultimi decenni: la crescente influenza degli azionisti “etici” e la diffusione della proprietà comune tra imprese concorrenti. Per meglio comprendere le implicazioni della controversia, è opportuno procedere a una più dettagliata descrizione di entrambi i fenomeni.
a. La pressione ESG: dalla massimizzazione del profitto all’utilità degli azionisti
Negli ultimi anni si è assistito a un profondo mutamento nei criteri di investimento da parte dei grandi fondi istituzionali. Sempre più frequentemente, essi non si limitano a valutare le imprese in base alla loro redditività finanziaria, ma prendono in considerazione anche l’impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) delle attività esercitate.
Tale approccio può riflettere, da un lato, un’evoluzione nei valori e nelle aspettative degli investitori; dall’altro, una crescente consapevolezza dei rischi sistemici connessi a fenomeni globali come il cambiamento climatico. In ogni caso, i dati sono indicativi della portata del fenomeno: secondo la Global Sustainable Investment Alliance, nel 2020 gli asset gestiti secondo criteri ESG hanno raggiunto i 35,3 trilioni di dollari.[9] Negli Stati Uniti, attualmente un dollaro su tre investito nei mercati finanziari segue principi di sostenibilità, con un incremento del 42% rispetto a soli due anni prima. Ne consegue che, per attrarre capitali e rimanere competitive, le imprese sono oggi chiamate a soddisfare in misura crescente anche criteri di performance sociale e ambientale.
Questa evoluzione mette in discussione il principio classico, ancora dominante nella teoria economica, secondo cui l’impresa dovrebbe perseguire esclusivamente la massimizzazione del profitto nell’interesse dei propri azionisti. Come affermava Milton Friedman in un celebre saggio del 1970, la responsabilità sociale dell’impresa consiste unicamente nell’aumentare i suoi profitti.[10] Saranno poi i singoli azionisti, attraverso l’impiego dei dividendi percepiti, a decidere se e come destinare risorse a fini sociali coerenti con le loro preferenze.
Oggi però questa visione non è più universalmente condivisa. Oliver Hart e Luigi Zingales, tra gli altri, hanno sostenuto che l’impresa non dovrebbe perseguire esclusivamente la massimizzazione del profitto, bensì quella dell’utilità degli azionisti, includendo tra le variabili rilevanti anche preferenze di natura sociale.[11] Un esempio paradigmatico è quello dell’inquinamento: se un’impresa genera danni ambientali che i suoi azionisti vorrebbero evitare, l’utilizzo ex post dei dividendi non è sempre in grado di compensare il danno già prodotto. In simili circostanze, solo un intervento ex ante sulle strategie aziendali può allineare le condotte dell’impresa ai valori degli investitori.
La proposta di Hart e Zingales trova riscontro in diversi studi empirici recenti. Ad esempio, Riedl e Smeets (2017)[12] dimostrano che molti investitori sono disposti a rinunciare a una parte dei rendimenti attesi pur di allocare il proprio capitale in fondi socialmente responsabili, indicando che le loro scelte riflettono preferenze con una componente non strettamente monetaria. Analogamente, Krueger, Sautner e Starks (2020)[13] rilevano che oltre due terzi degli investitori istituzionali prende in considerazione i criteri ESG per ragioni di natura etica o valoriale che travalicano finalità esclusivamente finanziarie.
Questa nuova impostazione crea però un problema. Quando gli azionisti sono interessati esclusivamente ai dividendi e al valore dell’impresa, le loro preferenze risultano sempre perfettamente allineate, poiché ciascuno beneficia dei profitti dell’impresa in misura proporzionale alla propria partecipazione azionaria. Quando invece esprimono anche valori etici o preferenze su dimensioni non monetarie, che possono divergere profondamente da un azionista all’altro, sorge il problema di come aggregare opinioni e interessi eterogenei.[14] Hart e Zingales propongono di affidarsi al voto assembleare come strumento di espressione collettiva della volontà degli azionisti. Resta tuttavia aperta la questione se tale meccanismo produca esiti efficienti – per non parlare della loro dubbia equità, considerando che il potere decisionale di ciascun azionista rimane proporzionale alla ricchezza investita. Si tornerà su questo punto più avanti nell’analisi.
b. Common ownership: la nuova frontiera della concentrazione
Parallelamente, un’altra tendenza ha progressivamente attirato l’attenzione degli economisti e delle autorità antitrust: il fenomeno della common ownership, ovvero la presenza di azionisti comuni in imprese concorrenti operanti nello stesso mercato. Si tratta di una dinamica particolarmente visibile nei settori altamente concentrati, dove è ormai frequente che pochi grandi fondi detengano partecipazioni significative in tutti i principali operatori.
La crescita della common ownership è stata alimentata dal boom degli investimenti passivi: i fondi indicizzati, per definizione, devono detenere partecipazioni in tutte le imprese di un indice, creando automaticamente situazioni di proprietà comune. Il fenomeno ha assunto ormai proporzioni sistemiche. Secondo stime recenti, i Big Three – BlackRock, Vanguard e State Street – risultano essere collettivamente i maggiori azionisti in 440 delle 500 società dell’indice S&P 500.[15] In diversi settori oligopolistici, questi fondi detengono partecipazioni superiori al 5% in ciascuna delle imprese leader del mercato. Un esempio emblematico è rappresentato dal settore del trasporto aereo statunitense, dove le stesse sette società di gestione patrimoniale sono i principali azionisti di ciascuna delle quattro maggiori compagnie aeree (sebbene non sempre nello stesso ordine di rilevanza).[16]
Un crescente corpo di studi teorici ed empirici ha evidenziato come la proprietà comune possa generare effetti anticoncorrenziali. Se un fondo detiene partecipazioni rilevanti in più imprese rivali, può avere interesse a scoraggiare strategie aggressive da parte di ciascuna di queste, così da massimizzare il rendimento complessivo del proprio portafoglio. Questo può comportare una contrazione dell’output, una riduzione degli investimenti, meno innovazione e, in ultima analisi, prezzi più elevati per i consumatori.[17]
I meccanismi attraverso cui gli azionisti comuni possono influenzare il comportamento delle imprese, pur non avendone il controllo diretto, sono molteplici e spesso sottili. In primo luogo, essi possono orientare il voto in assemblea a favore di amministratori o strategie aziendali che attenuano la pressione competitiva. In secondo luogo, possono contribuire a strutturare i sistemi di incentivazione manageriale premiando le performance relative, una pratica nota per disincentivare comportamenti aggressivi sul mercato. Infine, i manager stessi possono interiorizzare gli interessi degli azionisti comuni, anticipando le loro preferenze e adeguandovi le proprie decisioni strategiche, anche in assenza di pressioni esplicite.
c. Un effetto comune: la riduzione dell’output
Ciò che accomuna i due fenomeni — la pressione ESG e la common ownership — è la possibilità che entrambi conducano, sebbene per ragioni molto diverse, a un medesimo esito: una contrazione dell’output da parte delle imprese partecipate. Nel caso delle strategie ESG, la riduzione della produzione può rispondere a considerazioni ambientali, etiche o reputazionali; nel caso della common ownership, l’obiettivo è ridurre la pressione concorrenziale al fine di massimizzare il rendimento complessivo del portafoglio.
In linea teorica, la divergenza delle motivazioni potrebbe giustificare un trattamento giuridico differenziato: una convergenza decisionale ispirata da valori sociali condivisi può essere interpretata come una legittima espressione delle preferenze degli azionisti; al contrario, una convergenza orientata alla limitazione della concorrenza potrebbe configurare una violazione delle norme antitrust. Tuttavia, non è affatto chiaro se, e fino a che punto, la politica della concorrenza sia in grado di operare una simile distinzione. La difficoltà è accentuata dal potenziale intreccio tra i due fenomeni. Un fondo con partecipazioni comuni in imprese concorrenti potrebbe impiegare obiettivi ESG come giustificazione di facciata per politiche che, in realtà, perseguono effetti anticoncorrenziali. In questi casi, distinguere tra motivazioni autentiche e strumentali diventa problematico, rendendo difficile stabilire se si tratti di pratiche collusive oppure potenzialmente lecite.
6. ESG e comportamenti anticoncorrenziali
Per cercare di fare chiarezza in questo intreccio di questioni, conviene, per quanto possibile, isolare le dinamiche legate alle problematiche ESG da quelle connesse alla common ownership. Cominciamo dalle prime. Per concentrarci sulle problematiche ESG, ipotizziamo che gli accordi per ridurre la produzione di carbone non siano stati promossi da fondi di investimento che influenzano indirettamente il comportamento delle imprese partecipate, bensì dalle imprese stesse, controllate da azionisti sensibili ai temi ambientali. In questo scenario, il problema diventa: una riduzione dell’output deve essere valutata in modo diverso a seconda che sia motivata da un intento collusivo oppure dall’adesione a principi di tutela ambientale condivisi dagli azionisti?
La norma antitrust di riferimento negli Stati Uniti è la Sezione 1 dello Sherman Act, che vieta ogni accordo tra imprese “in restraint of trade or commerce.” La giurisprudenza ha però chiarito che la legge proibisce solo le restrizioni considerate unreasonable. Tuttavia, alcune intese, come gli accordi per la fissazione dei prezzi o la spartizione dei mercati, sono ritenute irragionevoli per loro natura (per se), e quindi vietate indipendentemente dagli effetti concreti che producono.[18] Il nodo interpretativo diventa allora se questo giudizio automatico di illiceità può mutare nel caso in cui la riduzione dell’output non sia volta ad aumentare i profitti, ma sia motivata dalle finalità ambientali perseguite dagli azionisti.
Facendo un ulteriore sforzo di astrazione, cominciamo considerando il caso in cui le imprese abbiano deciso di ridurre la propria produzione per ragioni di responsabilità ambientale in modo unilaterale, senza alcuna forma di coordinamento. Si può vietare tale comportamento? Una tale ipotesi appare quantomeno dubbia, dal momento che uno dei principi fondanti dell’economia di mercato è l’insindacabilità delle motivazioni individuali.[19] Ma se si concedesse questo punto, allora si dovrebbe anche ammettere che, quando più imprese condividono simili sensibilità ambientali, una certa forma di coordinamento diventa non solo comprensibile, ma forse necessaria. Infatti, in assenza di un’azione concertata la riduzione dell’output da parte di una singola impresa rischia di essere vanificata dall’aumento della produzione dei concorrenti, un effetto noto in economia ambientale come carbon leakage.[20] L’impatto ambientale complessivo di una riduzione unilaterale della produzione sarebbe pertanto modesto, mentre l’impresa che ha agito responsabilmente ne sopporterebbe i costi in solitudine. Di qui la necessità di un coordinamento. Ma se un’intesa tra le imprese serve a perseguire in modo più efficace obiettivi ritenuti legittimi, come la tutela ambientale, ha senso proibirla in nome del diritto antitrust?
Considerazioni simili stanno probabilmente alla base di alcune recenti politiche europee. In Europa, a differenza degli Stati Uniti, non è possibile invocare il criterio della “ragionevolezza” per giustificare un accordo tra imprese: l’articolo 101 del Trattato di Roma vieta infatti qualsiasi intesa tra imprese che abbia “per oggetto o per effetto” una restrizione della concorrenza, indipendentemente dalle finalità perseguite. Tuttavia, lo stesso articolo 101, al paragrafo 3, consente deroghe qualora l’accordo contribuisca, tra le altre cose, a promuovere il progresso economico. La Commissione Europea ha recentemente chiarito che anche obiettivi di sostenibilità ambientale possono rientrare tra le giustificazioni ammissibili per l’esenzione, purché siano soddisfatte certe condizioni. Ciò è stato formalizzato nelle Linee guida orizzontali sulla cooperazione tra imprese del 2023, che includono un capitolo dedicato agli accordi di sostenibilità. In esse, la Commissione riconosce esplicitamente che certe forme di cooperazione tra imprese possono produrre benefici ambientali tali da compensare eventuali effetti restrittivi sulla concorrenza.[21]
Chi scrive ritiene tuttavia che queste argomentazioni non siano del tutto convincenti. Anzitutto, fondare la legittimità di determinati comportamenti collusivi sulle finalità dichiarate comporta il rischio di favorire strategie di window dressing. Le imprese potrebbero strumentalizzare i temi ESG per mascherare accordi che hanno in realtà l’unico scopo di limitare la concorrenza e massimizzare i profitti, rendendo estremamente difficile per le autorità antitrust distinguere tra condotte autenticamente ispirate a obiettivi sostenibili e forme sofisticate di collusione.
In secondo luogo, l’idea che la tutela della concorrenza debba essere subordinata a considerazioni ambientali e sociali è di per sé problematica. Se, in presenza di esternalità negative, si ritiene che l’output in un determinato settore sia eccessivo, il rimedio più appropriato non dovrebbe consistere in intese restrittive tra le imprese, bensì in interventi pubblici di natura regolatoria, come una carbon tax o un sistema di cap-and-trade. Misure di questo tipo, pur determinando anch’esse un aumento dei prezzi, non generano extraprofitti privati ma si traducono in maggiori entrate pubbliche, che possono essere destinate alla riduzione del carico fiscale o al finanziamento della spesa sociale. Al contrario, un accordo tra imprese volto a limitare la produzione consente agli azionisti di appropriarsi delle rendite derivanti dalla restrizione dell’output, senza alcun beneficio per la collettività. Ma perché si dovrebbe consentire la privatizzazione di un beneficio che potrebbe essere redistribuito in modo più equo ed efficiente?
Ci sembra quindi che anche volendo aderire al principio di insindacabilità delle motivazioni individuali, questo debba valere esclusivamente per le decisioni unilaterali delle imprese. Se un’impresa sceglie autonomamente di ridurre il proprio output per ragioni ambientali, accetta il rischio che tale scelta comporti una riduzione dei profitti, a causa dell’effetto di leakage sopra ricordato – ossia l’espansione della produzione da parte dei concorrenti, che mantiene bassi i prezzi di mercato. Proprio questa esposizione al rischio economico dimostra la sincerità delle motivazioni etiche: se gli azionisti sono realmente mossi da principi ambientali, devono essere disposti ad accettare perdite monetarie pur di restare coerenti con i propri valori.
7. Common ownership e comportamenti anticoncorrenziali
Passiamo all’altro versante del problema: quello della common ownership. Anche nel caso delle implicazioni antitrust della common ownership, può risultare utile astrarre dalle specificità del caso States v. BlackRock, al fine di mettere meglio a fuoco i termini generali della questione. Per esempio, la letteratura ha discusso in modo approfondito se, e in che modo, i manager delle imprese possano essere indotti a tenere conto degli interessi di azionisti di grandi dimensioni, anche quando questi non detengono una partecipazione di controllo. Per evitare di addentrarci in questo nodo complesso, ipotizziamo che i cosiddetti Big Three detengano collettivamente la maggioranza del capitale delle imprese partecipate.
Supponiamo, inoltre, che non vi sia stata alcuna concertazione tra le tre società di gestione patrimoniale, ma che ciascuna abbia agito in modo indipendente dalle altre. Anzi, per semplificare ulteriormente l’analisi, possiamo immaginare un caso ancora più lineare: una singola società di gestione patrimoniale che detiene la maggioranza delle azioni in più imprese concorrenti operanti nello stesso mercato.
Qual sarebbe l’obiettivo di questo ipotetico azionista comune? Evidentemente, il suo interesse non è quello di massimizzare il profitto di una singola impresa, bensì quello di massimizzare l’utile complessivo del portafoglio, ossia la somma dei profitti delle imprese partecipate (o, per essere più precisi, una media ponderata di tali profitti, con pesi proporzionali alle rispettive quote detenute.)
Se si accetta l’impostazione di Hart e Zingales, secondo cui l’impresa dovrebbe perseguire l’utilità dei propri azionisti, ciascuna impresa finirebbe dunque per comportarsi naturalmente come parte di un cartello. Il risultato sarebbe una riduzione dell’output e un aumento dei prezzi rispetto al caso in cui ogni impresa operasse in modo indipendente perseguendo esclusivamente il proprio profitto. La concorrenza verrebbe eliminata non attraverso accordi collusivi, ma come effetto diretto dell’allineamento delle strategie aziendali agli interessi dell’azionista comune.
Si noti che questo problema si presenterebbe anche nel caso in cui l’azionista comune non attribuisse alcun valore intrinseco a obiettivi extra-finanziari. Anche adottando una prospettiva strettamente friedmaniana, in cui il solo obiettivo legittimo è la massimizzazione del profitto, ciò che rileva per l’azionista comune non è il profitto individuale di ciascuna impresa, bensì il profitto aggregato di tutte le imprese partecipate. Ma un mercato in cui ciascuna impresa massimizza il profitto complessivo di tutte le imprese, è un mercato in cui non esiste più la concorrenza. La common ownership pone, dunque, una sfida strutturale alla politica della concorrenza.
Secondo una visione ottimistica, il caso estremo che abbiamo considerato è destinato a rimanere puramente ipotetico. Esisterebbero infatti limiti endogeni alla diffusione della common ownership, tali da impedire che un singolo azionista comune possa raggiungere soglie di partecipazione sufficienti a esercitare un controllo effettivo, o anche solo un’influenza significativa, sulle imprese partecipate.[22]
In questa prospettiva, la politica antitrust dovrebbe preoccuparsi unicamente di prevenire forme di coordinamento tra fondi di investimento che collettivamente potrebbero riuscire a influenzare le strategie delle imprese in portafoglio, anche se individualmente non avrebbero la forza per farlo. Qualora questa impostazione venisse accolta in sede giudiziaria, i Big Three potrebbero essere sanzionati per violazione della Sezione 1 della Sherman Act, ma senza che ciò implichi l’adozione di rimedi strutturali particolarmente invasivi, come ad esempio l’imposizione di disinvestimenti forzati.
Purtroppo, la teoria economica non consente di avallare con certezza la visione ottimistica. Il fatto è che manca ancora una teoria compiuta della struttura proprietaria di equilibrio in contesti di common ownership. In assenza di un quadro teorico consolidato, la prospettiva pessimista – secondo cui la common ownership può raggiungere livelli tali da influenzare in modo significativo il comportamento delle imprese partecipate – appare, sotto il profilo teorico, altrettanto plausibile di quella ottimista. Anzi, è proprio questa visione più critica a trovare, ad oggi, maggior riscontro nell’evidenza empirica disponibile.
Per chi abbraccia questa prospettiva, la common ownership rappresenta allora una delle sfide più rilevanti e insidiose per la politica della concorrenza. Le opzioni attualmente sul tavolo sembrano ridursi a due alternative, entrambe problematiche: da un lato, sottoporre a scrutinio sistematico gli obiettivi perseguiti dai proprietari delle imprese, assumendo implicitamente che l’unico fine legittimo sia la massimizzazione del profitto individuale di ciascuna impresa; dall’altro, intervenire direttamente sulla struttura proprietaria, imponendo limiti alla common ownership, almeno oltre determinate soglie.
In entrambi i casi, si tratterebbe di misure marcatamente interventiste, che alterano in modo significativo i presupposti di un’economia di mercato fondata sulla libertà contrattuale e sull’autonomia degli attori economici. Nel caso specifico di States v. BlackRock, non è scontato che giudici di orientamento conservatore possano spingersi a proporre rimedi di tale portata. Tuttavia, in contesti giurisdizionali diversi – o in sedi normative europee – l’adozione di politiche più incisive potrebbe incontrare minori resistenze.
8. Eterogeneità degli obiettivi e coordinamento degli azionisti
Alla luce della giurisprudenza corrente, l’esito del caso States v. BlackRock che forse appare più probabile è che i Big Three vengano ritenuti responsabili di una violazione della Sezione 1 dello Sherman Act, per aver coordinato le proprie condotte, ma non della Sezione 7 del Clayton Act, evitando così l’imposizione di rimedi strutturali come disinvestimenti obbligati. Tuttavia, anche una soluzione apparentemente moderata come quella ipotizzata rischia di trascurare un elemento importante che distingue il caso States v. BlackRock dalle tradizionali intese anti-competitive. Qui, infatti, non si discute di accordi tra imprese concorrenti sul mercato del prodotto, bensì di intese tra i loro azionisti.
Questa distinzione non è meramente formale. Come abbiamo già osservato, quando gli azionisti perseguono obiettivi ESG, diversi dalla semplice massimizzazione del profitto, le loro preferenze possono divergere. Un’analoga eterogeneità può emergere, in presenza di common ownership, anche nel caso di azionisti puramente friedmaniani, cui interessa solo il profitto. Per esempio, un azionista che possiede una quota doppia nell’impresa A rispetto all’impresa B tenderà a preferire che sia quest’ultima ad assumere una condotta meno aggressiva, preservando così i profitti dell’impresa A. Al contrario, un azionista con partecipazioni speculari avrebbe incentivi opposti. Ne deriva una potenziale disomogeneità di interessi tra azionisti comuni, anche in assenza di finalità extra-finanziarie.
Come avviene la composizione di questi interessi non perfettamente allineati? In linea di principio, essa dovrebbe realizzarsi attraverso il meccanismo del voto assembleare. Ma, come avviene comunemente nelle assemblee legislative o di altra natura, è del tutto naturale che, prima del voto, si verifichino momenti di confronto e di coordinamento strategico tra i votanti. Se, ad esempio, si tratta di nominare un nuovo CEO tra diversi candidati, è plausibile che gli azionisti con interessi simili si consultino per convergere su un nome condiviso, accettabile da tutti. Analogamente, è perfettamente normale che si sviluppino forme di logrolling, in cui due o più azionisti si scambiano sostegno su tematiche di reciproco interesse, allo scopo di massimizzare la propria influenza decisionale.
Quando tali pratiche sono adottate da azionisti comuni, dovremmo assimilarle ad accordi collusivi tra imprese concorrenti? Oppure si tratta, piuttosto, di dinamiche fisiologiche in contesti assembleari in cui le decisioni sono assunte a maggioranza? È noto, almeno sin dal paradosso di Condorcet, che i meccanismi decisionali basati sulla maggioranza possono generare esiti instabili e prestarsi a manipolazioni strategiche quando le alternative in gioco sono più di due. In questo contesto, il coordinamento tra votanti non è necessariamente distorsivo: al contrario, può contribuire a una maggiore coerenza e razionalità delle decisioni collettive.
Sul piatto opposto della bilancia va posto il fatto che il coordinamento delle decisioni di voto da parte degli investitori istituzionali può aggravare una distorsione già insita nel funzionamento delle assemblee societarie, cioè l’asimmetria nel potere reale di voto tra piccoli azionisti e grandi fondi. I dati sulla partecipazione lo confermano: nelle società dello S&P 500, la partecipazione media degli azionisti individuali alle assemblee si attesta sotto il 30%, mentre supera il 90% per i fondi istituzionali. In pratica, le decisioni fondamentali in materia di governance e strategie aziendali vengono spesso prese da una minoranza organizzata che controlla la maggioranza del capitale votante.
A ciò si aggiunge che le società di gestione patrimoniale agiscono come fiduciari per milioni di investitori retail, i quali solo raramente esprimono preferenze esplicite. Questo conferisce ai gestori dei fondi un’ampia discrezionalità, che può essere ulteriormente amplificata da comportamenti coordinati. Il rischio è che il coordinamento tra fondi di investimento accentui le già esistenti distorsioni “antidemocratiche” del sistema elettorale societario, minando ulteriormente il principio di rappresentanza proporzionale degli interessi azionari.
Alla luce di tali considerazioni, l’interrogativo circa l’opportunità che la politica antitrust estenda il proprio divieto anche al coordinamento tra azionisti si presenta come questione di non agevole soluzione. Qualora la distinzione tra intese tra imprese concorrenti sul mercato del prodotto e accordi tra i rispettivi azionisti fosse sottoposta al vaglio dei giudici, la pronuncia potrebbe assumere un valore fortemente innovativo e aprire un precedente di rilievo sistematico.
9. E se azionisti e consumatori non coincidono?
Le difficoltà per la politica della concorrenza non derivano solo dall’eterogeneità interna agli azionisti, ma anche dal fatto che questi ultimi non coincidono necessariamente con la platea dei consumatori. Il modello dominante del diritto antitrust statunitense si fonda sul principio del consumer welfare, volto a tutelare il benessere del consumatore attraverso i benefici della concorrenza: prezzi più bassi, maggiore qualità, più varietà e innovazione. A partire dagli anni ’80, con l’influenza della scuola di Chicago, questo approccio ha concentrato l’analisi sugli effetti finali per i consumatori, lasciando sullo sfondo il ruolo e gli interessi degli azionisti.
Negli ultimi decenni, tuttavia, questa separazione è diventata sempre meno netta. In molte economie avanzate, un numero crescente di individui è allo stesso tempo consumatore di beni e servizi e investitore, diretto o indiretto, attraverso fondi pensione, ETF e fondi comuni. Ciò significa che le stesse persone che subiscono un aumento dei prezzi dell’energia, dovuto a una contrazione dell’offerta, possono beneficiare di rendimenti finanziari derivanti dalla partecipazione in fondi ESG che hanno promosso quella stessa contrazione.
Questo duplice ruolo complica la misurazione del benessere collettivo. Se un consumatore paga di più per l’energia ma ottiene maggiori rendimenti dal proprio fondo di investimento, il saldo netto è positivo o negativo? E cosa accade a chi non è investitore e subisce soltanto il rincaro? Il problema si aggrava se consideriamo la dimensione intergenerazionale. Molte strategie ESG giustificano costi immediati con benefici futuri, come la riduzione delle emissioni per mitigare il cambiamento climatico. Come vanno valutati questi effetti intertemporali?
Il diritto antitrust tradizionale non sembra disporre degli strumenti necessari per affrontare compiutamente le questioni redistributive tra diversi gruppi sociali o su un piano intertemporale. Già risulta complesso stimare l’impatto delle strategie delle imprese sui prezzi e, di conseguenza, sul benessere immediato dei consumatori; valutare gli effetti distributivi tra classi sociali, le esternalità ambientali e sociali o le ricadute di lungo periodo appare quasi impossibile. Spingersi in questa direzione significherebbe trasformare la politica antitrust da strumento tecnico a leva politica, soggetta a un impiego potenzialmente arbitrario: una prospettiva che incontra forti resistenze tra giuristi ed economisti, preoccupati di veder compromessa la certezza e la prevedibilità delle regole.
10. Conclusioni
Negli ultimi decenni, due dinamiche di fondo hanno profondamente segnato l’evoluzione della corporate governance: da un lato, l’ascesa dell’attivismo azionario ispirato a criteri ESG, che ridefinisce la missione dell’impresa e solleva interrogativi sulla legittimità di forme di coordinamento tra aziende orientate a obiettivi extra-economici; dall’altro, la crescente diffusione della common ownership, capace di incidere in maniera sistemica sugli incentivi concorrenziali e di produrre effetti assimilabili a quelli di un cartello, anche in assenza di intese esplicite.
Il caso States v. BlackRock nasce dall’intersezione di queste due tendenze, rivelando come l’intreccio tra strategie ESG e common ownership costituisca una sfida inedita per il diritto antitrust. A un livello superficiale, la vicenda mostra la difficoltà di distinguere tra motivazioni autenticamente etiche e strategie opportunistiche celate dietro l’impegno sostenibile. A un livello più profondo, essa solleva questioni fondamentali sul ruolo dell’impresa in un contesto in cui finalità ambientali e sociali convivono con la massimizzazione del profitto. Tale complessità è accresciuta dall’eterogeneità delle preferenze degli azionisti e dalla concentrazione del potere di voto nelle mani di pochi grandi gestori, circostanza che può favorire forme di coordinamento assembleare in grado di alterare la rappresentanza degli interessi e accentuare le distorsioni democratiche della governance societaria.
In questa prospettiva, States v. BlackRock si configura come un banco di prova cruciale per ripensare la politica della concorrenza in un’economia in cui le imprese operano non solo come attori economici, ma anche come soggetti sociali e politici. Il caso appare rilevante anche per diversi problemi di corporate governance, come la rappresentanza degli azionisti retail, il funzionamento del proxy voting e le possibili riforme volte a riequilibrare i rapporti di potere e a limitare l’influenza dei grandi fondi. Al tempo stesso, esso induce ad interrogarsi sul ruolo degli strumenti di politica pubblica – quali la carbon tax o i sistemi di cap-and-trade – come alternative più trasparenti ed eque rispetto a forme di autoregolazione privata, che tendono a privatizzare i benefici della riduzione dell’output. Infine, la controversia invita a considerare le implicazioni costituzionali e democratiche dell’esercizio di potere “para-legislativo” da parte dei grandi gestori patrimoniali globali, soprattutto quando tale potere viene esercitato in assenza di un chiaro mandato da parte degli investitori finali.
In sintesi, il caso States v. BlackRock rappresenta non solo un passaggio giurisprudenziale di rilievo ma anche un osservatorio privilegiato sulle tensioni e trasformazioni del capitalismo contemporaneo. Oltre che sulla disciplina antitrust, l’esito del procedimento potrà influire anche sulla ridefinizione dei ruoli di manager e azionisti in una economia in cui la performance economica e la responsabilità sociale sono destinate a convivere in un equilibrio ancora tutto da costruire.
[1] Clayton Antitrust Act, 15 U.S.C. §§ 12–27 (1914). La Sezione 7 disciplina le acquisizioni e fusioni suscettibili di ridurre sostanzialmente la concorrenza.
[2] Sherman Antitrust Act, 15 U.S.C. §§ 1–7 (1890). La Sezione 1 vieta ogni contratto, combinazione o cospirazione in restrizione del commercio.
[3] Sull’estensione settoriale della partecipazione azionaria dei Big Three, vedi ad esempio E. Posner, F. Scott Morton, E. Weyl, A Proposal to Limit the Anti-Competitive Power of Institutional Investors, 81 Antitrust L.J., 2017, p. 669 ss.
[4] Per una discussione non tecnica del concetto di ESG e del suo impatto sulle strategie d’impresa, vedi G. Serafeim, ESG: The Practitioner’s Guide to the Future of Investing, New York, 2020.
[5] Per uno sguardo d’insieme al fenomeno della common ownership e delle sue implicazioni antitrust, vedi OECD, Common Ownership by Institutional Investors and Its Impact on Competition, Paris, 2022.
[6] Sul ricorso strategico al Distretto orientale del Texas in cause complesse e dal contenuto innovativo, vedi M. Chen, “The Eastern District of Texas: Past, Present, and Future of a Contentious Forum,” Texas Law Review, vol. 95, 2017, p. 1565 ss.
[7] Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, il carbone è responsabile di circa il 30% delle emissioni globali di CO₂, pur rappresentando solo il 27% del mix energetico mondiale. La sua combustione rilascia inoltre inquinanti locali come ossidi di zolfo e azoto, particolato fine e metalli pesanti, con impatti significativi sulla salute pubblica. Studi epidemiologici stimano che l’inquinamento da carbone causi ogni anno centinaia di migliaia di morti premature a livello globale.
[8] In particolare, le utility elettriche, che sono tra i principali acquirenti, stanno progressivamente chiudendo le centrali a carbone per ragioni economiche oltre che ambientali.
[9] Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), Global Sustainable Investment Review 2020, p. 8, disponibile su https://www.gsi-alliance.org.
[10] M. Friedman, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” The New York Times Magazine, 13 Settembre 1970.
[11] O. Hart, L. Zingales, “Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value,” Journal of Law, Finance, and Accounting, vol. 2, n. 2, 2017, pp. 247–274.
[12] A. Riedl, P. Smeets, “Why Do Investors Hold Socially Responsible Mutual Funds?”, Journal of Finance, vol. 76, n.6, 2017, pp. 2505-2549.
[13] P. Kruger, Z. Sautner e Laura Starks, “The Importance of Climate Risks for Institutional Investors”, The Review of Financial Studies, vol. 33, n. 3, 2020, pp. 1067-1111.
[14] In presenza di potere di mercato, un problema simile sorge anche se gli azionisti non sono portatori di valori etici ma semplicemente hanno preferenze di consumo eterogenee.
[15] L. Bebchuk, S. Hirst, “The specter of the giant three”, Boston University Law Review, 2019, vol. 99, n.3, pp.712-741.
[16] J. Azar, M. Schmalz e I. Tecu, “Anticompetitive effects of common ownership”, The Journal of Finance, 2018, vol. 73, n. 4, pp. 1513–1565.
[17] Si veda ad esempio D. P. O’Brien, S.C. Salop, “Competitive effects of partial ownership: Financial interest and corporate control”, Antitrust Law Journal, 2000, vol. 67, n. 3, pp. 559–614 e E. Elhauge, “Horizontal shareholding”, Harvard Law Review, 2016, vol. 129, n. 5, 1267–1317.
[18] Questa impostazione trova le sue radici nella giurisprudenza della Corte Suprema. Nel caso National Society of Professional Engineers v. United States (1978), la Corte stabilì che “la regola di ragionevolezza dello Sherman Act non supporta una difesa basata sull’assunto che la concorrenza stessa sia irragionevole.”
[19] Tale principio è alla base di alcuni capisaldi del pensiero economico classico, come la sovranità del consumatore e la celebre argomentazione di Adam Smith ne La ricchezza delle nazioni, secondo cui: “Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio o del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dalla cura che essi hanno per il proprio interesse. Non ci rivolgiamo alla loro umanità ma al loro interesse personale.” Smith, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: W. Strahan and T. Cadell. (Trad. it. La ricchezza delle nazioni, a cura di R. Faucci, UTET, 2014).
[20] Questo effetto è stato studiato in particolare tra diversi paesi impegnati in programmi di mitigazione ambientale, ma la stessa logica si applica alle imprese. Si veda, ad esempio, C. Fischer, A.K. Fox, Comparing Policies to Combat Emissions Leakage: Border Tax Adjustments versus Output-Based Rebate, Resources for the Future, 2009, Discussion Paper 09-02.
[21] Commissione Europea, Comunicazione: Linee guida sulla cooperazione orizzontale tra imprese (2023/C 259/01), in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 259 del 21.7.2023. Per una discussione critica si veda ad esempio Monti, G. “Sustainability and EU Competition Law,” Journal of European Competition Law & Practice, 2022, vol. 13, n. 1, pp. 1–11.
[22] Abbiamo affrontato il problema dei limiti endogeni alla common ownership in un nostro precedente lavoro: V. Denicolò, F. Panunzi, “Common Ownership, Competition and Corporate Governance”, Management Science, 2024, vol. 71, n. 5, pp. 3924-3943. Si veda anche A. Piccolo e J. Schneemeier (2020), Ownership and competition, Working Paper, Indiana University.