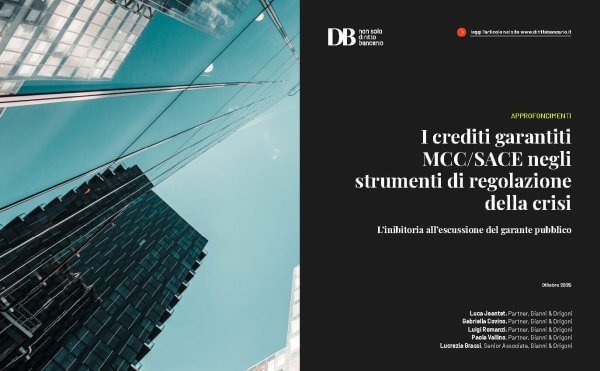Il presente contributo analizza il fenomeno dei finanziamenti erogati dalle banche con garanzia pubblica MCC/SACE con particolare riferimento alle procedure di gestione della crisi di impresa, soffermandosi sulle più recenti misure cautelari o protettive concesse in tale ambito.
1. I crediti garantiti MCC/SACE: caratteri generali
Il sistema produttivo italiano presenta una marcata interdipendenza tra le imprese e gli istituti bancari, in virtù della quale le imprese tendono a privilegiare il credito bancario quale principale fonte di finanziamento. Questo sistema si è però dimostrato negli anni vulnerabile e incapace di fornire una risposta adeguata e tempestiva alla crisi delle imprese. Per far fronte alle diverse sfide e difficoltà che hanno messo negli anni alla prova il mercato unico, il legislatore, dapprima europeo e poi nazionale, ha introdotto, sin dalla fine dello scorso secolo, dei meccanismi di sostegno alle imprese.
In questo contesto, l’art. 2, comma 100, lett. a), L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha istituito il Fondo di Garanzia per le micro, piccole e medie imprese (“Fondo di Garanzia PMI”) gestito da Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno S.p.A. (“MCC”) quale strumento di finanza pubblica, volto ad agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese al credito bancario, attraverso la concessione di una garanzia pubblica a parziale copertura del finanziamento accordato dagli istituti di credito, società di leasing e altri strumenti finanziari. Inoltre, l’art. 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 ha istituito l’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (“SACE”), con il compito di assumere in assicurazione i rischi di varia entità ai quali sono esposte le imprese nazionali. Tali misure sono state successivamente ampliate e implementate dalle Istituzioni come risposta all’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha colpito il mercato mondiale nel 2020, e alla guerra russo-ucraina, che ha interessato il contesto europeo nel 2022[1], con l’obbiettivo di facilitare l’accesso al credito e permettere alle imprese, in particole quelle di piccole dimensioni, di rimanere sul mercato.
In forza delle garanzie a prima richiesta prestate da MCC e SACE, un soggetto pubblico si assume il rischio del mancato rimborso del finanziamento da parte del debitore nei confronti della banca, per capitale e interessi. La garanzia MCC può coprire fino ad un massimo dell’80% dell’ammontare del credito, mentre la garanzia SACE offre una copertura fino all’80%-90% sui singoli prestiti bancari. Sicché, in caso di inadempimento dell’imprenditore, la banca potrà escutere la garanzia, ottenendo dal garante pubblico il pagamento dell’ammontare c.d. coperto[2]. A seguito del pagamento da parte di MMC/SACE, il garante subentrerà nella posizione dell’originario creditore finanziario e potrà dunque rivalersi sul debitore.
2. Sulla natura del credito del garante escusso
Con riferimento alle garanzie prestate da MCC, l’art. 8-bis, comma 3, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2015, n. 33, recante “Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” sancisce che il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite del Fondo di Garanzia PMI, a seguito dell’escussione della garanzia, “costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante”, ad eccezione dei crediti di giustizia. Dispone ugualmente, per le garanzie SACE, l’art. 9, comma 5, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, il quale stabilisce che “Per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia”.
Il dato normativo poc’anzi riportato ha sollevato non pochi dubbi interpretativi ed è stato pertanto oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale.
La Suprema Corte si è, infatti, interrogata in merito: (i) all’applicabilità del privilegio anche alle garanzie (e non solo ai finanziamenti diretti); e (ii) alla essenzialità della revoca quale requisito per il riconoscimento del privilegio.
Con riguardo al primo profilo, è stato chiarito che in assenza di una definizione normativa del termine “finanziamento”, questo deve essere inteso in senso ampio, come comprensivo di tutte le forme tecniche di intervento pubblico — ivi incluse le garanzie — mediante le quali viene realizzato il sostegno alle attività produttive[3]. Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità[4] ha affermato che “il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione per tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati” (cfr. Cass. Civ. n. 27360/2024) e che “il privilegio previsto, dall’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento” (cfr. Cass. Civ. n. 9657/2024).
Con riguardo invece al secondo profilo, sebbene un primo orientamento, valorizzando la lettera della norma, avesse considerato la revoca un elemento imprescindibile e prodromico all’escussione e, conseguentemente, alla nascita del privilegio[5], la giurisprudenza ha successivamente mutato indirizzo, riconoscendo la distinta natura dei due crediti, quello nascente dal contratto di finanziamento e quello vantato dal soggetto pubblico[6]: “la revoca dell’agevolazione concessa sotto forma di garanzia, anche se intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del beneficiario, è opponibile alla massa dei creditori, poiché il credito nasce privilegiato ex lege dal momento dell’erogazione del beneficio e non richiede un provvedimento formale di revoca per la sua operatività” (cfr. Cass. Civ. n. 6576/2025; Cass. Civ. n. 6570/2025; Cass. Civ. n. 6567/2025).
Dal momento che, dunque, la qualificazione della prelazione trova fonte nella legge ed è, pertanto, indipendente dalle vicende che interessano il credito garantito, il credito restitutorio del garante pubblico escusso non può che considerarsi (super)privilegiato ex lege sin dal momento nel quale la garanzia è stata prestata[7].
3. Valutazione “rinforzata” del merito creditizio
Da un punto di vista pratico, l’accesso alla garanzia pubblica avviene per il tramite della banca finanziatrice, la quale dovrà depositare apposita richiesta trasmessa dal debitore richiedente alla banca, presso una piattaforma online apposita (Portale FdP). Secondo le Disposizioni Operative del Fondo MMC e secondo le Condizioni Generali SACE, la richiesta di ammissione deve pervenire al gestore del fondo, per MCC, e all’Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero, per SACE, prima della delibera di concessione del finanziamento.
Si sottolinea che la sola erogazione della garanzia – e non anche del finanziamento – è svincolata da una valutazione del beneficiario. Infatti, una volta ricevuta la richiesta, il soggetto pubblico garante avvierà l’istruttoria, che avrà ad oggetto solo il soddisfacimento dei requisiti soggettivi e oggettivi, individuati dalle disposizioni di cui sopra, che i beneficiari finali devono soddisfare. A prova di ciò, l’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. 08 aprile 2020, n. 23 (il c.d. Decreto Liquidità), dispone infatti che il garante non esegue alcuna valutazione sostanziale, e l’erogazione della garanzia è solo subordinata “alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”.
Diversamente, alla banca è imposto un vero e proprio dovere di valutazione del merito creditizio: l’art. 5 T.U.B. – sebbene non sia direttamente dedicato alla valutazione del merito creditizio – stabilisce il principio di sana e prudente gestione che deve guidare l’attività bancaria. In tal senso, viola tale principio, configurandosi come una condotta abusiva, la mancata o non corretta valutazione del “merito” del prenditore, in un momento antecedente all’erogazione del credito, sanzionabile con una dichiarazione di nullità del contratto, quando, nei casi più gravi, da tale atteggiamento omissivo ne sia derivato un peggioramento delle condizioni finanziarie e patrimoniali del debitore.
Da ciò si evince che, mentre il garante è esonerato dal compiere alcun tipo di valutazione nel merito del beneficiario, nessuna norma imperativa deroga al dovere della banca di compiere un’approfondita istruttoria. In questa ottica, una decisione del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2024 ha contribuito a riempire di contenuto del suddetto dovere di diligenza qualificata sancito dall’art. 5 T.U.B., norma che non tipizza le condotte idonee a valutare il merito creditizio, ma si limita a prescrivere la doverosa acquisizione di informazioni adeguate, quando il finanziamento è coperto da garanzia statale, delineando un dovere “rinforzato” in capo alla banca laddove il mutuo sia garantito dallo Stato[8].. Nello specifico, il Tribunale partenopeo ha individuato il dovere della banca di chiedere al finanziato una copia del certificato dei debiti tributari o carichi pendenti, risultando non sempre esaustive e complete le scritture contabili obbligatorie.
Coerentemente si è espresso anche il Tribunale di Asti, il quale ha ravvisato nell’atteggiamento poco diligente della banca – che nel caso di specie aveva concesso credito ad un’impresa con chiari sintomi di insolvenza – la violazione dell’art. 316-ter c.p.[9], nella misura in cui ha permesso all’istituto di credito di beneficiare dei fondi pubblici posti a garanzia del finanziamento, omettendo informazioni che “in realtà avrebbero dovuto essere fornite all’ente preposto alla decisione circa l’erogazione dei finanziamenti e cioè l’informazione che il beneficiario del finanziamento era, in realtà, insolvente” (cfr. Tribunale Asti, 8 gennaio 2024, n. 105). Secondo il citato Tribunale la banca ha, in questo modo, abusato dei finanziamenti pubblici concessi dallo Stato, nella consapevolezza del futuro inadempimento del debitore, traslando il rischio di insolvenza in capo allo Stato, e andando contro la logica stessa delle garanzie MCC e SACE, sorte proprio per aiutare le imprese in difficoltà e, pertanto, concesse solo alle società che presentino delle concrete prospettive di risanamento.
Secondo il Tribunale piemontese, l’abusiva erogazione di finanziamenti che vantano del sostegno dello Stato crea un danno all’interesse pubblico atteso che le risorse pubbliche stanziate sono destinate all’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, nonché alla salvaguardia del tessuto produttivo imprenditoriale. Si legge, infatti, nella massima in commento: “La consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati, la cui causa non è quella del contratto tipico di mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito”. Da ciò non può dunque che conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo per illeceità della causa ai sensi dell’art. 1343 c.c..
Alla luce delle premesse che precedono, si richiama l’orientamento espresso da più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Piacenza, decreti dell’8 gennaio 2025 e del 15 aprile 2025), la quale, affrontando il tema del mutamento della causa giustificatrice del contratto a seguito dell’escussione della garanzia pubblica, ha affermato che gli eventuali profili di invalidità o inefficacia relativi al rapporto privatistico intercorrente tra l’ente finanziatore e l’impresa beneficiaria non si estendono al credito restitutorio azionato da MCC/SACE.
Il Tribunale ha infatti precisato che, nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l’obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all’ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico, in attuazione della disciplina di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Tale ricostruzione è stata altresì avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale assume ora una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme si è espressa anche la Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza n. 5786 del 4 marzo 2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull’ente creditizio in sede di erogazione del credito – ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall’intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Ciò chiarito, nel caso sottoposto al suo vaglio, il Tribunale di Piacenza, con i richiamati precedenti, ha altresì dichiarato la nullità del finanziamento per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., ritenendo che il negozio si ponesse in contrasto con l’art. 323, comma 1, lett. d), CCII che sanziona l’aggravamento del dissesto mediante operazioni gravemente colpose[10]. Sotto tale profilo, il Collegio giudicante ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell’art. 1418 c.c., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato” (Cass. 18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa in dissesto, che s’inserisca, ritardandolo, nell’iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a carico dell’imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa” (cfr. Cass. Civ. 16706/2020) e ha osservato che “la nullità può essere dichiarata all’esito dell’accertamento in concreto di una condotta delittuosa sussumibile sotto la fattispecie incriminatrice invocata, dovendosi riscontrare l’elemento oggettivo, quello soggettivo, nonché le modalità di concorso del soggetto finanziatore, quale extraneus del reato” (cfr. anche Cass. Civ. 26248/2024 e Tribunale di Ferrara, 3 maggio 2024).
Oltre a ciò, il Tribunale piacentino, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale che appare in via di consolidamento[11], ha ritenuto la condotta della banca finanche contraria al buon costume[12] in quanto causa dell’ aggravamento del dissesto della società, di conseguenza rigettando finanche la domanda di ripetizione indebito, in quanto “ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato”.
La declaratoria di nullità del contratto derivante esclusivamente dalla violazione di norme imperative, ovvero in combinazione con la contrarietà della condotta al buon costume, comporta rilevanti conseguenze applicative. Nel primo caso, infatti, la banca conserverebbe il diritto di ottenere la restituzione delle somme erogate, quantomeno a titolo di ripetizione di indebito; inoltre, potrebbero ritenersi ancora efficaci le garanzie originariamente acquisite nell’interesse del soggetto finanziato, specie qualora di natura omnibus. Diversamente, ove la nullità fosse ravvisata anche per contrarietà al buon costume, non sarebbe consentita neppure la ripetizione di indebito e la stessa validità delle garanzie, anche se omnibus, risulterebbe gravemente compromessa[13].
La preferenza per la soluzione più o meno sanzionatoria dovrà essere in ogni caso operata alla luce del comportamento assunto dall’istituto di credito nella fase istruttoria e dunque anche in relazione alla documentazione e alle informazioni ricevute dalla società debitrice.
Ad ogni modo è opportuno ricordare che i casi analizzati dalla giurisprudenza hanno ad oggetto finanziamenti erogati durante il periodo pandemico, in attuazione del Decreto Liquidità. Pertanto, l’impostazione finora seguita meriterebbe una revisione critica, tenuto conto che il giudizio ex ante che oggi si tende a formulare dovrebbe essere calato in un contesto in cui la valutazione del business plan alla base dell’erogazione era inevitabilmente condizionata dall’alea del periodo. Ne consegue che non dovrebbe instaurarsi una frattura valutativa tra il momento dell’erogazione e quello dell’insinuazione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale.
4. Il trattamento dei crediti garantiti MCC/SACE negli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza
Delineati il quadro normativo del credito privilegiato pubblico e la sua applicazione giurisprudenziale, si impone l’analisi delle specifiche modalità di trattamento dello stesso nell’ambito degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza.
A tale fine occorre anzitutto distinguere tra strumenti consensuali (i.e. accordi ex art. 23 CCII, accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII e accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII) e strumenti giudiziali diversi dalla liquidazione giudiziale (i.e. concordato preventivo e piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione).
Per quanto riguarda i primi, si rende opportuno chiarire che, prima dell’escussione, il soggetto legittimato ad esprimere formalmente il proprio assenso all’accordo è unicamente l’Ente creditizio erogante, quale titolare del rapporto obbligatorio principale. Cionondimeno, appare opportuno – ed è in tal senso raccomandabile[14] – che il creditore garantito coinvolga tempestivamente il soggetto garante, anche in considerazione dell’interesse che il primo ha ad ottenere, laddove possibile, l’adesione espressa da parte di SACE/MCC alla proposta di ristrutturazione, così da prevenire contestazioni circa l’opponibilità della modifica dell’obbligazione garantita.
Tale necessità trova fondamento, da un lato, nelle previsioni generali del codice civile, che sanciscono l’inefficacia verso il fideiussore delle modificazioni dell’obbligazione principale intervenute senza il suo consenso; dall’altro, nelle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la concessione e l’operatività delle garanzie rilasciate da SACE e MCC[15].
Le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia per le PMI stabiliscono infatti specifici protocolli di intervento nei casi di ristrutturazione del debito assistito da garanzia pubblica.
Più nel dettaglio, quando lo strumento consensuale adottato dal debitore ha ad oggetto una rimodulazione del debito, volta a modificare termini e condizioni di rimborso, l’allegato 17 consente a MCC di estendere la garanzia pubblica al nuovo piano di ammortamento concordato tra la banca e il debitore. Ai fini invece di uno stralcio della debitoria, l’allegato 16 stabilisce il seguente iter: soddisfacimento del creditore finanziario in misura almeno pari al 15% del proprio credito, escussione guidata della garanzia – nei limiti della percentuale coperta – sulla nuova base calcolata dopo lo stralcio e la rinuncia di MCC al diritto di rivalsa verso il debitore[16], subordinata alla verifica della convenienza della soluzione prospettata, da compararsi – anche con l’ausilio dell’attestazione o della relazione dell’Esperto ovvero di un Indipendent Business Report – necessariamente allo scenario alternativo liquidatorio o escussorio[17]. In sostanza, il garante dovrà attentamente valutare se l’alternativa liquidatoria ovvero il pagamento della garanzia, con successiva surroga, siano preferibili rispetto ad un accordo di ridefinizione del debito ovvero di parziale rinuncia.
Negli strumenti giudiziali diversi dalla liquidazione giudiziale il trattamento del garante pubblico non ancora escusso assume particolare complessità.
Non è, anzitutto, possibile applicare a tali strumenti la disciplina prevista dalle Disposizioni Operative adottate con il D.M. 19 novembre 2015 in caso di accordi con i creditori garantiti. Gli accordi di cui trattasi, infatti, sono specifiche intese bilaterali tra il debitore ed i suoi creditori nelle quali può prevedersi la conferma della garanzia pubblica ovvero l’escussione della garanzia pubblica senza esercizio – al ricorrere di precisi requisiti – del diritto di regresso da parte del garante pubblico verso il debitore. Si tratta, in particolare, degli “accordi transattivi” regolati dalla Parte VI, sezione C, delle Disposizioni Operative che si riferiscono a specifiche proposte che “possono essere formulate dai soggetti beneficiari finali, ovvero dai garanti a liberazione, anche parziale, della propria garanzia fideiussoria, ivi comprese le restrizioni ipotecarie su immobili di proprietà degli obbligati, senza liberazione degli stessi. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rinvenienti dalle procedure sulla crisi d’impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d’impresa, ecc)” ovvero “accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento”. Le Disposizioni Operative fanno quindi riferimento a “accordi transattivi” che muovono da una base pattizia tra il debitore e specifici creditori. Non è peraltro possibile far rientrare nella nozione di “proposta di accordi transattivi” una proposta di ristrutturazione che – come per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis CCII ovvero per il concordato preventivo – si rivolge alla massa dei creditori (inclusiva di tutte le categorie di creditori e non solo di quelli finanziari), implica l’esercizio del diritto di voto da parte della massa dei creditori (e, dunque, del creditore garantito) ed esclude la possibilità di stipulazione di accordi bilaterali soggetti al benestare del garante.
Partendo da tali considerazioni, già sotto la vigenza della Legge Fallimentare si era avvertita la necessità di considerare e rappresentare l’eventuale insorgenza del credito privilegiato di SACE o MCC, così da evitare che l’escussione della garanzia nel corso della procedura potesse compromettere la fattibilità del piano predisposto dal debitore. A tal fine, la giurisprudenza ha individuato come soluzione adeguata la previsione di un apposito fondo rischi: “In tema di concordato preventivo, occorre prevedere un fondo rischi per l’ipotesi di escussione della garanzia da parte delle banche con conseguente surroga di Medio Credito e Sace nei diritti degli istituti di credito e conversione per legge del credito da chirografario in privilegiato. Il deposito di un mero prospetto di calcolo non attestato e la mancata appostazione di uno specifico fondo rischi per l’eventualità di escussione della garanzia di Medio credito e di Sace si traduce in una carenza informativa nei confronti dei creditori, nei cui riguardi non è stata fornita una rappresentazione del probabile rango privilegiato che verranno ad assumere i crediti considerati nel piano come chirografari e della portata tendenzialmente esiziale per la tenuta stessa dell’ipotesi concordataria” (cfr. Tribunale di Nola, 11 luglio 2023).
Tale strada è stata condivisa ed integrata anche da autorevole dottrina, la quale ha osservato che “Estremamente problematico, infine, è il caso del credito di SACE/MCC che non sia stata escussa dalla banca garantita prima del voto dei creditori. Non trattandosi di creditori attuali, in tale ipotesi, non potrebbero essere classati, ma il piano dovrebbe prevedere l’appostazione di un fondo rischi, a copertura almeno di quanto si intende offrire a SACE/MCC in caso di distribuzione orizzontale delle risorse secondo la RPR. (…) Siccome in tesi, il fondo rischi appostato per SACE/MCC potrebbe non coprire l’intera ipotetica debitoria, questi soggetti dovrebbero potere interloquire sulla proposta, quantomeno come interessati all’omologa e, pertanto, dovrebbe essere loro notificato il decreto di ammissione per consentirgli, se lo ritengono, di svolgere un’opposizione all’omologazione”[18].
Sul punto è in seguito intervenuto anche il D.lgs. 136/2024, che ha introdotto, la lettera p)-bis, dell’art. 87, comma 1, CCII, secondo cui il piano deve contenere “l’indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito”, ponendo così fine a qualsivoglia contrasto.
La giurisprudenza ha, da ultimo, chiarito che la previsione de qua deve ritenersi applicabile anche al concordato semplificato e al concordato minore, osservando che “Nella proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, il debitore deve inserire in apposita classe il credito chirografario vantato da una banca assistito da garanzia rilasciata in virtù di misure di sostegno pubblico, non ancora escussa, e deve prevedere un apposito fondo volto a coprire il rischio di pagamento del terzo garante nell’ipotesi di escussione della garanzia, così come previsto, per il concordato preventivo, dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII” (cfr. Tribunale di Rimini, 25 marzo 2025) e che “L’art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII, trova applicazione anche nella procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 ss. CCII; ne consegue che il debitore proponente, nel caso di credito vantato da una banca assistito da garanzia rilasciata in virtù di misure di sostegno pubblico, non ancora escussa, deve inserire tale creditore in apposita classe, ai sensi dell’art. 74, comma 3, ultimo periodo, CCII, e deve prevedere nel piano concordatario un apposito fondo volto a coprire il rischio di pagamento del terzo garante nell’ipotesi di escussione della garanzia” (cfr. Tribunale di Modena, 3 febbraio 2025).
5. I crediti MCC/SACE e le misure cautelari: l’inibitoria di escussione della garanzia
Fermo quanto sopra esposto, è ricorrente la circostanza in base alla quale, in pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il creditore finanziario – in presenza di eventi qualificabili come fattori di rischio – ritenga necessario attivare il procedimento finalizzato all’escussione della suddetta garanzia, anche in considerazione dei termini decadenziali previsti a tal fine dalle vigenti Disposizioni Operative del medesimo MCC (par. H.1.3). A fronte di questo rischio, non è inusuale che il debitore in crisi o insolvente presenti, contestualmente all’avvio della procedura, istanza al Tribunale per l’applicazione di misure protettive e cautelari del patrimonio, tra le quali spicca, in questo contesto, la misura cautelare atipica[19] di inibitoria per le banche di intraprendere iniziative volte all’escussione della garanzia prestata da MCC/SACE[20].
Sul punto, è ampia la giurisprudenza di merito che si è pronunciata in ordine alla richiesta di concessione di una misura cautelare atipica, quale il divieto temporaneo alla banca per il recupero del suo credito garantito[21].
A tale riguardo, i Tribunali aditi hanno chiarito che la protezione cautelare non gode di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora, inteso quest’ultimo come rischio specifico che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell’impresa (cfr. Tribunale di Milano, 12 maggio 2024; Tribunale di Salerno, 22 febbraio 2024; Tribunale di Gorizia, 19 marzo 2024) e che l’oggetto del vaglio del giudice consiste nella verifica dell’adeguatezza e della coerenza della misura richiesta rispetto all’andamento delle trattative, e della sua funzionalità a garantire il risanamento dell’attività d’impresa[22]. In questo contesto, la richiesta di inibitoria all’escussione delle garanzie, anche rese da un soggetto pubblico, può essere riconosciuta solo se sono offerti elementi che consentano di apprezzare le ragioni concrete[23] per le quali l’escussione medesima potrebbe compromettere lo svolgimento delle trattative (cfr. Tribunale di Bologna, 12 maggio 2025).
Sulla base di queste premesse, recente giurisprudenza di merito ha ravvisato la presenza del periculum nella concreta possibilità che dall’escussione della garanzia derivasse un’alterazione dell’ordine legittimo delle cause di prelazione, tenendo a mente che il credito restitutorio di SACE/MCC vanta un privilegio riconosciuto ex lege: “con il pagamento alle banche da parte di MCC ed il conseguente esercizio del diritto di surroga nei confronti della debitrice, troverebbe ingresso nel passivo della società un debito privilegiato e maggiorato di penali” (cfr. Tribunale di Milano, 4 settembre 2024). In questa ottica, la cristallizzazione della pretesa bancaria permetterebbe di tutelare il patrimonio del debitore e, dunque, salvaguardare le trattative[24].
Tale ragionamento è stato condiviso dal Tribunale di Vicenza che, con il provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso la misura cautelare atipica oggetto del presente esame “onde evitare, da un lato, l’alterazione dello status quo tra i creditori (avvantaggiando gli escutenti, e demotivandoli rispetto all’esito della CNC), e, dall’altro, il definitivo consolidamento del super privilegio di MCC, che potrebbero pregiudicare le trattative in corso”.
Ad avviso di chi scrive, il periculum deve essere ravvisato anche in quei casi in cui – come si è avuto modo di argomentare nei paragrafi precedenti – il finanziamento sia affetto da nullità per illeceità della causa e, soprattutto, da nullità per contrarietà al buon costume comportante l’esclusione del diritto alla ripetizione delle somme erogate in applicazione dell’art. 2035 c.c..
L’iter fino a questo momento delineato trova applicazione tanto nella composizione negoziata, quanto con riferimento agli altri strumenti di regolazione della crisi, la cui disciplina è contenuta negli artt. 54 ss. CCII, purché vi sia il nesso di strumentalità tra la suddetta misura cautelare atipica e il tentativo di risanamento.
6. Conclusioni
Dall’analisi condotta emerge chiaramente come il sistema delle garanzie pubbliche MCC e SACE rappresenti un presidio essenziale per la stabilità del mercato creditizio e per la salvaguardia del tessuto produttivo, specie nei contesti di crisi d’impresa.
L’evoluzione interpretativa dell’art. 9, comma 5, D.lgs. n. 123/1998 e le più recenti previsioni introdotte dal D.lgs. n. 136/2024 hanno progressivamente chiarito la natura pubblicistica del credito del garante escusso, dotato di un privilegio ex lege e autonomo rispetto al rapporto privatistico originario tra banca e impresa. Tale qualificazione, fondata sulla funzione di reintegrazione delle risorse pubbliche impiegate, incide direttamente sulla gestione del credito nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi.
In tale contesto, la previsione di fondi rischi — oggi espressamente contemplata dall’art. 87, comma 1, lett. p)-bis, CCII — costituisce un presidio di trasparenza e sostenibilità del piano, volto a prevenire che l’eventuale escussione della garanzia determini la sopravvenuta infattibilità della proposta.
Infine, in relazione alle misure cautelari inibitorie all’escussione, la giurisprudenza ha evidenziato come il loro riconoscimento non sia automatico, ma subordinato alla verifica del nesso di strumentalità con il percorso di risanamento: solo quando l’escussione della garanzia risulti idonea a compromettere il buon esito della procedura e il migliore soddisfacimento dei creditori nei termini esemplificativi illustrati al paragrafo che precede, la misura potrà essere concessa.
[1] In particolare, con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) il legislatore: (i) ha introdotto una nuova forma di garanzia prestata da SACE la c.d. “Garanzia Italia”; e (ii) ha modificato la disciplina del Fondo di Garanzia PMI, al fine di permettere l’accesso automatico alle garanzie dallo stesso prestate agli operatori considerati più vulnerabili (art. 13, comma 1, lett. b)). Successivamente, con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), il legislatore ha nuovamente modificato la disciplina delle garanzie di cui al Decreto Liquidità: (i) prorogando la durata della “Garanzia Italia” al 30 giugno 2022; e (ii) prevedendo con riferimento alla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI: (i) il versamento di un contributo una tantum al Fondo di Garanzia PMI per le richieste presentate a decorrere dal 1° aprile 2022; e (ii) una nuova disciplina da applicarsi, invece, alle richieste di garanzia presentate a partire dal 24 giugno 2022 e deliberate dal Fondo di Garanzia PMI tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Successivamente, con il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2022, n. 91, il legislatore ha attribuito (i) a SACE la facoltà di prestare, fino al 31 dicembre 2022, garanzie a favore di istituti bancari, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, nonché ad altri soggetti autorizzati ad erogare credito in Italia, per finanziamenti di qualsiasi natura a favore delle imprese (c.d. “Garanzia SupportItalia”); e (ii) a MCC la facoltà di prestare garanzie, fino al 90% dell’importo del finanziamento e per un importo massimo di Euro 5.000.000 su taluni finanziamenti, individuabili sulla base della finalità a cui sono preposti, erogati alle PMI dopo il 18 maggio 2022.
Da ultimo, il legislatore italiano ha introdotto con la L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) nuove forme di garanzia con finalità e destinatari specifici:
- la c.d. “Garanzia Archimede” di cui all’art. 1, commi 259-268, della Legge di bilancio 2024;
- la c.d. “Garanzia Futuro”, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 143/1998;
- la c.d. “Garanzia Green”, di cui all’art. 1, comma 269, della Legge di bilancio 2024.
(cfr. Krino, Linee Guida per la Ristrutturazione dei crediti garantiti da MCC/SACE, p. 4).
[2] Al riguardo, l’art. 6.4 delle Condizioni Generali SACE (Escussione della Garanzia SACE) prevede che SACE paghi l’importo garantito in rate, secondo le scadenze previste nel piano di ammortamento del finanziamento garantito, ferma la facoltà, a propria discrezione, di pagare in un’unica soluzione. Diversamente, nessuna previsione relativa alle modalità di pagamento è contenuta nelle Disposizioni Operative MCC; tuttavia, nella prassi generalmente MCC liquida l’ammontare dovuto in un’unica soluzione.
[3] Cfr. P. Manganelli – T. Patrinieri, in Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da SACE e MCC, Diritto della Crisi, 2024.
[4] Cfr. anche Cass. Civ. n. 13180/2023; Cass. Civ. n. 19461/2022; Cass. Civ. n. 15857/2022; Cass. Civ. n. 1485/2022; Cass. Civ. n. 1453/2022; Cass. Civ. n. 39433/2021; Cass. Civ. n. 8601/2021; Cass. Civ. n. 8600/2021; Cass. Civ. n. 27159/2020; Cass. Civ. n. 8882/2020; Cass. Civ. n. 6508/2020; Cass. Civ. n. 25336/2020; Cass. Civ. n. 2457/2020; Cass. Civ. n. 2664/2019. Al contrario, le Corti di merito (tra cui Tribunale di Milano, 3 luglio 2014; Tribunale di Pistoia, 14 maggio 2015, Tribunale di Udine, 2 febbraio 2017, Tribunale di Roma, 2 marzo 2017, Tribunale di Milano, 1° marzo 2018, Tribunale di Udine, 14 aprile 2019) si sono sempre dimostrate particolarmente scettiche all’estensione della norma in questione alle garanzie.
[5] cfr. Cass. Civ. n. 1005/2023; Cass. Civ. n. 9657/2024; Cass. Civ. n. 15485/2024 secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l’avvenuta escussione di quest’ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
[6] Cfr. G. Castellano – N. Stiaffini, Finanziamenti garantiti dallo stato (MCC-SACE) e fideiussore bancario. Riflessione sistematica sugli interessi pubblici e privati in gioco, in Riv. Di Diritto del Risparmio, Approfondimenti, fascicolo 3/2024, p. 3-5.
[7] Cfr. L. Cipolla – L. Dell’oro – G. Gaudenzi, Procedure concorsuali e crediti garantiti da MCC e SACE, in Riv. Diritto Bancario, luglio 2024, p. 3; Cfr. S. Bonfatti, Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla concessione abusiva al danno erariale, in Riv. Diritto Bancario, settembre 2025, p. 12.
[8] Nota a sentenza di M. Spiotta, in www.onelegale.it: il Tribunale di Napoli ha ritenuto che costituisse una “aggravante” il fatto che il finanziamento fosse garantito in misura elevata dal fondo pubblico, nel senso che, la circostanza di erogare finanziamenti con capitale pubblico “avrebbe al contrario dovuto imporre” all’ente erogatore “un aumento della diligenza nella verifica del merito creditizio della controparte”.
[9] Indebita percezione di erogazioni pubbliche: “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
[10] A tale riguardo, potrebbe ritenersi che l’istituto finanziatore risponda non solo per il danno diretto arrecato alla società consistente nella concessione abusiva di un credito che la stessa non è (già al momento dell’erogazione) in grado di rimborsare, ma anche per il danno indiretto derivato ai creditori che hanno intrattenuto rapporti con la società in ragione dalla prosecuzione dell’attività aziendale. Ad avviso di S. Bonfatti, in Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla concessione abusiva al danno erariale, non può esservi concessione abusiva (da parte della banca) senza che vi sia stato ricorso abusivo (da parte del cliente), “Da qui alcune considerazioni che dovrebbero rappresentare una verifica preliminare della “serietà” della contestazione alla banca di “abusività” del comportamento tenuto in occasione della concessione di credito ad una impresa in crisi: (i) la preventiva revoca degli amministratori che a loro volta hanno necessariamente abusato nel ricorrere al credito in una situazione non più recuperabile (perché certamente più consapevoli della gravità della crisi di quanto non lo fosse qualsiasi terzo, compresa la banca); (ii) la preventiva promozione di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (per aver aggravato il dissesto utilizzando risorse finanziarie che, per quanto erogate, nessun pregiudizio avrebbero prodotto, se non investite)”.
[11] Cfr. Cass. Civ. 16706/2020; Cass. Civ. 4376/2024¸ Tribunale di Vicenza, 22 aprile 2021. Si veda anche Cass. Civ. 9441/2010 secondo cui “Ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 cod. civ., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume”.
[12] Secondo Cass. Civ. 25631/2017: “L’accertata nullità di un contratto di finanziamento stipulato in danno della P.A., da parte di un funzionario infedele, in conseguenza della illiceità della causa per violazione di norme imperative, non preclude l’autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della sua eventuale contrarietà anche al buon costume che, ove sia accertata, stante il disposto dell’art. 2035 c.c., impone di negare la ripetizione della prestazione eseguita al finanziatore”.
[13] S. Bonfatti, in Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla concessione abusiva al danno erariale, www.dirittobancario.it.
[14] M. De Lise – N. Palladino, in Una norma chiara per la gestione delle garanzie MCC, Sole24ore, 8 ottobre 2025: “Nei percorsi di composizione negoziata, la presenza di crediti assistiti da garanzia pubblica è basilare, eppure i professionisti non riescono a trovare un dialogo costruttivo per il risanamento delle imprese, in quanto non vi è, ancora oggi, una norma che consente di trovare una soluzione con i tempi scadenzati dal Codice della Crisi”.
[15] Si richiama l’art. 9.1 delle Condizioni Generali SACE Italia di cui al Decreto Liquidità, il quale stabilisce espressamente che il creditore garantito si impegna “a) non modificare condizioni o termini del Contratto di Finanziamento e (b) non consentire modifiche delle eventuali garanzie reali e/o personale, nella misura in cui le predette modifiche sub (a) e (b) possano determinare una modifica delle informazioni e dei contenuti della Richiesta di Garanzia SACE”. Analoghe previsioni sono previste nelle condizioni generali Garanzia SACE Green e nelle condizioni generali Garanzia SACE Futuro.
[16] Allo stato, tuttavia, non è contemplata la possibilità per MCC di aderire a un pagamento parziale successivamente all’avvenuta escussione. È auspicabile che, in futuro, le Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI vengano aggiornate prevedendo una disciplina specifica anche per questa ipotesi.
[17] Sul punto, si segnala, inoltre, che, ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia PMI (par. H.4.8), non sono procedibili proposte di transazione che comportino il pagamento di una quota inferiore al 15% del credito garantito. Pertanto, laddove si ipotizzino stralci superiori all’85%, sarà necessario ricorrere a strumenti alternativi al piano attestato.
[18] S. Rossetti, in Appunti sul classamento dei creditori nel concordato in continuità, Diritto della Crisi, 2023.
[19] La principale caratteristica delle misure cautelari, in assenza di specifica indicazione del loro contenuto, è l’atipicità, essendo definite dall’art. 2, lett. q), CCII e, dunque, essendo comprensive di ogni provvedimento cautelare a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, idoneo ad “assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”; si tratta, dunque, in primo luogo di “provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” (cfr. art. 19, comma 1, CCII).
[20] Cfr. Tribunale di Piacenza, 14 luglio 2025, inedito.
[21] Cfr. Tribunale di Genova, 20 marzo 2025, inedito.
[22] Cfr. Tribunale di Torino, il quale ha inibito l’escussione delle garanzie prestate dal soggetto che si era impegnato a sostenere finanziariamente il risanamento della società nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi da questa avviata, ritenendo, in particolare, che “le misure cautelari richieste presentano […] carattere di strumentalità e funzionalità conservativa, atto a preservare la disponibilità di […] a sostenere la continuità operativa di […]; correlativamente, è ravvisabile il pericolo che l’escussione delle garanzie di […] possa pregiudicare il buon esito della composizione (ravvisandosi quindi il nesso di funzionalità tra le misure richieste e il positivo esito delle trattative) a discapito della possibilità di un concreto risanamento imprenditoriale. In assenza di misure inibitorie, infatti, sarebbe possibile per i creditori […] procedere all’escussione delle garanzie con inevitabili ripercussioni negative non solo sulle trattative nell’ambito della composizione negoziata ma anche, in senso più ampio, sulla possibilità stessa di prosecuzione dell’attività d’impresa e sul mantenimento dell’operatività aziendale, con il concreto rischio di dispersione e distruzione del compendio aziendale, in evidente contrasto con le prospettive di recupero e soddisfacimento per tutti i creditori” (Ordinanza n. 139/2025, 7 luglio 2025, inedita).
[23] Cfr. Tribunale di Cuneo, il quale ha prorogato le misure cautelari già concesse ritenendo che “l’assenza di proroga determinerebbe la necessità di avviare un procedimento concorsuale che potrebbe essere più oneroso in termini di spese di procedura (e che potrebbe anche condurre ad un’eventuale scenario liquidatorio), procedimento che una volta attivato vedrebbe l’escussione della garanzia MCC con ripercussione sulla tutela del denaro pubblico” (Ordinanza del 22 gennaio 2025, inedito)
[24] Cfr. Tribunale di Napoli, il quale ha rilevato che “Quanto alle altre misure cautelari, in particolare all’inibitoria dell’escussione di qualsivoglia garanzia prestata in favore dei creditori ed, in particolare degli istituti di credito e dei fornitori, specificamente da Medio Credito Centrale S.p.A., SACE S.p.A. e Fidimed S.C., nonché da qualsivoglia diverso garante pubblico o privato […] e, specularmente, all’inibitoria a Medio Credito Centrale S.p.A., SACE S.p.A. e Fidimed S.C. nonché ad ogni ulteriore garante di liquidare le garanzie concesse in favore dei soggetti garantiti […], il gruppo istante ha dedotto, in particolare, che in caso di escussione della garanzia pubblica e di surroga del garante pubblico, il credito da finanziamento bancario, originariamente chirografario, assumerebbe il rango di privilegiato, per cui l’esecuzione del piano verrebbe ragionevolmente compromessa, trasformando la debitoria da chirografaria a privilegiata; al contrario, le misure richieste, sarebbero idonee a facilitare le trattative, consentendo che vengano condotte direttamente con il finanziatore garantito ed evitando che le imprese si trovino costrette a considerare un diverso e maggiore “super-privilegio” ante primo grado in particolare di MCC, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse. Ebbene, l’istanza di concessione di tali misure cautelari e delle ulteriori appare fondata. […] Tutte le misure cautelari richieste, inoltre, appaiono idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni. In particolare, si condivide che il divieto di escussione delle garanzie può facilitare le trattative, che in tal modo saranno da condurre con il creditore originario e non con il garante, tenendo conto anche di tutte le eccezioni eventualmente opponibili e le pretese da proporre nei confronti del medesimo, come in particolare in ordine alla legittimità o meno dell’erogazione del cospicuo credito bancario” (Ordinanza del 21 agosto 2025, inedita).