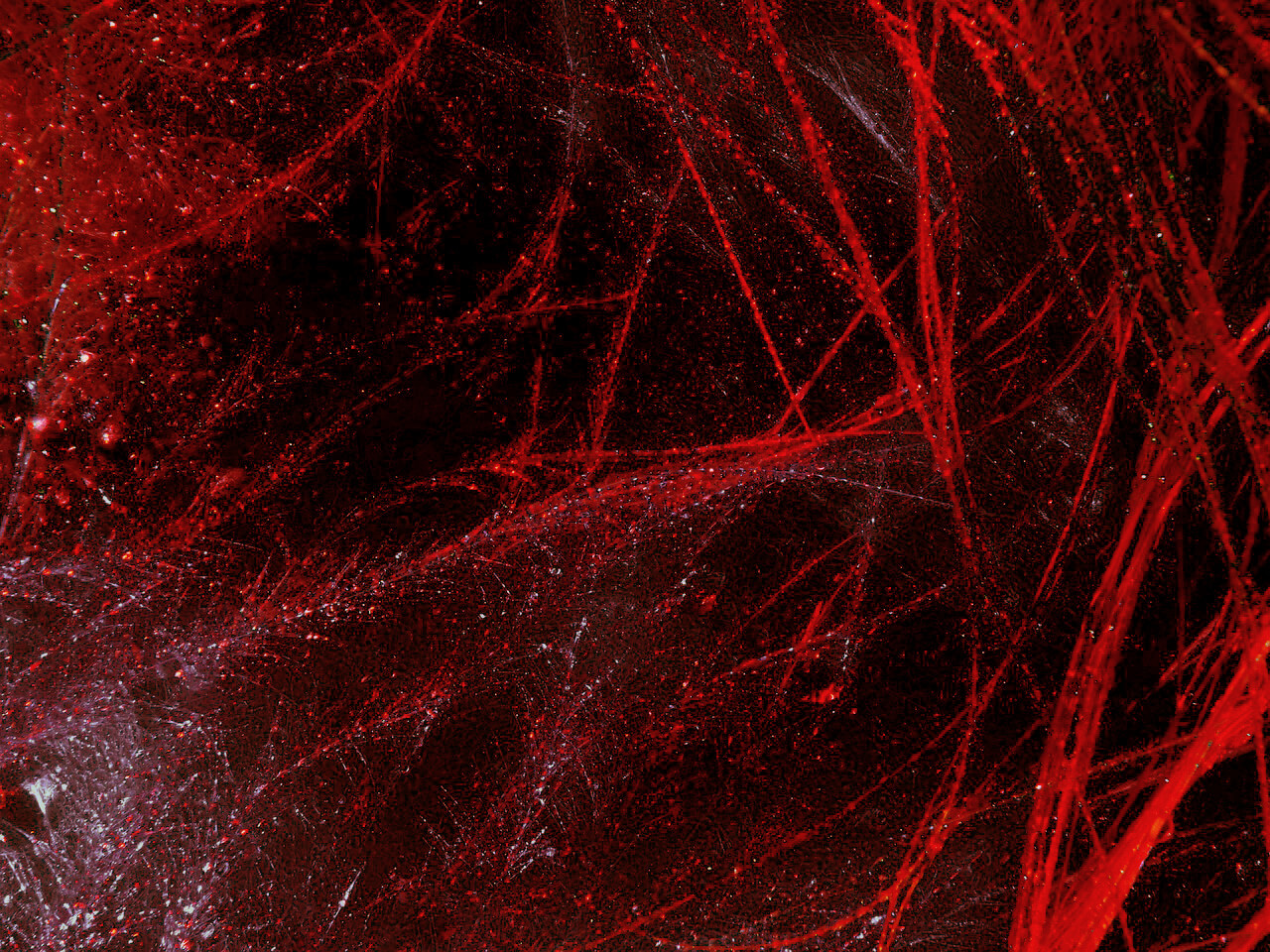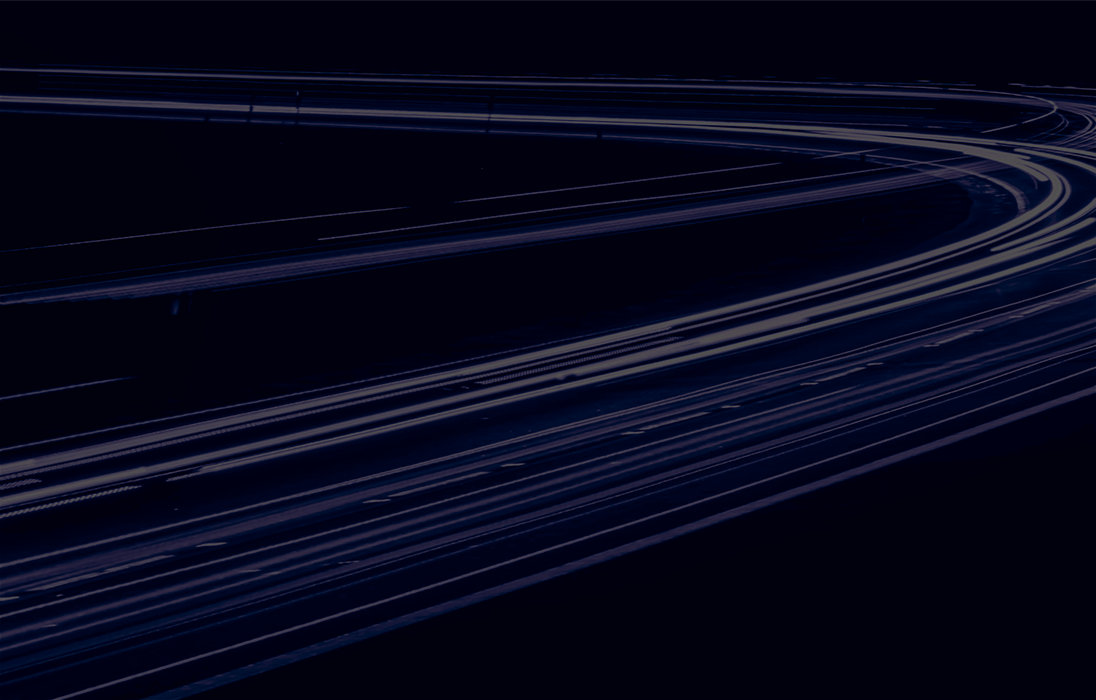Il D.L. 23/2020 (c.d. decreto liquidità), ha introdotto, come noto, in ragione dell’allora perdurante crisi pandemica Covid-19, misure urgenti in materia di accesso al credito, favorendo per l’appunto l’accesso al credito delle imprese nel periodo di crisi, per il tramite della prestazione di garanzie pubbliche (c.d. finanziamenti garantiti MCC o SACE) a sostegno del credito erogato, nell’interesse delle imprese finanziate.
Il credito del garante pubblico, che sorge in caso di escussione della garanzia e rimborso del finanziamento erogato dalle banche ad imprese rivelatesi inadempienti, è assistito da un privilegio che prevale sugli altri diritti di prelazione, ad eccezione dei crediti per spese di giustizia e dei crediti ex art. 2751-bis C.c., e ciò in forza dell’art. 9 del D. Lgs. 123/1998 (la cui applicabilità è stata estesa, ad opera della Cassazione, non solo ai finanziamenti pubblici “diretti”, ma anche in favore delle pretese di MCC e SACE, in conseguenza della prestazione di fideiussioni a garanzia dei finanziamenti erogati).
Tuttavia, e nonostante il privilegio riconosciuto, le numerose procedure di gestione della crisi d’impresa che si sono aperte negli ultimi anni, nei confronti delle imprese inadempienti, non sempre hanno comportato il recupero integrale delle risorse statali oggetto della garanzia.
La ricerca delle responsabilità a monte della concessione del credito – e di consequenziali soggetti a cui rivolgersi per il recupero delle somme erogate dallo Stato, tra cui la banca finanziatrice – ha recentemente indotto diverse Procure regionali della Corti dei Conti, stante la presenza di risorse di natura pubblicistica, ad invocare altresì la figura del danno erariale, ovvero il danno cagionato all’interesse patrimoniale dello Stato.
In particolare, è stato sostenuto che:
- i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche (c.d. garantiti MCC o SACE) sono riferibili allo Stato nonostante l’erogazione sia avvenuta tramite un soggetto privato, come la banca finanziatrice
- il beneficiario del sostegno, ovvero l’impresa finanziata, sia da considerarsi partecipe della realizzazione del programma d’interesse pubblico perseguito dalla disciplina applicabile ai finanziamenti, che, nel caso dei finanziamenti Covid-19, coincide con il superamento della crisi economica, che sia conseguente a quella pandemica.
In particolare, in seno alla Procura regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, la richiesta di danno erariale è stata avanzata non solo nei confronti del soggetto finanziato, ma anche della banca finanziatrice, colpevole – secondo l’impianto accusatorio – di non aver rispettato le norme che disciplinano la concessione del finanziamento garantito e la valutazione del merito creditizio.
Tale orientamento è stato espresso in una recente procedimento incardinato presso la Sezione giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti, la quale, tuttavia, con sentenza n. 6/2024, pur non entrando nel merito circa la configurabilità del danno erariale in capo all’ente finanziatore, ha tuttavia escluso la responsabilità della banca in assenza di una rigorosa prova, da parte della Procura, del nesso di causalità, della violazione del rapporto di rilievo pubblicistico contestato, e della gravità dei comportamenti ascritti (v. sotto e in allegato).
Da ultimo, si ha notizia della ripresa di tale orientamento della Procura in un ulteriore invito a dedurre della Procura Regionale del Veneto presso la Corte dei Conti, notificato ad una banca lo scorso mese di luglio.
La responsabilità erariale sussidiaria della banca secondo la Procura regionale
Il giudizio di responsabilità erariale, nel caso in esame, involgeva non solo gli esponenti aziendali dell’impresa finanziata, ma altresì la banca erogatrice del finanziamento, ai quali, i primi a titolo doloso ed in via solidale, e la seconda a titolo di colpa grave ed in via sussidiaria, la Procura chiedeva il risarcimento del danno erariale cagionato al MIMIT in ragione della garanzia pubblica escussa in conseguenza all’inadempimento dell’impresa.
La fattispecie posta alla Corte dei Conti conseguiva al parallelo procedimento penale nei confronti dell’amministratore dell’impresa, nell’ambito del quale era stato accertato che quest’ultima, una volta ottenuto il finanziamento con la reale finalità di acquisire risorse in modo illecito, facendo affidamento sulla garanzia pubblica, aveva poi trasferito gli importi ricevuti in favore di una società estera con lo scopo, risultato poi fittizio, di acquisire macchinari, da utilizzare per il piano operativo presentato all’atto della richiesta del finanziamento: tuttavia, tale società sarebbe stata costituita unicamente per sviare le risorse ricevute, poi ulteriormente riversate in conti correnti esteri non più tracciabili.
Come emerso dalle indagini, in sostanza, il piano industriale presentato dalla società si era rivelato un artificioso espediente per poter accedere al finanziamento, facendo leva sulle possibilità offerte dalla garanzia statale: costituiva in sostanza il presupposto di un’operazione truffaldina dell’amministratore della società, in danno alle risorse pubbliche.
La Procura regionale, quanto alla responsabilità per colpa grave della banca, sosteneva pertanto che l’istituto di credito, nell’ambito di un procedimento di natura amministrativa, come quello relativo ad un rapporto di servizio nella gestione di garanzie statali finalizzate a consentire l’accesso al credito, non aveva adeguatamente valutato il rischio creditizio dell’operazione: ciò, in quanto diversi indici finanziari (rapporto debito/credito, grado di indebitamento societario, rapporto MOL/Ricavi) deponevano nel senso della precarietà patrimoniale dell’impresa.
La banca, secondo l’ipotesi della Procura, si sarebbe infatti superficialmente accontentata di garanzie personali sostanzialmente irrisorie dell’amministratore, soggetto privo di risorse adeguate (come risultante dalle dichiarazioni dei redditi acquisiti nel corso dell’istruttoria amministrativa) e non aveva correttamente valutato il business plan presentato dalla società ammessa a finanziamento, risultato del tutto inaffidabile.
La Procura deduceva quindi la violazione gravemente colposa delle “Regole sulla concessione del credito”, poiché la banca aveva evidentemente confidato sulla garanzia statale a tutela della propria posizione, anche in considerazione del fatto che la stessa non aveva poi neppure effettuato controlli successivi sull’attività societaria.
La Corte dei Conti sulla responsabilità della banca nei finanziamenti garantiti MCC
La Corte dei Conti, tuttavia, contrariamente alla Procura, ha ritenuto, nel caso di specie, quanto alla responsabilità della banca, che fosse carente la prova del nesso causale, e che non fossero comunque ravvisabili profili di colpa grave della stessa nella fase di valutazione del merito creditizio, ovvero di ammissione dell’impresa al finanziamento, con l’assistenza della garanzia statale.
In sostanza, per il Collegio:
- non è stato provato quale violazione del rapporto di rilievo pubblicistico da parte della banca avesse contribuito alla determinazione del danno erariale, non essendo state specificate le regole che disciplinano le condizioni per il rilascio della garanzia statale: non è stata richiamata, in particolare, la disciplina di dettaglio che regola i rapporti tra il soggetto erogatore dei finanziamenti garantiti e la società pubblica di riferimento (MCC), non essendo possibile verificare se, nel comportamento dell’Istituto, vi siano state violazioni di prescrizioni e cautele previste per il rilascio della garanzia statale
- non è stato provato se e come la disciplina regolamentare interna – privatistica e relativa alla concessione di finanziamenti da parte dell’Istituto bancario – debba operare anche quale regola di riferimento per la concessione della garanzia statale: anche se lo scopo di tale disciplina è quello di tutelare gli interessi privatistici della banca nelle procedure di rilascio di prestiti alle imprese, secondo la Corte non viene chiarito come possa operare anche per definire i presupposti per il rilascio della garanzia statale
- in ogni caso, anche qualora tale regolamentazione abbia anche, in via generale, la finalità di assicurare le condizioni di rilascio della garanzia di cui alla L. 662/1996, per la Corte non si ravvisano gravi violazioni colpose imputabili alla banca, nella concessione del finanziamento e nel rilascio della garanzia statale, in quanto:
- la finalità precipua del Fondo di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996 è quella di consentire l’accesso al credito proprio a quei soggetti svantaggiati che non vi avrebbero altrimenti accesso sulla base delle stringenti regole altrimenti usualmente adottate dagli istituti bancari
- l’ordinamento presuppone un fondo apposito, limitato nella sua dotazione, preventivando quindi un proprio capitale di rischio
- il sistema complessivo congegnato dal legislatore prevede che la garanzia operi in favore di soggetti privi di una propria autonoma possibilità di accesso al credito per difetto di idonea garanzia personale
- dalla lettura degli atti penali allegati in giudizio emerge ampiamente l’esistenza di una condotta ingannatrice della società che, in radice, esclude la sussistenza di profili di colpa grave nelle attività valutative della banca (presentazione di fatture false per l’acquisizione di macchinari, fittizia e temporanea acquisizione del controllo societario di altra azienda ai fini dell’apertura di un altro punto di produzione, apparente rispetto delle condizioni del finanziamento, con restituzione di 15 rate del prestito): all’impresa va quindi interamente ricondotto il danno erariale dolosamente cagionato all’erario
- quanto alla valutazione del merito creditizio:
- la sussistenza di valide e sufficienti fideiussioni da parte di terzi soggetti costituisce un surplus non necessario per il rilascio del finanziamento: ove, infatti, si dovesse ammettere che la garanzia statale potesse essere rilasciata solo in favore di soggetti già ampiamente garantiti in via alternativa, se ne dovrebbe ricavare l’assoluta inutilità della garanzia statale e della stessa finalità pubblica di assistenza a soggetti che altrimenti non potrebbero avere accesso al credito
- risulta che la banca avesse effettuato una compiuta valutazione circa la remuneratività dell’intervento proposto nel business plan, finalizzato all’acquisizione dei macchinari, sulla base di motivazioni non illogiche, tali da far ragionevolmente presumere che lo svolgimento dell’attività imprenditoriale avrebbe certamente consentito il rimborso delle rate del finanziamento (come peraltro avvenne per i primi 15 mesi).
In conclusione, dopo aver rigettato la domanda avanzata nei confronti della banca erogatrice del finanziamento, la Corte ha condannato l’amministratore della società fallita per il danno erariale cagionato al MIMIT, ovvero al pagamento, a favore del pubblico erario, dell’importo della garanzia escussa in seguito all’inadempimento dell’impresa.