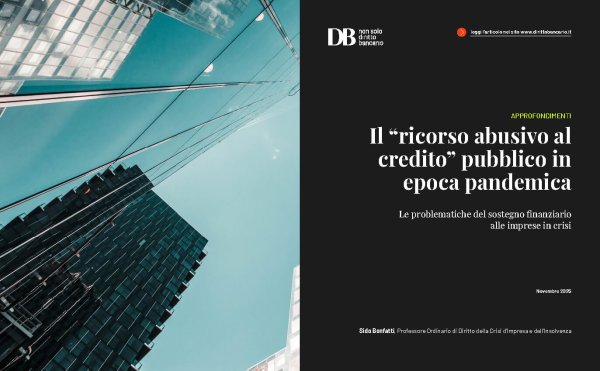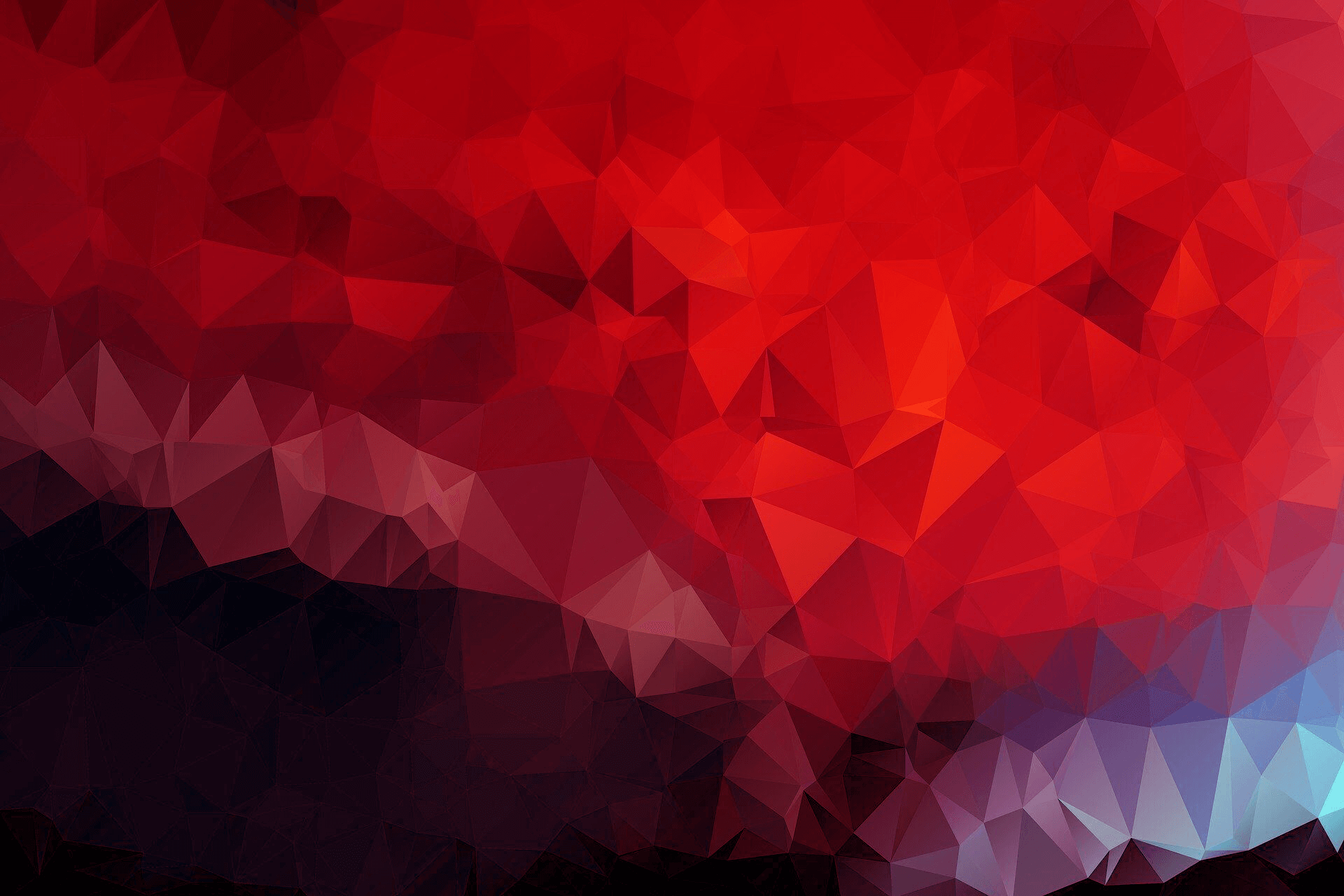Il presente contributo affronta le questioni investite dal tema del credito concesso in epoca Covid-19 dalle banche secondo quanto prevedeva la normativa emergenziale, nonché le contestazioni che oggi si stanno sviluppando e si legano al carattere pubblico della garanzia prestata dallo Stato a supporto di tali concessioni.
1. Premessa. La valutazione riservata in sede giudiziale al sostegno finanziario alle imprese in crisi per l’emergenza sanitaria.
A qualche anno di distanza dall’emersione della crisi sanitaria prodotta dal virus “Covid 19”, e dalla crisi economica che ne è seguita, è assurta all’attenzione della giurisprudenza una numerosa serie di fattispecie interessate dalla disciplina introdotta nell’ordinamento per favorire l’attività delle imprese che si erano venute a trovare in quel contesto problematico, e che non sono riuscite a superarlo: si tratta, principalmente, di “fallimenti” (rectius: liquidazioni giudiziali) di imprese, che il sostegno finanziario pubblico (attraverso l’intervento delle banche finanziatrici assistite da garanzia dello Stato o da soggetti o Enti equivalenti) non è riuscito a sottrarre al dissesto.
Tale fenomeno ha provocato importanti conseguenze economiche e finanziarie, per effetto del ricorso delle banche finanziatrici alle garanzie pubbliche che ne avevano assistito i prestiti alle imprese: il “superprivilegio” assicurato ai crediti (definibili, atecnicamente, di regresso[1]) dei garanti pubblici, non ha sempre potuto ridurre adeguatamente l’effetto pregiudizievole del fenomeno sotto il profilo economico (non sussistendo frequentemente i presupposti neppure per il soddisfacimento dei crediti “super privilegiati”), e forse non potrà annullarlo mai sotto il profilo finanziario (visti i tempi tuttora “biblici” delle liquidazioni concorsuali, dalle quali lo Stato dovrebbe ricevere il rimborso di quanto riconosciuto alle banche finanziatrici).
Forse anche per tale ragione ha suscitato rinnovato interesse l’argomento della “concessione abusiva di credito”: nel senso, di stimolare la verifica e l’approfondimento dell’effettiva sussistenza dei presupposti per l’erogazione dei finanziamenti “antipandemia” assistiti da garanzie pubbliche, la cui escussione produceva e produce il fenomeno negativo sopra rappresentato. In ipotesi di “concessione abusiva” poteva addursi (ed in effetti tutt’oggi si adduce) la insussistenza dei presupposti per l’esigibilità del credito (verso il soggetto finanziato “fallito”, o comunque insolvente), nonché per l’escutibilità della garanzia pubblica[2].
Di più.
In ipotesi di “concessione abusiva” poteva addursi (ed in effetti tutt’oggi si adduce) non soltanto la insussistenza dei presupposti per la escutibilità delle garanzie pubbliche: ma anche la sussistenza delle condizioni per la reclamabilità del risarcimento di un danno, rappresentato dall’ingiustificato “impegno” della garanzia dello Stato (o di soggetti ed Enti di natura giuridica pubblica) per fattispecie immeritevoli di tale intervento, con conseguente corrispondente privazione del sostegno finanziario pubblico ad imprese che invece lo avrebbero meritato[3].
Minimo comune denominatore delle due rappresentazioni sopra riferite è rappresentato dall’affermazione del principio, secondo il quale le banche avrebbero dovuto condizionare l’erogazione del “credito pubblico” – inteso come finanziamenti che avrebbero beneficiato della garanzia pubblica – all’accertamento del “merito creditizio” del soggetto finanziato, in omaggio alla necessaria osservanza dell’obbligo di improntare la gestione della banca alla “sana e prudente gestione” (art. 5 T.U.B.). L’affermazione può qualificarsi “unanime”: dalla giurisprudenza di merito[4] alla giurisprudenza della Suprema Corte[5]; dalla giurisprudenza civile alla giurisprudenza amministrativa[6]; dalle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia)[7] alle Autorità di controllo amministrativo (Corte dei Conti)[8].
La conclusione non è però meritevole di essere condivisa.
Di più.
Non solo la sussistenza del “merito creditizio” non costituiva e non costituisce un presupposto di legittimità della concessione del “credito pubblico” (nella forma, come consideriamo in questa sede, del finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica) – nel senso che il credito pubblico potrebbe ed avrebbe potuto essere concesso (come si cercherà di dimostrare) anche a soggetti e ad imprese prive di “merito creditizio“, senza che ciò legittimi o legittimasse la contestazione di “concessione abusiva di credito” (pubblico) – ma addirittura (come si proverà a dimostrare) la sussistenza di “merito creditizio” costituiva e costituisce un presupposto di illegittimità della concessione del “credito pubblico” (nella forma, come consideriamo in questa sede, del finanziamento bancario assistito da garanzia pubblica) – nel senso che il credito pubblico non potrebbe e non avrebbe potuto essere concesso (come si cercherà di dimostrare) a soggetti e ad imprese in possesso di “merito creditizio“, in quanto ciò legittimerebbe ed avrebbe legittimato la contestazione di “ricorso abusivo al credito” (pubblico) -.
2. La nozione di “credito pubblico“.
Per “credito pubblico” (o anche “finanziamento pubblico”) si intende in prima battuta la concessione di sostegno finanziario da parte dello Stato; da parte di un Ente pubblico; o da parte di soggetto od Ente che, in considerazione delle risorse che ne consentono il funzionamento, e della governance che lo caratterizza, possa essere riferito alla sfera pubblica. A tale proposito, e con specifico riguardo all’argomento che rappresenta l’oggetto del presente contributo, è per esempio pacifica l’attribuibibilità della natura giuridica pubblica al Fondo di garanzia PMI, gestito da Cassa Depositi e Prestiti, che fornisce una garanzia per facilitare l’accesso al credito per le piccole medie imprese[9].
La giurisprudenza amministrativa non ha dubbi sulla natura pubblica del Fondo de quo: indici in tal senso sono ricavati, innanzitutto, dalle norme sulla governance dettate dall’art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, art. 147 e dall’art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385[10]. Ulteriori indicazioni circa il carattere pubblicistico del Fondo per le PMI e della relativa garanzia si traggono dal richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel citato art. 13, comma 1, lett. m), del c.d. “decreto liquidità”[11].
L’esempio del Fondo PMI è utile anche per precisare che per “credito pubblico“ (o “finanziamento pubblico”) non si intende soltanto il sostegno finanziario erogato in modo diretto dallo Stato (o da soggetto od Ente avente natura giuridica pubblica): ma anche il sostegno finanziario erogato in modo indiretto, attraverso la prestazione (da parte dello Stato, ovvero del soggetto od Ente avente natura giuridica pubblica) di una garanzia[12] a favore del soggetto finanziatore (non importa se di natura privata, come ad esempio una impresa bancaria od un intermediario finanziario), e nell’interesse del soggetto finanziato. Tale conclusione deve essere confermata non soltanto sotto un profilo tecnico (essendo nota l’appartenenza al fenomeno del sostegno finanziario anche dei cc.dd. “crediti di firma”, rappresentati per l’appunto dalla prestazione di una garanzia in funzione dell’erogazione di un prestito da parte di terzi al soggetto che si intende sostenere finanziariamente), ma anche sotto il profilo giuridico, tanto in termini generali, quanto con specifico riferimento all’argomento che si intende affrontare[13].
In termini generali viene giudicata irrilevante la circostanza che il contratto di finanziamento (“ diretto”) sia concluso con un soggetto privato (in particolare, la banca finanziatrice). La giurisprudenza evidenzia che in questi casi lo Stato assume “una posizione di rischio omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro”, dato che la garanzia pubblica è “presupposto determinante per la concessione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito del rapporto triangolare che lega fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato”[14]. In altri termini, la operazione di finanziamento bancario per il sostegno della impresa in crisi con la garanzia pubblica è stata intesa come la espressione di un collegamento negoziale nell’ambito del Programma statale di ripresa economica perseguito dallo Stato. Infatti, tra i due negozi, l’uno di fonte contrattuale, ma predeterminato dalla legge nei contenuti (contratto di finanziamento con vincolo di scopo) e l’altro di fonte legale (garanzia legale “a prima richiesta” a carico dello Stato), è stato giudicato rinvenibile proprio quel vincolo teleologico che costituisce il presupposto del collegamento negoziale, e da cui discende l’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in tale materia. Nel caso specifico si tratterebbe di un collegamento negoziale c.d. “necessario” costituito ex lege, che non lascia spazio all’autonomia contrattuale per l’individuazione di ulteriori o diversi fini di utilizzo del finanziamento, cristallizzandosi la causa del prestito vincolato nella garanzia statale di fonte legislativa, nel quadro del Programma di ripresa. La natura della garanzia statale “a prima richiesta”, disancorata, cioè, dalle vicende del contratto principale, e giustificata dal fine ultimo della ripresa nazionale, rende, inoltre, il collegamento “unilaterale”, dato che, per definizione, la garanzia non può essere influenzata dalle sorti del contratto di prestito, neppure in termini di validità[15].
Nell’ipotesi di sostegno finanziario diretto, il beneficiario dell’intervento (che nelle fattispecie che andremo considerando qualificheremo “credito pubblico”, ovvero “finanziamento pubblico”) è ovviamente il soggetto finanziato.
Lo stesso deve dirsi nell’ipotesi di sostegno finanziario indiretto: giacché è grazie alla prestazione di garanzia che il soggetto finanziato ottiene il sostegno dal finanziatore, autore del prestito diretto. Indubbiamente, peraltro, anche quest’ultimo può dirsi beneficiario dell’intervento (“pubblico”): nel senso di costituire il destinatario diretto della garanzia prestata dallo Stato, o dal soggetto od Ente dotato di natura giuridica pubblica; nonché il destinatario del pagamento effettuato con risorse “pubbliche“, nell’ipotesi di mancato rimborso del finanziamento e conseguente escussione della garanzia (pubblica).
In conseguenza di quanto sopra rappresentato, l’eventuale “abusività” del ricorso al “credito pubblico” può interessare, in linea di principio, soltanto il soggetto finanziato, nella fattispecie di credito pubblico “diretto”: perché è soltanto costui che può rendersi protagonista della violazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia, ed in particolare l’ammissibilità al sostegno finanziario pubblico. Nelle fattispecie, invece, di credito pubblico “indiretto”, l’eventuale “abusività“ del ricorso al sostegno dello Stato (o equipollente) può riguardare anche il comportamento del soggetto finanziatore (per esempio, la banca): sia in quanto possibile colpevole di una condotta censurabile (nell’esercizio dell’attività propedeutica all’erogazione del finanziamento assistito da garanzia pubblica); sia in quanto possibile complice del soggetto finanziato che si sia reso protagonista di un comportamento abusivo – per avere concorso con lo stesso, nel compimento delle attività poi giudicate abusive – ; sia in quanto possibile reo, per avere posto in essere una attività illecita “in proprio” – per esempio, in funzione della destinazione del finanziamento assistito da garanzia pubblica alla estinzione di crediti pregressi vantati nei confronti del soggetto finanziato, con conseguente sostituzione di una esposizione in ipotesi chirografaria con una esposizione assistita da garanzia pubblica -.
3. “Concessione abusiva di credito” e “ricorso abusivo al credito” (pubblico): una prima possibile manifestazione del fenomeno.
Si è già detto come tra gli argomenti di particolare attualità in campo giuridico, con riguardo all’esercizio dell’attività d’impresa ed al sostegno finanziario dei soggetti che ne sono protagonisti, si segnali il rinnovato interesse per la problematica della “concessione abusiva di credito”: cioè la prestazione di sostegno finanziario a chi non l’avrebbe meritato, con conseguente prolungamento ingiustificato dell’attività d’impresa, e possibile aggravamento del dissesto.
Meno ricorrente risulta l’argomento del “ricorso abusivo al credito”: per quanto difficilmente si comprenda come possano sussistere fattispecie nelle quali al soggetto finanziatore venga imputato di avere concesso credito in modo imprudente, o inopportuno – per la mancanza di meritevolezza del soggetto finanziato -, senza che contemporaneamente (e, anzi, precedentemente) non si imputi al soggetto finanziato di avere fatto ricorso abusivamente al credito, pur senza meritarlo: essendo difficile immaginare che il finanziatore (di norma: una banca) fosse a conoscenza delle difficoltà dell’impresa più di quanto non lo fosse l’imprenditore (che il finanziamento non ha soltanto richiesto, ma anche utilizzato)[16].
Con specifico riferimento al “credito pubblico” l’attenzione all’accertamento dei presupposti per la correttezza del ricorso al sostegno finanziario dello Stato (nella forma diretta della erogazione di finanziamenti al soggetto interessato, ovvero nella forma indiretta di prestazione di garanzie nel suo interesse – ed in favore del soggetto finanziatore -), e quindi alla valutazione della sussistenza dei presupposti per una possibile contestazione di “abusività”, è per lo più rivolta nei confronti dei beneficiari del sostegno finanziario, in quanto destinatari finali dell’agevolazione pubblica.
Nelle fattispecie di “credito pubblico” indiretto, quindi concesso attraverso la prestazione di una garanzia in favore di un soggetto (di norma: un intermediario bancario) finanziatore, la presenza di irregolarità nell’assistenza al soggetto finanziato evoca il fenomeno della “concessione abusiva” di credito, in quanto erogato in un contesto nel quale il credito avrebbe dovuto, invece, essere negato. Non si può escludere a priori che in futuro possa essere presa in considerazione anche l’ipotesi di contestare alla banca finanziatrice una condotta equivalente a quella definita come “ricorso abusivo al credito” (pubblico), nel momento in cui si mettesse sotto accusa (qualora ne risultino i presupposti in fatto) la determinazione della banca nel sostenere finanziariamente il proprio cliente (quasi inducendolo ad abusare della disciplina del sostegno finanziario pubblico alle imprese), allo scopo di trasformare passività pregresse di carattere chirografario in passività attuali assistite da garanzia pubblica (erogando in funzione dell’estinzione delle prime nuove risorse finanziarie assistite dallo Stato o da soggetto od Ente equivalente): il “ricorso abusivo” sarebbe rappresentato dalla illegittima acquisizione, da parte della banca, di una garanzia pubblica prima inesistente.
4. Il “credito pubblico” ai tempi della pandemia da Covid 19.
La crisi sanitaria originata dalla pandemia conosciuta con il nome “Covid 19” creò i presupposti per una crisi anche economica, per affrontare (e possibilmente superare) la quale si fece grande ricorso al fenomeno del “credito pubblico”.
A far tempo dalla fine dell’anno 2019, e poi in modo crescente per tutto l’anno 2020, anche il nostro Paese è stato colpito dalla crisi sanitaria conosciuta con il nome COVID-19[17]. Alla crisi sanitaria è seguita una crisi economica, se non altro per l’iniziale condizione di isolamento alla quale la cittadinanza fu costretta.
Vennero presto in rilievo le conseguenze pregiudizievoli che ciò avrebbe provocato sull’attività delle imprese: ed emerse la necessità di aiuti pubblici per il loro sostegno economico e finanziario.
Ove fosse stata possibile, si sarebbe potuto ricorrere all’erogazione di sostegni finanziari pubblici “a fondo perduto”, o quantomeno rimborsabili nel lungo termine: ma per i Paesi (come l’Italia) presentanti già un forte disavanzo nel settore del “debito pubblico”, la soluzione non sarebbe stata perseguibile.[18] [19]
Fu così individuato il rimedio di favorire l’accesso al credito bancario, in funzione del mantenimento in vita delle imprese (o del maggior numero possibile di esse) per il periodo necessario a conseguire il superamento della “crisi pandemica”: e stante le ovvie incertezze su quando e come ciò sarebbe stato possibile, l’accesso al credito bancario venne agevolato attraverso la prestazione di garanzie pubbliche nell’interesse delle imprese finanziate[20]. In tale contesto, le garanzie complessivamente rilasciate attraverso la SACE sarebbero state considerate “non standardizzate”, e pertanto da contabilizzare, sia nell’indebitamento netto sia nel debito pubblico, solo in caso di effettiva escussione”[21] : al punto da far affermare che “nelle valutazioni ufficiali l’impatto sull’indebitamento netto delle misure contenute nel decreto in esame è nullo nell’immediato”.[22][23]
A livello comunitario nel mese di marzo 2020 la Commissione Europea, preso atto del concreto ed imminente “rischio di recessione” dell’intera Area Euro, intervenne con le Comunicazioni del 13 e del 20 marzo 2020 per dare indicazioni volte a superare gli effetti negativi dei divieti di circolazione e delle chiusure delle attività commerciali imposte dall’emergenza sanitaria su “tutte le imprese di tutti i tipi … (piccole, medie e grandi imprese)” e, conseguentemente, sull’economia degli Stati Membri, ammettendo a tal fine il ricorso alle deroghe previste dal Trattato alle disposizioni generali in tema di “Aiuti di Stato”.
Visto l’art. 107, comma 3, lett. b), del TFUE, – norma secondo la quale “possono considerarsi compatibili con il mercato interno… b) gli aiuti destinati a…. porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro”, – la Commissione Europea ha riconosciuto agli Stati membri la possibilità di incentivare la ripresa economica, dettandone modalità, volte ad assicurare all’economia il “flusso del credito”, con aiuti da destinare non al sistema bancario, ma direttamente alle imprese[24].
La Commissione, in particolare, ha ammesso “aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti”, precisando che “al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze[25].”
Sempre nel mese di marzo 2020, il giorno 11, la Camera dei Deputati dello Stato Italiano autorizzò il Governo ad adottare “misure di carattere straordinario ed urgente che consentano di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-2019”.[26] In tale occasione la Camera evidenziò che “gli assi portanti del provvedimento [volto a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica] sono quattro”, uno dei quali rappresentato dalla esigenza di “assicurare la liquidità [alle imprese]”, allo scopo di evitare che problemi di liquidità potessero compromettere “la solidità economica e finanziaria delle imprese”.[27]
Meno di un mese dopo veniva introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il “decreto liquidità“ (d.l. 8 aprile 2020, n. 23). Tale provvedimento ha riconosciuto una serie di forme di Aiuto di Stato, attivando a tal fine:
- per le piccole e medie imprese, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, di cui all’art. 2, comma 100, a) della legge n. 662/1996, gestito dall’allora Ministero dello sviluppo economico (MISE), oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da cinque banche, e ha previsto che assicurasse ai finanziamenti erogati di importo fino a € 30.000,00 la copertura del 100% (art. 13, del d.l. n. 23/2020); e
- per le grandi imprese, la società assicurativa in house SACE p.a., partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti all’epoca dei fatti (ad oggi, dal MEF), anche in questo caso assicurando copertura al 100%, e disponendo, a sua volta, l’ulteriore copertura del 90%, a carico di un Fondo statale costituito presso il MEF (art. 1, commi 2, lett. f) e art. 1, comma 2, lett. d) n. 1), del d.l. n. 23/2020[28]).
La prestazione di garanzie pubbliche non fu il solo strumento attraverso il quale venne favorito l’accesso delle imprese (in “crisi pandemica”) al credito bancario: si ricorse anche a strumenti rivolti a semplificare ed accelerare i processi funzionali a consentire l’erogazione dei finanziamenti così garantiti, perché lo sforzo posto in essere per il superamento della crisi non si esaurisse nelle “buone intenzioni”. A tale scopo – solo per fornire alcuni esempi -venne stabilito che:
(i) le banche non fossero tenute a segnalare alla Centrale dei Rischi (come ordinariamente avrebbero dovuto fare) le garanzie pubbliche concesse in base alla legge, decreti e provvedimenti normativi, ovvero rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti[29];
(ii) in caso di perfezionamento di “accordi transattivi“ per il pagamento di finanziamenti già segnalati a “sofferenza” attraverso un piano di rimborso rateale, l’importo interessato si configurasse “come un nuovo finanziamento rateale” – cioè come se fosse un finanziamento “normale”, e non il rimborso rateale di un debito inadempiuto -;[30]
(iii) l’art. 1-bis, comma 1, del già menzionato “decreto liquidità” (d.-l. n. 23/2020, come convertito dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40), affermava che “le richieste di nuovi finanziamenti… devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà…. con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) che l’attività di impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;……”; e il comma 5 aggiungeva “fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzie effettuate ai sensi dell’articolo 13”;
(iv) il richiamato articolo 13, alla lettera e) del comma 1, recitava: “sono ammissibili alla garanzia del fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia ……… i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ….”[31];
(v) il comma 1 del medesimo articolo, alla lettera g-bis), recitava: “la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020”;
(vi) il comma 1 del medesimo articolo, alla lettera g-ter), recitava: “la garanzia è altresì concessa … in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono stati oggetto di misure di concessione. ….”;
(vii) il comma 1 del medesimo articolo, alla lettera m), recitava “sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche…. in favore di piccole e medie imprese…. purché tali finanziamenti… abbiano …un importo …comunque non superiore a 30.000 €. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate…… Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ……”;[32]
(viii)“al fine di ridurre i tempi necessari per la concessione dei finanziamenti sono state sospese le procedure di valutazione del merito di credito dei debitori da parte del Medio Credito Centrale che gestisce il Fondo di Garanzia per le PMI e non ne sono state previste per la maggior parte delle garanzie concesse dalla SACE…: in alcuni casi il credito potrebbe affluire ad imprese comunque destinate a non superare la crisi”[33].
5. L’affermazione del principio della ammissibilità del ricorso al “credito pubblico” esclusivamente a seguito dell’accertamento della sussistenza del “merito creditizio”, pena la contestabilità della asserita “concessione abusiva di credito”.
Come è noto, l’attività di (raccolta di risparmio tra il pubblico e) concessione di finanziamenti ha natura di attività di impresa, come le attività economiche “di diritto comune“, ma è altresì oggetto di una disciplina speciale, che prende le mosse già in sede di avvio dell’esercizio dell’attività: esercizio che è subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa (della Banca d’Italia); è accompagnato da una “vigilanza” di varia natura (“informativa”; “regolamentare”; “ispettiva”), regolata da una disciplina settoriale (il Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia – T.U.B. -: d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385); e può essere interrotto anche per ragioni estranee ai risultati economici conseguiti (per “crisi di legalità”, che sono rilevanti ai fini anche della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria a prescindere dai risultati economici dell’Istituto di credito)[34].
Il carattere “speciale” dell’attività esercitata (per la gravità delle conseguenze che un esercizio scorretto può produrre), e la severità della disciplina mirante a garantirne la correttezza – marcatamente più incisiva della corrispondente disciplina dell’esercizio dell’attività d’impresa “di diritto comune”[35] – rappresentano un limite alla iniziativa imprenditoriale che può essere sviluppata nel contesto di un Istituto di credito: un limite che è conosciuto con l’espressione “sana e prudente gestione”, e che nei rapporti con le imprese viene declinato con l’obbligo di una adeguata valutazione del “merito creditizio”.[36]
Gli interessi coinvolti dalla violazione dell’obbligo di subordinare la concessione, o anche il mantenimento, del sostegno finanziario all’impresa all’accertamento del “merito creditizio“ della stessa – intesa come idoneità dell’esercizio della sua attività a garantire il puntuale ed integrale rimborso dei finanziamenti ricevuti – sono molteplici: non soltanto quello dell’ intermediario in quanto tale (che va incontro al rischio di dover registrare la perdita del proprio credito); non soltanto quello di coloro che l’hanno costituito e sostenuto (i soci, trattandosi necessariamente di intermediario costituito nella forma della persona giuridica); ma anche l’interesse di coloro che avessero fatto affidamento sulla presumibile correttezza dell’operato dell’intermediario, e sulla conseguente rilevanza del giudizio positivo dallo stesso riservato all’impresa finanziata (giacché altrimenti non avrebbe dovuto finanziarla!).
Tale fenomeno ha acquistato, secondo un orientamento giurisprudenziale emerso negli ultimi tempi, anche maggiore rilevanza con riguardo al sostegno finanziario delle imprese, colpite da una crisi economica in conseguenza (oppure in contemporaneità) della crisi sanitaria, allorché sia stato fatto ricorso al “credito pubblico” (nella forma, come detto, della richiesta di prestazione di garanzie pubbliche in favore della banca finanziatrice): giacché il coinvolgimento di un interesse di natura pubblica ha indotto ad affermare che la valutazione della sussistenza dei presupposti del regolare integrale rimborso del finanziamento erogato dovesse essere anche più severa dell’ordinario . Si è giunti ad affermare, infatti, che la presenza di una garanzia Statale (o equivalente), come tale dotata di portata generale, avrebbe dovuto indurre le banche, richieste di avvalersene allo scopo di erogare finanziamenti alle imprese anche in situazioni di crisi (pandemica), ancora più prudenti di quello che non avrebbero dovuto essere in mancanza dell’ammissibilità alla garanzia dello Stato[37].
6. Gli effetti civili della “concessione abusiva di credito“ per mancato accertamento del “merito creditizio“: dalla nullità del solo contratto; alla nullità del contratto e della garanzia pubblica; alla sola responsabilità risarcitoria.
Gli effetti della violazione del principio secondo il quale l’erogazione del credito deve essere circoscritta ai soggetti ed alle fattispecie per i quali sussistano i presupposti del “merito creditizio” (sostanzialmente: l’idoneità a rimborsare regolarmente ed integralmente il finanziamento ottenuto) sono stati spesso individuati nella nullità del contratto bancario per contrarietà a norme imperative (principalmente il ricordato art. 5 T.U.B.) – quindi soggetto alla sanzione dell’art. 1418 cod. civ. – ovvero per violazione di disposizioni attinenti all’ordine pubblico e al “buon costume” (economico).
La valutazione dell’applicabilità del primo principio (in via esclusiva), oppure del secondo (anche in combinazione con il primo) comporta importanti conseguenze: giacché nel primo caso permarrebbe comunque il diritto della banca ad ottenere il rimborso delle somme erogate, quantomeno a titolo di ripetizione di indebito (ed oltre a ciò si potrebbe affermare la permanenza delle garanzie originariamente conseguite nell’interesse del soggetto finanziato, particolarmente nelle fattispecie nelle quali la garanzia avesse assunto un contenuto omnibus); mentre nel secondo caso neppure la ripetizione di indebito sarebbe consentita, in forza di quanto disposto dall’art. 2035 cod. civ., secondo il quale “chi ha eseguito la prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buoncostume non può ripetere quanto ha pagato” – e la stessa permanenza delle garanzie eventualmente acquisite, per quanto di natura omnibus, potrebbe seriamente essere messa in discussione –[38].
Se consideriamo le fattispecie rappresentate dall’asserita violazione della norma (giudicata) imperativa concernente la necessaria osservanza della sussistenza del “merito creditizio” con riguardo alle operazioni di finanziamento assistite da garanzia pubblica (“anti-Covid19”) – che rappresenta l’argomento al quale è dedicato il presente contributo – i precedenti inclini a propendere per la tesi più severa sono stati abbastanza numerosi.[39]
Perché si produca l’effetto disposto dall’art. 2035 cod. civ. occorre anche l’accertamento della contrarietà della stipulazione del contratto al “buon costume” (economico): tenendo peraltro presente, a tale proposito, che la nozione di contratto contrario al “buon costume“ si ritiene non essere circoscritta alle fattispecie di negozi che infrangono la regola del pudore sessuale e della decenza, ma si estende anche ai contratti che urtano contro i principi e le esigenze etiche della coscienza collettiva, elevata a livello di morale sociale, in un determinato momento ed ambiente[40].
Nel contesto, che stiamo considerando, della crisi d’impresa, sono state valutate contrarie al “buon costume“ (economico) anche le condotte consistenti nell’erogazione di somme di denaro in favore di imprese già in stato di decozione, con il risultato di consentire all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di “fallimento“, incrementando le passività verso il ceto creditorio: trattasi di condotte che sono state ritenute contrarie alle regole di correttezza che dovrebbero governare le relazioni di mercato, e giudicate caratterizzate dall’approfittamento della situazione di crisi di soggetti economici in dissesto[41].
Non sono mancate peraltro le decisioni che, anche propendendo per l’applicazione della sanzione di nullità del contratto di finanziamento stipulato senza essere preceduto da una adeguata valutazione del merito creditizio dell’impresa finanziata, hanno escluso che ciò impedisse di fare valere una pretesa restitutoria delle somme erogate[42] – e non mancano le opinioni che con specifico riguardo all’argomento che qui interessa escludono che la pur ritenuta nullità del contratto di finanziamento impedisca comunque l’accesso alla garanzia pubblica (per esempio, “anti-Covid19”) –[43]: come pure non sono mancate le decisioni che hanno distinto il profilo della validità/invalidità del contratto (ritenuto comunque valido ed efficace, con tutto ciò che ne consegue per la legittimità della pretesa restitutoria delle somme erogate e dell’azionabilità delle garanzie, private o pubbliche, che ne avessero accompagnata la concessione), dal profilo, teoricamente rappresentabile, dell’insorgenza di una obbligazione risarcitoria per gli effetti pregiudizievoli che il comportamento superficiale e non adeguatamente professionale della banca avesse provocato[44].
Anche la Corte di Cassazione è stata investita sovente della questione: e recentemente è intervenuta a precisare la ratio della portata di propri precedenti, che erano stati addotti a sostegno della tesi più severa, e che invece sono stati dichiarati estranei – anche perché non inerenti l’attività di erogazione del credito – alle valutazioni pertinenti alla espressione di un giudizio sulle conseguenze attribuibili alla “concessione abusiva di credito”, intesa come sostegno finanziario non giustificato da una adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto favorito.
Nell’occasione la Suprema Corte[45] ha precisato che per l’affermazione della nullità del contratto di finanziamento (per contrarietà a principi di ordine pubblico “economico“, con conseguente produzione dell’effetto della c.d. soluti retentio in danno della banca finanziatrice) non è sufficiente la considerazione dell’orientamento (peraltro confermato) in base al quale l’erogazione del credito che sia qualificabile come “abusiva“- in quanto effettuata, con dolo o colpa grave, ad una impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico–finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi –, integra un illecito del soggetto finanziatore. Tale orientamento non viene smentito, nel senso di confermare l’obbligo della banca di adempiere ai doveri primari di una prudente gestione, pena la conseguenza dell’obbligo del risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa da parte del soggetto finanziato[46] [47]. Tuttavia la violazione dell’obbligo in questione non è considerata produttiva nè di una nullità genericamente intesa, nè – si potrebbe dire: tantomeno – di una nullità produttiva dell’effetto del divieto della ripetizione di indebito (e dell’escussione delle garanzie ricevute).[48]
Per giustificare la precisazione del proprio pensiero con riguardo alle conseguenze dell’attribuzione di un carattere “abusivo“ al comportamento della banca finanziatrice la Corte di Cassazione ha sottolineato che le decisioni addotte come precedenti[49] di una ritenuta nullità dei contratti di finanziamento bancari caratterizzati da una ritenuta “abusività” – nel senso di una mancata adeguata osservanza del presupposto del “merito creditizio“ del soggetto finanziato – riguardavano fattispecie (diverse dall’attività finanziaria) caratterizzate “dall’accertamento di peculiari condotte delittuose”, in mancanza delle quali il risultato della nullità del contratto (e della inammissibilità della ripetizione delle somme erogate) non viene ritenuto condivisibile[50] [51].
Successivamente la giurisprudenza di merito ha registrato un adeguamento ai principi affermati dalla Suprema Corte[52].
L’affermazione ovvero l’esclusione della nullità del contratto bancario di finanziamento “viziato” da una inadeguata valutazione del “merito creditizio” del soggetto finanziato (e per tale ragione qualificato “ abusivo”) – salva restando la possibile responsabilità risarcitoria degli effetti pregiudizievoli eventualmente provocati dalla superficialità della banca – condiziona anche la risposta alla domanda concernente l’attribuzione dell’ onere della prova. Le decisioni che hanno propenso per la nullità del contratto hanno altresì affermato che l’onere della prova (di avere sottoposta la richiesta di finanziamento ad una adeguata valutazione della capacità di rimborso del cliente) spetta alla banca finanziatrice[53]: laddove l’affermazione della permanente validità giuridica del contratto, salvo l’accertamento dei presupposti per l’affermazione di una responsabilità risarcitoria in ipotesi di inadeguata valutazione del “merito creditizio” – che anche secondo il riferito orientamento della Suprema Corte appare la soluzione preferibile – conduce all’attribuzione al soggetto preteso danneggiato dell’onere della prova della negligenza dell’istruttoria bancaria[54].
7. Segue. La responsabilità risarcitoria nei confronti del “pubblico“, cioè lo Stato: la sussistenza dei presupposti del “danno erariale”.
Al superamento della “crisi pandemica” non si è sempre accompagnato anche il superamento della “crisi economica”: molte imprese non hanno riacquisito l’equilibrio economico-finanziario nonostante i sostegni ricevuti e nonostante il ritorno ad una condizione di normalità sanitaria.
L’esperienza delle “procedure di crisi” che si sono aperte nei confronti delle imprese che “non ce l’hanno fatta“ ha dimostrato che il privilegio attribuito ai crediti dei garanti pubblici escussi dalle banche sarà pur stato qualificato “super”, ma in realtà non ha sempre comportato il recupero integrale delle risorse impegnate dallo Stato: men che meno lo ha consentito – integrale o parziale che fosse – in tempi accettabili, attesa la durata biblica delle procedure concorsuali liquidative.
Di qui – forse – lo stimolo a ricercare fonti di responsabilità alle quali rivolgersi per tentare di ovviare al danno subito. I potenziali interlocutori sono sempre quelli: o la banca, o l’impresa: e trattandosi di situazioni che postulano che l’impresa sia “fuori gioco” – perché è soltanto nell’ipotesi di incapienza del patrimonio rispetto al super-privilegio erariale che diventa necessario verificare la sussistenza di altre possibili fonti di indennizzo -, l’unico potenziale interlocutore residuo è rappresentato dalla banca.
Il carattere “ pubblico “ della garanzia prestata dallo Stato (o da chi per lui ) in favore dei finanziamenti bancari concessi alle imprese in crisi (nel nostro caso, “pandemica”) ha peraltro autorizzato ad evocare anche il “danno all’interesse pubblico” conosciuto come “danno erariale”: i precedenti noti sono, al momento, relativamente pochi (o forse poco noti): ma non è difficile immaginare che possano moltiplicarsi (ed “emergere”) in un arco di tempo molto contenuto.
Si è già osservato che i finanziamenti assistiti dalle “garanzie pubbliche“ di cui si parla in questa sede (MCC; SACE; Fondo di Garanzia PMI; eccetera) vengono ritenuti riferibili allo Stato nonostante l’erogazione avvenga attraverso un soggetto privato (la banca finanziatrice); e che il beneficiario del sostegno in questione (l’impresa finanziata) viene considerato partecipe della realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito dalla disciplina di volta in volta applicabile ai finanziamenti de quibus – nel caso di specie, il programma di ripresa economica a valle della “crisi pandemica” -.
“Dalla sostanziale riferibilità allo Stato dei finanziamenti erogati attraverso l’istituto di credito privato nonché dalla necessaria partecipazione del beneficiario alla realizzazione del programma di interesse pubblico perseguito (…) discende, in ragione dell’obbligo per il medesimo beneficiario di agire in conformità ai fini pubblici per cui l’erogazione è concessa, la sussistenza di un rapporto di servizio in senso lato e dunque della giurisdizione di questa Corte dei Conti”[55]. Da ciò viene ricavata la conclusione della sussistenza di “un obbligo per il medesimo beneficiario (e per chi interloquisce con lo stesso) di “agire in conformità ai fini pubblici per cui l’erogazione è concessa”.
8. Segue. La giurisdizione della Corte dei Conti e l’applicabilità del giudizio amministrativo.
L’affermazione della sussistenza di un “rapporto di servizio“ tra la banca e lo Stato, nel momento in cui la prima ottiene una garanzia pubblica a sostegno del finanziamento erogato all’impresa, è posta alla base dell’orientamento secondo il quale l’accertamento della correttezza dell’operato dell’Istituto di credito rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti[56].
Nello stesso modo, in materia di accertamento dei presupposti per la reclamabilità di un “danno erariale” si è ormai affermato in modo consolidato l’orientamento che ne attribuisce la cognizione alla giurisdizione del medesimo Giudice[57].
Ciò comporta l’applicabilità della disciplina del giudizio amministrativo deputato ad esaminare l’eventuale sussistenza di danni prodotti all’Erario (d. lgs. 26 agosto 2016, n. 174: “Codice di Giustizia Contabile”). Tale procedimento può prendere le mosse da segnalazioni della Procura della Repubblica a margine delle indagini condotte nell’ambito di procedimenti penali.
Prima di emettere l’atto introduttivo del giudizio (“atto di citazione”) il Pubblico Ministero notifica al presunto responsabile un atto di “Invito a dedurre”, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del ritenuto contributo causale alla realizzazione del danno reclamato, ed è fissato un termine non inferiore a 45 giorni entro il quale il presunto responsabile può esaminare le fonti di prova poste alla base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti. Nell’invito a dedurre, il Pubblico Ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ. Successivamente all’invito a dedurre, il Pubblico Ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.
Nello stesso termine di cui sopra (non oltre 45 giorni) il presunto responsabile può chiedere di essere sentito personalmente (con facoltà di farsi assistere da un difensore): in tal caso l’omessa audizione personale determina l’inammissibilità della citazione. Il Pubblico Ministero fissa il luogo e il giorno dell’audizione (che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito, comunque entro il termine di cui sopra).
Il successivo (eventuale ) atto di citazione in giudizio deve essere depositato dal Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno.
9. Segue. La quantificazione del “danno erariale“.
Come si è detto, il credito dello “erario” in conseguenza della escussione della garanzia “pubblica“ prestata in favore della banca a fronte del finanziamento concesso a una impresa in crisi (nel caso, ” pandemica”), ha carattere “super privilegiato”: è pertanto possibile che sia rimborsato integralmente.
Il rimborso integrale non è ovviamente sempre assicurato: e, come si è detto, potrebbe essere in ogni caso ritardato nella tempistica.
Dal chè se ne potrebbe ricavare la valutazione che il “danno erariale”, provocato dall’escussione di una garanzia pubblica illegittimamente ottenuta a sostegno di un finanziamento indebitamente erogato ad una impresa priva di “merito creditizio”, debba essere commisurato all’importo non soddisfatto in sede liquidativa, ovvero al pregiudizio finanziario (interessi) connesso al ritardato soddisfacimento.
Nello stesso modo si dovrebbe poter dedurre che l’ammontare del “danno erariale”, provocato dall’originario inadempimento dell’impresa finanziata, debba essere ridotto dei pagamenti ovvero dei recuperi ottenuti dalla banca nell’attività di esazione del credito.
Si dovrebbe altresì potere dedurre che nessun danno sussista ancora, fino a quando la garanzia pubblica non è stata escussa – perché il finanziamento è in regolare ammortamento secondo il piano di rateizzazione che lo caratterizza -.
A maggior ragione si dovrebbe altresì potere dedurre che nessun danno sussista più, se il finanziamento assistito da garanzia pubblica è stato integralmente rimborsato.
Tutte le conclusioni sopra rappresentate sono errate, alla luce della attuale giurisprudenza amministrativa: l’ultima (rappresentata da una pretesa risarcitoria dello Stato fatta valere nei confronti di una banca il cui credito sia stato integralmente rimborsato dall’impresa finanziata) non presenta, al momento, precedenti conosciuti, ma è perfettamente coerente con gli orientamenti che hanno dichiarato la erroneità delle conclusioni precedenti (irrilevanza della mancanza di inadempimenti; irrilevanza della riduzione successiva del credito soddisfatto)[58].
Il “danno erariale”, nel caso di specie, è commisurato all’importo della garanzia ottenuta dalla banca a sostegno del finanziamento erogato all’impresa “in crisi”, in quanto la sua prestazione ha prodotto l’effetto di “impegnare“ il plafond deliberato dalle autorità politiche competenti a servizio del progetto di sostegno dell’economia nazionale aggredita dalla crisi sanitaria[59], in tal modo – idealmente – impedendone l’utilizzo, per corrispondente importo, per una diversa impresa, che avrebbe potuto rivelarsi meritevole di ottenerlo, ma per la quale non vi fosse stata la necessaria provvista finanziaria. Il concetto non risulta espresso esattamente in questi termini, ma è l’unico modo attraverso quale dare giustificazione (logica, se non giuridica) alle decisioni della giurisprudenza amministrativa che, come detto, non tengono in considerazione l’eventualità che nessun danno ancora si sia prodotto – perché il finanziamento è regolarmente in ammortamento -; nè che il danno sia destinato ridursi – per il recupero del credito conseguito dalla banca -.
Il pregiudizio patrimoniale si ritiene integralmente verificato in tutte le sue componenti allorché la somma erogata è stata utilizzata in modo diverso e/o distorsivo rispetto a quello pubblico programmato. Questo orientamento sostiene che “in tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione”[60].
In altri termini, il danno erariale viene considerato certo ed attuale se sussiste al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell’attività recuperatoria dell’Amministrazione danneggiata[61].
Nel contesto sopra rappresentato può rivestire un particolare interesse la fattispecie nella quale l’illecito contestato all’impresa finanziata con l’aiuto pubblico preceda l’accertamento dell’effettivo ricorso alla garanzia statale[62]. Infatti la restituzione rateizzata, contrattualmente pattuita con la banca a norma di legge, da operarsi a partire da “non prima di 30 mesi dalla data del finanziamento” e in numero di “fino a 120 rate” (art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23/2020), costituisce adempimento ad uno degli obblighi contrattualmente assunti dall’impresa finanziata nei confronti della banca, insieme a quello di utilizzare le somme percepite per i fini di pubblico interesse indicati nel contratto, volti alla ripresa economica. Dato che detta restituzione si pone in una fase anche temporalmente successiva al perfezionamento del danno al “Programma di Risanamento Economico”, che viene individuato – come detto – già solo nella indebita percezione dell’aiuto pubblico (“di firma”), potrebbe considerarsi irrilevante il successivo adempimento o meno dell’obbligo restitutorio del finanziamento percepito. Se è la percezione (o l’erogazione; o entrambe) del “finanziamento pubblico” in mancanza dei presupposti di legge, a formare oggetto del danno all’erario, per lesione del “Programma di ripresa”, ci si deve chiedere se anche l’ulteriore inadempimento dell’obbligazione di restituzione del finanziamento ottenuto costituisca un danno allo Stato, e se tale danno vada a coincidere, almeno per la quota parte quantificata in via equitativa in base al criterio dell’importo erogato, con quello al “Programma di ripresa”, o sia da questo diverso e ulteriore.
La giurisprudenza ha ritenuto di ravvisare detta coincidenza parziale, nei limiti dell’importo erogato utilizzato per la quantificazione equitativa del danno al Programma, con conseguente rilevanza dell’eventuale pagamento dei ratei restitutori del mutuo nella sede dell’esecuzione della condanna, ai fini, se del caso, del loro scomputo dal totale dovuto a titolo di risarcimento del danno erariale. In tali fattispecie la giurisprudenza ha ritenuto che la valorizzazione dell’operazione in senso unitario non possa che coinvolgere l’interezza dei rapporti negozialmente collegati tra impresa, banca e Stato, ivi comprendendo anche il momento della restituzione dei ratei, “a pena di una sua del tutto aporistica considerazione in senso atomistico e residuale, atta a circoscrivere tale momento alla sola relazione contrattuale dell’imprenditore con il soggetto finanziatore, in contrasto con la logica interpretativa adottata”[63].
Per converso la giurisdizione amministrativa ha escluso la possibilità di ritenere la mancata restituzione dei ratei come danno ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello alla lesione del “Programma di ripresa”, in quanto produttiva di un depauperamento dello Stato in termini di pagamento, a favore della banca, della garanzia escussa[64]. A tale proposito la giurisprudenza ha considerato che come l’interpretazione in chiave sostanziale dell’operazione, nella sua unitarietà, deve fare propendere per la natura pubblica del finanziamento, quasi che fosse erogato direttamente dallo Stato garante, così la mancata restituzione dei ratei deve essere intesa come mancata restituzione di un finanziamento pubblico.
La conclusione alla quale la citata giurisprudenza è pervenuta è rappresentata dalla considerazione che, da un lato, il danno all’erario, inteso come vulnus al “Programma di ripresa”[65], riferito all’erogazione indebita di un finanziamento pubblico, o allo sviamento delle risorse rispetto al fine prefissato, ben può dirsi perfezionato al momento dell’erogazione dei fondi (indebiti) da parte della banca (o della loro distrazione); dall’altro lato, la mancata restituzione (rateizzata) di tali fondi (alla banca) altro non è che mancata restitutio in integrum a favore del soggetto leso (Stato) per quella parte del danno che può quantificarsi, seppure in via equitativa e parziale, sulla base del criterio dell’importo indebitamente ricevuto. Da ciò è stata fatta discendere la conseguenza che in mancanza di versamento dei ratei restitutori la condanna debba essere eseguita per l’intero importo quantificato in via equitativa, comprensivo del valore del finanziamento erogato che ne costituisce il minimo calcolabile, non essendosi verificata la restitutio in integrum a favore dello Stato danneggiato. Per converso, ove i ratei siano stati anche in parte versati, per la medesima parte si dovrebbe intendere iniziata la restitutio, con conseguente necessità di scomputarne il corrispondente importo dal quantum di cui alla condanna[66].
Rimane tuttavia il dubbio legato alla considerazione che l’indebito utilizzo di risorse destinate ad uno scopo pubblico, e di entità necessariamente limitata[67], per uno scopo difforme da quello che giustificherebbe il ricorso alle stesse, ingenera il pericolo della privazione delle stesse da parte di chi ne sarebbe invece meritevole: donde, probabilmente, la ragione della affermazione del principio generale, della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la quantificazione del danno provocato con la “concessione abusiva di credito” di cui si sta discorrendo dovrebbe essere determinata in via equitativa: salvo prendere atto che l’unico criterio applicato risulta quello corrispondente all’importo della garanzia pubblica indebitamente attivata.
10. Segue. I soggetti responsabili del “danno erariale”.
La natura del “danno erariale” comporta l’attribuibilità della responsabilità relativa non soltanto agli “enti” al patrimonio dei quali sia imputabile l’indebito arricchimento (in particolare la società di capitali interessata, banca finanziatrice o impresa finanziata che essa sia), bensì anche alle persone fisiche che abbiano agito per l’ente.
A tale proposito la giurisprudenza amministrativa spiega che poiché l’impresa beneficiaria di un “finanziamento pubblico” concorre alla realizzazione del programma della Pubblica Amministrazione – volto al sostegno delle imprese in difficoltà economica e finanziaria -, instaurando con questa un “rapporto di servizio”, la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico, “ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati“[68]. Pertanto, il “rapporto di servizio” e la conseguente giurisdizione contabile devono ritenersi estese anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche, comunque incidendo sulla realizzazione del programma, così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso del privato[69]. Le persone giuridiche, infatti, sono ritenute, nel caso di specie, “soggetti inerti”, ai quali non possono riferirsi gli elementi soggettivi tipici ed indispensabili della responsabilità, come configurata dall’art. 1 della n. 20/1994: le persone giuridiche rispondono oggettivamente, con il loro patrimonio, per il fatto (dannoso) dei propri gestori, ai quali deve imputarsi l’attività gestoria illecita come configurata dalla norma e che deve essere accertata, affinché possa aggredirsi il patrimonio della persona giuridica, altrimenti questa aggressione sarebbe senza titolo. In altri termini, la responsabilità patrimoniale-contabile a carico di una persona giuridica postula sempre l’accertamento di condotte illecite imputabili a persone fisiche[70].
Conformemente, in tale senso, la Cassazione ha affermato che, “ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico – che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico – bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che, qualora l’amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla realizzazione del quale esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento delle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile”[71].
In un recente caso, nel quale l’impresa aveva ottenuto un finanziamento garantito da SACE per 2, 6 milioni circa[72], la “scure pubblica“ si è abbattuta sul direttore (anzi: la direttrice) finanziario dell’impresa interessata in via personale. In un contesto nel quale la società italiana era stata vittima di un “dissesto di gruppo”, originato dal default della capogruppo francese-cinese, provocato da fattori principalmente esogeni (“aumento della concorrenza da parte di altri gruppi e dell’e-commerce, contrazione del mercato dell’abbigliamento per bambini dovuto al calo delle nascite e al contemporaneo sviluppo del mercato dell’usato, perdite di alcune licenze su alcuni marchi importanti (Levi’s e Esprit), mobilitazioni sociali verificatesi in Francia nel 2019….”), al momento della conclusione (non positiva ) del procedimento di redressement judiciaire che era stato aperto in Francia su tutto il Gruppo, la direzione finanziaria aveva dato disposizione di effettuare alcuni pagamenti:
(i) ai consulenti che l’avevano assistita nelle controversie legali relative a questioni sindacali sorte a causa dei licenziamenti collettivi originariamente programmati per la ripresa della società (per oltre il 15%);
(ii) relativi a debiti tributari e previdenziali verso l’erario, l’Inps, le Regioni e gli Enti locali (per oltre il 60%),
ed aveva conservato il residuo (oltre 600.000,00 euro).
La Procura Regionale contesta l’utilizzo del finanziamento pubblico in quanto incoerente con lo “scopo legale“ ad esso dichiaratamente sotteso, del perseguimento dell’obiettivo della “ripresa economica perseguito dallo Stato con il Decreto Liquidità”. Essa osserva che i finanziamenti garantiti ai sensi del d.-l. n. 23/2020 “sono stati assoggettati a un vincolo di destinazione stabilito dal legislatore in maniera puntuale, da individuarsi nel pagamento dei costi di personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, per investimenti o per il sostegno al capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, con lo scopo ultimo di stimolare la ripresa dell’economia nazionale”. I pagamenti effettuati dall’impresa, per quanto rivolti al soddisfacimento di crediti meritevoli di considerazione (per lo più crediti altrettanto pubblici, come l’Erario, l’Inps, gli Enti locali, eccetera), per il momento in cui erano stati posti in essere (il mancato conseguimento della ristrutturazione “di gruppo”) “non possono essere considerati come finalizzati al sostegno del regolare svolgimento dell’attività economica”: di qui la individuazione di un “danno erariale“ direttamente e personalmente in capo al manager responsabile della gestione finanziaria.
Quanto alla quantificazione del danno cagionato all’erario, la Procura Regionale non ritiene che essa debba essere identificata nella “diminuzione del patrimonio dello Stato legata all’erogazione pecuniaria a valere sul fondo del MEF, poiché questa si verifica solo in via eventuale, in caso di escussione della garanzia” – nonché, bisogna aggiungere, in caso di mancato successo del regresso assistito da “super-privilegio“ -, “quanto piuttosto dal vulnus inferto al programma statale di ripresa economica che, in questo caso, costituisce il vero e proprio bene giuridico ritenuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento”[73]. Tale danno, secondo la Procura Regionale, “ è suscettibile di valutazione economica nella misura della quota parte del mancato apporto alla ripresa che ci si poteva ragionevolmente attendere dal corretto utilizzo del finanziamento” da parte della impresa interessata: in conseguenza “si ritiene applicabile una quantificazione in via equitativa del danno, dato che l’inutile esborso di fondi a garanzia pubblica è dannoso per il pubblico erario, con negativi riverberi su tutto il programma da realizzare e, quindi, con riflessi valoriali negativi che vanno ben oltre i margini meramente finanziari del contributo ricevuto”[74]. Ciò precisato; ed ammesso che “risulta complesso tradurre tale mancato apporto al programma [di risanamento economico nazionale] in una quantificazione di danno esatta”; la Procura Regionale opta per la richiesta di risarcimento di un “danno erariale” pari “all’intero importo del finanziamento ottenuto dall’impresa, coperto dalla garanzia statale”: vale a dire, nel caso di specie, 2, 6 milioni di euro, benché oltre 600.000,00 euro non fossero stati spesi (!); e benché l’attivazione del “super- privilegio“ mobiliare potesse comportare il recupero dell’intera differenza di 2,0 milioni (!!).
La prima reazione sarebbe quella di obiettare che male ha fatto il direttore (anzi, la direttrice) finanziario dell’impresa a restituire i 600.000,00 euro non utilizzati allo Stato, perché forse tanto valeva intascarli…!: la sanzione sarebbe stata identica!
In un caso ancora più recente, che ha interessato proprio l’attività di una banca finanziatrice intervenuta a sostenere una impresa colpita da “crisi pandemica”, l’accertato carattere truffaldino della rappresentazione della condizione nella quale l’impresa versava (gli esponenti aziendali sono stati tutti rinviati a giudizio per bancarotta, essendo stati accusati di avere presentato “bilanci relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 del tutto fasulli, in quanto rappresentanti un giro d’affari multimilionario del tutto inventato, ma che serviva per indurre i fornitori a ritenere di avere a che fare con soggetti affidabili e quindi degni di credito e per ottenere dalla banca il prestito garantito”), e la intervenuta presentazione dell’impresa interessata da parte di 1 mediatore creditizio locale regolarmente iscritto, ai sensi dell’art. 128-sexies TUB e del d. lgs. n. 141/2010, nell’elenco tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) – ed unanimemente giudicato “al di sopra di ogni sospetto” (tanto che il relativo responsabile ricopre la carica di Sindaco in una città limitrofa) -, non sono stati giudicati sufficienti da parte della Procura Regionale competente ad escludere la Banca dall’accusa di concorso nel “danno erariale” prodotto allo Stato in conseguenza della escussione della garanzia pubblica prestata da MCC nell’interesse dell’impresa-fantasma.
L’operato della banca era ovviamente riferibile alla condotta delle persone fisiche (dipendenti; dirigenti; professionisti) che erano state interessate dalla richiesta di finanziamento da parte dell’impresa presentata dal mediatore creditizio locale, e che avevano proceduto dapprima alla istruttoria della pratica di finanziamento, e successivamente alla sua deliberazione, a seguito di un esito positivo del “merito creditizio” (stante a quanto rappresentato dall’impresa e dal mediatore).
La pretesa risarcitoria fatta valere dalla Procura Regionale interessata non ha coinvolto le persone fisiche perché ha ritenuto che le stesse avessero agito nell’interesse della banca, in un’ottica di cd. policy aziendale. Ora, ciò che rileva non è tanto la ragione per la quale non si è proceduto al coinvolgimento anche delle persone fisiche, bensì la circostanza che seguendo il ragionamento della Procura Regionale la attribuibilità del danno provocato (e corrispondentemente del lucro conseguito) ad un soggetto dotato di una personalità giuridica “piena” non avrebbe impedito, di per sé, di estendere la contestazione della pretesa risarcitoria anche alle persone fisiche che avevano agito nel suo interesse (come proprio avvenuto, invece, nel precedente sopra citato).
11. La qualificabilità delle operazione di “credito pubblico” (funzionali a sostenere le imprese al momento della “crisi pandemica”) come “mutui di scopo”, e come tali postulanti il controllo dell’effettiva destinazione delle somme erogate.
La “abusività“ del ricorso al “credito pubblico” è stata individuata dalla giurisprudenza in almeno due direzioni:
- la concessione a chi non lo avrebbe meritato;
- l’improprio utilizzo, anche da parte di chi lo avrebbe meritato.
Sotto il primo profilo, come detto, alle imprese e alle banche è stato contestato, in molte situazioni, rispettivamente, di non essere stata in possesso, e di non avere accertata la sussistenza, di adeguato “merito creditizio“ (mentre tale requisito viene considerato necessario dalla giurisprudenza – amministrativa -).
Sotto il secondo profilo alle imprese è stato sovente contestato di avere utilizzato in modo improprio il sostegno finanziario ricevuto, pur in presenza di un originario “merito creditizio” che ne aveva giustificato l’erogazione.
La ragione di tale contestazione è stata fondata sull’attribuzione ai finanziamenti della specie della natura giuridica di “mutuo di scopo”: vale a dire, di contratti la cui causa giuridica deve essere individuata non soltanto nella generica consegna di una somma di danaro accompagnata dall’assunzione dell’obbligo della sua restituzione, bensì nell’assunzione dell’obbligo di assegnare a quanto ottenuto una destinazione precisata[75].
È stato affermato, in particolare, che i finanziamenti garantiti ai sensi del d.l. n. 23/2020 sono stati assoggettati a “vincolo di destinazione” in funzione della conservazione e ripresa del tessuto economico nazionale, tanto che per quelli a copertura SACE il legislatore nazionale ha indicato in modo puntuale il loro possibile uso unicamente per “costi di personale”, “canoni di locazione” o per “affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante” impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, sempreché localizzati in Italia, con impegno delle imprese a non delocalizzare le produzioni[76].
Seppure in mancanza di una simile analitica indicazione, anche le garanzie del Fondo PMI sono state intese come “vincolate”, quanto meno in via indicativa, a tali linee di utilizzo, dovendosi escludere la compatibilità con i fini di ripresa economica, che le hanno giustificate, di una loro destinazione a scopi a questi estranei[77].
Da ciò la domanda se nell’attività connessa alla concessione del “credito pubblico” di cui siamo discorrendo debba ritenersi compresa, per quanto riguarda l’operato della banca, non soltanto la pretesa verifica della sussistenza di un adeguato “merito creditizio“ da parte dell’impresa finanziata: ma anche il successivo controllo della coerenza della destinazione delle somme erogate con l’obiettivo sotteso alla previsione dell’intervento pubblico: come sarebbe, per esempio, in particolare, per quanto riguarda l’utilizzo dei “finanziamenti SACE”, per quanto sopra rappresentato.
L’argomento non pare risultare oggetto di specifiche prese di posizione da parte della giurisprudenza (amministrativa): ma si deve ritenere probabile che, investiti dell’argomento, i Tribunali confermerebbero la natura giuridica di “mutuo di scopo” della forma di “credito pubblico“ di cui siamo discorrendo, con conseguente affermazione della responsabilità della banca finanziatrice nell’ipotesi di mancato controllo della corretta destinazione delle somme erogate.
12. Il riconoscimento, “di fatto”, dell’alternatività della “garanzia pubblica” rispetto alla sussistenza della “garanzia ordinaria”.
L’esame delle fattispecie che hanno costituito l’oggetto della ricordata giurisprudenza, e la considerazione delle valutazioni “in fatto” che accompagnavano la descrizione delle situazioni nell’ambito delle quali si era proceduto a concedere sostegno finanziario assistito da garanzie pubbliche, dimostrano la insanabile contraddittorietà tra “fatto“ (per come viene ammesso nella ricostruzione delle vicende sottoposte alla valutazione giudiziale) e “diritto” (per come è stato rappresentato, in termini generali, a proposito dell’individuazione dei presupposti per la legittimità della concessione del predetto sostegno).
Sono infatti diffusissime le affermazione secondo le quali “in mancanza della garanzia pubblica il finanziamento non sarebbe stato concesso”: ciò che, come si è detto, si rivela insanabilmente contraddittorio con la pretesa che l’erogazione del “credito pubblico” fosse condizionata all’accertamento della sussistenza di un adeguato “merito creditizio” dell’impresa finanziata.
Nell’esaminare le caratteristiche della situazione venutasi a creare a seguito della “crisi sanitaria“, è stato rappresentato come lo Stato avesse adottato un Programma pubblico di ripresa dell’economica nazionale, sostenuto per legge, nell’ambito del regime derogatorio degli Aiuti di Stato, a mezzo di una garanzia pubblica “a prima richiesta“, a copertura di contratti di finanziamento stipulati tra imprenditore banche, “con assunzione integrale su di sé, da parte dello Stato, del rischio di impresa della banca per l’(eventuale) mancata restituzione dei ratei di prestito anticipati”[78].
13. La configurabilità dei presupposti per la contestazione della “concessione abusiva di credito” (pubblico) nella sola ipotesi di sostegno finanziario all’impresa in crisi irreversibile.
Chi ha operato, nel periodo interessato dalla crisi pandemica, all’interno delle imprese bancarie, o chi ha collaborato con coloro che rivestivano ruoli nell’ambito dei “servizi-credito”, ricorderà molto bene le pressioni derivanti da innumerevoli fronti, tese a velocizzare ed assicurare il sostegno bancario alle imprese in crisi. Ma non è questo il versante sul quale si vuole sviluppare la discussione. La discussione deve rimanere collocata nella sede che le è opportuna, e cioè quella della valutazione della correttezza dell’operato delle banche in quel momento ed in quelle situazioni.
Un esame oggettivo del contesto normativo e regolamentare che ha caratterizzato la concessione del credito bancario nel momento dello sviluppo della “crisi pandemica” conduce al conseguimento dei seguenti risultati interpretativi:
(i) era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato, anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice: e ciò alla sola condizione che all’impresa finanziata “rimanesse” un 10% (poi portato al 25%) del finanziamento erogato;
(ii) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice), anche alle imprese già versanti in una situazione critica di dubbia superabilità (“inadempienze probabili; esposizioni scadute e e/o sconfinanti; esposizioni deteriorate”), le cui difficoltà fossero dovute probabilmente (ma senza che ciò dovesse essere provato) alla “crisi pandemica” (doveva trattarsi di una classificazione negativa attribuita all’impresa soltanto successivamente al 31 gennaio 2020);
(iii) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche lo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice), anche alle imprese già versanti in una situazione critica di dubbia superabilità (“inadempienze probabili; esposizioni scadute e e/o sconfinanti; esposizioni deteriorate”), le cui difficoltà non fossero dovute certamente alla “crisi pandemica”, ma ad una crisi di marca esclusivamente aziendale (“inadempienze probabili; esposizioni scadute e e/o sconfinanti; esposizioni deteriorate”, classificate tali dalla banca “prima del 31 gennaio 2020” – quando la pandemia neppure si sapeva cosa fosse -);
(iv) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice; ed anche laddove si trattasse di imprese già classificate come “inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti, esposizioni deteriorate”; ed anche qualora la crisi economica non fosse certamente dovuta alla “crisi pandemica” – perché emersa prima della manifestazione della pandemia -), senza l’intervento di una verifica valutativa da parte del garante pubblico, che venne sospesa[79];
(v) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice; ed anche laddove si trattasse di imprese già classificate come “inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti, esposizioni deteriorate”; ed anche qualora la crisi economica non fosse certamente dovuta alla “crisi pandemica” – perché emersa prima della manifestazione della pandemia -), automaticamente, nel caso di finanziamenti non superiori a 30.000,00 euro – art. 13, co. 1, lett. m) -;
(vi) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice; ed anche laddove si trattasse di imprese già classificate come “inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti, esposizioni deteriorate”; ed anche qualora la crisi economica non fosse certamente dovuta alla “crisi pandemica” – perché emersa prima della manifestazione della pandemia -), omettendo di segnalare la presenza delle garanzie pubbliche (quindi la circostanza che l’impresa finanziata versava per definizione in uno stato di crisi) nella Centrale dei Rischi[80];
(vii) fermo restando quanto sopra precisato, era lecita la concessione di credito, in funzione dell’ammissione dello stesso alla garanzia pubblica dello Stato (ed anche allo scopo di ripianare precedenti passività della banca finanziatrice; ed anche laddove si trattasse di imprese già classificate come “inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti, esposizioni deteriorate”; ed anche qualora la crisi economica non fosse certamente dovuta alla “crisi pandemica” – perché emersa prima della manifestazione della pandemia -), alla sola condizione che la banca svolgesse una “verifica formale di quanto dichiarato… dal titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente ..” con una “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà…” con la quale dichiarare “che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi” (art. 1-bis, comma 1, d.-l. n. 223/2020, applicabile “anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuata ai sensi dell’articolo 13” – finanziamenti in funzione del “rientro” da passività pregresse -): attenzione: la norma proseguiva dichiarando: “per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva ……. il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato” dall’impresa finanziata (art. 1-bis, comma 5, d.-l. n. 223/2020, applicabile “anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuata ai sensi dell’articolo 13” – finanziamenti in funzione del “rientro” da passività pregresse -)[81].
L’argomento trattato da ultimo merita particolare interesse non soltanto per il suo contenuto oggettivo, quanto anche – quasi soprattutto – per l’origine della disciplina da cui risulta interessato:
(i) 8 aprile 2020
viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il ”Decreto Liquidità” (n. 23/2020). In tale sede, l’articolo 1 dettava la disciplina delle “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese “; seguiva l’articolo 2 dedicato alle “Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese”;
(ii) 27 aprile 2020
viene audito dalle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati il Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia. Questi osservava che “Un altro tema importante riguarda(va) la rapidità di attuazione delle norme ..”, ed osservava che il decreto-legge “non esclude(va) la possibilità di una valutazione di merito da parte dei finanziatori”, che ovviamente era causa di ritardi pregiudizievoli. Riferiva che ”a questo proposito le banche hanno adottato prassi eterogenee: alcune erogano il finanziamento dopo aver effettuato un riscontro formale della completezza della documentazione prevista; altre hanno definito anche un processo, più o meno semplificato, per la valutazione del merito di credito della clientela. La necessità di effettuare e documentare una valutazione di questo tipo viene motivata dalle banche con il rischio legale di incorrere in reati connessi con una anomala erogazione del credito (rischio che è in relazione inversa con il merito di credito nel debitore)”. Aggiungeva che a suo avviso “la questione richiede(va) di individuare un equilibrio tra due opposte esigenze, quella di fare affluire le risorse con rapidità alle imprese che ne hanno bisogno, e quella di tutelare lo Stato, evitando che le garanzie vadano a coprire prestiti ad elevatissimo rischio di non essere onorati”. Proponeva allora una soluzione: “Per attenuare il problema si potrebbe fare leva su una maggiore responsabilizzazione del potenziale prenditore, utilizzando l’autocertificazione per attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento. Rendendo più chiari i presupposti e riducendo quindi gli ambiti di discrezionalità dei soggetti finanziatori si velocizzerebbe il processo di erogazione, arginando il rischio legale per la banca”.
Detto fatto!
(iii) aprile-maggio 2020
viene convertito in legge il decreto n. 23/2020.
L’articolo 1 non è più seguito dall’articolo 2.
Viene inserito fra le due norme l’articolo 1-bis, che al primo comma recita: “Le richieste di nuovi finanziamenti.. devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà…. con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara …. che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi”; ed al quinto comma precisa: “… Per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato”.
La conclusione alla quale conduce l’esame oggettivo del testo normativo è evidente:
(i) ci si trova di fronte a una situazione assolutamente emergenziale;
(ii) si dovevano convincere le banche a finanziare imprese in oggettivo stato di crisi (anche per cause diverse dall’infezione pandemica!);
(iii) si riteneva (giustamente) insufficiente la prestazione di una garanzia pubblica fino al 90% del finanziamento, se non fino al 100%: rimaneva ferma la preoccupazione del “rischio legale di incorrere in reati connessi con una anomala erogazione del credito”;
(iv) si mirava a conseguire l’obiettivo di “evitare che le garanzie vadano a coprire prestiti a elevatissimo rischio di non essere onorati”: considerando quindi accettabile la prospettiva di un rischio di inadempimento soltanto “elevato”.
In questo modo, all’inizio del mese di giugno dell’anno 2020, una indagine condotta “presso un campione di banche” (quindi: non tutte le banche, ma soltanto “un campione”) evidenziava che “alla data del 5 giugno[82] queste ultime (il campione di banche intervistate) avevano ricevuto circa 850.000 domande di finanziamento con garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI…. per un controvalore di circa 55 miliardi di euro. Circa il 62% delle richieste ha dato origine all’erogazione di finanziamenti a quella stessa data. La lavorazione delle domande richiede, come minimo, oltre la verifica formale dei requisiti di ammissibilità, la presentazione della domanda di filo da parte del richiedente”. Protagonista dell’indagine era stata la Banca d’Italia[83]: che non si era minimamente scandalizzata per la circostanza che i finanziamenti venissero erogati sulla base di una “verifica formale dei requisiti di ammissibilità” – perché ai minorenni non si possono concedere finanziamenti! -, integrata dalla “domanda di fido da parte del richiedente” – perché non si danno soldi a chi non li ha domandati! -.
Tutto ciò dimostra che la verifica del “merito creditizio“ dell’impresa colpita da una crisi economica derivante dall’incipiente “crisi pandemica” (o, addirittura, da una crisi economica manifestatasi precedentemente – “beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate …. e che sono state oggetto di misure di concessione “: art. 13, co. 1, lett. g-ter) d.-l. n. 23/2020 – ) non avrebbe potuto esprimersi, come avviene in momenti storici diversi da quelli “emergenziali“, attraverso la valutazione della capacità di rimborso del finanziamento concesso: giacché tale valutazione postula la ragionevole previsione di eventi – la presumibile durata della crisi; il presumibile andamento del mercato di riferimento; – che in tempo di “ crisi emergenziali” sono semplicemente imprevedibili. Nella primavera del 2020, chi avrebbe potuto ragionevolmente prevedere quando sarebbero cessati gli effetti della pandemia incipiente? E in quale condizione sarebbe stato ridotto il mercato di operatività delle singole imprese finanziate?
Il criterio di riferimento per la valutazione della censurabilità del sostegno finanziario alle imprese colpite da “crisi pandemica” – o la cui già emersa situazione di crisi si trovasse ad essere aggravata dalla sopravvenuta “crisi pandemica” – poteva essere costituito esclusivamente dal giudizio di irreversibilità assoluta della crisi: solo in quell’ipotesi il finanziamento erogato nell’oggettiva consapevolezza della sua inutilità aziendale, e produttivo dell’unico risultato dell’ abbattimento della precedente esposizione della banca finanziatrice avrebbe meritato (e meriterebbe tuttora) la censura della condotta “abusiva“ e l’affermazione della conseguente responsabilità risarcitoria.
Per una impresa che sia già stata classificata dalla Banca a come “inadempienza probabile “; o come “esposizione scaduta e/o sconfinante”; o ancora “deteriorata”, e per cause neppure direttamente riferibili alla “crisi pandemica“ (per essere stata attribuita la classificazione negativa in data anteriore al 31 gennaio 2020) la valutazione di “merito creditizio “ è in re ipsa: ed è irrimediabilmente negativa. Tanto più se a quell’impresa la banca si accinge a concedere credito per un importo appena appena superiore (10% all’inizio; successivamente 25% ) a quello che le è necessario per “rientrare” da un finanziamento precedente non rimborsato: circostanza che può legittimamente rappresentare anche la principale (ma non esclusiva: infra) ragione del perfezionamento dell’operazione – importando al legislatore che in ogni caso l’impresa fosse “mantenuta in piedi“, nella speranza del superamento della “crisi pandemica”, dovendosi senz’altro preferire una economia sorretta con le stampelle (finanziarie) piuttosto che una economia definitivamente abbattuta -.
Nella situazione descritta il discrimen tra concessione “abusiva” – e come tale illecita -, e concessione “protetta” – e però pienamente lecita – doveva e deve essere individuato nel giudizio di irreversibilità della condizione di crisi. Solamente in presenza di una impresa “defunta” l’erogazione di credito non sarebbe stata meritevole dell’assistenza della garanzia pubblica: ovviamente, tanto più nelle situazioni nelle quali l’operazione fosse stata funzionale a consentire alla banca di conseguire un “rientro“ da precedenti finanziamenti divenuti ormai irrecuperabili[84].
14. Gli effetti penali della “concessione abusiva di credito“. I presupposti del concorso della banca nel reato di bancarotta e nel reato di malversazione di erogazioni pubbliche.
L’asserito carattere “abusivo” dell’erogazione del credito da parte della banca, in conseguenza di una inadeguata valutazione del merito creditizio del cliente, è stato talora considerato anche come presupposto di concorso nel reato commesso dal soggetto finanziato (bancarotta: di norma nella versione della “bancarotta semplice” per ritardata apertura del concorso “fallimentare“) a carico (della banca finanziatrice, ma più precisamente) dei dipendenti dell’istituto bancario interessati dall’operazione di finanziamento.
Proprio la decisione di merito, la cui impugnazione ha condotto alla pronuncia della Suprema Corte, sopra commentata, che ha inteso distinguere le fattispecie della concessione di credito bancario “superficiale“ dalle fattispecie caratterizzate da scopi “predatori“, aveva dedotto dall’asserita mancanza di sufficiente diligenza nell’erogazione di un finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera m) del “ Decreto Liquidità” – d.-l. n. 23/2020 – la sussistenza dei presupposti per un concorso della banca nel reato di bancarotta semplice ascrivibile all’imprenditore per ritardata dichiarazione di fallimento ex art. 217, comma 1, n. 4) l. fall.[85] La Suprema Corte ha tuttavia osservato che la decisione di merito aveva indebitamente tracciato una correlazione tra inadeguata valutazione del merito creditizio e sussistenza dei presupposti del concorso nel reato di bancarotta, e non aveva “in alcun modo tratteggiato l’elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus”. In effetti il ritardato ricorso da parte dell’imprenditore ad una “procedura di crisi” – magari proprio quella “fallimentare” – che sarebbe appropriata per disciplinarne la situazione non ha alcuna relazione caratterizzata da profili di consequenzialità con la stipulazione di un contratto di finanziamento, derivando semplicemente (e solamente) dalla colpevole inerzia dell’imprenditore nell’assumere le iniziative che la legge pretenderebbe in tali circostanze: né la concessione di “nuova finanza“ può costituire in sé e per sé la causa dell’aggravamento del dissesto, dipendendo tale fenomeno, piuttosto, dall’utilizzo che della nuova finanza viene fatta dall’imprenditore[86]. Come dire, che “al fine di profilare un concorso in bancarotta determinante la nullità del contratto di finanziamento è necessario dimostrare un quid pluris rispetto all’inadempimento dell’obbligo di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito”.[87]
Sulla base delle precitate argomentazioni la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del dl. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengano destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge[88].
In virtù dell’automatismo e della gratuità disposte dal d.l. “liquidità”, la garanzia pubblica è stata ritenuta una forma di “finanziamento pubblico”, come tale espressione di un vero e proprio “valore economico conseguito [dall’impresa] a carico dello Stato”, con l’effetto di far ritenere applicabile alle fattispecie di indebita percezione dei finanziamenti bancari garantiti, l’art. 316-ter del c.p., ritenendosi, le erogazioni percepite, sostanzialmente “a danno dello Stato”[89].
Non sono noti precedenti nei quali sia stata affermato il concorso di pendenti bancari dei reati sopra rappresentati.
15. La configurabilità del “ricorso abusivo al credito” (pubblico) nelle ipotesi di ricorso alle garanzie pubbliche in presenza di “merito creditizio”.
L’affermazione del principio secondo il quale l’erogazione di “credito pubblico” ad imprese prive di “merito creditizio” è produttiva di un danno erariale di per sé, a prescindere cioè dalla circostanza se la garanzia statale (od equipollente) sia poi o non sia stata escussa – per la ragione che il vulnus lamentato è rappresentato dall’impegno che il ricorso alla garanzia pubblica comporta (incidendo sul plafond autorizzato dal legislatore per questo genere di interventi), così pregiudicando il soccorso finanziario ad imprese che veramente lo meriterebbero -, muove da presupposti che consentono di affermare anche il principio contrario: quello avente ad oggetto la “abusività” della concessione di “credito pubblico” ad imprese dotate di “merito creditizio”, il cui sostegno finanziario dovrebbe essere affidato alla responsabile valutazione degli enti finanziatori.
Se il problema è posto – come la giurisprudenza amministrativa sostiene – dallo “attentato” al disegno politico di sostegno dell’economia “in crisi”; e se il danno è provocato dal fatto che l’impegno che la prestazione di garanzia pubblica per un determinato finanziamento (non meritevole di assistenza) può provocare l’impossibilità di concederla per una operazione finanziaria diversa (che magari, invece, la meriterebbe); allora nella ipotesi nella quale venga accertata la presenza del “merito creditizio“ al momento della concessione del finanziamento, si verifica lo “abuso” dell’eventuale ricorso alla garanzia pubblica, perché non ve ne sarebbero stati presupposti; e perché ciò comporta il pregiudizio sopra rappresentato.
In altri termini: l’erogazione del credito rappresenta una attività economica che, come tutte, è caratterizzata dal “rischio d’impresa” che la sua natura esprime. In mancanza di circostanze eccezionali (come avverrebbe per la presenza di una “crisi pandemica”) non è ammesso il ricorso alla “garanzia pubblica”: tanto più se tale garanzia non è quantitativamente illimitata, ma circoscritta ad un importo complessivo massimo definito legislativamente, il cui utilizzo improprio può provocare una minore efficacia dei suoi effetti.
Per rimanere nel tema della crisi pandemica da Covid-19, il ricorso al “credito pubblico” per garantire un finanziamento concesso ad una impresa dotata di “merito creditizio”, e quindi come tale non bisognevole di sostegno statale, equivarrebbe all’utilizzo di un vaccino da parte di un soggetto immune dalla malattia pandemica: equivarrebbe alla sottrazione di quel vaccino a chi invece ne avrebbe avuto necessità.
D’altro canto, non è difficile immaginare questo scenario: perché, se può essere considerata “naturale” l’adesione della banca alla richiesta di “finanziamento pubblico” destinato alla ristrutturazione di passività pregresse – perché è evidente l’interesse della banca a conseguire la garanzia pubblica per il nuovo finanziamento, sostitutivo di quello precedente in ipotesi privo di garanzie, benché ciò comporti l’onere di prorogare significativamente i tempi di rimborso -; meno ovvia può essere la disponibilità della banca a sostenere finanziariamente una impresa verso la quale non sussista alcuna passività pregressa, assumendo un rischio – prima inesistente, per la mancanza di rapporti precorsi – valutabile in termini accettabili, con riguardo alle caratteristiche dell’impresa interessata (che, quindi, presenterebbe tutte le caratteristiche del ”merito creditizio”): ma collocato in un contesto economico (per esempio, proprio quello legato alla “crisi pandemica”) che può ingenerare motivi di preoccupazione non facilmente misurabili[90].
Di qui l’ipotesi, che non può essere considerata totalmente fantasiosa, del ricorso da parte della banca al sistema delle “garanzie pubbliche“ anche in presenza di una valutazione positiva del “merito creditizio” dell’impresa finanziata, allo scopo di conseguire una tutela (supplementare) che “male non fa”: con il risultato, peraltro, come sopra rappresentato, di “attentare” alla politica di sostegno economico delle imprese in difficoltà, avendo “distratto” l’aiuto pubblico a favore di chi non avrebbe avuto necessità.
Di qui la previsione di un possibile futuro orientamento giurisprudenziale volto a contestare l’abusività del “credito pubblico“ concesso alle imprese non già prive di “merito creditizio “, bensì dotate proprio di tale caratteristica, perché in quanto tali non avrebbero giustificato il ricorso al “medicamento” utilizzato – la garanzia pubblica -, così privandone chi invece ne avrebbe avuto necessità.
16. Il perseguimento di un “interesse pubblico” mediante la produzione di un “sacrificio privato”.
L’accertata “automaticità” del riconoscimento del credito del “garante pubblico” escusso dalla banca finanziatrice ammessa al beneficio della legislazione emergenziale “anti-Covid 19” (come di qualsiasi altra banca che abbia erogato un finanziamento assistito da garanzia Statale) e la rilevanza del privilegio attribuitogli ex lege (“davanti a tutti”, con la sola esclusione delle spese di giustizia e dei crediti di lavoro, delle cooperative e degli artigiani), producono automaticamente una (sia pure potenziale) alterazione della par condicio creditorum con riguardo alle passività sussistenti al momento dell’erogazione del finanziamento: perché nell’ipotesi (necessariamente non particolarmente remota) di mancato risanamento dell’impresa finanziata, il suo patrimonio risulterà appesantito da passività non soltanto aumentate nella quantità, ma soprattutto destinate a ridurre il patrimonio disponibile per il soddisfacimento dei restanti creditori, in quanto inesorabilmente anteposte ad essi con conseguente effetto depauperatorio.[91] [92]
In questo scenario non si ritiene condivisibile l’orientamento, che andava affermandosi in giurisprudenza, favorevole a disporre “misure cautelari“ nei confronti delle banche assistite da garanzie pubbliche e dei relativi garanti pubblici, volte ad impedire l’escussione delle garanzie, allo scopo di esonerare l’imprenditore dall’obbligo di considerare nel “piano di risanamento“ e nell’accordo di ristrutturazione con i propri creditori il “super privilegio” del garante pubblico escusso – costituendo perlomeno un apposito “super-fondo rischi” per fronteggiarlo, una volta sorto a seguito dell’escussione – e sottrarre in tal modo l’impresa interessata all’obbligo di destinare altrimenti (cioè al pagamento del debito verso il garante pubblico esposto, ovvero la costituzione di un corrispondente super-fondo rischi) la finanza necessaria all’accordo proposto ai creditori chirografari[93] – con la conseguenza di mettere a rischio il soddisfacimento finale del debito pubblico! -.
Allo stesso modo si deve riservare una condivisione soltanto parziale alla innovazione normativa (evidentemente provocata dall’orientamento giurisprudenziale, sopra ricordato, che si andava affermando) apportata dal c.d. “terzo correttivo” (d. lgs. 13 settembre 2024, n. 136), allorché ha integrato l’articolo 87, comma 1, CCII, con la lettera p-bis), secondo la quale nel “Piano” sotteso alla proposta di Concordato preventivo deve essere compresa “l’indicazione, dove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell’ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito“: condivisione – si è detto – soltanto parziale, perché appare incomprensibile la ragione per la quale la applicabilità della precisazione così introdotta (e di per sé totalmente condivisibile) sia stata circoscritta al “Piano“ sotteso ad una proposta di Concordato preventivo, piuttosto che (come sarebbe stato preferibile; e come in ogni caso si ritiene necessario, a prescindere dal dettato normativo) all’interno di qualsiasi “piano“ posto alla base di qualsiasi proposta di ristrutturazione del debito, quale che sia la sede nella quale essa viene rappresentata[94][95][96].
Non diversamente, non si colgono le ragioni per le quali potrebbe essere condivisa l’opinione favorevole alla disposizione di “misure cautelari“ nei confronti dei “garanti pubblici“, tese ad impedire il pagamento delle fideiussioni escusse dalle banche garantite.[97]
L’analisi già condotta sui presupposti di legittimità del ricorso, e dell’ammissione, al sostegno finanziario bancario assistito da garanzia pubblica, si arricchisce pertanto di un altro elemento di valutazione: l’accettazione della inevitabile conseguenza del peggioramento della condizione dei creditori dell’impresa, e della possibile alterazione della par condicio tra gli stessi, per il solo fatto dell’utilizzo dello strumento offerto dal legislatore in funzione del tentativo di ristrutturazione dell’impresa. L’intervento del sostegno finanziario bancario (assistito dalle garanzie pubbliche, in mancanza delle quali esso non sarebbe concesso), se da una parte comporta la creazione delle condizioni per un possibile risanamento dell’impresa (con conseguenti benefici per tutti: “interesse pubblico”), dall’altra genera i presupposti di un possibile grave peggioramento della condizione dei creditori dell’impresa e di una possibile, gravissima alterazione della par condicio tra gli stessi (“sacrificio privato”, perché circoscritto ai soli creditori dell’impresa), giacché in caso di esito negativo del tentativo di recupero, non si tratta solamente del timore di vedere aumentate le passività finanziarie senza un corrispondente aumento degli attivi patrimoniali (effetto comunque probabile), bensì della inevitabile sorte di uno “scavalcamento“ da parte di un creditore (lo Stato: “interesse pubblico”) beneficiario di un trattamento super-preferenziale[98].
[1] In argomento v. L. Mandrioli, Il credito restitutorio del garante pubblico tra diritto delle obbligazioni e concorso, Pacini giuridica, 2025.
[2] La Corte dei Conti-Sezione Riunite in sede di controllo riferisce, nel Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica, Le garanzie pubbliche, 2025, p. 31, che “nell’ambito della tutela delle risorse finanziarie pubbliche, erogate quali incentivi alle imprese, nel 2024 la Guardia di Finanza ha effettuato numerosi interventi contestando finanziamenti assistiti da garanzia statale non spettante per un ammontare di 98, 6 milioni”.
[3] Infra, n. 4.
[4] Da ultimo Trib. Roma, 31 ottobre 2025, in www.ilcaso.it: ma più ampiamente infra.
[5] Da ultimo Cass., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248, in dirittodellacrisi.it, 8 ottobre 2024.
[6] Oltre alla giurisprudenza citata infra si rinvia al Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica curato dalla Corte dei Conti-Sezione Riunite in sede di controllo, Le garanzie pubbliche, 2025, cit., pp. 30-31.
[7] Nella seconda metà dell’anno in corso la Banca d’Italia ha indirizzato alle banche una comunicazione avente ad oggetto “prestiti con garanzia pubblica” che traeva spunto da un procedimento di verifica di audit e di compliance sull’operatività in prestiti con garanzia statale (“PGS”), a seguito dell’esame di un campione di posizioni creditizie assistite da garanzia pubblica. Nell’occasione la Banca d’Italia ha richiamato il segnalato orientamento della giurisprudenza, con specifico riferimento alla già citata decisione della Corte di Cassazione n. 26248 dell’8 ottobre 2024.
[8] Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica: Le garanzie pubbliche, 2025, cit., p. 75: “Le garanzie pubbliche sui prestiti hanno agevolato l’accesso al credito, contribuito a contenere le insolvenze e a stimolare gli investimenti. Anche il sistema creditizio deve rispettare le disposizioni di vigilanza prudenziale sia nella fase di erogazione sia nella successiva gestione dei finanziamenti, inclusi quelli assistiti da garanzia pubblica. Comportamenti imprudenti o carenze nei controlli possono ridurre l’efficacia dello strumento di garanzia statale o indirizzare risorse pubbliche verso iniziative prive di adeguato merito creditizio, esponendo così le banche a potenziali rischi di credito, contenziosi legali e danni reputazionali”. V. anche infra.
[9] Ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996, il Fondo di garanzia è costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli Istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Il Fondo di garanzia PMI fa parte del Sistema nazionale di garanzia, istituito dall’art. 1, co. 48, della legge n. 147/2013 ai fini di riordino del sistema delle garanzie per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica.
[10] L’amministrazione del Fondo, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzione di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d’impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Successivamente l’art. 11, c. 4, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, ha disposto che gli interventi di garanzia del Fondo di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), della legge n. 662/1996, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
[11] Corte dei Conti, Sezione Giurisprudenziale per la Regione Liguria, 25 giugno 2024, n. 55.
[12] Di norma ” a prima richiesta “, cioè escutibile in modo automatico.
[13] In argomento v. Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23, secondo la quale “La giurisprudenza ha evidenziato che, in tali casi, [intervento dello Stato mediante la prestazione di garanzie] lo Stato assume “una posizione di rischio omologa a quella derivante dalla consegna diretta del denaro”, dato che la garanzia pubblica è “presupposto determinante per la concessione del finanziamento da parte del privato, nell’ambito del rapporto triangolare che lega fondo garante, banca concedente il finanziamento e imprenditore finanziato”.
[14] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 2125/2022. Si veda, altresì, Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 11246/2022, che valorizza la natura dell’erogazione di Aiuto di Stato; Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[15] Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[16] La traduzione in una norma di legge (l’articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b), e comma 5, del d.-l. n. 23/2020) del suggerimento di “fare leva su una maggiore responsabilizzazione del potenziale prenditore, utilizzando l’autocertificazione per attestare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al finanziamento” – infra, n. 14 – dimostra senza ombra di dubbio che non vi può essere violazione della disciplina del sostegno finanziario all’impresa in “crisi pandemica” da parte della banca finanziatrice, senza che vi sia stata una corrispondente (e precedente) violazione da parte dell’imprenditore finanziato: già solo per il fatto che l’erogazione del finanziamento doveva essere preceduta da una autocertificazione rilevante anche ai fini penali. Non può ipotizzarsi l’erogazione di un finanziamento “contro voglia“, neppure considerando l’assurdità di un banchiere che voglia simulare uno sviluppo non veritiero del proprio Istituto: perché se l’imprenditore finanziato non spende, anche il finanziamento “regalato “ non produce alcun effetto – mentre se l’imprenditore finanziato (chiede e) spende, pur senza averne i requisiti di “merito creditizio“, il primo ad abusare della fittizietà della situazione creata è proprio lui! -.
Da qui alcune considerazioni che dovrebbero rappresentare una verifica preliminare della “serietà” della contestazione alla banca di “abusività” del comportamento tenuto in occasione della concessione di credito ad una impresa in crisi:
(i) la preventiva revoca degli amministratori che a loro volta hanno necessariamente abusato nel ricorrere al credito in una situazione non più recuperabile (perché certamente più consapevoli della gravità della crisi di quanto non lo potesse essere qualsiasi terzo, compresa la banca);
(ii) la preventiva promozione di una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (per avere aggravato il dissesto utilizzando risorse finanziarie che, per quanto erogate, nessun pregiudizio avrebbero prodotto, se non investite). “In linea generale, in una procedura di concordato preventivo, se si afferma la nullità del mutuo concesso per concessione abusiva di credito …. , perché la banca ha prestato denaro ad un soggetto insolvente senza prospettive di risanamento o senza avere svolto una adeguata istruttoria, come previsto dalle norme sulla vigilanza prudenziale in ossequio ai principi di sana e prudente gestione del credito, la circostanza deve risultare dal ricorso e, in ogni caso di omissione, deve essere fatta risaltare dal Commissario giudiziale ex art 106 CCII, ridondando innanzitutto sotto il profilo della stessa ammissibilità del concordato. La società ricorrente pertanto dovrebbe: 1) evidenziare nel ricorso che è stato commesso il reato [di ricorso abusivo al credito]…; 2) avere mutato l’organo amministrativo responsabile del reato; 3) prospettare di volere svolgere l’azione di responsabilità per aggravamento del passivo nei confronti del predetto organo amministrativo; 4) prospettare di volere svolgere l’azione civile nei confronti degli Istituti di credito… per la declaratoria di nullità del mutuo e per il risarcimento dei danni…; 5) chiedere e ottenere analoga cautela nel giudizio civile, prima della data fissata per il voto, che avrà effetto per il post-omologazione del concordato, …..; 6) comunque avere disposto un accantonamento congruo… per il caso di sconfitta nella causa civile e mancata declaratoria della nullità del mutuo, cui seguirebbe l’escussione della garanzia con la legittima rivalsa del garante pubblico; 7) prospettare ai creditori chirografari un worst case, in cui l’accantonamento non verrà ripartito, e un best case, in cui anche l’accantonamento verrà ripartito a causa vinta, migliorando le prospettive di voto proprio a seguito dell’avvenuta concessione della misura cautelare sia da parte del giudice del concorso sia da parte del giudice civile, che hanno esaminato favorevolmente il fumus boni iuris inerente all’invalidità del mutuo. Solo in presenza di tutte queste condizioni può essere concessa in via cautelare strumentale la inibitoria agli istituti di credito ad attivare o coltivare la garanzia statale” (Trib. Vicenza, 22 ottobre 2024, in www.dirittodellacrisi.it).
[17] Intorno all’autunno del 2019 le autorità sanitarie di una città della Cina riscontrarono i primi casi di pazienti che mostravano i sintomi di una “polmonite di causa sconosciuta”. Il ceppo responsabile della pandemia fu identificato nei primi giorni di gennaio 2020 e denominato ufficialmente Coronavirus 2 della Sindrome Respiratoria Acuta Severa, abbreviato SARS-CoV-2. Successivamente la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus fu definita COVID-19. A marzo 2020 il tasso di mortalità e di morbilità dovuti alla malattia non erano ancora ben chiari: ma subito dopo il fenomeno si aggravò in modo consistente.
[18] In sede comunitaria venne adottato dalla Commissione europea un Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in data 19 marzo 2020: già in data 3 aprile sarebbe stato modificato. Più precisamente, in data 20 marzo 2020 fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la comunicazione della Commissione Europea denominata “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (2020/C 91 I/01)”, con la quale la Commissione derogava alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, riconoscendo alle imprese che non si trovavano “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019 la possibilità di beneficiare di agevolazioni pubbliche fino al termine – come da ultimo prorogato – del 30 giugno 2022, incluse garanzie sui prestiti, alle condizioni meglio delineate alle sezioni 3.2 e 3.4. In argomento P. MANGANELLI, Il trattamento concorsuale dei crediti garantiti da SACE e MCC, in www.dirittodellacrisi.it, 19 febbraio 2024.
[19] La introduzione di una disciplina fondata sul collegamento negoziale tra un contratto di diritto privato di finanziamento tra impresa e banca, da un lato, e una garanzia statale di fonte legale, dall’altro lato, ha perseguito la finalità di apportare al sistema economico una liquidità di cui lo Stato non ha inteso disporre in via diretta, ma solo in via mediata (tramite la garanzia a favore della banca) – Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23 -.
Il tema degli “Aiuti di Stato” alle imprese in difficoltà è di continua attualità: in data 25 agosto 2025 è stata resa nota una iniziativa della Commissione UE, la quale ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere contributi al fine di aggiornare i propri Orientamenti sugli “Aiuti di Stato” per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (Aiuti di Stato a imprese difficoltà: orientamenti aggiornati dalla Commissione UE, in www. diritto bancario.it, 25 agosto 2025).
Ai sensi della regolamentazione vigente gli Aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno se facilitano lo sviluppo di determinate attività economiche o di determinate regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Gli orientamenti prevedono tre tipi di aiuti:
- aiuti per il salvataggio
- aiuti per la ristrutturazione
- aiuti temporanei alla ristrutturazione.
La revisione sulla quale la Commissione UE chiede ai Paesi membri di esprimersi prevede, in particolare:
- l’estensione del campo di applicazione degli orientamentiin materia di salvataggio e ristrutturazione al settore siderurgico, attualmente escluso
- la modifica della definizione di “impresa in difficoltà”, per quanto concerne alcuni tipi di start-up innovative
- l’apporto di modifiche tecniche a seguito di diverse decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Il termine per rispondere all’invito a presentare prove e al Questionario della consultazione pubblica è stato fissato nel giorno 14 novembre 2025.
[20] Nel corso della audizione davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati in data 27 aprile 2020, in occasione della conversione in legge del d.-l. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”: c.d. “decreto liquidità”), il Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia ricordava come le principali misure introdotte riguardassero: i) l’attivazione di garanzie statali, concesse attraverso SACE S.p.A., per un importo complessivo di 200 miliardi da utilizzare entro la fine dell’anno….; ii) l’ampliamento, fino al 90%, della quota di riassicurazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei crediti all’esportazione assicurati dalla stessa SACE – misura che avrebbe consentito di liberare risorse nel bilancio della SACE per altri 200 miliardi, utilizzabili per concedere garanzie a condizioni di mercato anche dopo il 2020 -; iii) una diversa articolazione, per l’anno 2020, dell’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (FCG), anche attraverso l’aumento delle quote di copertura dei prestiti e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.
Analogamente si è espresso G. ROCCA, I crediti garantiti da sace ed mcc, tra norme di riferimento e primi arresti giurisprudenziali, in ristrutturazioni aziendali.Il caso.it, 17 novembre 2024, secondo il quale “il decreto “Liquidità” ha istituito un piano da 750 miliardi di euro per garantire liquidità alle imprese. Infine, il decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), con un budget di 16 miliardi di euro, ha esteso la durata delle misure di sostegno, tra cui la cassa integrazione, gli interventi di liquidità e le misure fiscali tramite contributi a fondo perduto. Le misure sono state inoltre affiancate da moratorie private concordate con i singoli intermediari e da quella promossa dall’ABI, che ha consentito alle banche ed intermediari finanziari aderenti di sospendere fino a 1 anno il pagamento delle rate dei finanziamenti e di estenderne la scadenza”.
[21] Le garanzie rilasciate dal Fondo Centrale di Garanzia erano invece considerate “standardizzate”, ossia concesse in numero elevato, generalmente per importi piccoli e su operazioni con caratteristiche simili. Secondo i regolamenti statistici europei tali garanzie vengono contabilizzate nell’indebitamento netto in base alla probabilità di escussione stimata dal soggetto che le rilascia.
[22] Audizione del Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati in data 27 aprile 2020.
[23] Contemporaneamente, peraltro, si avvertiva che “l’ammontare delle garanzie pubbliche alle imprese complessivamente attivabili sulla base dei decreti 18 e 23 del 2020 si colloca intorno ai 450 miliardi, circa 5 volte il valore di quelle in essere alla fine del 2019. Data la gravità della crisi e l’incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell’attività economica, la probabilità di una futura escussione di tali garanzie sarà verosimilmente molto più elevata che in condizioni normali. Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi… potranno essere significativi. I tassi di insolvenza potrebbero anche superare quelli del biennio 2012-2013, quando si avvicinarono al 10%, risentendo dell’ampliamento della platea dei beneficiari (sono incluse, tra l’altro, le imprese con prestito deteriorati: infra), delle più elevate percentuali di copertura e dell’assenza di previsioni che limitino l’utilizzo delle garanzie ai soli nuovi finanziamenti o al rinnovo di quelli in scadenza contrattuale “ – Audizione del Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati: infra, n. 14 -.
[24] “Le banche e gli intermediari finanziari hanno un ruolo fondamentale nel far fronte agli effetti dell’epidemia di COVID-19 mantenendo il flusso di credito all’economia. Se il flusso di credito sarà assoggettato a forti limitazioni, l’attività economica subirà un brusco rallentamento…”. “Gli aiuti di cui alla presente comunicazione concessi dagli Stati membri alle imprese a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, erogati attraverso le banche che agiscono come intermediari finanziari, vanno a diretto beneficio delle imprese.”.
[25] Commissione europea, Comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (2020/C 91 I/01).
[26] Camera dei Deputati 11 marzo 2020 – Doc. LVII-bis, n. 1).
[27] Si programmò così “in primo luogo” di fare in modo che venisse “ulteriormente potenziato il Fondo Centrale di Garanzia a sostegno delle PMI. Il Fondo sarà esteso con accesso gratuito su tutto il territorio nazionale, saranno prolungate le garanzie prestate e sarà possibile aumentare le percentuali di garanzia”. In secondo luogo di “rendere più semplice la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa, ma sarà anche resa possibile la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti bancari prolungandone la durata grazie all’intervento di parziali garanzie statali”: ed in tale contesto si fissò l’obiettivo di assicurare “che le imprese possano continuare a beneficiare delle aperture di credito accordate ma non ancora utilizzate”. A queste misure si accompagnarono le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti e da SACE per sostenere le imprese, che furono incrementate da 1 a 7 miliardi.
[28] Anche per le PMI è prevista la possibilità di fare ricorso alla garanzia SACE, una volta esaurito l’importo massimo percepibile a valere sul Fondo PMI.
[29] Comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno 2020 – Precisazioni sulle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi – Garanzie Covid-19 – Accordi “a saldo e stralcio”.
[30] Comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno 2020, cit. Nel caso di specie si precisava che “in questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario segnala il cliente nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” per l’importo [eventuale] stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”.
[31] Il significato della disposizione è stato valorizzato, inter alia, da Trib. Monza., 4 luglio 2024, cit., secondo il quale “… la norma chiarisce anzitutto che l’importo erogato può essere utilizzato, ancorché parzialmente, per operazioni di rinegoziazione di debiti pregressi (ovvero, per operazioni di ripianamento: ciò costituisce un ulteriore elemento a comprova della validità del mutuo solutorio, come già illustrato nel punto di cui sopra). Successivamente la norma precisa che, in aggiunta al margine destinato all’effetto di rinegoziazione/ripianamento, il nuovo finanziamento debba apportare ulteriore liquidità pari ad almeno 25% dell’importo debitorio oggetto di rinegoziazione”.
[32] Anche la Banca d’Italia fu propensa, all’epoca, a valutare sufficientemente adeguata una indagine di carattere puramente documentale. Nel documento “Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”, del 17 giugno 2020, l’Autorità di Vigilanza prendeva in considerazione i ” finanziamenti fino a 25.000 euro (limite poi innalzato 30.000 euro in sede di conversione, legge 5 giugno 2020, n. 40), per i quali la legge prevede che le banche possano procedere all’erogazione senza attendere l’accoglimento della domanda da parte del Fondo”. La Banca d’Italia osservava che per tale categoria “l’istruttoria segue generalmente un iter semplificato corredato da un insieme di documenti, di norma consistente nella richiesta di finanziamento, nel bilancio di esercizio o nell’ultima dichiarazione fiscale presentata”.
[33] Audizione del Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati in data 27 aprile 2020.
[34] S. Bonfatti, L’insolvenza bancaria. Gli intermediari finanziari, in Crisi d’impresa e procedure concorsuali, diretto da O. Cagnasso e L.Panzani, Torino, 2025.
[35] Ne è una riprova la disciplina delle cc.dd. “situazioni di crisi”: sia perché non interessa soltanto le crisi di carattere economico, ma anche le crisi di carattere gestionale e di conformità alla legge; sia perché si avvale di strumenti sconosciuti al “diritto imprenditoriale comune”. Ne è un esempio recente la nomina (6 agosto 2024) di ”Commissari Temporanei in affiancamento” al Consiglio di amministrazione dell’azienda di credito Banca Privata Leasing S.p.A. I Commissari Temporanei in affiancamento (art. 75-bis, co. 1, T.U.B.) coadiuvano gli organi sociali nella realizzazione delle iniziative funzionali al pieno ripristino di un’operatività improntata ai principi di sana e prudente gestione, in un contesto nel quale la banca prosegue regolarmente la propria attività, e la gestione rimane affidata agli organi aziendali in carica. Nel caso di specie l’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) avrebbe individuato carenze nei controlli antiriciclaggio. Inoltre Banca Privata Leasing avrebbe superato i limiti regolamentari che vietano di prestare a un solo soggetto più del 25% del patrimonio per evitare un’eccessiva concentrazione del rischio. Da notare che Banca Privata Leasing aveva chiuso il 2023 in crescita, con un margine di intermediazione di 15,52 milioni (11,6%) e un utile di 2,82 milioni (+28,7%). Si era bensì registrato un aumento dei “crediti deteriorati” (da 22, 2 milioni lordi a 39, 4 milioni lordi ), ma senza che ciò dovesse impensierire in modo eccessivo, perché per la maggior parte si trattava di operazioni assistite da garanzie reali (dal bilancio emergeva che i crediti deteriorati netti a fine 2023 erano pari a 31 milioni, costituiti per il 64,6% da leasing immobiliari).
[36] Si adduce a tale proposito, di norma, quanto dettato dall’articolo 5 del Testo Unico Bancario, secondo il quale “le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all’osservanza delle disposizioni in materia creditizia”.
[37] In argomento Trib. Verona, 16 dicembre 2024. Il Tribunale premette che “gli istituti di credito durante l’istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento sono tenuti alla corretta valutazione del merito creditizio, secondo le norme e disposizioni di vigilanza sia nazionali che sovranazionali vigenti al momento della richiesta… “. Aggiunge poi che “tali obblighi di corretta valutazione dovevano essere rispettati anche in relazione ai finanziamenti con garanzia statale erogati in conseguenza della pandemia Covid 19 ai sensi dell’art.. 13 del D.L. 23/20. L’operatore bancario è quindi tenuto ad accertare la condizione economico-finanziaria del soggetto finanziato all’attualità, posto che solo avendo a disposizione dati aggiornati è possibile valutare in modo attendibile la capacità di restituzione del prestito “. Ciò premesso, il Tribunale precisa che “in presenza di dati ed informazioni autonomamente reperibili datati e non aggiornati, la Banca – per assolvere correttamente al proprio compito di valutazione del merito creditizio – è tenuta a richiedere all’interessato ulteriori dati ed informazioni in suo possesso, che siano in grado di fornire una rappresentazione all’attualità della sua condizione economica e finanziaria”. Nel caso di specie, osservando che “la stessa banca non nega certo di avere proceduto alla valutazione del merito creditizio in modo corretto prima di concedere il mutuo”, non vi era ragione di dubitare che nella fattispecie “fosse stata effettivamente richiesta alla impresa finanziata una situazione patrimoniale finanziaria aggiornata”, sicché la banca “era evidentemente venuta a conoscenza dell’informazione dei dati dai quali emergeva in modo manifesto la condizione di insolvenza della società” finanziata: da qui, l’esclusione del credito bancario dal passivo fallimentare per revocabilità del finanziamento erogato. Nella fattispecie decisa da Trib. Napoli, 27 novembre 2024 (in www.il caso.It, 18 marzo 2025; e in www.diritto bancario.it, 5 marzo 2025) l’esclusione dello stato passivo fallimentare del credito vantato dalla banca in conseguenza dell’erogazione di un finanziamento concesso nel contesto della “crisi pandemica”, giudicato incauto, è fondata sulla compensazione con il credito risarcitorio fatto valere dal curatore fallimentare per l’asserito aggravamento del dissesto favorito dal sostegno finanziario bancario.
[38] In argomento Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025, in www.ilcaso.it, 20 marzo 2025, secondo il quale: ”ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’arte 2035 c.c. le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale e della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di una impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governa le azioni di mercato “. In applicazione di tale principio il Tribunale ha rigettato l’opposizione della banca nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato che ne aveva escluso il finanziamento, assistito da garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI per “concessione abusiva”, tale giudicata in quanto “non basta qualificare come diligente la sola consultazione di report contenenti giudizi di sintesi sul merito creditizio e attestanti la mancanza di specifici eventi integranti indici di difficoltà economica (come protesti o procedure esecutive), in quanto ad un soggetto altamente professionale è richiesta la verifica concreta e puntuale delle effettive condizioni finanziarie ed economiche del soggetto finanziato, non potendo confidare solo su giudizi o dati aggregati di sintesi forniti da terzi (per quanto professionalmente riconosciuti nel settore del rating).
[39] Trib. Ferrara, 3 maggio 2024, in www.dirittodellacrisi.it; Trib. Pescara, 2 luglio 2024, in www.ilcaso.it, 24 luglio 2024; Trib. Torino, 1° agosto 2024, in www.dirittodel risparmio.it, 2025; Trib. Napoli, 27 novembre 2024, in www.ilcaso.it., 18 marzo 2025; Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025, in www.dirittodellacrisi.it.
Secondo Trib. Asti, 8 gennaio 2024 (in ristrutturazioniaziendali.Il caso.it, 11 gennaio 2024 “la consapevole concessione di una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato, costituisce un complesso di negozi giuridici funzionalmente collegati, la cui causa non è quella del contratto di tipo di mutuo e neppure quella del patto di dilazionamento della scadenza del debito. La funzione concreta del negozio, infatti, non è la erogazione immediata di una somma con assunzione del rischio circa la sua integrale restituzione a fronte dell’impegno del mutuatario al rimborso rateale e neppure la concessione di una dilazione degli obblighi restitutori di un finanziamento già erogato mediante stipulazione di nuove più sopportabili condizioni, perché, per entrambi i negozi, è assente la stessa astratta possibilità che la restituzione avvenga. La vera causa concreta dell’operazione negoziale è l’assicurazione alla parte mutuante della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito.
Una simile causa del negozio è in contrasto con le disposizioni normative di natura primaria e secondaria che regolano le modalità con le quali va condotta l’attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e l’accesso alle garanzie prestate dal Fondo (cfr. L. 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 100; D. M.. 31/05/1999, n. 248 del Ministero dell’industria, del commercio dell’artigianato e, in particolare in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI, ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato, il D. M. Ministero delle attività produttive 20/06/2005 e allegati al D.M. Ministero delle attività produttive 23/09/2005).
Tali ultime disposizioni stabiliscono le condizioni per l’accesso alle garanzie statali, sono inderogabili dai privati e si deve ritenere abbiano carattere imperativo alla luce degli interessi generali alla cui protezione sono destinate. Si tratta, infatti, di norme regolatrici l’erogazione di ingentissime somme di competenza dello Stato in relazione alle quali la collettività vanta un interesse assolutamente preminente al loro corretto impiego “; Trib. Pescara, 2 luglio 2024, in www.ilcaso.it., 24 luglio 2024, secondo il quale “la legittimità della condotta della banca nella concessione di credito ad una impresa, in speciale modo quando il credito sia assistito da una garanzia pubblica, presuppone il compimento, da parte della medesima, di una valutazione preventiva da cui sia possibile desumere ragionevoli prospettive di rimborso, insussistente nel caso di specie.
Tale valutazione doveva essere effettuata ex ante sulla base di documenti, dati e notizie acquisite da cui, in caso di imprese in difficoltà, possa in buona fede desumersi la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del risanamento aziendale, secondo un progetto oggettivo, ragionevole e fattibile, elementi non considerati affatto dalla banca neanche in sede difensiva, non avendo dato prova di aver effettuato alcune indagini sul merito creditizio dell’azienda e sulla capacità di rimborsare l’importo finanziato al momento della stipula del contratto”.
In argomento v. S. Ambrosini, I rapporti fra le imprese in composizione negoziata e i creditori bancari dopo il decreto correttivo del 2024 (con una digressione sui finanziamenti abusivi), in ristrutturazioniaziendali.Il caso. it., 10 marzo 2024.
[40] S. Ambrosini, op. cit., 18.
[41] In questi termini le decisioni della Suprema Corte n. 16706 del 5 agosto 2020; n. 2014 del 26 gennaio 2018; n. 9441 del 21 aprile 2010; n. 5371 del 18 giugno 1987.
[42] App. Salerno, 28 novembre 2024, in www.ilcaso.it.
[43] In argomento S. Bertolotti e L. Scaccaglia, Mutui garantiti da MCC: sulla nullità per violazione del precetto penale, in www.iusletter.com, 27 novembre 2024, 15, secondo i quali “seguendo la infondata tesi della nullità dei mutui garantiti, a nostro avviso non sarebbe possibile ravvisare benefici per lo Stato, che sarebbe comunque tenuto a liquidare la garanzia che non risulta compromessa dalla nullità del contratto, trattandosi di credito che sorge ex lege, tenuto altresì conto che le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI prevedono che la banca garantita è tenuta unicamente a proporre insinuazione al passivo senza che rilevi l’eventuale esclusione, la quale, quand’anche motivata dalla nullità del finanziamento e confermata all’esito dell’opposizione, non può assumere rilevanza al fine di consentire a MCC, quale gestore del Fondo, di non liquidare la garanzia, e ciò in ragione di quanto previsto dall’art. 96, u.co., l. f., disposizione ripresa nel Codice della Crisi dall’art. 204, u.c. (ed al proposito gli autori rinviano anche a L. Cipolla, L. Dell’Oro, G. Gaudenzi, Procedure concorsuali e crediti garantiti da MCC e SACE, 12 luglio 2024, in www.dirittobancario.it).
[44] Trib. Monza, 4 luglio 2024, n. 737, in https://iusletter.com, 17 luglio 2024; Trib. Padova, 30 luglio 2024, in www.expartecreditoris.it, 10 aprile 2025; Trib. Roma, 29 ottobre 2024, in www.ilcaso.it, 20 febbraio 2025.
[45] Cass., Sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26248, in dirittodellacrisi.it, 8 ottobre 2024.
[46] Cass., n. 26248/2024, la quale ha cassato la decisione di merito che aveva fatto discendere la irripetibilità del finanziamento erogato dalla banca dalla semplice affermazione della violazione della norma di legge richiedente una adeguata valutazione del merito creditizio, precisa tuttavia che anche con riguardo ai finanziamenti “anti Covid-19” erogabili automaticamente, perché inferiori all’importo di euro 30.000,00, “non v’è ragione per cui i generali principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a 30.000,00 euro) erogati, come quello per cui è causa, nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. n. 23 del 2020…”.
[47] Il chè non significa che chiunque preteso danneggiato sia considerato legittimato a fare valere il pregiudizio collegato alla condotta asseritamente “abusiva” della banca: in particolare, sono considerati privi della legittimazione ad agire in tal senso tanto l’impresa asseritamente danneggiata (dovendo considerarsi la prima responsabile del danno prodottosi, per avere tanto richiesto, quanto poi utilizzato il finanziamento “abusivo”), quanto il curatore “fallimentare” nel contesto dell’eventuale liquidazione giudiziale dichiarata in danno dell’impresa (Cass., SS.UU., n. 7029/2006; n. 7030/2006; n. 7031/2006. Più recentemente App. Milano, 20 marzo 2015, n. 1229, in ius.giuffrefl.it., 5 agosto 2015).
[48] In questo senso, della giurisprudenza di merito, App. Salerno, 28 novembre 2024, cit..
[49] Cass., 5 agosto 2020, n. 16706; e Cass., 19 febbraio 2024, n. 4376, in ius.giuffrefl.it., 17 maggio 2024, con nota di M. Lonati, Finanziamenti erogati all’impresa in stato di decozione: contrarietà alla morale sociale economica e soluti retentio.
[50] La Suprema Corte, ricordando i propri precedenti citati, sottolinea come nel primo caso “il credito insinuata al passivo fallimentare derivava da forniture a credito effettuate ad un imprenditore in crisi, che veniva così a indebitarsi ulteriormente, aggravando il proprio dissesto – con integrazione della fattispecie penalistica di cui all’articolo 217, comma 1, n. 4, l. fall. -, nel contesto di un disegno del fornitore finalizzato a rilevarne gli assett, tramite una forma di finanziamento dissimulato, erogato in tranches a fronte di forniture non eseguite, tanto che la condotta è stata descritta come ^una disinvolta attitudine predatoria nei confronti di soggetti economici in dissesto^”. Nel secondo caso invece il credito insinuato al passivo fallimentare riguardava ” un finanziamento per oltre 2 milioni e mezzo di euro erogato da un socio amministratore a società in totale dissesto, finalizzato a procrastinare il fallimento, nel contesto di una attività truffaldina e fraudolenta che aveva avuto ampio risalto mediatico”.
[51] Immediatamente dopo la pronuncia commentata la Suprema Corte ha ribadito che la “concessione abusiva di credito” da parte di un istituto bancario, consistente nell’erogazione incauta di finanziamenti ad impresa in stato di insolvenza o crisi conclamata, integra un illecito che obbliga il finanziatore al risarcimento del danno qualora ne derivi l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa. Non costituisce tuttavia concessione abusiva di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi, abbia assunto un rischio non irragionevole erogando credito ad un’impresa potenzialmente in grado, secondo una valutazione ex ante, di superare la crisi o di permanere proficuamente sul mercato, sulla base di documenti e dati da cui sia stata desunta in buona fede tale possibilità. Ai fini della configurabilità della responsabilità della banca, il curatore fallimentare – in caso di assoggettamento dell’impresa finanziata a liquidazione giudiziale – deve provare: a) la condotta violativa delle regole dell’attività bancaria caratterizzata da dolo o colpa; b) il danno-evento costituito dalla prosecuzione dell’attività in perdita; c) il danno-conseguenza rappresentato dall’aumento del dissesto; d) il nesso causale tra la condotta e i danni. La mera esistenza di elementi indiziari circa la precaria situazione finanziaria dell’impresa finanziata (quali squilibri di bilancio, sottocapitalizzazione o segnalazioni alla Centrale Rischi) non è di per sé sufficiente a dimostrare l’abusività dell’erogazione del credito, essendo necessario provare specificamente la violazione delle regole prudenziali da parte della banca e il conseguente aggravamento del dissesto causalmente riconducibile alla prosecuzione dell’attività consentita dal finanziamento (Cass., 4 novembre 2024, n. 28320 – e in argomento v. M. Lonati, Abusiva concessione di credito per la banca che continua a finanziare l’imprenditore in crisi, in ius.giuffrefl.it, 14 febbraio 2025 -; Cass., 27 ottobre 2023, n. 29840 – in argomento M. Selvini, Abusiva concessione di credito: l’analisi del giudice sulla valutazione del merito creditizio, in ius.giuffrefl.it, 27 marzo 2024 -).
[52] Trib. Roma, 31 ottobre 2025, in www.ilcaso.it, ha affermato, in una fattispecie nella quale veniva contestata la ” abusività” di un finanziamento bancario assistito dalla garanzia del Fondo pubblico ex l. n. 662/1996, che “l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad una impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico–finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa…. In nessun caso la violazione di un dovere di comportamento può determinare, in mancanza di espressa previsione di legge, l’invalidità del contratto, poiché le regole di condotta operano su un piano distinto – come quello della responsabilità contrattuale o precontrattuale, a seconda che la violazione avvenga nella fase attuativa o prenegoziale – rispetto a quello della invalidità“.
[53] Trib. Pescara, 2 luglio 2024, in www.ilcaso.it. Tale decisione ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da una banca che aveva erogato un finanziamento garantito da MCC, ritenendo nullo per difetto di causa il contratto di finanziamento, il cui scopo era stato indicato con la dicitura “reintegro circolante”, in quanto la banca non avrebbe fornito la prova di avere svolto l’analisi del merito creditizio e della capacità di rimborso del cliente finanziato. In termini analoghi Trib. Asti, 8 gennaio 2024, in www.ilcaso.it.
[54]Trib. Modena, 4 giugno 2024, n. 1018 (in www.iusletter.com), che ha ritenuto non essere ”seriamente sostenibile, come allegato in citazione, che all’asserita condotta illecita della banca finanziatrice di c.d. “concessione abusiva di credito ” consegua, per ciò solo, la nullità del contratto di finanziamento e correlate fideiussioni”. Il Tribunale, nell’occasione, ha aggiunto che la “concessione abusiva del credito” non può assurgere a causa di nullità – sotto il versante genetico (causale) – del contratto di finanziamento e correlate fideiussioni, ma, al più, può assumere rilievo, in sede civile, sotto il versante risarcitorio, ma solo nell’ipotesi nella quale risultino provati gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano ascritto alla banca. Nello stesso senso Trib. Padova, 23 luglio 2024, in ristrutturazioniaziendali.Il caso.it, il quale ha affermato che le disposizioni sulla valutazione del merito creditizio rientrano nel novero di “norme di condotta“. In particolare, ha sottolineato il Tribunale, “nel caso del contratto di mutuo, gli elementi strutturali sono costituiti dalla corresponsione di una somma di denaro da parte del mutuante e dalla sussistenza dell’obbligo restitutorioo del mutuatario di capitale e interessi in un dato periodo di tempo, secondo il piano di ammortamento prescelto. Tali elementi risultano indifferenti alla precedente valutazione delle capacità restitutorie del mutuatario malamente eseguita o non eseguita del tutto da parte del mutuante: ove infatti il mutuante, ciononostante, eroghi la somma mutuata ed il mutuatario assuma su di sé l’obbligo restitutorio, il contratto sarà stato comunque validamente perfezionato, potendo assolvere la funzione sua propria di finanziamento del mutuatario…. la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio non comporta nullità del contratto di mutuo, costituendo, al più, presupposto per la condanna al risarcimento dei danni e per la risoluzione del contratto nei casi che lo consentano “. Nello stesso senso Trib. Padova, 19 novembre 2024, in ristrutturazioniaziendali.Il caso.it.; App. Salerno, 28 novembre 2024 (in il caso.It., 21 febbraio 2025). In argomento S. Bertolotti e L. Scaccaglia, Mutui garantiti da MCC: sulla nullità per violazione del precetto penale, in www.iusletter.com, 27 novembre 2024, 11.
[55] Corte dei Conti, Sez. Veneto, n. 6/2024; Corte dei Conti, Sez. Toscana, n. 23/2024; Corte dei Conti, Sez. Liguria, n. 67/2023, n. 70/2023 e n. 55/2024; Corte dei Conti, Sez. Piemonte, n. 435/2021; Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 18/2023; Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, n. 32/2007; Cass., SS.UU., n. 4511/2006
[56] Corte dei Conti, Sez. Veneto, n. 6/2024; Corte dei Conti, Sez. Liguria, n. 67/2023 e n.70/2023; Corte dei Conti, Sez. Piemonte, n. 435/2021; Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 18/2023; Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, n. 32/2007; Cass., SS.UU., n. 4511/2006. In argomento v. anche Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica curato dalla Corte dei Conti-Sezione Riunite in sede di controllo, Le garanzie pubbliche, 2025, cit., p. 31.
[57] La giurisdizione della Corte dei Conti riguarda principalmente la contabilità pubblica e le materie specificate dalla legge, come la responsabilità amministrativa per danno all’erario e i giudizi di conto, e si estende al giudizio di alcune materie di carattere pensionistico. La sua attività giurisdizionale, stabilita dall’art. 103 della Costituzione, si affianca a funzioni di controllo e si esplica nel giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per vicende legate alla gestione delle risorse pubbliche.
[58] Con le distinzioni del caso, giacché taluno è portato ad attribuire rilevanza, sia pure a posteriori, all’eventuale riduzione del credito assistito dalla garanzia pubblica escussa. Secondo la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, 3 agosto 2023, n. 70, “sul punto il Collegio ritiene sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, alla cui stregua in tema di responsabilità amministrativa il Giudice contabile è chiamato ad accertare e quantificare un pregiudizio patrimoniale certo ed attuale con riferimento al momento del giudizio, stante l’irrilevanza dei possibili recuperi dei quali si dovrà eventualmente tener conto in sede di esecuzione della decisione. In altri termini, è pacifico che il danno erariale risulti certo ed attuale se sussiste al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità, a nulla rilevando che lo stesso possa in futuro essere risarcito (almeno in parte) ovvero venir meno a seguito dell’attività recuperatoria dell’Amministrazione danneggiata ….. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa non rileva neppure la futura possibile restituzione integrale, da parte del beneficiario, del finanziamento ricevuto, la quale produrrebbe i propri effetti, che rimangono certamente salvi, esclusivamente nella sede esecutiva della sentenza”.
[59] Supra, n. 4. La rilevanza, in termini generali, del profilo a cui si fa cenno, si può ricavare dalla consultazione del verbale della seduta della Camera dei deputati dell’11 marzo 2020, alla quale si è già fatto cenno. In quella sede si è dato conto della necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente che consentissero di fronteggiare le rilevanti esigenze di natura sanitaria e socio-economica derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-2019. Il pacchetto di misure che il Governo manifestò di volere adottare consisteva in un aumento delle risorse destinate al Sistema sanitario pubblico, al sistema della Protezione civile e alle Forze dell’ordine, ed al sostegno alle aziende interessate al fine di impedirne crisi di liquidità. A tale scopo, nell’occasione, si ricordò che nella lettera trasmessa pochi giorni prima (il 5 marzo 2020) dal Governo alla Commissione UE, nel riferire preliminarmente sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e sulle misure già assunte, si faceva presente che il Governo aveva deciso un “pacchetto” di misure del valore di circa 6,3 miliardi di euro sul deficit della pubblica amministrazione: ma contemporaneamente si precisava che tale stima di deficit avrebbe potuto cambiare in occasione della presentazione del “Programma di Stabilità per l’Italia”, adducendo anche “l’imprevedibilità dell’impatto sul quadro economico e di finanza pubblica dell’emergenza in corso”. Nella medesima lettera all’UE il Governo aveva fatto presente che avrebbe chiesto alla Commissione di considerare il pacchetto di emergenza come una spesa una tantum e, come tale, da non computare ai fini del saldo strutturale.
In occasione della ricordata seduta dell’ 11 marzo si rappresentò la necessità che venisse presentata una richiesta di autorizzazione all’ulteriore ricorso all’indebitamento di ulteriori 13,75 miliardi, da utilizzare nel corso del 2020 in relazione all’ulteriore intensificarsi dell’epidemia da COVID-19. Considerata anche la precedente richiesta di autorizzazione, l’obiettivo programmatico di indebitamento netto avrebbe potuto pertanto aumentare fino a 20 miliardi di euro.
Per tale ragione nell’occasione il Governo chiedeva al Parlamento di autorizzare uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, definiti nella precedente Nota di aggiornamento al DEF, per un importo fino a 20 miliardi di euro.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha rappresentato (Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica, Le garanzie pubbliche, 2025, cit., p. 17) che per le garanzie pubbliche attivate in situazioni emergenziali, introdotte dal “decreto liquidità”, a partire dalla ” GaranziaItalia ” e successivamente modificate con “SupportiItalia “, è stato previsto un modello di governance, concepito per contemperare l’esigenza di rapidità operativa – richiesta dalla natura straordinaria della misura – con la necessità di assicurare un controllo puntuale da parte dello Stato su operazioni potenzialmente impattanti per i conti pubblici.
[60] Sez. Campania, nn. 249/2012 e 52/2000; Sez. Lombardia, n. 406/2006; Sez. Marche, n. 793/2003; SS.RR. n. 532/1987; Corte dei Conti, Sezione Giurisprudenziale per la Regione Liguria, 25 giugno 2024, n. 55.
[61] Così, ex multis, Sez. Liguria, nn. 372/2009, 155/2008 e 609/2004; Sez. Campania, n. 696/2008; Sez. Basilicata, n. 208/2003; Corte dei Conti, Sezione Giurisprudenziale per la Regione Liguria n. 55/2024. Quest’ultima decisione, in particolare, ha affermato che “nel caso di specie, i caratteri della certezza, concretezza ed attualità non vengono elisi dalla circostanza eventuale che l’Amministrazione non abbia, allo stato, subito l’escussione della garanzia da parte della banca erogatrice del finanziamento né sarebbe pertinente opinare che a tale eventualità, sul piano civilistico, potrebbe porsi rimedio attraverso l’azione di regresso del Fondo di garanzia escusso nei confronti dell’imprenditore inadempiente, poiché la stessa si colloca su un piano distinto ed è retta da principi diversi da quelli propri dell’azione di responsabilità amministrativa. Nell’odierno giudizio di cognizione non rileva neppure la futura possibile restituzione integrale, da parte del beneficiario, del finanziamento ricevuto, la quale produrrebbe i propri effetti, che rimangono certamente salvi, esclusivamente nella sede esecutiva della sentenza, come già più sopra chiarito”.
[62] In argomento v. Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[63] Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[64] Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[65] Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23; Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Liguria, 25 giugno 2024, n. 55.
[66] La Corte dei Conti-Sezione Riunite in sede di controllo, Quaderno n. 2 della serie I quaderni del Rapporto sul Coordinamento della finanza pubblica, Le garanzie pubbliche, 2025, cit., afferma che ” in considerazione della complessità dell’operazione di finanziamento assistito da garanzia, in caso di violazioni del paradigma normativo che regolamenta il singolo finanziamento assistito da garanzia, l’illecito erariale si concretizza nel momento in cui si verifica il danno” (p. 31), ma dà altresì atto della circostanza che “sul punto la giurisprudenza di primo grado della Corte dei Conti non è univoca, ritenendo che il danno coincida con la semplice escussione della garanzia (Puglia 6/24 ), ovvero con la richiesta di escussione della garanzia (Marche 98/2025), ovvero ancora con l’indebito ottenimento/distrazione dei fondi concessi dalla banca (Veneto 13/2024, Liguria 67/2023 e Toscana 23/2024)”.
[67] Non a caso la legge di bilancio per l’esercito 2025 ha previsto, in relazione al Fondo Centrale per le PMI, una riduzione della percentuale massima garantibile e l’introduzione di un contributo, sotto forma di premio, da corrispondere al Fondo Centrale di Garanzia a carico degli intermediari. La stessa legge di bilancio, pur prorogando per il 2025 1 regime ancora favorevole rispetto a quello in vigore prima della ” crisi pandemica “, ha apportato alcuni correttivi, volti a scoraggiare un eccessivo discorso alla garanzia pubblica: è stata ridotta al 50% la percentuale massima di garanzia per i finanziamenti erogati alle medie, piccole e micro imprese per esigenti di liquidità.
[68] Cass., ss.uu., n. 3310/2014; n. 295/2013; n. 5019/2010; n. 23332/2009; n. 25513/2006.
[69] Cass., ss.uu.,. n. 20701/2013; n. 295/2013; nn. 5019 e 9963/2010; n. 20434/2009; n. 4511/2006.
[70] Cass., ss.uu., n.123/2001.
[71] Cass., ss.uu. n. 15490/2020. Cfr. anche, ex multis, Cass., ss.uu., nn. 20434/2009; 4511/2006; 3351/2004; nonchè Corte dei Conti, Sez. I centr. App., sentt. nn. 20/2011 e 256/2011; Corte dei Conti, Sez. Toscana, sentt. nn. 149, 228 e 318 del 2023.
[72] Trattasi del documento pubblicato nella presente Rivista 5 settembre 2025, e riferibile alla Procura Regionale per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti.
[73] Ed a tale proposito si cita il precedente di Corte dei Conti, sez. giur., Toscana, sentenza n. 23/2024.
[74] Ed a tale proposito si cita il precedente di Corte dei Conti, sez. II, App., sentenza n. 380/2021.
[75] Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[76] Non si deve però dimenticare che fra le destinazioni ammesse era ricompreso il rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito presentato dalla impresa beneficiaria, purché il finanziamento prevedesse l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione (e a condizione che il rilascio della garanzia fosse idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione). È stato, inoltre, ammesso che una quota del finanziamento, non superiore al 20% dell’importo erogato, potesse essere destinata al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020), per le quali il rimborso fosse stato reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa (art. 1, comma 2, lett. n) e n-bis), del d.l. n. 23/2020).
[77] Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23.
[78] Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 23: “L’automatismo dell’erogazione e l’assenza di obblighi di controllo sostanziali, insieme alla copertura della garanzia al 100%, sollevano, infatti, l’Istituto di credito da qualsiasi rischio di insolvenza, finanche in caso di fallimento dell’impresa beneficiaria. Si può, dunque, affermare che la garanzia pubblica è lo strumento per la realizzazione del Programma. Infatti, in sua assenza, il sistema bancario non avrebbe erogato alle imprese la liquidità necessaria per fare fronte all’emergenza senza acquisire, a sua tutela, informazioni e garanzie della loro solvibilità”. La decisione continua osservando che “la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha rimarcato l’unitarietà dell’operazione dal punto di vista causale, per il collegamento tra il contratto di prestito all’impresa da parte della banca e la garanzia ex lege dello Stato, che ne costituisce la causa in concreto. In particolare, ha osservato che “il finanziamento erogato dalla banca, …, trova causa proprio nella garanzia prestata gratuitamente e automaticamente dal Fondo PMI, al fine di dare sostegno alla liquidità delle imprese private che versavano in una fase di illiquidità, e per le quali, in condizioni ordinarie di mercato, il ricorso al credito bancario sarebbe risultato assai difficile, se non precluso dall’esame del merito di credito. Per effetto dell’intervento della garanzia pubblica, del resto, il rischio di credito ricade integralmente sullo Stato, che ha previamente accantonato un apposito fondo. Il Fondo PMI, nel caso di specie, dunque, non garantisce condizioni economiche di maggior favore, bensì consente la stessa realizzabilità dell’operazione economica di finanziamento, esonerando, con la propria prestazione di garanzia, la banca dall’esame del merito di credito e assumendo l’onere patrimoniale della mancata restituzione del finanziamento bancario…” (Cass. pen., sez. VI, sent. n. 28416/2022)”. Sempre la decisione in commento osserva come la decisione della Corte di Cassazione penale richiami il proprio precedente, secondo il quale “senza la garanzia, il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica insita nella necessità di assolvere alle finalità proprie dell’ente pubblico che agisce tramite l’istituto bancario” (Cass. pen., Sez. 6, n. 11246 del 13/01/2022, Pressiani, Rv. 283106 – 01).” Non diversamente la decisione della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, 25 giugno 2024, n. 55, che in una fattispecie nella quale era stato erogato un finanziamento garantito dal fondo PMI, ha affermato che “la garanzia statale assurge a vera e propria condicio sine qua non del finanziamento erogato dalla banca privata, di talché le disponibilità finanziarie acquisite grazie al finanziamento garantito dal Fondo derivano non già dal puro ricorso al mercato finanziario quanto dall’intervento indiretto posto in essere dallo Stato. Alla stregua di tali rilievi si è dunque in presenza di un ausilio economico ottenuto dallo Stato…. ancorché il finanziamento sia direttamente erogato dalle banche consorziate del fondo PMI”.
Secondo la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Liguria, 3 agosto 2023, n. 70, “l’art. 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ……, c.d. “decreto liquidità” ……, ha previsto l’intervento finanziario dello Stato in favore delle piccole e medie imprese che fossero risultate in crisi di liquidità per effetto del blocco delle attività determinato dalla pandemia da Covid-19. Ciò attraverso il Fondo centrale di garanzia ………… Con tale Fondo, l’Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie: in sostanza, la garanzia pubblica sostituisce le garanzie ordinariamente richieste per ottenere un finanziamento”. Con riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti per l’affermazione del reato di ” indebita percezione di erogazioni pubbliche” (art. 316-ter c.p.) è stato affermato, con riguardo ai finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 13 del “decreto liquidità”, che “il finanziamento trova la sua causa proprio nella garanzia che lo Stato assegna alla finalità pubblica di impulso all’economia privata allo strumento negoziale posto in essere con la necessaria mediazione e partecipazione dell’istituto di credito. Senza la garanzia il prestito non sarebbe stato concesso, mentre la stessa conferisce al prestito una funzione propriamente pubblicistica …..”(Cass. pen., n. 11246/2022).
[79] Audizione del Capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia davanti alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati in data 27 aprile 2020.
[80] Comunicazione della Banca d’Italia del 19 giugno 2020, cit. ” … non devono essere segnalate in CR, nella categoria ” garanzie ricevute”, le garanzie:
– pubbliche concesse in base a leggi, decreti e provvedimenti normativi;
– rilasciate automaticamente, al ricorrere di determinati presupposti”.
[81] Nella circolare alle banche associate del 9 aprile 2020 l’Associazione Bancaria Italiana si esprimeva in questi termini, con riguardo ai finanziamenti disciplinati dall’articolo 13 del “Decreto Liquidità” – cioè i finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia PMI – (pag. 8): “Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario; .. la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data di richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o ” scadute e/o sconfinanti deteriorate “…”; con riguardo ai finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (poi 30.000,00 euro) “il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo”.
[82] Quindi nell’arco di meno di 2 mesi dall’entrata in vigore del “decreto liquidità”.
[83] Banca d’Italia, Finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, 17 giugno 2020.
[84] Emblematica, per quanto riguarda la valutazione riservata all’impresa protagonista di un “ricorso abusivo al credito” e la valutazione riservata alla banca finanziatrice, può essere considerata la fattispecie oggetto della decisione del Tribunale di Torino, 7 febbraio 2025, pronunciata a conclusione di un giudizio penale conseguente ad una denuncia di truffa, da parte di una banca, nei confronti di un imprenditore, che aveva fatto ricorso al finanziamento pubblico del tipo “framework 3.2.” assistito dalla garanzia del Fondo per le Piccole e Medie Imprese, al fine di fare fronte alle esigenze di liquidità conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Scoperta, e confessata dall’imprenditore senza riserve, la falsificazione integrale della documentazione presentata alla banca per l’ottenimento del finanziamento de quo – garantito bensì dallo Stato, ma in misura non integrale -, il Tribunale ritiene di dovere modificare il capo di imputazione escludendo il reato di truffa, e qualificando l’operato dell’imprenditore commesso su dire nel reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche”. A tale proposito il Tribunale afferma che l’erogazione del finanziamento “framework 3.2.”, con conseguente garanzia pubblica, “non richiedeva alcuna verifica da parte dell’Istituto di credito circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall’imputato in sede di autocertificazione …. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. VI, n. 2125 del 24 novembre 2021, ribadita da Cass. pen., Sezione VI, n. 1246 del 13 gennaio 2022) ….”, che ha descritto la fattispecie come “ la condotta di chi consegua la garanzia – che si pone quale condicio sine qua non dell’erogazione del credito – sulla base di una autodichiarazione che attesti la ricorrenza dei requisiti necessari per accedere al finanziamento garantito, in realtà non sussistenti…… Anche nella vigenza del decreto legge [d.l. n. 23/2020] era richiesta solo l’autocertificazione e l’ente finanziatore non era tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato in sede di autocertificazione dal soggetto che richiede finanziamento..” nè “era tenuto a svolgere alcun accertamento sulla verità del contenuto delle autocertificazioni..”.
[85] Trib. Torino, 1° agosto 2024 (commentata da S. Bertolotti e L. Scaccaglia, cit.) aveva ritenuto che “la fattispecie di bancarotta semplice ipotizzata nel caso in esame, nel quale la banca ha concesso, senza effettuare la dovuta valutazione del merito creditizio, ad impresa avente indici riconoscibili di insolvenza, un mutuo garantito al 100% in via automatica da un fondo di garanzia statale, così contribuendo ad aggravarne il dissesto e ritardandone il fallimento, sia posta a tutela anche di un interesse collettivo, da individuare nell’ordinato esercizio del commercio, interesse generale e costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost. alla regolarità ed alla correttezza delle operazioni commerciali e dell’esercizio dell’impresa, non solo degli interessi dei creditori, configurandosi come reato plurioffensivo”. In terminis, per quanto viene riferito nel contributo ad essa dedicato, la decisione di Trib. Piacenza, 8 gennaio 2025 (commentata da E. Corucci, La concessione abusiva del credito all’impresa in crisi e la sua rilevanza penale, in IUS Crisi d’impresa, 27 giugno 2025).
[86] In argomento v. E. Staunovo-Polacco, La nullità dei contratti per concessione abusiva di credito e aggravamento del dissesto alla prova degli insegnamenti della suprema corte sulle nullità “virtuali”, in ristrutturazioni aziendali.Ilcaso.it, 29 luglio 2024, § 4.
[87] Trib. Salerno, 13 marzo 2025, N. R.G. 1519/2024.
[88] Cass. pen., VI, n. 28416/2022.
[89] corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, 28 febbraio 2024, n. 24.
[90] Ipotizziamo la richiesta di sostegno finanziario da parte di una impresa farmaceutica, ai tempi della “crisi pandemica”, per l’effettuazione di un importante investimento volto al potenziamento della sua capacità produttiva, in considerazione dell’ottimo andamento dell’attività aziendale: è abbastanza probabile che la valutazione del “merito creditizio” dell’impresa avrebbe dato, di per sé, un segno positivo: ma come sarebbe stato possibile rispondere alla domanda, peraltro del tutto pertinente, per quanto tempo sarebbe ancora durata la ” crisi pandemica “, e per quanto tempo, quindi, l’impresa farmaceutica avrebbe presentato il fatturato attuale?
[91] In argomento v. M. Lonati, Abusiva concessione di credito per la banca che continua a finanziare l’imprenditore in crisi, cit., secondo la quale“ …. non si può negare che ove ad essere contratto fosse un finanziamento garantito da ipoteca o dal fondo di garanzia, la par condicio creditorum verrebbe sovvertita dalla natura ipotecaria del credito o per effetto della iscrizione di un credito privilegiato negli Stati passivi dei debitori abusivamente finanziati”. A proposito della ipotizzabilità di un comportamento “abusivo” da parte della banca che non provveda sollecitamente al recesso dall’apertura di credito a suo tempo concessa al cliente, “presumibilmente in virtù della sicurezza fornita dalla garanzia reale acquisita, a scapito degli altri creditori”, Trib Ferrara, 3 maggio 2024 (in dirittodellacrisi.it), che ha confermato l’esclusione dallo stato passivo del credito bancario derivante da un finanziamento (ipotecario) concesso nell’anno 2011, e successivamente rinnovato più volte sino alle soglie della dichiarazione di fallimento dell’impresa finanziata (dichiarato nell’anno 2022), per ritenuta abusività della condotta rappresentata dalla ripetuta concessione di rinnovi e rateizzazioni, in considerazione del ritenuto concorso della banca nel reato, ascritto all’imprenditore, di ingiustificato ritardo nella richiesta di apertura del fallimento in proprio, con conseguente applicabilità del divieto per la banca anche della pretesa di ripetizione di indebito, come sanzionato dall’art. 2035 cod. civ.
[92] “Gli istituti bancari si sono mossi nell’ottica della riqualificazione dei propri crediti, blindando quelli chirografari con il suggello della garanzia pubblica. La mole di rifinanziamento è venuta in essere ha comportato un incremento sensibile nella cifra globale dei crediti assistiti da garanzia sull’intero dei crediti bancari. In buona sostanza, le garanzie SACE/MCC hanno rafforzato “a tappeto” crediti ab origine sorti come non ipotecari” – G. Rocca, I crediti garantiti da SACE e MCC ecc., cit., 7. In argomento v. anche S. Leuzzi e P. Rinaldi, in diritto della crisi, 2021 -.
[93] Trib. Milano, 12 maggio 2024, in www.dirittodellacrisi.it, che richiama Trib. Salerno, 22 febbraio 2024, ibidem, e Trib. Gorizia, 19 marzo 2024, ibidem.
[94] In argomento Trib. Modena, 3 febbraio 2025, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025, (5), 699, secondo il quale “l’art. 87, comma 1, lett. p-bis), CCII trova applicazione anche nella procedura di concordato minore di cui agli artt. 74 s.s. CCII: ne consegue che il debitore proponente, nel caso di credito vantato da una banca assistito da garanzia rilasciata in virtù di misure di sostegno pubblico, non ancora escussa, deve inserire tali creditori in apposita classe, ai sensi dell’art. 74, comma 3, ultimo periodo, CCII, e deve prevedere nel piano concordatario un apposito fondo volto a coprire il rischio di pagamento del terzo garante nell’ipotesi di escussione della garanzia “. Analogamente Trib. Milano, 12 maggio 2024, in www.dirittodellacrisi.it; Trib. Nola, 11 luglio 2023, in One LEGALE; Trib. Bergamo, 14 ottobre 2020, in www.ilcaso.it. In dottrina. S. Leuzzi e P. Rinaldi, La ristrutturazione del debito da finanziamento “emergenziale” garantito: una criticità e una proposta, in www.diritto della crisi.it, 2021, hanno osservato che “quando il deposito del piano è tempestivo la surroga non è quasi mai ancora intervenuta. In tal caso, il debitore in difficoltà non troverà dinanzi a sé il garante parastatale, ma l’istituto di credito, con l’onere gravoso e conseguente di appostare un fondo rischio in privilegio per l’importo differenziale tra la misura della garanzia e l’ammontare della soddisfazione chirografaria prospettato”. G.B. Nardecchia, Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2025 (1), 66, ha precisato, al proposito, “Fermo restando che, se l’escussione interviene dopo il deposito della domanda completa di proposta, piano e annessa documentazione, il debitore dovrà richiedere un termine per la modifica del piano e della proposta, con eliminazione del fondo rischi ed allocazione delle risorse nella classe del creditore garante”.
[95] Con riguardo alla procedura di Concordato preventivo si riferisce che “nella prassi le più recenti proposte concordatarie prevedono la creazione di una classe privilegiata per il garante statale lasciata momentaneamente vuota e pronta a popolarsi una volta avvenute le relative escussioni, con creazione di apposito fondo nella massa passiva. Solo in tal modo è possibile distinguere il credito chirografario delle banche da quello privilegiato statale, con conseguente differente trattamento per i diversi soggetti, anche ai fini del voto sulla proposta di concordato” (L. Cipolla, L. Dell’oro, G. Gaudenzi, Procedure concorsuali e crediti garantiti da MCC e SACE, in www.dirittobancario.it, 12 luglio 2024). Secondo Trib. Roma, 11 aprile 2024, in www.dirittodellacrisi.it, “ la soluzione prospettata dalla proponente – mantenere il debito garantito bancario in una classe di chirografo, ma costruendo sin d’ora una classe di creditori privilegiati attualmente vuota (e, se rimasta tale sino al voto, da non computare evidentemente nel calcolo delle maggioranze) ma destinata ad essere via via popolata dai garanti – pare, in via di prima analisi, corretta, in quanto attribuisce – né potrebbe fare altrimenti – la collocazione chirografaria agli istituti di credito, in quanto all’attualità titolari di un credito chirografario, ma sconta già la prevedibile escussione da parte dei garanti che li colloca, se dovesse avvenire prima del voto, in una apposita classe a questo punto votante (con correlata riduzione del credito collocato nella classe del chirografo bancario)“.
[96] Per quanto concerne le altre “procedure di crisi “, pare interessante segnalare le modifiche ed integrazioni apportate, successivamente all’entrata in vigore del CCII, alle “Disposizioni Operative” del Fondo di Garanzia per le PMI, tra le quali la riformulazione della disciplina relativa agli accordi transattivi, tra i quali rientrano anche le procedure di regolazione della crisi d’impresa, che prevedano uno stralcio del debito. Il paragrafo C) della parte VI delle Disposizioni Operative, in particolare, prevede una specifica procedura seguendo la quale i soggetti debitori possono formulare proposte di accordi transattivi riguardanti il debito garantito, nell’ambito dei differenti strumenti di regolazione della crisi. Le proposte di ristrutturazione del debito devono prevedere una percentuale di pagamento non inferiore al 15% del debito complessivo e devono essere valutate positivamente delle banche finanziatrici (in argomento L. Cipolla, L. Dell’Oro, G. Gaudenzi, Procedure concorsuali e crediti garantiti da MCC e SACE, cit.).
[97] Da ultimo Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, in www.dirittodellacrisi.it, secondo il quale è giustificabile l’accoglimento della richiesta di “impedire temporaneamente l’escussione di una qualunque garanzia, compresa quindi quella pubblica di MCC, onde evitare, da un lato, l’alterazione dello status quo tra i creditori (avvantaggiando gli escutenti, e demotivandoli rispetto all’esito della CNC), e, dall’altro lato, il definitivo consolidamento del super-privilegio di MCC, che potrebbero perciò pregiudicare le trattative in corso”: non vedendosi come, escussione o non escussione, si possa prescindere dalla circostanza che il credito di MCC troverà collocazione prima di ogni altro credito (con la sola esclusione di quelli previsti dall’art. 2751-bis) si c.c.
[98] L’effetto denunciato presenta ancora maggiore evidenza allorché si consideri la fattispecie, del resto largamente ricorrente e pressoché generalizzata, del ricorso al “credito pubblico” proprio in funzione del ripianamento (sia pure accompagnato dalla rateizzazione) del credito bancario pregresso, in origine chirografario e successivamente pressoché integralmente soddisfatto a scapito dei restanti creditori (“scavalcati” dal regresso super-privilegiato del garante pubblico).