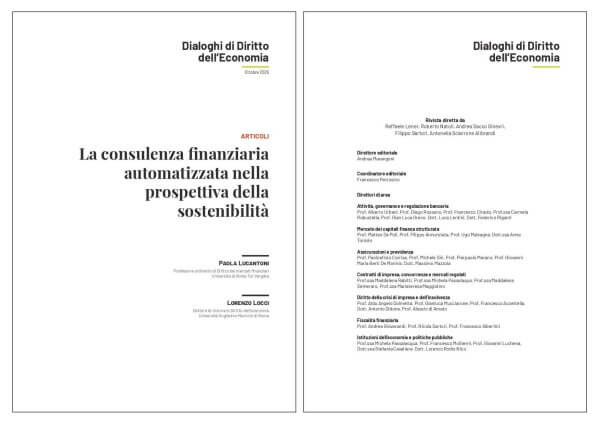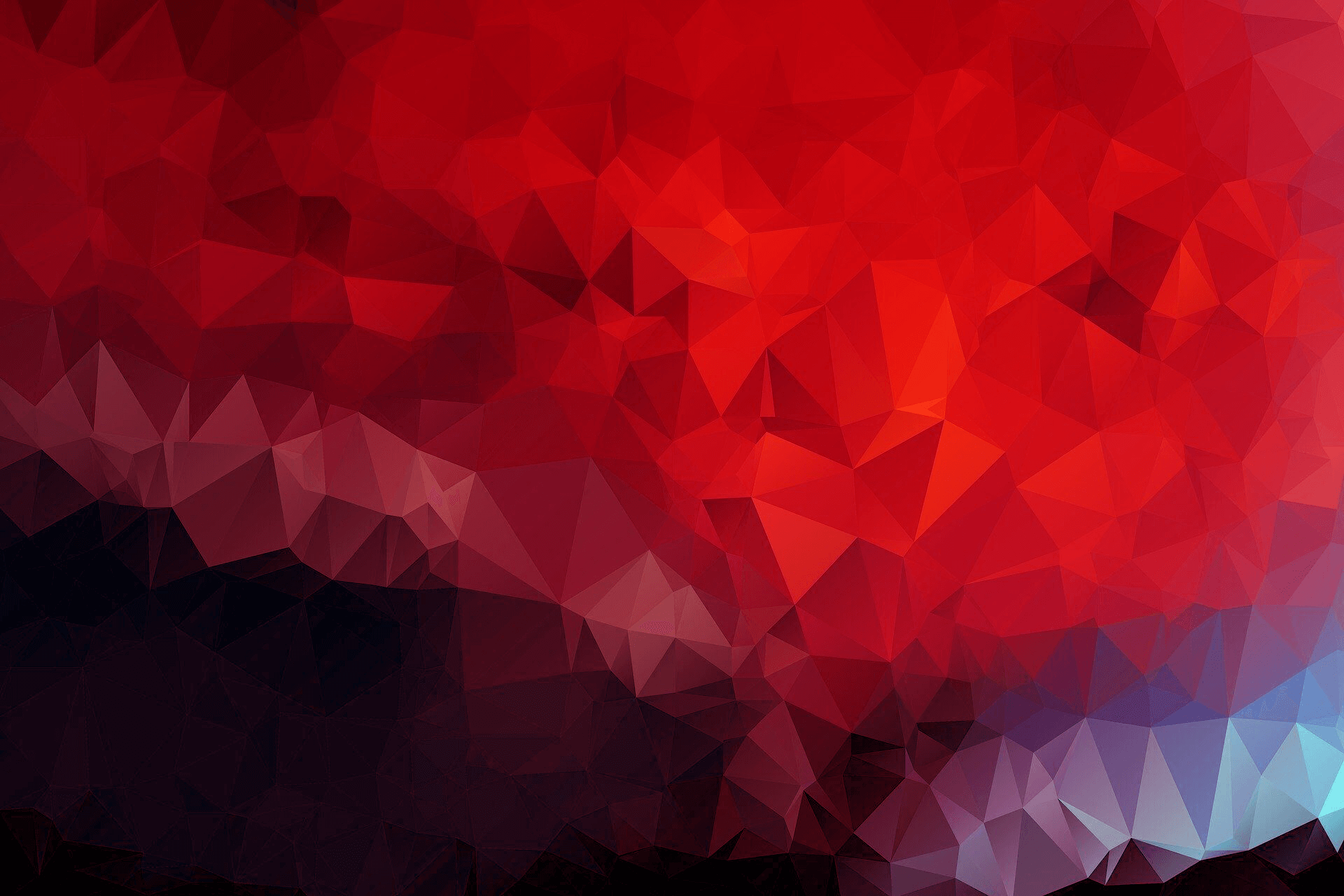SOMMARIO[*]: La rivoluzione tecnologica, prospettando nuove modalità di organizzazione dei servizi di investimento, impone una prospettiva nuova di regolamentazione e di vigilanza a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato finanziario, capace di dialogare con l’intelligenza artificiale. Infatti, la diffusione di tali tecnologie ha inciso profondamente sulle dinamiche del mercato trasformando, tra l’altro, le modalità di erogazione di alcuni servizi tipici come la consulenza finanziaria, che viene oggi prestata anche in forma interamente o parzialmente automatizzata (c.d. “robo-advice”). Per un verso, il ricorso ai servizi di consulenza automatizzata può assicurare benefici per gli investitori in termini di affidabilità delle raccomandazioni formulate e di maggiore inclusione di soggetti tradizionalmente estranei al circuito del mercato finanziario (c.d. “unbanked”). Per altro verso, l’utilizzo di tali strumenti implica anche potenziali rischi, tra cui la tendenza alla uniformità dei comportamenti degli investitori in luogo della valutazione appropriata e adeguata del profilo individuale di ciascuno di essi. In tale contesto, è dibattuta la questione se la consulenza finanziaria automatizzata favorisca o meno scelte di investimento sostenibili da parte degli investitori retail. Al riguardo, le argomentazioni sviluppate nella presente trattazione inducono a ripensare la questione circa il ruolo del robo-advisor non tanto come volano di investimenti sostenibili, quanto piuttosto come strumento volto a favorire una consulenza e una gestione di portafoglio scevra da conflitti di interesse e improntata alla sostenibilità ed efficienza del mercato finanziario nel suo complesso.
ABSTRACT: The technological revolution, by offering new organization models for the provision of investment services, requires a new approach to regulation and supervision that is capable of interacting with artificial intelligence in order to protect investors and the integrity of the financial market. In fact, the spread of such systems and technologies deeply affects market dynamics, including by transforming the way in which certain typical services are provided, such as financial advice, which is now also provided in a fully or partially automated form (so-called “robo-advice”). On the one hand, the use of automated advisory services can bring benefits for investors in terms of reliability of the recommendations and greater inclusion of individuals who are traditionally outside the financial market circuit (so-called “unbanked”). On the other hand, the use of such tools also involves potential risks, including a tendency towards uniformity in investors’ behaviors rather than appropriate and adequate assessment of each investor’s individual profile. In this context, the issue as to whether automated financial advice promotes sustainable investment decisions by retail investors is debated. In this regard, the arguments developed in this paper lead to rethink the role of robo-advisors not as a driver of sustainable investments, but rather as a tool aimed at promoting advice and portfolio management free from conflicts of interest and focused on the sustainability and efficiency of the financial market as a whole.
1. Introduzione: automazione dei processi decisionali nella quarta rivoluzione industriale.
L’evoluzione tecnologica del primo decennio del terzo millennio, nota anche con l’espressione di “quarta rivoluzione industriale” [1], sta plasmando in profondità i meccanismi produttivi dell’economia globalizzata con l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi decisionali, finora sede privilegiata dell’attività dell’uomo. Nella prospettiva del giurista, poi, con l’industria 4.0, abitata dalle smart factories, l’intelligenza artificiale, da fattore produttivo dell’organizzazione diviene, in parte, essa stessa organizzazione dei fattori produttivi.
Con particolare riferimento al mercato finanziario, la rivoluzione tecnologica, prospettando nuove modalità di organizzazione dei servizi di investimento, impone una prospettiva nuova di regolamentazione, anche a livello secondario, e di vigilanza, a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato finanziario, capace di dialogare con l’intelligenza artificiale[2]. Se il clima, nel mercato finanziario, è da quarta rivoluzione, ancorché tecnologica, la risposta del legislatore europeo oscilla tra due poli opposti: da un lato sembra prospettare regulatory sandboxes[3], zone franche che fungono da incubatori del mercato in cui gli attori possano sperimentare le nuove tecnologie; dall’altro, mosso dallo spettro delle potenzialità eversive dell’intelligenza artificiale, affida soprattutto ai regulatory technical standards dell’ESMA il difficile compito di imbrigliare le novità finanziare in una disciplina che, seppur a protezione degli interessi degli investitori e dell’integrità del mercato, rischia di aumentare enormemente i costi di compliance del sistema.
2. Mercati finanziari ed efficienza informativa.
Nella prospettiva di regolazione del mercato interessa, ai fini della nostra indagine, esplorare la rilevanza, dal lato dell’offerta e da quello della domanda, delle informazioni al fine di ricostruire la prospettiva, mutevole nel tempo, di conformazione del legislatore dei meccanismi di formazione del prezzo di mercato dei prodotti finanziari.
Dal lato dell’offerta, difatti, il mercato deve garantire al venditore, nella prospettiva della concorrenza con gli altri partecipanti al mercato stesso, di rendere disponibili, per i consumatori, le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del bene. Dal lato della domanda, il dato del prezzo, unitamente alle altre informazioni sulla tipologia di prodotto, deve consentire il meccanismo di regolazione delle scelte di consumo, necessariamente ancorate vuoi al prezzo vuoi alle caratteristiche dei prodotti offerti da valutarsi in termini di funzionalità rispetto alle aspettative di consumo.
Il tema di indagine, se calato nel mercato finanziario, è connotato da elementi di specialità, a ragione delle caratteristiche dei prodotti scambiati nel mercato finanziario.
Graduando le tipologie di beni in funzione della modalità di assegnazione di un giudizio di valore da parte del consumatore, la dottrina economica ha proposto una tripartizione tra le differenti categorie di prodotti – search goods, experience goods e credence goods – che sintetizza tre differenti gradi di processabilità delle informazioni da parte del consumatore e, dunque, tre differenti modalità di attribuzione del valore al bene. Viene, così, utilizzata l’espressione di “search good” per indicare quei beni, tipicamente di consumo, che impongono al cliente un’attività di ricerca, ex ante e sul mercato, avente ad oggetto la qualità dei beni o servizi offerti, condizionata anche dalla provenienza da un determinato venditore, e la loro funzionalità ai bisogni di consumo dell’individuo stesso. In questo caso il soggetto, consumatore, è protagonista, non sostituibile in base alle caratteristiche personali di ogni individuo, del processo di selezione del bene maggiormente rispondente ai propri bisogni. Ne risulta che tutta la legislazione consumeristica è fortemente incentrata sulla trasparenza, sebbene sia segnata, più di recente, da un intervento di eteronormazione da parte anche delle autorità indipendenti, funzionale alla conformazione del mercato. In una diversa prospettiva, invece, si collocano la categoria degli experience goods, cui possono essere ricondotti quei beni (tipicamente negoziati sul mercato secondario dei beni usati) o servizi (come la ristorazione), il cui giudizio di valore è possibile solo ex post, dopo aver consumato/acquistato il prodotto o dopo aver usufruito del servizio.
I prodotti finanziari sono, invece, ascrivibili alla terza categoria dei c.d. credence goods, o beni di secondo grado, il cui giudizio sul valore di scambio, recte sul prezzo di mercato, è possibile solo processando una serie complessa di informazioni non accessibili direttamente dall’investitore, ma unicamente per il tramite di rappresentazioni fornite direttamente dall’emittente/offerente[4]. Nel caso dei prodotti finanziari il mercato, difatti, tramite il prezzo, « opera una valutazione di secondo grado »[5] che quantifica il rischio dell’investimento secondo due parametri rappresentati (i) da i profili soggettivi dell’emittente/offerente, inteso come il soggetto giuridico titolare dell’iniziativa della raccolta del risparmio (ii) e dai profili oggettivi dello strumento finanziario, che si determinano in base all’inventario dei diritti incorporati nei prodotti finanziari immessi sul mercato.
Con l’espressione « efficienza informativa » del mercato dei capitali, meglio nota con l’acronimo EMH tratto dall’espressione efficient market hypothesis [6], si è inteso riferirsi all’idoneità del prezzo (che, si ripete, rappresenta il valore di scambio) degli strumenti finanziari ad esprimere un giudizio sul valore (stavolta fondamentale) dell’investimento nel mercato finanziario per consentire, all’investitore, di assumere una decisione in ordine alla destinazione del proprio risparmio. In altre parole, si verrebbe a realizzare quella « situazione cioè in cui il mercato è in grado di apprezzare le informazioni in esso disponibili; in cui in sostanza, il prezzo è idoneo a rifletterle »[7]. Da ciò, si è osservato, discendono quattro corollari: (i) « il prezzo diviene il segnale che per così dire incorpora le informazioni presenti sul mercato »; (ii) « il prezzo rappresenta esso stesso un’informazione »; (iii) « il prezzo è in grado di variare solo a seguito di nuove informazioni al momento non conosciute »; (iv) e le variazioni di prezzo « non sono definizioni prevedibili »[8].
Il ragionamento, allora, si sposta sulla individuazione dei meccanismi che consentano (1) la formazione di un prezzo in grado di esprimere il valore di (non scambio ma forse più propriamente) posizionamento del prodotto finanziario nel mercato primario e, ipso tempore, (2) garantiscano al mercato di individuare le caratteristiche tipologiche distintive dei prodotti di nuova immissione.
Sui due temi, si è sottolineato come la via da seguire sia garantire la disponibilità condivisa delle informazioni sulle caratteristiche dell’emittente e degli strumenti finanziari tra i partecipanti al mercato, realizzando quel c.d. level playing field che colma le asimmetrie informative esistenti tra gli investitori, vuoi per ragioni connesse alla funzione privilegiata ricoperta da alcuni nelle strutture di corporate governance (i c.d. insiders, da contrapporsi agli outsiders), vuoi a ragione delle competenze professionali in materia di investimenti (sophisticated e unsophisticated investors)[9].
Il ragionamento non è, tuttavia, andato esente da critiche, da parte di chi ha argomentato che gli investitori “non sofisticati” riceverebbero una forma reale di tutela, non attraverso la disponibilità delle informazioni, nel quadro della EMH, ma dalla presenza di investitori c.d. informati, dotati di una abilità tecnica nel processo di valutazione dei prodotti finanziari e, così, di fissazione del prezzo nel mercato primario, e di agevolazione, nel mercato secondario, di un processo efficiente di allineamento del valore di scambio al valore (che supra si è definito) fondamentale. In altre parole, si sposterebbe il piano del ragionamento: non garantire la capacità dei singoli di processare le informazioni per il tramite di un accesso indiscriminato alle informazioni da parte di tutti gli investitori, ma la presenza di informed traders nel mercato, le cui negoziazione, su base sistematica, asseconda i meccanismi virtuosi di formazione del prezzo[10].
Neppure questo ragionamento è, tuttavia, andato esente da critiche. Al riguardo, si è fatto notare che altro è l’efficienza informativa, intesa come capacità del mercato di incorporare nel prezzo le informazioni inerenti i prodotti finanziari; altro è l’efficienza valutativa (anche nota come efficienza fondamentale), intesa come idoneità dei prezzi dei prodotti finanziari a rappresentare un giudizio corretto sul valore dell’investimento in termini anche di aspettative di remunerazione dell’investitore[11]. Il tema è interessante e sembra evocare quella distinzione tra valore di scambio e valore fondamentale da cui siamo partiti, ma soprattutto sposta il piano dell’indagine sui meccanismi di formazione del prezzo del titolo.
Dal dibattito (che si è brevemente riportato) se ne ricava il monito di evitare di cadere nel tipico caso di c.d. Nirvana fallacy, commettendo l’errore di ritenere che esistano soluzioni astrattamente ideali di misurazione del valore del prodotto finanziario che poi scontano l’impossibilità di ricorrere a concreti mezzi di misurazione[12].
3. Crisi del paradigma della razionalità dell’investitore: metacognizione ed eteroregolazione nelle scelte di investimento.
Le teorie classiche e neoclassiche del decisore razionale si basano sul principio per cui ogni scelta è funzionale a processare le informazioni disponibili nella prospettiva di una scelta ottimale per l’individuo, per via mediata dai meccanismi di mercato, per la collettività. Avvalendosi, in particolare, dei risultati degli studi cognitivi, le azioni umane potrebbero spiegarsi sulla base di pochi elementi: (a) gli scopi; (b) un insieme di opzioni di azione; (c) un criterio, quello della massimizzazione dell’utilità attesa[13], in base al quale ipotizzare le conseguenze di tali opzioni. È di tutta evidenza che solo un decisore ideale, onnisciente e onnipotente, avrebbe a disposizione e sarebbe in grado di utilizzare tutte le informazioni relative alle varie scelte possibili. Senza considerare che un criterio simile comporterebbe un dispendio di tempo notevole, che andrebbe a contraddire i principi evoluzionistici della conservazione della specie[14].
I primi studi di behavioral economics mettono in crisi il paradigma neoclassico che fonda l’efficienza del mercato sull’azione dell’investitore razionale che compie scelte consapevoli perché informato[15]. Contestualmente la crisi finanziaria insorta nel 2008 mostra con chiarezza i segni di una razionalità limitata degli investitori in grado di compromettere la capacità di apprezzare soprattutto i prodotti complessi, mostrando di contro atteggiamenti di emulazione di condotte altrui (c.d. herd behavior[16]), eccessiva fiducia, nonostante la non adeguata educazione finanziaria, nelle operazioni di mercato (c.d. overconfidence) e avversione alle perdite (c.d. loss aversion)[17].
La spiegazione delle dissonanze cognitive[18] dell’investitore, anche professionale[19], viene dalle scienze cognitive. Analizzando, di fatti, le caratteristiche del ragionamento decisionale[20], emerge come l’individuo sistematicamente utilizzi le c.d. «euristiche di ragionamento»[21] da intendersi come “scorciatoie” della mente funzionali alla risoluzione di problemi. Così, pur non seguendo i principi propri della logica formale, si compiono scelte soggettive qualificabili come “economiche ed efficaci” in relazione ai propri scopi[22]. La mente, in altre parole, può essere vista come un «apparato (sottosistema) di regolazioni finalistica del comportamento di un sistema, sulla base di rappresentazioni»[23].
Le categorie basilari dell’attività mentale sono, infatti, considerate (i) le “conoscenze” definite anche con l’espressione “stato percepito”, cioè una rappresentazione che l’agente tende ad adeguare al mondo per ottenere il successo della sua azione[24]; e (ii) gli “scopi” definiti come “stato regolatore”, nel senso di una rappresentazione mentale a cui l’agente cognitivo cerca di adeguare il mondo tramite l’azione[25]. Sicché la “conoscenza” è altro rispetto all’informazione, poiché sconta la prospettiva soggettiva con cui l’individuo processa l’informazione; quanto agli “scopi”, poi, vanno letti in stretta relazione con le “credenze”, ossia con quel convincimento, soggettivo anch’esso e così fallibile, della funzionalità di un’azione a realizzare lo scopo stesso. Un sistema mentale così organizzato può compiere le scelte in modo implicito, cioè perseguendo lo scopo attraverso euristiche del ragionamento (procedura più rapida), e/o in modo esplicito, cioè ponderando le valutazioni attraverso più complesse argomentazioni (procedura più lenta)[26].
L’abbandono della retorica del decisore “razionale” perché “informato” non comporta tuttavia, una svalutazione della filosofia della trasparenza sul prodotto, bensì ne suggerisce una formulazione, che seppur sconti una consapevolezza sui limiti cognitivi del risparmiatore, non rinunci a sollecitare la necessaria attività di comprensione dei fatti, che non può essere mai negata nei processi di conoscenza dell’uomo[27]. In questa nuova prospettiva, occorre prendere le mosse, nell’esaminare la disciplina della trasparenza obbligatoria, dalla considerazione che il ragionamento decisionale dell’investitore si basa (non sulla razionalità bensì) sulla “metacognizione”[28], intesa come conoscenza dinamica acquisita (non per il tramite della rielaborazione razionale perché oggettiva delle informazioni ma) per il tramite di “metarappresentazioni” ossia attraverso la rielaborazione, necessariamente soggettiva e perciò non razionale, delle informazioni che la mente umana è in grado di produrre. Al fine di rafforzare l’attività metacognitiva dell’investitore, agevolando le inevitabili euristiche del ragionamento decisionale, il legislatore impone modelli di prospetto, diversamente strutturati, maggiormente idonei a rappresentare le informazioni rilevanti e, in aggiunta, introduce ulteriori presidi alla trasparenza sul prodotto, quali il Key Investor Information Document (KIID) nella Direttiva 2009/65/UE (c.d. UCITS IV) per i prodotti del risparmio gestito e, il Key Investor Document (c.d. KID) nella Regolamentazione 2014/1246/UE (c.d. PRIIPS), per la commercializzazione dei prodotti complessi[29].
Ciò posto, l’attività metacognitiva, pur necessaria, non è sufficiente a garantire all’investitore – utilizzando l’espressione dell’art. 6 del Regolamento Prospetto – « una valutazione con cognizione di causa ». Lo statuto normativo del mercato primario deve, necessariamente, essere conformato alla realizzazione di un (inevitabile) sistema di « accudimento del risparmiatore »[30], introducendo, in definitiva, precipui meccanismi di “eteroregolazione” delle scelte di investimento del risparmiatore che tengano conto dei rischi sottesi all’acquisto di prodotti immessi nel mercato primario.
Gli esiti in ordine ai limiti cognitivi dell’investitore nel processare le informazioni rilevanti, si è detto, non minano il primato e la necessità, nel sistema del mercato regolato, dell’informazione obbligatoria, bensì suggeriscono di giustapporre agli obblighi di trasparenza precipui meccanismi di eteroregolazione delle scelte dell’investitore, in cui le euristiche di ragionamento funzionali alle scelte dell’investitore siano, dal diritto privato regolatorio, fortemente orientate verso decisioni, coerenti con i bisogni e così con le aspettative dell’investimento, che il risparmiatore, soprattutto retail, non è in grado di assumere da solo.
Due i (nuovi) tasselli della regolamentazione: da un lato, il rafforzamento dei doveri di protezione dell’intermediario nella relazione negoziale con il cliente; dall’altro l’introduzione di regole di governo del prodotto finanziario, riferibili vuoi all’intermediario produttore e distributore (c.d. product governance) vuoi all’autorità di vigilanza del mercato, interno ed europeo (c.d. product intervention).
Quanto al primo aspetto, la Direttiva n. 65/2014/CE, c.d. MiFID II, riscrivendo le regole di condotta, graduate secondo la tipologia di servizio di investimento prestato, segna il passaggio verso un sistema di tutela dell’investitore centrato, più che sulla capacità dell’individuo di compiere scelte razionali, sugli obblighi di comportamento degli intermediari. Tra questi spicca, per una possibile (e secondo alcuni pervasiva) deriva paternalistica[31], la regola dell’adeguatezza che, anche scavalcando le indicazioni del singolo risparmiatore, fa gravare sull’intermediario la valutazione sulla rispondenza della decisione di investimento ai bisogni del cliente[32]. La regola della adeguatezza, poi, pensata nel sistema MiFID come canone dei soli servizi di consulenza e di gestione dei portafogli, viene, dalle autorità di vigilanza, estesa, in via interpretativa, a tutti i servizi di investimento, con la conseguenza, in punto di applicazione della disciplina, di assoggettare alla verifica della adeguatezza ogni operazione che l’investitore compia per il tramite dell’intermediario[33].
Dal nuovo apparato di norme, emerge così «uno sforzo cooperativo che l’ordinamento pretende dall’intermediario per supplire alle distorsioni cognitive normalmente indotte nella clientela dalla complessità dei servizi prestati» e si spinge fino al «punto di accompagnare il cliente verso la conclusione di un regolamento di interessi il più possibile commisurato alla sua fisionomia e ai suoi bisogni»[34]. Il tema della relazione fiduciaria tra intermediario ed investitore rileva anche sul piano dell’informazione da prospetto, nella misura in cui la vicenda finanziaria dell’offerta al pubblico e dell’ammissione a quotazione, possa far emergere una accessorietà funzionale della consulenza alle operazioni di acquisto da parte del cliente[35].
Il secondo strumento regolatorio, introdotto, sempre con la MiFID II, ai fini di tutela dell’investitore e che si affianca così ai presidi di trasparenza e ai doveri di protezione in capo agli intermediari, riguarda il governo del prodotto. Ci si riferisce, in particolare, alle regole di product governance che impongono agli intermediari, nella strutturazione dei prodotti finanziari e nella distribuzione degli stessi, modalità organizzative funzionali a garantire l’immissione sul mercato di prodotti « concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali » e « fare in modo che gli strumenti siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell’interesse del cliente » (così art. 24, § 2, MiFID II)[36].
A ciò si aggiunga, con una prospettiva ancor più marcatamente paternalista, il potere di product intervention, riconosciuto alle autorità di vigilanza, nazionali ed europee, di vietare o limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati strumenti finanziari (artt. 40-43 Regolamento n. 600/2014/UE, c.d. MiFIR). In altre parole, fissando ex ante il divieto di compiere scelte di investimento che ricadano su alcuni prodotti finanziari, è rimesso all’autorità di vigilanza « il compito di selezionare quali e chi debbano essere i soggetti più deboli e più meritevoli di essere protetti, e a tutela dei quali verrebbero allora posti quelli che (…) altro non sarebbero, a ben vedere, che limiti legali alla capacità al compimento di specifici atti negoziali caratterizzati in ragione della specificità dell’oggetto »[37].
In conclusione, in una prospettiva di paternalismo libertario[38], il legislatore, pur incentivando, con le regole sulla trasparenza obbligatoria, l’attività discrezionale dell’investitore, introduce la previsione di poteri, in capo a soggettisti pubblici (le autorità di vigilanza) e privati (gli intermediari), che ex ante siano in grado consentire quella «valutazione con cognizione di causa» predicata dall’art. 6 del Regolamento Prospetto (ed invero anche dall’art. 24. §. 5, MiFID II).
4. Pluralità dei modelli organizzativi della consulenza automatizzata. Princìpi e problemi.
Tutto ciò premesso, si è anticipato in apertura del presente contributo che la diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) ha inciso profondamente sulle dinamiche del mercato finanziario; e ciò anche trasformando le modalità di erogazione di alcuni servizi tipici come la consulenza finanziaria, che viene oggi prestata anche in forma interamente o parzialmente automatizzata (c.d. “robo-advice”)[39].
Più specificatamente, con l’espressione robo-advice si è soliti richiamare un’ampia categoria di fattispecie accomunate dalla circostanza che il servizio di consulenza di investimento viene prestato attraverso piattaforme online preimpostate e operanti sulla base di algoritmi che elaborano raccomandazioni per la creazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di portafogli di investimento rispondenti alle caratteristiche degli utenti-investitori[40].
Tale processo può avvenire in forma totalmente automatizzata in tutte le sue fasi (c.d. robo-advice puro), ovvero con la parziale integrazione di forme di interazione umana in uno o più stadi della prestazione del servizio (c.d. robo-advice ibrido) oppure, ancora, mediante l’impiego dei sistemi di IA di supporto all’agente umano che si interfaccia con l’utente finale (c.d. robo-for-advisor)[41].
In ciascuno dei modelli organizzativi sopra richiamati, l’automazione dell’attività di consulenza – sia essa pura, ibrida o a servizio dell’agente umano – consente al cliente di ottenere raccomandazioni di investimento a basso costo rispetto all’intermediazione tradizionale, elaborate sulla base delle informazioni fornite tramite appositi questionari online che permettono all’algoritmo di classificare il profilo dell’investitore in diverse aree di interesse (ad es., conoscenza ed esperienza finanziaria, situazione patrimoniale, obiettivi di investimento, propensione al rischio, preferenze in materia di sostenibilità, ecc.). Una volta alimentato con le suddette informazioni, l’algoritmo è quindi in grado di elaborare un piano di investimento coerente con le caratteristiche dell’utente, il quale ha poi la possibilità di dare seguito a tali raccomandazioni di investimento direttamente tramite la piattaforma che le ha fornite – ove essa lo consenta – oppure mediante un diverso intermediario[42].
Sotto il profilo normativo e regolamentare, fermo il noto principio della neutralità tecnologica – che comporta l’applicazione della normativa esistente al medesimo servizio fornito a prescindere dal mezzo utilizzato – le regole applicabili all’esercizio dell’attività di robo-advisory variano a seconda che le raccomandazioni fornite dal sistema di IA siano o meno “personalizzate” rispetto al profilo dell’investitore che se ne avvale.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 58/1998 (Tuf), per “consulenza in materia di investimenti” si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. Pertanto, laddove la piattaforma di robo-advice – sulla base delle caratteristiche tecniche che ne regolano il funzionamento – fornisca una consulenza effettivamente “personalizzata” in favore dell’utente finale, è ragionevole ritenere che a tale attività si applicherà la disciplina regolamentare a ciò correlata (ad es., le regole di condotta cui soggiacciono gli intermediari abilitati all’esercizio dell’attività di consulenza loro riservata).
Diversamente, nel caso in cui l’algoritmo elabori informazioni standard – i.e., non “personalizzate” rispetto al profilo del potenziale investitore (ancorché generalmente attinenti a tale tipologia di utente medio, ad es., pensionato, neolaureato, lavoratore dipendente con un certo reddito, ecc.) – sembra possibile ritenere che non si configuri l’attività di consulenza prevista dal Tuf, trovando comunque applicazione altri presìdi a tutela dell’utilizzatore finale (ad es., quelli in materia di attività pubblicitaria ex art. 101 Tuf).
Inoltre, come anticipato, la piattaforma di robo-advice potrebbe supportare il cliente – oltre che nella fase iniziale dell’investimento – anche nella successiva attività di monitoraggio e gestione dello stesso. Ad esempio, la piattaforma potrebbe fornire all’utente ulteriori raccomandazioni di investimento al fine di indurre l’investitore a formulare, mediante la stessa piattaforma online, nuovi ordini di acquisto e/o di dismissione, ovvero potrebbe finanche procedere automaticamente al ribilanciamento di tale portafoglio ove il cliente abbia sin dall’inizio conferito apposito mandato in tal senso all’intermediario in questione. Tutto ciò allo scopo di consentire all’investitore di mantenere l’esposizione derivante dal proprio portafoglio di investimenti coerente con il proprio profilo di rischio nel corso del tempo e/o di incrementare i profitti e ridurre le perdite, ecc.
Ne deriva che siffatta attività, in base alle concrete modalità in cui essa si configura e al contenuto del mandato conferito da ciascun utente, potrebbe essere riconducibile anche a quella di “gestione di portafogli” di cui all’art. 1, comma 5-septies, del Tuf, per tale intendendosi “la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti”.
Di qui l’opportunità, evidenziata ad ogni livello[43], di operare una rivisitazione in chiave applicativa delle regole di condotta degli intermediari finanziari al fine di meglio adattarle alle peculiari modalità di erogazione dei servizi di cui trattasi, che – come visto – prescindono dalla presenza, anche solo parziale, di un agente umano quale interfaccia del cliente finale ovvero quale responsabile del procedimento nelle varie fasi dello stesso.
Ciò apre la strada a due ordini di considerazioni.
Per un verso, l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario – e in particolare nell’ambito della prestazione di servizi di consulenza – può assicurare benefici per gli investitori: ad esempio, essa può portare i soggetti abilitati a formulare raccomandazioni di investimento più affidabili[44] in ragione dell’ampia base di dati disponibili e processabili in poco tempo. Ancora, è stato osservato che il robo-advice risponde a un tentativo di “democratizzazione” del servizio di consulenza funzionale a favorire l’inclusione finanziaria di soggetti che solitamente non si avvalgono dei canali tradizionali (c.d. soggetti unbanked)[45] o che non rappresentano il profilo “ideale” di cliente per un consulente finanziario professionale (ad esempio poiché titolari di un reddito non sufficientemente elevato). Del pari, altri autori hanno rilevato che l’utilizzo di sistemi informatici in grado di profilare correttamente il cliente, per un verso, impedisce agli intermediari più spregiudicati di approfittarsi di investitori inesperti e, per altro verso, esclude la possibilità che i consulenti umani possano essere vittima di errori cognitivi nelle valutazioni loro demandate[46].
Per altro verso, è stato altresì evidenziato che il ricorso ai servizi di consulenza finanziaria automatizzata implica anche potenziali rischi quali, ad esempio, la tendenza di uniformità di comportamenti degli investitori, in luogo della valutazione appropriata e adeguata al profilo di ognuno (c.d. effetto herding)[47].
Ciò deriva, in primo luogo, dalla tendenza – riscontrata a livello internazionale – per cui “advice provided by robo-advisors tends to be quite uniform. (…) the overwhelming majority of robo-advisors recommend investment funds, mutual funds or, even more often, ETFs” secondo un approccio “numbers-based” [48].
In secondo luogo, la circostanza che i servizi di robo-advisory consentano – in ragione del minor costo della consulenza e della maggiore facilità di accesso – un ampliamento della platea dei potenziali investitori implica al contempo che i destinatari di tali raccomandazioni, specie quelli meno esperti, possano essere indotti ad assumere rischi eccessivi a causa di un eccesso di confidenza nei propri mezzi e dell’assenza di un confronto (challenge) con un consulente umano professionale.
Allo stesso modo, non si può escludere, da un lato, che i meccanismi di profilazione adottati dalla piattaforma siano insufficienti a identificare adeguatamente[49] il profilo di rischio del cliente (ad es., perché le domande incluse nel questionario online non sono abbastanza dettagliate oppure perché il cliente non le comprende fino in fondo oppure, ancora, perché l’utente fornisce le risposte con troppa approssimazione) e che, dall’altro lato, il funzionamento dell’algoritmo possa risentire di errori di valutazione e bias cognitivi dei soggetti che li hanno programmati (con la conseguenza, peraltro, di aprire potenzialmente la strada a complessi contenziosi aggravati dalla non chiara attribuzione di responsabilità in caso di malfunzionamento del software)[50].
In questa ultima prospettiva, tale ulteriore elemento di rischio è stato recentemente oggetto di attenzione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha evidenziato la necessità di operare un delicato compromesso tra l’incremento dell’accuratezza predittiva e la riduzione della spiegabilità dei modelli utilizzati per la valutazione automatizzata. Infatti, sebbene i modelli di IA, soprattutto c.d. machine learning, impiegati per il robo-advisory possano migliorare significativamente le performance nelle previsioni, la loro complessità e l’opacità dei processi decisionali[51] possono altresì non rispettare i diritti degli interessati, specialmente il diritto alla comprensione e contestazione della decisione automatizzata di cui all’art. 22, par. 3 GDPR[52].
In questo contesto, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-203/22 del 27 febbraio 2025, ha sancito il principio fondamentale in base al quale l’interessato ha il diritto di ottenere una spiegazione significativa sulla logica utilizzata nel processo decisionale automatizzato[53], avendo tuttavia a riferimento un caso di credit scoring, ossia il metodo automatizzato e statistico attraverso il quale gli intermediari analizzano la solvibilità dei richiedenti credito e che, nel tempo della quarta rivoluzione industriale, utilizza tecniche di IA e machine learning[54].
La Corte ha precisato che il diritto di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nell’imporre al titolare del trattamento di fornire informazioni chiare, concise e facilmente accessibili, attraverso la descrizione dei principi e della procedura seguiti per la valutazione automatizzata, non si limita a richiedere la mera comunicazione della formula algoritmica, bensì una descrizione comprensibile delle modalità con cui i dati personali sono utilizzati per determinare un risultato specifico[55], come, nel caso di specie, la solvibilità di un individuo[56].
Tale pronuncia rappresenta un punto rilevante nell’evoluzione del rapporto tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, ribadendo la centralità del principio di trasparenza anche nell’ambito delle decisioni algoritmiche. Ne discende che, anche nel contesto della consulenza finanziaria automatizzata, sarà imprescindibile garantire un adeguato bilanciamento tra l’efficienza predittiva degli strumenti di IA e il rispetto dei diritti dell’interessato, attraverso modelli che, pur nella loro complessità, consentano un livello di intelligibilità sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi imposti dalla normativa regolante il sistema finanziario e le previsioni in materia di tutela dei dati personali ai sensi del GDPR.
5. La consulenza finanziaria automatizzata favorisce scelte di investimento sostenibili?
Come visto, l’accezione più ampia di attività di robo-advisory – accolta dal legislatore europeo della MiFID II – ricomprende sia l’attività di consulenza finanziaria sia l’attività di gestione di portafogli (asset management).
I dati empirici mostrano che il volume delle masse gestite dalle imprese di investimento che si avvalgono di servizi di consulenza automatizzata, e il numero di clienti che hanno deciso di rivolgersi a tali advisory firm, è significativamente aumentato nel corso degli anni (specie negli Stati Uniti, dove l’attività di robo-advice e di digital asset management si è sviluppata sin dalla fine degli anni 2000)[57].
La diffusione della consulenza automatizzata ha quindi effettivamente ampliato la platea di potenziali investitori disponibili a immettere risorse nel circuito del mercato finanziario. Di conseguenza, si è accresciuta la capacità di tali intermediari di indirizzare gli investimenti di un numero crescente di risparmiatori attraverso la formulazione di raccomandazioni personalizzate e l’esecuzione di operazioni di acquisto/dismissione individuate sulla base dei dati elaborati dai sistemi di intelligenza artificiale.
Ciò posto, è noto come le istituzioni europee e internazionali abbiano intrapreso numerose iniziative volte a evidenziare lo stretto legame esistente tra nuove tecnologie, sostenibilità e finanza (si pensi, ad es., all’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, al Green Deal europeo, ecc.). Le nuove tecnologie, si afferma, rappresentano un volano per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale[58].
In questa prospettiva, ci si domanda se il ricorso alla consulenza automatizzata sia uno strumento utile a favorire scelte di investimento sostenibile da parte del pubblico retail.
È noto, infatti, che il legislatore europeo ha previsto l’obbligo per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari di integrare i rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance nei loro processi decisionali, come parte del loro dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.
Assume rilievo in tal senso, in primo luogo, la definizione di “investimento sostenibile” contenuta nel Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari[59]. Il provvedimento mira a favorire la comparabilità dei prodotti finanziari distribuiti nel mercato allo scopo di evitare distorsioni nelle scelte di investimento dei risparmiatori.
Vi è poi il Regolamento delegato (UE) 2021/1253, che ha modificato il citato regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento. Per effetto di detto intervento le imprese di investimento – incluse dunque, in virtù del citato principio della neutralità tecnologica, le robo-advisory firm – debbono, tra l’altro, fornire una descrizione dei fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari raccomandati al cliente e avere riguardo alle eventuali preferenze di sostenibilità manifestate dallo stesso al momento della profilazione e dei successivi aggiornamenti.
Le suddette innovazioni normative, unitamente all’analisi dei dati empirici disponibili in merito al profilo tipico dei maggiori fruitori dei servizi di consulenza automatizzata, hanno indotto ad individuare nel robo-advice lo strumento ideale per favorire la scelta verso investimenti sostenibili da parte degli investitori retail[60].
Ciò posto, si ritiene tuttavia opportuno formulare alcune sintetiche considerazioni in merito alla effettiva capacità dei meccanismi di consulenza automatizzata di favorire scelte di investimento sostenibile da parte degli operatori del mercato finanziario.
In primo luogo, è stato osservato come i servizi di robo-advisory sino ad oggi prestati prevalentemente da operatori già presenti sul mercato con un posizionamento ben consolidato, spesso mediante l’avvio di joint venture e partnership con imprese Fintech[61]. La prestazione di tali servizi da parte di start-up e imprese puramente Fintech è oggi residuale.
La ragione di ciò è da ascrivere al fatto che gli incumbent individuano nelle nuove tecnologie uno strumento che consente di ampliare il portafoglio clienti, ridurre i costi di erogazione del servizio ed evitare che nuovi operatori possano sottrarre loro quote di mercato.
È innegabile, dunque, che le imprese che operano attraverso strumenti di robo-advisory, al pari di qualsiasi altra impresa commerciale, siano orientate alla creazione di un profitto. Ciò è possibile in quanto l’impresa di investimento sia in grado di trattenere i propri clienti e acquisirne di nuovi. A tal fine, è necessario che i clienti delle imprese di investimento registrino a loro volta un profitto derivante dagli investimenti effettuati (seppur in un orizzonte temporale e in una misura variabile a seconda delle preferenze espresse nel questionario di valutazione). Studi empirici recenti mostrano infatti che la maggior parte dei risparmiatori non è disposta a sacrificare il ritorno economico in nome di iniziative di sostenibilità meno profittevoli[62].
Del resto, si è detto che il successo della consulenza automatizzata si deve alla capacità di tale strumento di rendere disponibile a soggetti c.d. unbanked una consulenza professionale e personalizzata. Il robo-advisory rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale clienti non ideali per un consulente tradizionale – solitamente perché non dotati di una capacità reddituale tale da garantire significativi margini di guadagno al consulente – possono affacciarsi sul mercato finanziario ed eventualmente beneficiare di profitti derivanti da investimenti finanziari che gli sarebbero altrimenti preclusi attraverso i canali tradizionali. Ciò dimostra che il cliente di una robo-advisory firm si avvale di tale servizio primariamente per conseguire utili derivanti dall’investimento. I dati empirici mostrano altresì che difficilmente il cliente muta il proprio profilo di investimento nel corso di un rapporto profittevole al solo fine di perseguire interessi “altri” rispetto a quello lucrativo[63].
D’altra parte, è stato osservato che l’ordinamento mette a disposizione modelli organizzativi diversi dall’impresa lucrativa per gli operatori che intendano perseguire finalità diverse dalla mera creazione di un profitto (es., associazioni, fondazioni, società benefit, ecc.)[64].
A ciò si aggiunga, come detto, che le stesse robo-advisory firm sono società commerciali volte alla creazione di un profitto. Pertanto, è difficile immaginare che tali imprese di investimento possano di default suggerire investimenti sostenibili a discapito di altri potenzialmente più profittevoli. E ciò sia in quanto tale raccomandazione sarebbe contraria allo scopo lucrativo dell’impresa stessa sia perché essa potrebbe essere contraria al migliore interesse del cliente.
A tale ultimo riguardo, la stessa ESMA ha osservato che “i fattori di sostenibilità non dovrebbero prevalere sull’obiettivo di investimento personale di un cliente. Le preferenze di sostenibilità dovrebbero pertanto essere trattate nell’ambito del processo di valutazione dell’adeguatezza solo dopo che è stato individuato l’obiettivo di investimento del cliente” [65].
Peraltro, si è detto che gli algoritmi che dominano il funzionamento delle imprese di robo-advise operano secondo un’ottica numbers-based, ossia valutano le proposte di investimento sulla base del rendimento dello strumento finanziario nel passato più o meno recente. Tale impostazione induce a domandarsi se gli investimenti Esg, in ragione del loro eventuale minore rendimento nel tempo rispetto ad altri tipi di investimento più profittevoli, siano anche solo presi in considerazione dall’algoritmo ai fini dei suggerimenti da formulare al cliente.
In quest’ottica, a ben vedere, la consulenza “umana” presenta dei vantaggi, poiché demanda all’agente umano la sensibilità circa l’individuazione delle reali propensioni del cliente, affidando la raccomandazione di investimento – oltre che al calcolo matematico – anche all’intuizione e all’esperienza del consulente.
A ciò si aggiunga che la consulenza umana incorpora una componente di educazione finanziaria per il cliente, che è invece pressoché inesistente nel robo-advice e che rappresenta probabilmente lo strumento più efficace per orientare le decisioni di investimento degli utenti verso la finanza sostenibile.
Tutto ciò premesso, resta fermo che l’attività del robo-advisor deve rimanere orientata al perseguimento del migliore interesse per il cliente. Da ciò derivano due ordini di considerazioni ulteriori.
In primo luogo, se il cliente debitamente informato esprime una netta preferenza per gli investimenti sostenibili al momento della sua profilatura, allora un algoritmo ben funzionante dovrebbe formulare raccomandazioni di investimento che prediligano la sostenibilità dell’investimento, se del caso a discapito di un migliore rendimento in termini economici.
In secondo luogo, si ritiene che il servizio offerto dall’impresa di investimento (sia tradizionale che automatizzata) dovrebbe sempre tendere a una crescita sostenibile del portafoglio di investimento del cliente, unendo la propensione al rendimento alla diversificazione del rischio di portafoglio. Tale obiettivo virtuoso consentirebbe la soddisfazione del cliente e il raggiungimento degli obiettivi di stabilità ed efficienza del mercato finanziario.
Ci si domanda, ad esempio, come reagirebbe un algoritmo dedicato alla gestione automatizzata di un portafoglio se i titoli in esso presenti dovessero subire improvvisamente una significativa svalutazione? L’algoritmo procederebbe in automatico alla vendita di quei titoli per limitare la perdita del cliente (amplificando però la svalutazione dei titoli medesimi e i riflessi sistemici connessi al rischio di default dell’emittente)? L’algoritmo ragionerebbe allo stesso modo se anche altri clienti della stessa impresa di investimento avessero investito in quegli stessi titoli?
Tali domande inducono a ripensare la questione circa il ruolo del robo-advisor non tanto come volano di investimenti sostenibili, quanto piuttosto come strumento volto a favorire una consulenza e una gestione di portafoglio scevra da conflitti di interesse e improntata alla sostenibilità ed efficienza del mercato finanziario nel suo complesso in quanto tale obiettivo coincide con il migliore interesse del cliente.
* Anche se il lavoro è frutto di una riflessione comune, i §§ 1, 2 e 3 sono da attribuirsi a Paola Lucantoni mentre i §§ 4 e 5 a Lorenzo Locci.
[1] Sull’impatto della quarta rivoluzione industriale nel mondo produttivo v. L. Yang, Industry 4.0. A Survey on technologies, applications and open researches issues, 6 Journal on Industrial Information Integration 1 (2017).
[2] In argomento cfr. D. Zetzsche, R. Bucley, D. Arner and J. N. Barneris, Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation, European Banking Institute Working Paper Series No. 11 (2017); T.C.W. Lin, The New Investor, in 60 UCLA L. Rev. 678 (2013); V. Caivano, S. Ciccarelli, G. Di Stefano, M. Fratini, G. Gasparri, M. Giliberti, N. Linciano, I. Tarola, Il trading ad alta frequenza. Caratteristiche, effetti, questioni di policy, CONSOB, Discussion Papers, 5 dicembre 2012; e, con particolare riferimento alla digitalizzazione della consulenza finanziaria, Robo Advice, cfr. CONSOB, La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, Quaderni FinTech, 3 gennaio 2019.
[3] È la prospettiva seguita in riferimento alle Distributed Ledger Technologies su cui sia consentito il riferimento a P. Lucantoni, Distributed Ledger Technology e infrastrutture di negoziazione e post-trading, in R. Lener (a cura di), FinTech: diritto, tecnologia e finanza, Quaderno di Minerva bancaria, 2018, p. 97 ss.
[4] Su questi temi cfr. R. Kerschbamer-M. Sutter-U. Dulleck, How Social Preferences Shape Incentives in (Experimental) Markets for Credence Goods, in 126 Econ J (2017), p. 393 dove una analisi delle inefficienze informative originate nel mercato dei credence goods, tra cui i servizi legali, i servizi informatici, caratterizzati da una superior information of the seller about the surplus-maximising quality. Nella letteratura interna, con particolare riferimento ai servizi finanziari la cui rispondenza del prezzo del servizio al giudizio di valore sull’utilità attesa dal cliente dipende dalla relazione negoziale tra intermediario e cliente ma anche da fattori macroeconomici che sfuggono al controllo delle parti cfr. F. Cesarini, I servizi finanziari: il punto di vista dell’economista, in I servizi del mercato finanziario. In ricordo di Gerardo Santini, Milano, 2009, p. 28.
[5] Così, in riferimento al mercato delle azioni, G. Ferri jr., Investimento e conferimento, Milano, 2001, p. 197. L’A., a p. 189, osserva come se il sistema del codice considera la partecipazione azionaria innanzitutto come uno « strumento di investimento », nella regolamentazione del mercato finanziario viene al contrario intesa tendenzialmente in termini di « oggetto di scambio » e dunque oggetto di « un sistema di scambi » che è il mercato; ancora di più, la partecipazione azionaria può essere intesa come un « prodotto » che circola nel mercato finanziario. Il collegamento tra azione e mercato caratterizza, poi, lo stesso fenomeno azionario complessivamente considerato, posto che « l’adozione dello strumento azionario risulta diretta non tanto e non solo alla circolazione della partecipazione sociale, quanto piuttosto alla formazione del relativo mercato in quanto sistema autonomo di valutazione, e dunque in quanto sistema di prezzi ». L’A. inoltre, a p. 191 testo e nt. 130, osserva come « la formazione del mercato finisce per (ed appare diretta ad) attribuire un autonomo valore alla azione, quello, appunto, di mercato, nell’ambito del quale la duplicità dei valori (nominale e reale) della azione viene per così dire superata: e se la funzionalità della azione si esaurisce nel mercato, si deve allora concludere che la presenza di un duplice valore, reale e nominale, della azione consegue appunto al fatto che essa rappresenta l’esito di una tipizzazione della partecipazione, e non viceversa ». In questo stesso senso, in riferimento al mercato secondario, C. Angelici, La circolazione della partecipazione azionaria, in Tratt. delle soc. per az., diretto da G.E Colombo e G.B. Portale, 2*, Torino, 1991, p. 131 ss. secondo cui la standardizzazione dell’azione risultante dalla tecnica azionaria agevola « l’instaurazione e il funzionamento di un mercato secondario che abbia per oggetto l’unità azionarie: un mercato nel quale ad esse, proprio perché prefigurate in termini oggettivi (…) è possibile assegnare uno specifico valore », peraltro suscettibile « entro certi limiti, di prescindere dal valore stesso del patrimonio sociale ». In argomento anche A. Tucci, La violazione dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto, Milano, 2008, in part. p. 34 ove l’osservazione che nel mercato finanziario «le azioni (e, eventualmente, gli altri «strumenti finanziari») – e indirettamente, le situazioni soggettive in esse incorporate – vengono in rilievo, fondamentalmente, come oggetto di scambio».
Così la formazione del prezzo, poi, si basa sulla logica del mercato e può portare ad un valore diverso da quello reale, ancorché ad esso collegato; la funzione dell’azione è, secondo G. Ferri jr., Investimento e conferimento, cit., p. 193 e nt. 137 allora, «quella di riconoscere alla partecipazione sociale un prezzo unitario, riferito cioè a quella unità che si denomina appunto azione». Ne consegue che in presenza di pluralità di categorie di azioni il mercato esprimerà per ciascuna un prezzo. Nello stesso senso M. Maugeri, Partecipazione sociale, quotazioni di borsa e valutazione delle azioni, in Riv. dir. comm., 2014, I, p. 93 ss. e M. Maugeri-H. Fleischer, Problemi giuridici in tema di valutazione delle azioni del socio recedente: un confronto tra diritto tedesco e diritto italiano, in Riv. dir. soc., 2013, p. 94 ss.
[6] Come noto, la tesi della efficienza del mercato dei capitali è stata introdotta nel dibattito dottrinario da E. F. Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, in 25 Journal of Finance (1970), p. 383 ss. L’efficienza informativa è stata, con un ragionamento che ad avviso di chi scrive si muove più sul piano del mercato secondario, declinata secondo tre livelli di efficienza nel mercato dei capitali. La forma debole di efficienza assume che i prezzi degli strumenti finanziari riflettano tutte le informazioni disponibili al pubblico nel periodo precedente ma non siano in grado di assorbire le nuove informazioni non ancora disponibili. In aggiunta, sempre in ipotesi di efficienza debole, si presume che le informazioni storiche sui prezzi, volumi e rendimenti delle negoziazioni degli strumenti finanziari non siano in grado di fornire una previsione attendibile sui prezzi futuri. La forma semi forte della teoria dell’efficienza del mercato dei capitali incorpora i postulati della forma debole e aggiunge la considerazione che i prezzi si aggiustano velocemente alla comparsa di nuove informazioni sul mercato stesso; ne risulta così un aggiornamento continuo dei prezzi di mercato dei prodotti finanziari. La versione forte di efficienza informativa si spinge oltre considerando che il prezzo di mercato sia in grado di incorporare tutte le informazioni, non solo quello disponibili pubblicamente nel tempo ma anche quelle riservate ad un delimitato gruppo di soggetti. La versione forte di efficienza porta così a negare che eventuali insiders possano estrarre benefici privati dallo sfruttamento di informazioni riservate.
Per una indagine sui meccanismi effettivi con cui l’informazione viene assorbita nel prezzo v. R. Gilson-R. Kraakman, The mechanism of market efficiency, in 70 Virginia Law Review (1984), p. 549 ss. e sempre gli stessi autori The mechanisms of market efficiency twenty years later: the hindsight bias, in 28 Journal of Corporation Law (2003), p. 717 ss. Su questi temi si veda anche D.C. Langevoort, Theories, Assumptions, and Securities Regulation: Market Efficiency Revisited, in 140 University of Pensilvenia Law Rev (1992), p. 851; W.A. Klein-J.C. Coffee jr., Business Organization and Finance, Westbury, New York, 1996, p. 392 ss.; M. Rubinstein, Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case, in 57 Financial Analysts Journal (2001), p. 15 ss.
[7] Così C. Angelici, Note in tema di informazione societaria, in F. Bonelli, V. Buonocore, F. Corsi, R. Costi, P. Ferro-Luzzi, A. Gambino, P.J. Jaeger, A. Patroni Griffi (a cura di) Milano, 1998, p. 251.
[8] Così C. Angelici, op.loc.ultt.citt.
[9] Sulla funzionalità dell’informazione obbligatoria alla formazione del prezzo di mercato a tutela dell’investitore, v. M.B. Fox, Retaining Mandatory Securities Disclosure: Why Issuer Choice is not Investor Empowerment, in 85 Va. L. R. (1999), p. 1335 ss. secondo cui una maggiore informazione al mercato aumenta la possibilità che i prezzi rappresentino il valore degli strumenti finanziari; Id., The securities globalization disclosure debate, in 78 Washington University Law Quarterly (2000), p. 567 ss., in part. p. 573; Id., Civil liability and mandatory disclosure, in 109 Columbia Law Review (2009), p. 237 ss., in part. p. 252; Su questo tema v. anche M. Kahan, Securities laws and the social costs of “inaccurate” stock prices, in 109 Duke Law Journal (1992), p. 977 ss., in part. p. 985.
[10] Su questi temi, oggetto d’indagine nell’analisi economica del diritto, cfr., F. H. Easterbrook-D. R. Fischel, Mandatory Disclosure and the Protection of Investors, in 70 Virginia Law Review (1984), p. 669 ss., in part. la critica a p. 694 secondo cui il ragionamento sulla necessità di rendere disponibili sul mercato le informazioni a tutela dell’investitore è « as unsophisticated as the investors it is supposed to protect. It disregards the role of markets in impounding information in prices. So long as informed traders engage in a sufficient amount of searching for information and bargains, market prices will reflect all publicly available information ». Si veda in argomento anche G. Hertig-R. Kraakman-E. Rock, Issuers and investor protection, in R. Kraakman-J. Armour- P. Davies-L. Enriques- H. B. Hansmann-G. Hertig-K. J. Hopt-H. Kanda- E Rock (eds.), The Anatomy of Corporate Law – A comparative and Functional Approach, Oxford, 2004, p. 193 ss., in part. p. 206 e L. Gullifer-J. Payne, Corporate Finance Law, Principles and Policy, 2nd ed., Portland, 2015, p. 486 ss.
[11] Sulla duplicità della prospettiva di valutazione dell’efficienza cfr. I. Ayres, Back to basics: regulating how corporations speak to the market, in 77 Va. L. Re. (1991), p. 945 ss.; J. N. Gordon-L. A. Kornhauser, Efficient markets, costly information, and securities research, in 60 N.Y.U.L. Rev., (1985), p. 761 ss. e, da ultimo, S.J. Choi-A.C. Pritchard, Securities regulation: cases and analysis, 3rd ed., New York, 2020, p. 52.
[12] Il monito è di R.J. Gilson-R. Kraakman, The mechanisms of market efficiency twenty years later: the hindsight bias, cit., p. 715 ss., in part. p. 716. Si veda anche D.C. Langevoort, Taming the animal spirit of the stocks markets: a behavioral approach to securities regulation, in 97 Nw. U. L. Rev. (2002), p. 135 ss., in part. p. 140.
[13] Su questi temi si rinvia, per gli aspetti più propriamente cognitivi, a J. Von Newman-O. Morgenstern, Theory of games and economic behavior, Princeton University Press, 1994; V. Girotto, Il ragionamento, Il Mulino, 1994 e M. Marraffa, Psicopatologia, scienza cognitiva e filosofia della mente, in Sistemi intelligenti, 1998, p. 320 ss.
[14] F. Mancini-A. Gangemi, Il paradosso nevrotico ovvero della resistenza al cambiamento, in C. Castelfranchi-F. Mancini-M. Miceli (a cura di), Fondamenti di cognitivismo clinico, Torino, 2002; F. Mancini-A. Gangemi, Ragionamento e razionalità, ibidem sottolineano come vari studi sperimentali fanno osservare come anche individui normali producono sistematicamente degli errori nel ragionamento decisionale. Ad esempio, è stato ampiamente studiato l’effetto focalizzante secondo cui se poniamo ad un soggetto una domanda, la maggior parte degli individui normali tenderanno a focalizzare l’attenzione sull’approfondimento proposto piuttosto che sulle alternative possibili come dovrebbe fare un decisore ideale. Così V. Girotto-P. Legrenzi-M. Sonino, Ragionamento, decisione e teoria dei modelli mentali, in Sistemi Intelligenti, 1995, VII, 3, p. 477 ss.; P. Legrenzi-V. Girotto-P. N. Johnson-Laird, Focusing in reasoning and decision-makig, in 49 Cognition, 1993, p. 37 ss. È questo un processo simile a quello che è stato definito ragionamento psuedo-diagnostico, secondo cui quando ci troviamo di fronte alla necessità di verificare un’ipotesi, tendiamo a cercare di completare le informazioni relative all’ipotesi esistente, piuttosto che raccogliere elementi per confutarla cercando ipotesi alternative. Y. Trope-A. Liberman, Social hypothesis testing: cognitive and motivational mechanism, in E. T. Higgins-A. W. Kruglanski, Social psychology: handbook of basic principles, Guilford, 1996, p. 239 ss. che dimostrano come la maggior parte degli individui con patologie psicologiche producono sistematicamente ragionamenti pseudo-diagnostici.
Secondo J. Baron, Thinking and Deciding, Cambridge, 2000, passim, è conveniente e funzionalmente adattivo prendere decisioni in modo rapido e far sì che il decisore reale non ottimizzi o massimizzi l’utilità attesa, ma si accontenti di prestazioni soddisfacenti. In questa luce, il comportamento decisionale più razionale non è quello ideale che si rivela lungo, faticoso, costoso e dunque decisamente non conveniente dal punto di vista adattivo, ma quello che si limita ad accettare la linea di condotta giudicata più soddisfacente. A questo punto è conseguente che il decisore reale deve disporre di un criterio di “soddisfacimento” in base al quale, in un dato momento, può interrompere l’analisi costi-benefici delle opzioni e decidere.
Un ingrediente fondamentale del processo decisionale sono le emozioni, processi mentali prevalentemente inconsci che svolgono il ruolo di selezionare e portare nel flusso di coscienza uno scenario limitato di scelte alternative, svolgono una funzione valutativa più generale, e favoriscono la tendenza all’azione. In argomento, ex multis, K. Oatley-P. N. Johnson-Laird, Towards a cognitive theory of emotions, in 1, Cognition and emotion, (1987), p. 29 ss.; A. R. Damasio, Emotion in the perspective of an integrated nervous system, in 26 Brain Research Reviews (1994), p. 83 ss.
La teoria del “portfolio” coniata da R. L. Leahy, Depressive decision making: validation of the portfolio theory model, in 15 Journal of Cognitive Psycotherapy (2001), p. 341 ss. per descrivere le modalità tipiche impiegate dai depressi nel prendere decisioni viene utilizzata da H. Markowitz, Portfolio selection, in 7 The Journal of Finance, (1952), p. 77. L’A., in particolare, teorizza che gli individui, nel prendere decisioni, si differenziano tra loro nella valutazione delle loro risorse attuali e future riguardo a: (a) relazioni interpersonali, (b) capacità di stima della predicibilità e del controllo, (c) percezioni e interpretazione dei guadagni e delle perdite, (d) tolleranza del rischio, (e) bisogno di richiedere informazioni prima delle decisioni.
In argomento si veda anche P. Jonson-Laird, P. Legrenzi, M. Sonino Legrenzi, Reasoning and a Sense of Reality, in 63 British Journal of Psychology, (1972), p. 395 e, più di recente, P. Legrenzi, La consulenza finanziaria. Soldi, pensieri ed emozioni, Il Mulino, 2018.
[15] Il primo studio sulla razionalità limitata degli individui risale a H. A. Simon, A behavioral model of rationale choice, in 69 Quarterly Journal of Economics (1955), p. 99 ss. I primi contributi sulla finanza comportamentale sul fallimento del paradigma neoclassico dell’investitore razionale perché informato si devono a W. De Bondt-R. H. Thaler, Does the stock market overreact?, in 40 Journal of Finance (1984), p. 793 ss.; W. De Bondt-R. H. Thaler, Do securitiy analysts overreact?, in 80 American Economic Review (1990), p. 52; posizioni riprese in N. H. Thaleb, Il cigno nero, Milano, 2008; R. H. Thaler-C. R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions on Health, Wealth, and Happiness, New Haven, 2008, e R. H. Thaler, Misbehaving: The Story of Behavioral Economics, New York, 2015. Per la prospettiva dell’analisi economica del diritto v. C. Jolls-C. Sustein-R. H. Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, in 50 Standford Law Review (1998), p. 1471; C. Sustein, Behavioral law and economics: a progress report, in 1 American Law and Economics Review (1999), p. 155.; e A. Shleifer, Inefficient Markets – An Introduction to Behavioral Finance, Oxford, 2000, p. 10 ss.
[16] Così D. S. Scharfstein-J. C. Stein, Herd Behavior and Investment, in 80 The American Economic Review (1990), p. 465; K A. Froot-D. S. Scharfstein-D.C. Stein, Herd on the street: Informational inefficiencies in a market with short-term speculation, in 4 The Journal of Finance (1992), p. 1461; J. R. Graham, Herding Among Investment Newsletters: Theory and Evidence, in 1 The Journal of Finance (1999), p. 237 secondo cui “a newsletter analyst is likely to herd on Value Line’s recommendation if her reputation is high, if her ability is low, or if signal correlation is high”; e di H. W. Micklitz, Herd behavior and third party impact as a legal concept, in Contract Governance. Dimensions in Law and Interdisciplinary Research, Oxford, 2015, p. 152 secondo cui « herd behavior amounts to no more than an indicator to raise awareness ».
Sulla necessità di assumere decisioni non emulative di altri si leggano le osservazioni di J. M. Keynes, The General Theory of Employment, London, 1936, p. 58: “finally it is the long-term investor, he who most promotes the public interest, who will in practice come in for most criticism, wherever investment funds are managed by committees or boards or banks. For it is in the essence of his behaviour that he should be eccentric, unconventional and rash in the eyes of average opinion. If he is successful, that will only confirm the general belief in his rashness; and if in the short run he is unsuccessful, which is very likely, he will not receive much mercy. Worldly wisdom teaches that it is better for reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally”.
[17] V. nella analisi economica del diritto più attenta ai risultati delle scienze cognitive E. Avgouleas, The Global Financial Crisis and the Disclosure Paradigm in European Financial Regulation: The Case for Reform, cit., p. 440. In riferimento ai limiti della trasparenza nei casi di mutui subprime O. Bar-Gill, The law, economics and psychology of subprime mortgage contracts, in 94 Cornell Law Review (2009), p. 1073
[18] L’espressione «dissonanze cognitive» si deve a L. Festinger, A theory of cognitive dissonance, Standford, 1957.
[19] In argomento si vedano le considerazioni di G. Spindler, Behavioural Finance and Investor Protection Regulations, in 34 Journal of Consumer Policy (2011), p. 321 secondo cui “the financial crisis forces us to reconsider the traditional paradigms of rational of market participants. Obviously, even professionals of financial intermediaries suffered from irrationalities and psychological effects thus aggravating other factors of the crisis”. Cfr., altresì, CFA Institute, Designing a European Summary Prospectus Using Behavioral Insights, March 2017, disponibile su https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/designing- a-european-summary-prospectus.ashx?la=en&hash=05868EC687A61ED02F78FC 9644B04F0C28B989FA.
Da segnalare anche l’incidenza della overconfidence sui giudizi delle agenzie di rating, la cui attività, pur essendo orientata a ridurre le asimmetrie informative ha, tuttavia, generato, soprattutto tra gli intermediari e gli investitori professionali, un affidamento eccessivo e non mediato da analisi personali. In argomento cfr. le riflessioni contenute in IOSCO, Code of Conduct for Credit Rating Agencies (2004) (http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD180.pdf) e in FSB, Principles on Reducing Reliance on Credit Ratings (2010): http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_101027.pdf
[20] Operare delle scelte è, come mostra la scienza cognitiva, un’operazione cognitiva incessante, segnata da diversi gradi di consapevolezza e variamente connotata, anche emotivamente, al mutare della nostra vita quotidiana. Sui meccanismi cognitivi cfr., nella letteratura italiana, A. Carcione-M.C. De Marco- G. Dimaggio- M. Procacci- A. Semerari- G. Niccolò, La regolazione delle scelte nei disturbi di personalità, in Cognitivismo Clinico, 2004, p. 32 ss. Osservano gli Autori, a p. 34, che «le azioni di un agente cognitivo sono guidate e regolate da scopi» ma «anche se scopi e azioni sono interconnessi, non tutti gli scopi richiedono l’elaborazione cosciente di un piano ».
[21] Sul tema amplius D. Kahneman-A. Tversky, Judgment under uncertainty: heuristics and biases, in 185 Science (1974), p. 1124 dove gli autori segnalano l’importanza delle euristiche di ragionamento come scorciatoie per operare delle scelte di fronte a problemi complessi e in condizioni di incertezza ed identificano vari casi di bias cognitivi collegati a tali euristiche e gli errori seri e sistematici cui possono condurre.; D. Kahneman-A. Tversky, Prospect theory: an analysis of decision under risk, cit., p.263; T. Gilovich-D. Griffin-D. Kahneman, Heuristic and Biases – The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge, 2002.
[22] In tal senso D. Kahneman-A. Tversky, On the psychology of prediction, in 80 Psychological Review (1973), p. 237 ss.
[23] Così M. Miceli-C. Castelfranchi, Le difese della mente, Roma, 1995, p. 77; Id., La cognizione del valore. Una teoria cognitiva dei meccanismi e processi valutativi, Milano, 1992.
[24] Così C. Castelfranchi-M. Miceli, Architettura della mente: scopi, conoscenze e loro dinamica, in C. Castelfranchi-F. Mancini-M. Miceli, Fondamenti di cognitivismo clinico, Torino, 2002, p. 53 ss.
[25] Le più comuni credenze di supporto agli scopi sono: credenze relative al mezzo-fine; credenze di preferibilità; credenze relative ai costi; credenze di raggiungibilità; credenze di raggiungimento; credenze di competenza; credenze condizionali. Così A. Carcione-M.C. De Marco-G. Dimaggio-M. Procacci-A. Semerari-G. Niccolò, La regolazione delle scelte nei disturbi di personalità, cit., p. 32 ss.
[26] Per una ampia prospettazione dei meccanismi sottesi alle scelte si veda D. Kahneman, Pensieri lenti e pensieri veloci, (trad. it. e ristampa), Milano, 2019, passim. Il primato del visibile fa parte di una strategia ancora più generale, per la quale l’A., a p. 96, ha inventato l’acronimo WYSIATI (what you see is all there is). L’A. osserva come «saltare alle conclusioni, sulla base di prove limitate, è talmente importante per comprendere il pensiero intuitivo, e si presenta così spesso in questo libro, che userò una brutta e complicata abbreviazione WYSIATI». Le intuizioni iniziali devono essere rielaborate e superate grazie a pensieri lenti.
[27] Come autorevolmente sottolineato, la conoscenza dell’uomo può essere conseguita «unicamente per l’attività dell’individuo, per sua disposizione recettizia e mai prodotta unicamente dall’esterno». Così S. Pugliatti, voce «Conoscenza», in Enc. dir., vol. IX, Milano, 1961, p. 114.
[28] L’uso del termine metacognizione si trova in J.H. Flavell, Metacognition aspects of problem solving, in L. Resnick (edt by), The Nature of Intelligence, Erlbaum, 1976; Id., Metacognition and cognitive monitoring: a new area of cognitive developmental inquiry, in 34 American Psychologist (1979), p. 906. Nella letteratura italiana cfr., per tutti, A. Carcione-G. Nicolò-A. Semerari, Curare i casi complessi. La terapia metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità, Bari, 2016, p. 22; A. Carcione-G. Nicolò-R. Pedone-R. Popolo- L. Conti- D. Fiore- M. Procaccci- A. Semerari- G. Dimaggio, Metacognitive mastery dysfunctions in personality disorder psycotherapy, in 190 Psychiatry Research (2011), p. 60 ss.
[29] Così N. Moloney, How to protect investors. Lessons from EC and UK, cit., p. 288 ss. che sottolinea la centralità anche dell’educazione finanziaria (c.d. financial literacy). Nello stesso senso A. Perrone, Servizi di investimento e tutela dell’investitore, cit., p. 1 ss. e V. Colaert, Building blocks of investor protection: All-embracing regulation tightens its grip, cit.,p. 229 ss.
Per una posizione tesa ad utilizzare i risultati della economia comportamentale per trarre argomenti a favore della trasparenza obbligatoria rispetto a quella volontaria R. Prentice, Whither securitis regulation? Some behavioral observation regarding proposal for its future, in 51 Duke Law Journal (2002), p. 1397; S. Bainbridge, Mandatory disclosure: a behavioral analysis, in 68 University of Cincinnati Law Review (2000), p. 1023; D. Langevoort, Taming the animal spirits of the stock markets: a behavioral approach to securities regulation, cit., p. 135; S. Choi-A. Pritchard, Behavioral economics and the SEC, in 56 Standford Law Review (2003), p. 1.
Non sono mancate però critiche all’economia comportamentale. Cfr. S. Levitt-J. List, Homo economicus evolves, in 319 Science (2008), p. 909 secondo cui la ricerca dovrebbe integrare i risultati dell’economia comportamentale e delle indagini empiriche per proporre una teoria unificata piuttosto che una collezione di spunti interessanti; e D. Fudenberg, Advancing beyond advances in behavioral economics, in 44 Journal of Economic Literature (2006), p. 694.
[30] L’espressione è di G. Guizzi, Attualità e prospettive nel sistema della tutela del risparmio, in Corriere giur., 2016, p. 745 ss. Nello stesso senso N. Moloney, op. loc. ultt. citt.; V. Colaert, op. loc. ultt. citt.; e A. Perrone, Servizi di investimento e regole di comportamento. Dalla trasparenza alla fiducia, cit., p. 36 ss.
[31] Sul paternalismo giuridico cfr. A. Ogus, The Paradoxes of Legal Paternalism and How to Resolve them, in 30 Leg. Stud. (2010), p. 62 ss. Sul legame tra paternalismo ed efficienza cfr. E. Zamir, The Efficiency of Paternalism, in 84 Va. L. Rev. (1998), p. 229 ss.
[32] Così N. Moloney, How to protect investors. Lessons from the EC and UK., cit., p. 53. In argomento v. A. Tucci, Il contratto inadeguato e il contratto immeritevole, in Contr. e impr., 2017, p. 921 ss.; Id., Profili del contratto nell’investimento finanziario, in Riv. dir. comm., 2016, I, p. 347 ss.; Id., Il rapporto intermediario/cliente, tra “servizio” e “contratto”, in G. Alpa-S. Amorosino-A. Antonucci-G. Conte-M. Pellegrini-V. Sepe-V. Troiano (a cura di), Scritti in onore di F. Capriglione, Padova, 2010, II, p. 809 ss.; sia consentito altresì il rinvio a P. Lucantoni, Le regole di condotta degli intermediari finanziari, in I contratti del mercato finanziario, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, 2a ed., tomo 1°, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino, 2011, p. 239-278; A. Antonucci, Declinazioni della suitability rule e prospettive di mercato, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, p. 728 ss.; Ead., Regole di condotta e conflitti di interesse, in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, p. 9 ss. e C. Brescia-Morra, Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini, in R. D’Apice (a cura di), L’attuazione della MiFID in Italia, Bologna, 2010, p. 517 ss.
Sul tema, proponendo una maggiore integrazione delle tutele tra settori bancari, assicurativi e finanziari, V. Colaert, Product Information for Banking, Investment and Insurance Products, in V. Colaert-D. Busch-T. Incalza (edt by), European Financial Regulation. Levelling the Cross-Sectoral Playing Field, Oxford, 2019, p. 303 ss.. Per una diversa impostazione v. R. Natoli, Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, cit., p. 184 che, in riferimento al mercato finanziario sottolinea come: «Tutto ciò comporta che le tutele contrattuali tipiche sui mercati finali come le regole d’informazione e i recessi di pentimento risultino, in questo sistema normativo, necessari ma non sufficienti. A esse si aggiungono tutele più avanzate, di tipo non procedurale ma sostanziale, come i regolamenti adeguati. Tali tutele più avanzate, riposando sull’asimmetria cognitiva immanente alla negoziazione di beni complessi, esibiscono però una ratio specifica che le rende inestensibili ad altre relazioni contrattuali nelle quali sussiste soltanto la mera ricorrenza fattuale di un’asimmetria informativa o di una debolezza economica».
[33] Si veda, al riguardo, la posizione assunta, al livello europeo, dal Cesr, Cesr’s Technical Advice on Possible Implementing Measures of The Directive 2004/39/EC on MiFID, 2005; ESMA, Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements, July 2012; e nel contesto interno Consob, Documento di consultazione per l’attuazione della direttiva MiFID – Schede di approfondimento. I servizi e le attività di investimento. Alcune nozioni, 2007.
[34] Così R. Natoli, Il contratto “adeguato”. La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione, Milano, 2012. L’A. sottolinea, a p. 133, «la differenza tra la logica di protezione del consumatore che agisce nei mercati finali la logica di protezione del cliente che opera sui mercati finanziari: nei primi la standardizzazione delle informazioni serve a garantire, per mezzo della trasparenza, la possibilità di istituire confronti su basi omogenee tra i prodotti e i servizi offerte dalle imprese e così a innervare il dinamismo concorrenziale: nei secondi a questa finalità si aggiunge l’esigenza apicale di preservare l’integrità del mercato finanziario e la fiducia dei risparmiatori: per raggiungere le quali occorre, innanzitutto, reagire alla strutturale asimmetria cognitiva che affligge gli acquirenti di beni sofisticati e complessi».
Sul tema della nuova conformazione della relazione fiduciaria tra intermediario cliente, oltre agli autori citati nella nota n. 70, cfr. P. Mülbert-A. Sajnovits, The Element of Trust in Financial Markets Law, in 18 German L. J (2017), p. 6 ss.; O. Cherednychenko, Contract Governance in EU: Conceptualising the Relationship between Investor Protection and Private Law, in 21 Eur. L. J (2015), p. 500 ss.; L. Purpura, L’evoluzione “fiduciaria” dei doveri di comportamento dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento alla clientela al dettaglio, in Banca, borsa, tit. cred., 2013, I, p. 222 ss.; R. Colombo, Trust and Reform of Securities Regulation, in 35 DJCL (2010), p. 835 ss.; L. Klöhn, Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: a Behavioural Law & Economics Perspective, in 10 EBOR (2009), p. 439 ss.
[35] In argomento v. altresì M. Libertini, La tutela della libertà di scelta del consumatore e i prodotti finanziari, in M. Grillo (a cura di), Mercati finanziari e protezione dei consumatori, 2010, p.1 ss, in part. p. 44, secondo cui per i risparmiatori «il problema principale non è quello di poter scegliere liberamente e consapevolmente un prodotto finanziario anziché un altro, bensì quello di potersi fidare quasi per intero di un intermediario di fiducia ».
[36] Su questi temi cfr. D. Busch, Product Governance and Product Intervention under Mifid II/MiFIR, in D. Busch-G. Ferrarini (edt by), Regulation of the EU Financial Markets. MiFID II and MiFIR, Oxford, 2017, p. 123 ss.; V. Troiano, La product governance, in V. Troiano-R. Motroni (a cura di), La Mifid II. Rapporti con la clientela. Regole di governance. Mercati, Padova, 2016, p. 215 ss.
[37] Così G. Guizzi, Attualità e prospettive nel sistema della tutela del risparmio, cit., p. 752 e V. Colaert, The MiFIR and PRIIPs Product Intervention Regime: In Need of Intervention, in ECFR (2020), p. 99 ss. Si veda, da ultimo, per un’applicazione degli strumenti a protezione degli investitori durante l’emergenza sanitaria del Covid-19 F. Annunziata, La distribuzione di prodotti di investimento e l’emergenza sanitaria. Una proposta (2020), in www.dirittobancario.it.
[38] In argomento il riferimento è a R. H. Thaler-C. R. Sustein, Libertarian Paternalism in not an Oxymor, in 70 U. Chi. L. Re. (2003), p. 1159 ss. e Id., Libertarian Paternalism, in 93 The American Economic Review (2003), p. 175 ss., in part. p. 179 ove la considerazione che libertarian paternalism è « an approach that preserves freedom of choice but that authorizes both private and public institutions to steer people in directions that will promote their welfare ».
[39] Cfr. F.Consulich, M. Maugeri, C.Milia, T.N.Poli, G.Trovatore, AI e abusi di mercato: le leggi della robotica si applicano alle operazioni finanziarie?, in Quaderni giuridici Consob, n. 29, maggio 2023, disponibile all’indirizzo www.consob.it, pp. 15 ss.
[40] Cfr. M.T.Paracampo, La consulenza finanziaria automatizzata, in Fintech. Introduzione ai profili giuridici di un mercato unico tecnologico dei servizi finanziari, a cura di M.T.Paracampo, Torino, 2017, pp. 127 ss.
[41] Cfr. C.Schena, A.Tanda, C.Arlotta, G.Potenza, Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e rischi per l’industria finanziaria nell’era digitale, in Quaderni FinTech Consob, n. 1, marzo 2018, disponibile all’indirizzo www.consob.it, pp. 36 ss.
[42] Cfr. F.De Santis, La disintermediazione (umana) nel servizio di consulenza MIFID (Robo Advice), in Sostenibilità e mercato finanziario. Questioni aperte e profili comparati, a cura di E.Corapi, Milano, 2023, pp. 127 ss.
[43] Cfr., ad esempio, ESAs, Joint Committee Report on the results of the monitoring exercise on ‘automation in financial advice’, 5 settembre 2018, disponibile all’indirizzo www.esma.europa.eu.
[44] Cfr. F.Consulich, M. Maugeri, C.Milia, T.N.Poli, G.Trovatore, ult. op. cit., p. 16.
[45] Cfr. M.T.Paracampo, ult. op. cit., p. 128.
[46] Cfr. D.Rossano, La consulenza finanziaria automatizzata e la tutela degli investitori, in FinTech, a cura di F.Fimmanò e G.Falcone, Napoli, 2019, pp. 210 ss.
[47] Cfr. F.Consulich, M. Maugeri, C.Milia, T.N.Poli, G.Trovatore, ult. op. cit., p. 16.
[48] Cfr. P.Maume, Regulating Robo-Advisory, in Texas International Law Journal, August 2018, disponibile all’indirizzo www.ssrn.com, pp. 22 ss.
[49] A tale riguardo, preme ricordare che l’art. 54 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), prevede espressamente che: “[q]uando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell’adeguatezza compete all’impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione”.
[50] In arg. cfr., tra gli altri, R.Lener, Intelligenza artificiale e interazione umana nel robo-advice, in Riv. trim. dir. econ., suppl. al n. 3/2021, disponibile all’indirizzo www.fondazionecapriglione.luiss.it, pp. 101 ss.; D.Rossano, ult. op. cit., pp. 219 ss.; M.Rabitti, Intelligenza artificiale e finanza. La responsabilità civile tra rischio e colpa, in Riv. trim. dir. econ., suppl. n. 2 al n. 3/2021, disponibile all’indirizzo www.fondazionecapriglione.luiss.it, pp. 295 ss.; V.Falce, Data strategy e finanza digitale. Il caso della “consulenza automatizzata”, in Assicurazioni – Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private, 2022, pp. 429 ss.; R.Ghetti, Robo-advice: automazione e determinismo nei servizi di investimento ad alto valore aggiunto, in Banca borsa tit. cred., n. 4, 2020, pp. 540 ss.; M.T.Paracampo, ult. op. cit., p. 141.
[51] Sul tema dell’opacità delle scelte decisionali dell’algoritmo, la c.d. black box cfr. F.Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms that Control Money and Information, Harvard University Press, Cambridge MA 2015; nonché, R.Messinetti, La tutela della persona umana “versus” l’intelligenza artificiale. Potere decisionale dell’apparato tecnologico e diritto alla spiegazione della decisione automatizzata, in Contr. e impr., 2019, pp. 861 ss.;
[52] Sul tema cfr. N.Brutti, Mito del consenso e rating reputazionale, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, n.2, 1 Marzo 2024, pp. 402 ss.; per una riflessione interdisciplinare cfr. A.Adinolfi – A.Simoncini (a cura di), Protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e le loro conseguenze, Napoli, 2022.
[53] Questo il principio di diritto enunciato nella sentenza C-203/22 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea «L’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev’essere interpretato nel senso che in caso di processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, l’interessato può pretendere dal titolare del trattamento, a titolo di «informazioni significative sulla logica utilizzata», che quest’ultimo gli spieghi, mediante informazioni pertinenti e in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali relativi a tale interessato al fine di ottenerne un risultato determinato, come un profilo di solvibilità.» disponibile su www.eurlex.it.
[54] Sul tema cfr. E.Bonaccorsi di Patti, F.Calabresi, B.De Varti, F.Federico, M.Affinito, M.Antolini, F.Lorizzo, S.Marchetti, I.Masiani, M.Moscatelli, F.Privitera e G.Rinna, Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers), ottobre 2022; G.Cerrina Feroni, Intelligenza artificiale e sistemi di scoring sociale. Tra distopia e realtà, in Dir. inf., 2023; R.O’Dwyer, Are You Creditworthy? The Algorithm Will Decide, in Undark Magazine, 7 May 2018; L.Ammanati – G.L.Greco, Il credit scoring “intelligente”: esperienze, rischi e nuove regole, in Rivista di diritto bancario, 2023, 461; M.Rabitti, Credit scoring via machine learning e prestito responsabile, in Rivista di diritto bancario, 2023, pp. 175 ss..
[55] Sul tema cfr. M.Temme, Algorithms and Transparency in View of the New General Data Protection Regulation, in European Data Protection Law Review, 2017, vol .3, n. 4 pp. 479 ss.; G.Malgieri G.Comandé, Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation, in International Data Privacy Law, 2017, vol. 7, n. 4, pp. 243 ss.; L.Edwards – M.Veale, Slave to the algorithm? Why a ‘right to an explanation’ is probably not the remedy you are looking for, in Duke Law and Tech. Rev., 2017, n. 1, vol. 16, p. 18 ss.; H.Junklewitz, R.Hanon, G.Malgeri, I.Sanchez, Bridging the gap between AI and explainability in the GDPR: Towards trustworthiness-by-design in automated decision-making, in IEEE Computational Intelligence Magazine, 17 (1), 2022, pp.72 ss.
[56] Sul diritto ad un’informazione adeguata relativa alla logica sottesa nei processi decisionali automatizzati ex art. 15 GDPR, si rimanda alle decisioni della Corte d’appello di Amsterdam del 4.04.2023, casi nn. 200.295.747/01; 200.295.742/01; e 200.295.806/01.
[57] Per riferimenti cfr. P.Maume, ult. op.cit., pp. 11 ss.
[58] In arg. cfr., ex multis, F.Capriglione, Diritto ed economia. La sfida dell’Intelligenza Artificiale, in Riv. trim. dir. econ., suppl. al n. 3/2021, disponibile all’indirizzo www.fondazionecapriglione.luiss.it, pp. 4 ss.
[59] Per “investimento sostenibile” ai sensi del provvedimento indicato nel corpo del testo si intende un “investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.
[60] Cfr. R.Magliano, Greentech e intelligenza artificiale: un nuovo impulso per promuovere sostenibilità e consapevolezza da parte dell’investitore retail, in Sostenibilità e mercato finanziario. Questioni aperte e profili comparati, a cura di E.Corapi, Milano, 2023, pp. 7 ss., ove è altresì precisato che si avvalgono dei servizi di consulenza automatizzata prevalentemente millenials e donne, ossia gli stessi soggetti che appaiono maggiormente interessati a strumenti finanziari etichettabili come green e con spiccate caratteristiche di sostenibilità. Altri dati in merito alla platea di utenti che si rivolgono ai servizi di consulenza automatizzati sono disponibili in Aa.Vv., La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari, Quaderni FinTech Consob, n. 3, gennaio 2019, disponibile all’indirizzo www.consob.it.
[61] Cfr. P.Maume, ult. op.cit., pp. 11 ss.
[62] Cfr. L.Hornuf, C.Merkle, S.Zeisberger, Nudging Investors towards Sustainability: A Field Experiment with a Robo-Advisor, 10 dicembre 2024, disponibile all’indirizzo www.ssrn.com, pp. 22 ss.
[63] Cfr. L.Hornuf, C.Merkle, S.Zeisberger, ult. op. cit., pp. 22 ss.
[64] Cfr. A.Sacco Ginevri, Divagazioni su corporate governance e sostenibilità, in Riv. trim. dir. econ., suppl. n. 3 al n. 1/2022, disponibile all’indirizzo www.fondazionecapriglione.luiss.it, pp. 83 ss.
[65] Cfr., Esma, Relazione finale sull’integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella MiFID II, 30 aprile 2019, disponibile all’indirizzo www.eur-lex.europa.eu.