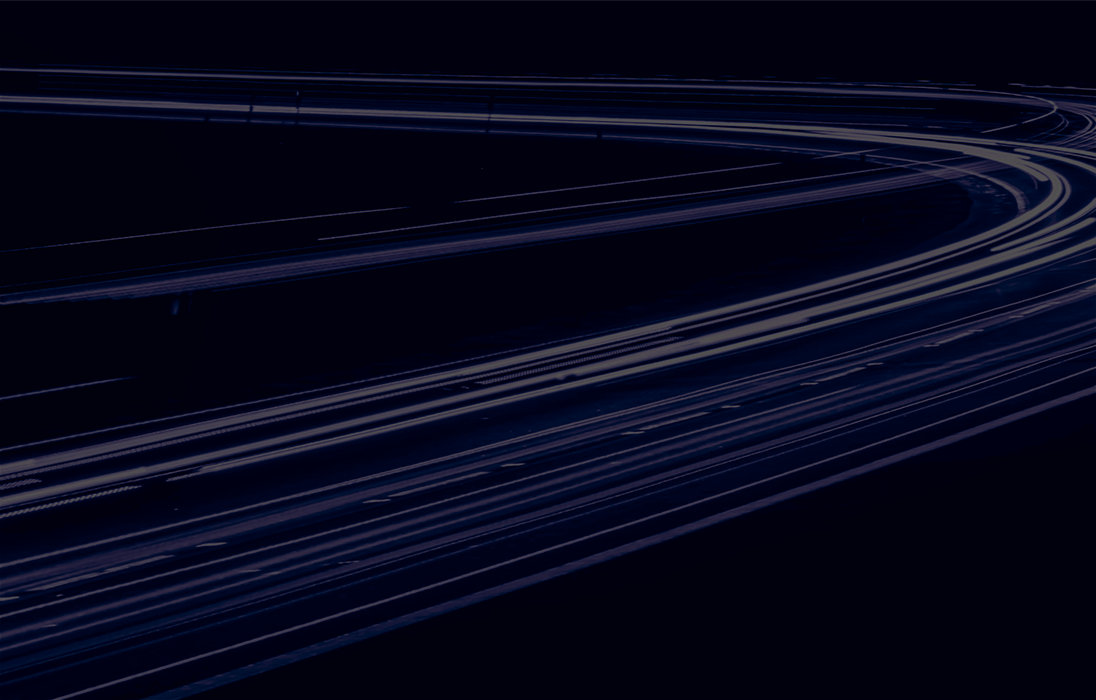Il presente contributo affronta il tema dell’assoggettamento ad IRAP dei dividendi di banche e assicurazioni alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso Banca Mediolanum e delle nuove norme introdotte nella bozza di legge di bilancio 2026.
1. Premessa e perimetro della questione
Nel solco del nostro precedente contributo[1], nel quale pronosticavamo che la Corte di Giustizia UE avrebbe ricondotto l’IRAP entro il vincolo sostanziale della direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia, di seguito la “Direttiva”), la sentenza nel noto caso Banca Mediolanum (C-92/2024, C-93/2024 e C-94/2024)[2] ha ora stabilito che l’articolo 4 della Direttiva osta all’assoggettamento ad IRAP dei dividendi intra-UE percepiti dagli intermediari finanziari, rinviando la valutazione del trattamento IRAP dei dividendi domestici al sindacato di costituzionalità nazionale.
Come noto, quando una società fiscalmente residente percepisce dividendi da società figlie stabilite in altri Stati membri, ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi, tali utili sono esclusi dalla base IRES nella misura del 95 per cento ai sensi dell’art. 89, comma 2, del TUIR, che ha dato attuazione dell’art. 4, par. 1, lett. a), della Direttiva, mentre il residuo 5 per cento resta imponibile, in via forfetaria, a titolo di spese di gestione[3].
Per gli intermediari finanziari, tuttavia, l’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. 446/1997 prevede che il 50 per cento dei medesimi dividendi concorra alla base imponibile IRAP (come componente del margine di intermediazione), con l’effetto che, per i flussi intra-UE, si determina un onere complessivo che eccede, in termini economici, il limite del 5 per cento consentito dalla Direttiva.
È bene rammentare che, similmente, per le imprese di assicurazione, l’art. 7, comma 1, d.lgs. 446/1997 include il 50 per cento dei dividendi nella base imponibile IRAP. Poiché la ratio dell’arresto della Corte di giustizia non dipende dalla qualificazione soggettiva del contribuente, bensì dal congegno del prelievo e dal suo effetto economico rispetto al tetto del 5 per cento sancito dalla Direttiva, l’interpretazione ivi accolta è pienamente estensibile anche al comparto assicurativo: mutatis mutandis, le considerazioni che seguono valgono egualmente per gli intermediari finanziari e per le imprese di assicurazione.
Il nodo interpretativo che la Corte eurounitaria era chiamata a sciogliere è stato perspicuamente descritto dall’Avvocato generale Kokott che nelle sue conclusioni scrive, al punto 29: “la questione, formulata in termini alquanto elaborati, cui la Corte deve dare risposta può essere riassunta come segue: il divieto di tassazione delle distribuzioni di utili percepite a livello della società madre, di cui all’articolo 4 della direttiva madri figlie, è rivolto soltanto contro la doppia imposizione diretta realizzata mediante una tassazione degli utili tramite imposta sul reddito delle società (o un’analoga imposta) oppure riguarda anche la doppia imposizione indiretta tramite un’altra imposta (nel caso di specie, l’IRAP), nella cui base imponibile confluiscono parzialmente i dividendi (…)?”.
La risposta positiva fornita dalla Corte nel caso Banca Mediolanum segna un punto di svolta, con effetti diretti sui giudizi pendenti e immediate implicazioni sistemiche.
2. La sentenza Banca Mediolanum: questione, metodo e portata
La Corte affronta la questione applicando il consueto metodo interpretativo tripartito (letterale, contestuale e teleologico) e perviene alla conclusione che il sistema dell’esenzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva “riguarda qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi che una società madre percepisce dalle sue società figlie residenti in altri Stati membri”, indipendentemente dalla natura dell’imposta medesima.
In particolare, muovendo dal tenore letterale e dalla ratio della Direttiva, la CGUE ribadisce che l’obiettivo perseguito è quello di evitare la doppia imposizione “in termini economici” degli utili distribuiti, così da garantire la neutralità fiscale nella catena distributiva: tale obiettivo impone di considerare ostativa all’articolo 4 della Direttiva anche l’inclusione parziale dei dividendi nella base imponibile di imposte diverse dall’IRES, qual è, appunto, l’IRAP.
Questa lettura è coerente con il canone funzionale già espresso nelle sentenze AFEP[4] e X[5]. In tali arresti la Corte ha precisato che la portata del divieto sancito dall’art. 4, par. 1, lett. a), della Direttiva non è limitata alla sola imposta sul reddito delle società, ma osta anche a prelievi ulteriori che, al momento della distribuzione o della ridistribuzione, includano i dividendi nella base imponibile, qualora ciò determini un onere complessivo superiore alla soglia del 5 per cento. In AFEP l’incompatibilità è stata affermata con riguardo al contributo aggiuntivo del 3 per cento dovuto in Francia in sede di distribuzione dei dividendi; in X è stata esclusa la compatibilità con la Direttiva della fairness tax belga con l’affermazione del principio per cui, una volta scelto il modello dell’esenzione, ogni ulteriore tassazione dei medesimi utili ricrea la doppia imposizione economica che la Direttiva intende prevenire. È in questa prospettiva che la sentenza Banca Mediolanum conclude per l’incompatibilità dell’inclusione del 50 per cento dei dividendi intra-UE nella base imponibile IRAP degli intermediari finanziari.
Il ragionamento trova ulteriore conferma nei richiami alle pronunce Brussels Securities[6] e Schneider Electric[7]. La prima ribadisce l’alternatività dei modelli delineati dall’art. 4 della Direttiva (esenzione oppure credito d’imposta) escludendo che possano combinarsi elementi dell’uno e dell’altro per giustificare prelievi aggiuntivi. La seconda chiarisce che anche meccanismi soltanto in apparenza neutrali, come versamenti anticipati accompagnati da crediti d’imposta, risultano incompatibili quando, in termini economici, spingono il carico oltre la soglia del 5 per cento: ciò che rileva è l’effetto finale sul flusso degli utili lungo la catena madre-figlia, non la tecnica legislativa prescelta.
In tale cornice, il riferimento alla recentissima sentenza John Cockerill[8] (C-135/24), riguardante il sistema belga basato sul metodo alternativo all’esenzione dell’inclusione-deduzione, sottolinea l’esigenza che, al livello della società madre, il carico impositivo resti neutrale rispetto agli utili percepiti.
Quanto alle situazioni puramente interne e alla prospettata discriminazione a rovescio, il rinvio a PF e a.[9] conferma che, in assenza di un elemento transfrontaliero, l’eventuale disparità resta materia di scrutinio costituzionale interno.
3. Effetti immediati sul contenzioso e sulla prassi nazionale
La pronuncia comporta due effetti immediati: da un lato, l’obbligo per il giudice nazionale di disapplicare, nelle ipotesi rientranti nell’ambito della Direttiva, l’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997, riconoscendo, nei limiti ordinamentali, i rimborsi dell’IRAP indebitamente versata; dall’altro, la necessità per l’amministrazione finanziaria di riallineare la propria prassi, evitando resistenze defatigatorie e provvedendo ai rimborsi in autotutela quando risultino integrati i presupposti soggettivi e oggettivi del regime madre-figlia.
La sentenza Banca Mediolanum lo impone, declinando espressamente il principio del primato del diritto dell’Unione nella forma del divieto di ricreare, in via surrettizia, una tassazione economica ulteriore rispetto alla franchigia prevista dal sistema della Direttiva.
Per quanto concerne la disapplicazione da parte del giudice nazionale, il primato è espresso in termini molto efficaci ai paragrafi 52 s. della già citata sentenza John Cockerill: “…da un lato, in forza del principio del primato, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 53 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/96 ha effetto diretto (v., per analogia, sentenza del 12 febbraio 2009, Cobelfret, C-138/07, punti 63-65)”.
È, poi, essenziale ricordare che il principio del primato del diritto dell’Unione impone a tutti gli organi dello Stato, e non soltanto al giudice, di garantire la piena efficacia delle norme unionali dotate di effetto diretto, traducendosi, in caso di conflitto, nel dovere di disapplicare la disposizione interna incompatibile. Infatti, la Corte di giustizia, nella fondamentale Fratelli Costanzo ha chiarito in modo inequivoco che l’obbligo di non applicare la norma nazionale contrastante con una direttiva self-executing incombe su “tutti gli organi dell’amministrazione”, senza necessità di attendere la previa rimozione legislativa o giurisdizionale della disposizione interna[10].
Il medesimo canone di leale cooperazione si estende, a determinate condizioni, sino a imporre il riesame di decisioni amministrative divenute definitive[11].
Riconsiderata alla luce di tali coordinate, la vicenda affrontata nella sentenza Banca Mediolanum esige che l’amministrazione finanziaria conformi immediatamente la prassi all’interpretazione vincolante dell’art. 4 della direttiva 2011/96/UE: disapplicando in via amministrativa l’art. 6, comma 1, lett. a), d.lgs. 446/1997 con riferimento ai dividendi intracomunitari; riesaminando, nei limiti dei poteri di autotutela, gli atti non consolidati alla luce del dictum unionale e riconoscendo i rimborsi per le annualità non coperte da decadenza o prescrizione, senza poter opporre, di per sé, esigenze di bilancio o la diversa natura formale del prelievo.
Sotto il profilo applicativo interno, l’arresto Banca Mediolanum, inoltre, dispiega i propri effetti secondo la regola generale dell’interpretazione pregiudiziale del giudice del diritto UE, la quale impone la portata vincolante e retrospettiva delle decisioni della Corte UE.
Ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte “interpreta il diritto dell’Unione, non le disposizioni nazionali”: il dictum interpretativo vincola tutti i giudici degli Stati membri, a prescindere dallo Stato di provenienza della norma scrutinata. Da ciò discende, in via generale, la retroattività dell’interpretazione già sancita in Denkavit (C-61/79): “poiché l’interpretazione di una norma del diritto comunitario data dalla Corte […] chiarisce e precisa […] il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore (…) la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa”.
Solo eccezionalmente la Corte limita nel tempo gli effetti della propria interpretazione, quando “vi [sia] un rischio di gravi ripercussioni economiche” e “un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata” delle disposizioni UE (Richards, C-423/04; Bidar, C-209/03; Kalinchev, C-2/09); ed è principio fermo sin da Barra (C-309/85) che “questa limitazione è tuttavia ammessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull’interpretazione richiesta”.
In definitiva, se il primato del diritto dell’Unione è una clausola giuridica e non un omaggio retorico, l’unico esito compatibile con lo Stato di diritto europeo è un riallineamento amministrativo leale, tempestivo e integrale: tutto il resto (resistenze defatigatorie, attendismi procedurali, schermature lessicali) non è strategia di tutela dell’erario, è semplice disapplicazione del primato.
4. Il recepimento nella bozza di legge di bilancio 2026: disciplina sostanziale e rimborsi
La bozza di legge di bilancio 2026 recepisce in via generalizzata il principio affermato in sede unionale, intervenendo direttamente sugli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.
Per gli enti creditizi e finanziari, l’art. 17 della bozza introduce nell’art. 6 un nuovo comma 6-bis: i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in altro Stato membro UE “non concorrono a formare il margine di intermediazione […] in quanto esclusi dalla formazione del valore della produzione netta […] per il 95 per cento del loro ammontare”, al ricorrere delle condizioni del regime madre-figlia (art. 27-bis d.P.R. 600/1973; art. 44, comma 2, lett. a, TUIR).
Analoga previsione è inserita, per le imprese di assicurazione, nell’art. 7 della bozza mediante un nuovo comma 1-bis con identica esclusione al 95 per cento dalla base IRAP, sempre in presenza dei requisiti Direttiva-coerenti.
Le nuove regole si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Per i periodi anteriori, la quota IRAP riferita a dividendi intra-UE assoggettata in misura eccedente rispetto al nuovo regime “può essere esclusivamente chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 602/1973”, con espressa previsione del diritto alla restituzione ove il termine di decadenza sia ancora pendente e con facoltà, su opzione, di utilizzare le somme rimborsabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997, anche in coordinamento con l’imposta sostitutiva di cui all’art. 20 della stessa legge; l’uso in compensazione decorre dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza, con disapplicazione di specifici limiti quantitativi e rinvio a un provvedimento direttoriale per le modalità attuative.
L’art. 21 della medesima bozza prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, un incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP applicabili agli enti creditizi e alle imprese di assicurazione (art. 16, comma 1-bis, lett. b) e c), d.lgs. 446/1997), con regola ad hoc per la determinazione degli acconti.
Nel complesso, il combinato disposto dell’articolo 17 (che dà attuazione interna alla regola eurounitaria e predetermina un percorso di rimborso) e dell’articolo 21 (che ritara l’aliquota di settore) sembra inscriversi in una strategia bifasica: neutralizzazione della sovrimposizione sui dividendi intra-UE, da un lato; recupero di gettito su base general-settoriale, dall’altro.
Resta sul tavolo, in chiave domestica, la questione, solo potenziale e tutta costituzionale, dell’eventuale frizione tra il differenziale di trattamento interno ed europeo.
5. Considerazioni di sistema e de iure condendo: la discriminazione “a rovescio” e le sue possibili declinazioni nella fattispecie concreta
Per discriminazione a rovescio si intende, in termini generali, la situazione in cui un soggetto nazionale risulta trattato in modo più gravoso rispetto a un soggetto residente in un altro Stato membro, per il solo fatto che, nelle fattispecie transfrontaliere, operano limiti o regimi di favore discendenti dal diritto dell’Unione. La giurisprudenza della CGUE ha affrontato la questione in svariati ambiti, mantenendo tuttavia una linea di costante prudenza nelle materie non pienamente armonizzate.
La sentenza Banca Mediolanum affronta espressamente l’argomento nella parte finale della motivazione, là dove dà atto della tesi del Governo italiano secondo cui la soluzione adottata genererebbe una discriminazione alla rovescia in danno delle società madri residenti che percepiscono dividendi da società figlie anch’esse italiane. La Corte osserva che tale ipotesi attiene a una situazione puramente interna, rientrante nella competenza del giudice nazionale, richiamando il canone tradizionale per cui il principio di parità di trattamento sancito dal diritto dell’Unione non può essere fatto valere in una situazione priva di ogni elemento transfrontaliero, con rinvio ai giudici interni quanto alla verifica di eventuali violazioni del principio di eguaglianza sancito dall’ordinamento nazionale e all’individuazione del rimedio (Mosconi e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, C-3/02; PF e a., C-830/18).
Questo dictum, per quanto asciutto, è denso di implicazioni. In primo luogo, esso riconosce espressamente che un rischio di discriminazione a rovescio può effettivamente manifestarsi allorché il combinato disposto tra l’articolo 4 della Direttiva e la disciplina nazionale produca un trattamento più favorevole per i dividendi intra-UE rispetto a quelli domestici. In secondo luogo, pur non dettando alcun vincolo positivo allo Stato membro, la CGUE apre lo spazio al sindacato costituzionale interno, nel quale il principio di eguaglianza e ragionevolezza può fungere da grimaldello per rimuovere un’irragionevole asimmetria impositiva. L’ordinanza trae linfa da un filone giurisprudenziale consolidato secondo cui il diritto dell’Unione non si sostituisce, in via generale, ai rimedi costituzionali domestici per sanzionare le distonie delle situazioni interne. In questa chiave, è significativo che già la Corte costituzionale (nel giudizio sfociato nella sentenza n. 12 del 2022[12]) abbia stigmatizzato l’approccio del giudice rimettente che aveva “del tutto assertivamente” escluso l’applicabilità della Direttiva all’IRAP “senza tuttavia minimamente confrontarsi con la giurisprudenza” della CGUE, evocata anche “al fine […] di dedurre la cosiddetta discriminazione alla rovescia”.
La pronuncia in commento, dunque, consolida lo schema che vede la Direttiva come limite invalicabile nelle fattispecie transfrontaliere e il principio di eguaglianza costituzionale come strumento di riequilibrio nelle situazioni interne.
In un’ottica meramente ipotetica e senza pretesa di esaustività, qualora fosse investita della questione, la Corte costituzionale potrebbe verosimilmente collocare lo scrutinio della “discriminazione a rovescio” dell’IRAP sui dividendi domestici nel paradigma combinato degli artt. 3 e 53 Cost., interrogandosi se il differenziale di carico che residua per le sole fattispecie interne trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole alla luce della capacità contributiva effettivamente manifestata. In coerenza con la propria giurisprudenza, tale verifica potrebbe svolgersi attraverso il canone della coerenza del prelievo con il suo presupposto economico, censurando l’irragionevolezza di un sistema che, per effetto del diritto unionale, tratta in modo deteriore una situazione puramente interna rispetto a una transfrontaliera del tutto analoga.
In questo scenario, la bozza di legge di bilancio 2026 compie il solo tratto “europeo” del percorso (presumibilmente per ragioni di gettito), disinnescando l’IRAP sui dividendi intra-UE mediante l’esclusione al 95 per cento e approntando un canale di rimborso per il pregresso; ma, proprio per ciò, il differenziale interno riemerge con nettezza. A tutt’oggi, i dividendi domestici delle banche e delle imprese di assicurazione continuano a concorrere alla base IRAP (nella misura del 50 per cento), laddove l’identico flusso intra-UE viene sostanzialmente sterilizzato: il rischio di discriminazione a rovescio non è dunque un’ipotesi scolastica, bensì l’esito fisiologico di una armonizzazione “a metà”.
Dopo Banca Mediolanum e, soprattutto, alla luce dell’intervento “a metà” della legge di bilancio (neutralizzazione al 95% dei dividendi intra-UE ai fini IRAP per banche e assicurazioni, permanenza della regola del 50% per i dividendi interni), l’ordinamento conosce due trattamenti per la medesima fattispecie economica (la percezione di utili) differenziati unicamente dall’elemento transfrontaliero. Accogliendo tali coordinate, uno spazio non trascurabile per contestare il superamento della soglia di ragionevolezza sul terreno costituzionale esiste.
La giustificazione “di sistema” dell’inclusione parziale ai fini IRAP (intesa come quota forfetaria correlata al margine di intermediazione per le banche e alla voce 33 per le imprese di assicurazione) risulta oggi internamente incoerente. Per i flussi intra-UE, infatti, il legislatore stesso prende atto che ogni imposizione oltre il 5 per cento integra una sovrimposizione economica incompatibile con la logica della catena madre-figlia; non è allora persuasivo spiegare perché quel medesimo eccesso debba reputarsi “fisiologico” quando la distribuzione è domestica. Ne discenderebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione oggettiva e ragionevole: la stessa manifestazione di ricchezza è trattata in modo opposto in funzione del solo elemento transfrontaliero, senza un nesso ragionevole con una differente capacità contributiva. L’argomento del gettito, in questa prospettiva, non varrebbe certo come ragione oggettiva: la Corte costituzionale è costante nel pretendere che il prelievo sia coerente con il proprio presupposto e proporzionato al fatto indice, non già giustificato dal solo fabbisogno finanziario.
In un eventuale giudizio incidentale, il vaglio di non manifesta infondatezza appare dunque realistico; l’esito dipenderà, da un lato, dalla capacità dello Stato di articolare una finalità autonoma e specifica per l’onere residuo sulle fattispecie domestiche (ad esempio, esigenze strutturali dei settori bancario/assicurativo riferibili alle sole partecipazioni nazionali); dall’altro, dalla capacità del contribuente di costruire un quadro argomentativo solido, articolato su tre snodi: (i) la quantificazione dell’extra-carico domestico rispetto al “tetto” del 5 per cento; (ii) la prova della piena comparabilità economica tra dividendi interni e intra-UE ai fini della capacità contributiva; (iii) l’indicazione di alternative meno restrittive idonee a perseguire le medesime finalità, così da evidenziare che la misura non è “necessaria” in senso costituzionale, poiché il medesimo obiettivo può essere raggiunto con strumenti ugualmente efficaci ma meno gravosi per il contribuente. Qualora tale verifica riuscisse, la disciplina potrebbe risultare irragionevole alla luce dei canoni elaborati dalla Corte costituzionale: non solo per difetto di coerenza con il presupposto d’imposta e con la capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.), ma anche perché non “necessaria” nel senso proprio del giudizio di proporzionalità, ove si dimostri l’esistenza di strumenti ugualmente idonei a perseguire il fine dichiarato con minore sacrificio per il contribuente[13]. In tal caso, l’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo renderebbe la disciplina non proporzionata, e dunque incostituzionale in parte qua.
In un’ottica di buona regolazione, il legislatore dovrebbe dunque completare l’allineamento del trattamento ai fini IRAP dei dividendi di banche e assicurazioni. In questa prospettiva, il legislatore, se volesse effettivamente azzerare la discriminazione a rovescio sul versante domestico, potrebbe imboccare due strade tra loro alternative. Da un lato, potrebbe replicare ai fini IRAP la regola già prevista per i dividendi transfrontalieri, escludendo dalla base imponibile il 95 per cento dei dividendi “interni”, così da allineare il carico complessivo in capo alla madre al limite del cinque per cento. Dall’altro, potrebbe neutralizzare a valle l’inclusione contabile mediante una deduzione ai fini fiscali o altro meccanismo come, ad esempio, un credito d’imposta di importo equivalente, in modo da sterilizzare l’impatto IRAP. In entrambi i casi, l’esito sarebbe la parificazione sostanziale tra domestico e intra-UE, con un impianto semplice, auto-applicativo e coerente con l’obiettivo di evitare la sovrimposizione economica.
La codificazione di un test di coerenza interna, insieme a un principio di non penalizzazione della scelta domestica, servirebbe a preservare l’eguaglianza a parità di presupposto e a prevenire il contenzioso costituzionale che, diversamente, appare oggi più che prevedibile. Sarebbe manutenzione ordinaria di un sistema coerente; ma, allo stato, il quadro delineato dalla bozza continua a lasciare aperta (e ben aperta) la questione interna.
6. Una nota finale: il prisma CEDU sulla “discriminazione alla rovescia”
Il recente arresto della Corte europea dei diritti dell’uomo in de Galbert Defforey e altri c. Francia (22 maggio 2025) segna un primo, significativo confronto con la “discriminazione alla rovescia” in materia tributaria nella Convenzione Europea de Diritti dell’Uomo (“CEDU”).
I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell’art. 14 CEDU[14] in combinato disposto con l’art. 1 Prot. n. 1[15], un trattamento “domestico” fiscale deteriore rispetto al regime applicabile, per effetto del diritto dell’Unione, a operazioni omologhe ma transfrontaliere.
La Corte EDU ha respinto i ricorsi, valorizzando tre coordinate: i) l’assenza di un criterio vietato fondato sulla nazionalità o residenza (la differenza dipendeva dalla natura dell’operazione, non dallo status del contribuente) e la libera scelta del contribuente (i ricorrenti avevano volontariamente optato per determinate operazioni e per la loro tempistica, per cui l’onere fiscale derivava anche da scelte negoziali libere, e non da una qualità personale); ii) l’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nelle politiche fiscali e nelle scelte transitorie connesse a riforme di ampio spettro; iii) la sussistenza di una giustificazione oggettiva e di un “ragionevole rapporto di proporzionalità” tra i mezzi e il fine perseguito. In questa chiave, la Corte ha rimarcato che l’appartenenza all’Unione e la specificità dell’ordinamento dell’UE possono giustificare differenze di trattamento rispetto a situazioni non coperte dal diritto unionale, senza che ciò integri, di per sé, una violazione della CEDU. La Corte EDU ha verificato la proporzionalità anche valorizzando il grado di neutralità fiscale assicurato dal sistema e la natura transitoria degli assetti oggetto del giudizio. Infine, ha ribadito che “non spetta ad essa sostituirsi alle autorità nazionali competenti a determinare ciò che è nell’interesse generale in materia economica e sociale (…) o valutare se – e in quale misura – le differenze tra situazioni sotto altri aspetti analoghi giustifichino disparità di trattamento”.
Queste coordinate suggeriscono due cautele sistematiche. Anzitutto, la via della CEDU non è, di regola, quella più immediata per censurare una “asimmetria domestica” indotta dall’operare del diritto UE: la soglia CEDU in tema di eguaglianza fiscale è alta, perché filtrata dal margine di apprezzamento e dal requisito di una base legittima non arbitraria della differenziazione.
In secondo luogo, proprio per questa ragione, il baricentro della tutela resta verosimilmente interno: è il sindacato della Corte costituzionale (artt. 3 e 53 Cost.), eventualmente evocato anche via art. 117, primo comma, Cost. quale norma interposta[16], a offrire il crinale più naturale per affrontare la frizione tra trattamento intra-UE (vincolato dalla Direttiva) e trattamento domestico, frizione che la CGUE in Banca Mediolanum ha espressamente rimesso ai giudici nazionali quando la situazione sia “puramente interna”.
Ciò non toglie che il parametro CEDU possa svolgere una funzione sussidiaria: ove l’asimmetria interna si traduca in un onere “manifestamente privo di una base ragionevole” o in un effetto sproporzionato sulla proprietà del contribuente (art. 1 Prot. n. 1), la traiettoria tracciata in de Galbert Defforey lascia spazio a un controllo di ragionevolezza nel contesto della CEDU, sebbene entro un perimetro più ristretto di quello costituzionale e, soprattutto, meno “sensibile” alla logica pro-integrazione propria della giurisprudenza CGUE. In altri termini: mentre la Corte di giustizia presidia la libera circolazione scoraggiata da regimi differenziali, la Corte EDU verifica, con strumenti diversi, che la differenziazione fiscale non trascenda nell’arbitrio.
Come in Galbert Defforey c. Francia, anche con riguardo ai dividendi di banche e assicurazioni, la differenza di trattamento non poggia sulla nazionalità o sulla residenza dei soggetti coinvolti, ma sulla natura dell’operazione (interna vs transfrontaliera) e può essere difesa come esito di scelte legislative graduali e di ricalibrature settoriali del carico.
Detto ciò, se si intende percorrere la via CEDU, l’argomentazione dovrà rispettare i parametri di Strasburgo: ricondurre la vicenda all’art. 1 Prot. n. 1 (incisione patrimoniale) in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione), dimostrare l’esistenza di un onere individuale eccessivo (excessive burden) non sorretto da una ragionevole giustificazione rispetto alle finalità dichiarate (gettito, stabilità di settore, coerenza del prelievo) ed evidenziare, in esito, il difetto di equo bilanciamento (fair balance) tra interesse generale e diritto di proprietà del contribuente.
In via meramente speculativa, i passaggi da presidiare coincidono, nella sostanza, con quelli propri del giudizio di costituzionalità, con un’attenzione particolare alla prospettazione di alternative meno onerose. Questo snodo non trasforma la Corte EDU in giudice dell’opportunità, ma serve a mostrare che la soluzione normativa eccede il necessario rispetto al fine, scivolando in una sproporzione manifesta rilevante ai sensi dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 1 Prot. n. 1. È su questo terreno, e non su quello, troppo generico, della “disparità interna”, che si misura la ragionevolezza in chiave CEDU.
Sul piano processuale, restano essenziali l’esaurimento dei rimedi interni (inclusa, se del caso, la questione incidentale di legittimità costituzionale), la prova di un pregiudizio significativo e la rigorosa oggettivazione della comparabilità: medesima catena madre-figlia, identica funzione allocativa del dividendo, stesso riflesso su margine di intermediazione/voce 33; unico elemento differenziale, la presenza o l’assenza dell’elemento transfrontaliero.
Anche così, per quanto de Galbert Defforey insegni che la verifica della Corte EDU si arresta dinanzi a differenziazioni sorrette da una base oggettiva e da un rapporto ragionevole di proporzionalità, la CEDU può svolgere una funzione di valvola di sicurezza: una censura resta ipotizzabile nei casi limite, in cui sia manifesta la assenza totale di ratio, un impatto manifestamente sproporzionato, transizioni arbitrarie.
Sul caso dei dividendi delle banche e delle assicurazioni, nella fisiologia del sistema, la verifica più esigente di ragionevolezza e coerenza rimane affidata, e verosimilmente si giocherà, sul terreno dei parametri costituzionali interni.
7. Conclusioni
Banca Mediolanum ha definitivamente consacrato l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva, dell’assoggettamento ad IRAP dei dividendi intra-UE percepiti da banche e assicurazioni oltre la soglia del cinque per cento.
La bozza di legge di bilancio 2026, se approvata nei termini attualmente noti, recepisce tale arresto per il futuro e, sul piano retrospettivo, prende atto della portata interpretativa della sentenza, predisponendo un canale ordinato di rimborso per le istanze relative alle annualità ancora aperte o di compensazione. Al contempo, però, l’intervento parziale apre una voragine di “discriminazione a rovescio”: i dividendi domestici continuano a scontare l’inclusione parziale nella base imponibile IRAP, mentre i dividendi intra-UE ne sono sostanzialmente esenti, a parità di presupposto economico.
Il baricentro del contenzioso non può che spostarsi sul giudizio incidentale di legittimità costituzionale: è in quella sede che il differenziale domestico/intra-UE dell’IRAP sui dividendi può essere vagliato alla luce degli artt. 3 e 53 Cost., mediante un controllo pieno di ragionevolezza, coerenza e proporzionalità del prelievo, con possibile esito ablativo erga omnes qualora la disparità non si correli a diversa capacità contributiva e risulti evitabile attraverso strumenti equivalenti meno gravosi. La via CEDU, per converso, è per sua natura sussidiaria e più ristretta: il sindacato ex art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1 Prot. n. 1, si arresta al margine di apprezzamento dello Stato in materia fiscale e consente censure soltanto quando la differenziazione sia manifestamente priva di ragionevole base o determini un “excessive burden”. Le decisioni di Strasburgo non espungono direttamente la norma interna, ma vincolano lo Stato convenuto all’adozione di misure individuali e, se del caso, generali sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri; l’effetto sistemico discende, dunque, dall’obbligo di conformazione, non da una caducazione erga omnes immediata.
Per concludere, l’ordinamento unionale ha tracciato il perimetro; la bozza di legge di bilancio lo ha recepito solo per metà; il riequilibrio delle situazioni interne è ora affidato, in via principale, al controllo di costituzionalità.
[1] B. Pizzoni, L. Favi, L’imposizione IRAP sui dividendi delle banche all’esame della Corte UE, in Diritto Bancario, sez. Attualità, 4 Giugno 2024.
[2] Sentenza CGUE 1 agosto 2025, cause riunite C-92/24, C-93/24, C-94/24, Banca Mediolanum SpA / Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia.
[3] In applicazione dell’art. 4, paragrafo 3, secondo periodo della Direttiva.
[4] Sentenza CGUE 17 maggio 2017, C‑365/16, Association française des entreprises privées (AFEP) e a. contro Ministre des Finances et des Comptes publics.
[5] Sentenza CGUE, 17 maggio 2017, C-65/15, X contro Ministerraad.
[6] Sentenza CGUE 19 dicembre 2019, C-389/18, Brussels Securities SA contro État belge.
[7] Sentenza CGUE 12 maggio 2022, C-556/20, Schneider Electric SA e a. contro Premier ministre e Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance.
[8] Sentenza CGUE 13 marzo 2025, C-135/24, John Cockerill contro État belge.
[9] Sentenza CGUE 2 aprile 2020, C‑830/18, Landkreis Südliche Weinstraße contro PF e a..
[10] Sentenza CGCE 22 giugno 1989, C-103/88, Fratelli Costanzo SpA contro Comune di Milano. Si legge, in particolare, al paragrafo 31 della decisione: “Sarebbe peraltro contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di far censurare l’operato dell’amministrazione, e al contempo ritenere che l’amministrazione non sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”.
[11] La giurisprudenza dell’Unione ha chiarito, con Kühne & Heitz (sentenza 13 gennaio 2004, C-453/00), che il principio di leale cooperazione (all’epoca art. 10 Trattato CE) può imporre all’amministrazione, se investita di specifica istanza e ove l’ordinamento interno le attribuisca il relativo potere, di riesaminare una decisione definitiva per conformarla all’interpretazione del diritto UE nel frattempo resa dalla Corte di giustizia: ciò, tuttavia, solo se la definitività sia seguita a una decisione del giudice di ultima istanza che non abbia adito la Corte a titolo pregiudiziale e se l’interessato si sia attivato immediatamente dopo avere conosciuto la giurisprudenza sopravvenuta. Si tratta, dunque, di un dovere di riesame eccezionale e condizionato, che non generalizza la riapertura del passato ma ne ritaglia varchi funzionali all’effettività del diritto dell’Unione. Sul versante interno, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2014, n. 13676), muovendo dall’esigenza di certezza dell’ordinamento, identificano nei “termini” e nel giudicato i limiti sistemici alla riattivazione retrospettiva di posizioni soggettive: per termini si intendono i confini temporali legali all’esercizio di diritti o poteri (in specie decadenza e prescrizione), il cui spirare rende la pretesa inattuale o inazionabile e concorre a cristallizzare i c.d. rapporti esauriti; il giudicato, per suo conto, segnando l’irretrattabilità della decisione, preclude la rimessione in discussione della regula iuris definita con efficacia finale. Entrambi operano come sbarramenti ordinatori, salva diversa scelta del legislatore, proprio perché strumentali alla stabilità delle situazioni giuridiche. Le due statuizioni operano su piani complementari: Kühne & Heitz abilita il riesame amministrativo solo quando ricorrano puntualmente le condizioni rigorose fissate dalla Corte di giustizia, senza pretendere la riapertura indiscriminata di vicende consolidate; le Sezioni Unite, specularmente, presidiano la stabilità dei rapporti attraverso termini e giudicato, rimettendo al solo legislatore l’eventuale riapertura generalizzata delle situazioni consolidate. In questo senso, la stessa giurisprudenza unionale ha precisato, in Kempter (sentenza 12 febbraio 2008, C-2/06), che il diritto dell’Unione non impone di per sé un limite temporale alla domanda di riesame, ferma restando la facoltà degli ordinamenti nazionali di fissare termini ragionevoli nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
[12] Il giudizio verteva sulla legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.lgs. 446/1997, nella parte in cui assoggetta ad IRAP i dividendi percepiti da banche e holding finanziarie. La Corte costituzionale ha esaminato se tale imposizione violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), e ha ritenuto non fondata la censura. In quella sede ha osservato incidenter tantum che il giudice a quo aveva escluso immotivatamente di valutare la compatibilità della norma con la Direttiva.
[13] Nel controllo di costituzionalità delle norme impositive, la Corte costituzionale valuta la ragionevolezza (art. 3 Cost.) e la coerenza con la capacità contributiva (art. 53 Cost.) anche attraverso un test di proporzionalità: la misura non deve eccedere, per intensità o struttura, lo scopo dichiarato. In tale prospettiva la Consulta ha più volte affermato che al legislatore spetta un’ampia discrezionalità, ma entro il limite della non arbitrarietà e della non manifesta sproporzione. Così, ad esempio, ha dichiarato incostituzionale l’indeducibilità integrale dell’IMU sugli immobili strumentali, ritenendola incoerente e sproporzionata rispetto ai parametri degli artt. 3 e 53 Cost. (Corte cost., sent. n. 262/2020); e ha censurato, in ambito previdenziale, interventi che superavano i “limiti di ragionevolezza e proporzionalità” (Corte cost., sent. n. 70/2015). Il principio ha oggi un ancoraggio positivo nello Statuto dei diritti del contribuente. L’art. 10-ter, l. n. 212/2000 (come introdotto dal d.lgs. n. 219/2023) dispone: “Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo. Il principio di proporzionalità […] si applica anche alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.”
[14] Che recita: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
[15] Che recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. (…) Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie (…)per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
[16] Così Cimino, La Corte EDU si pronunzia per la prima volta su una problematica di discriminazione alla rovescia di rilevanza fiscale: profili sistematici e nuove prospettive di tutela anche costituzionale, Riv. Dir. Trib., Supplemento OnLine, 30 settembre 2025.