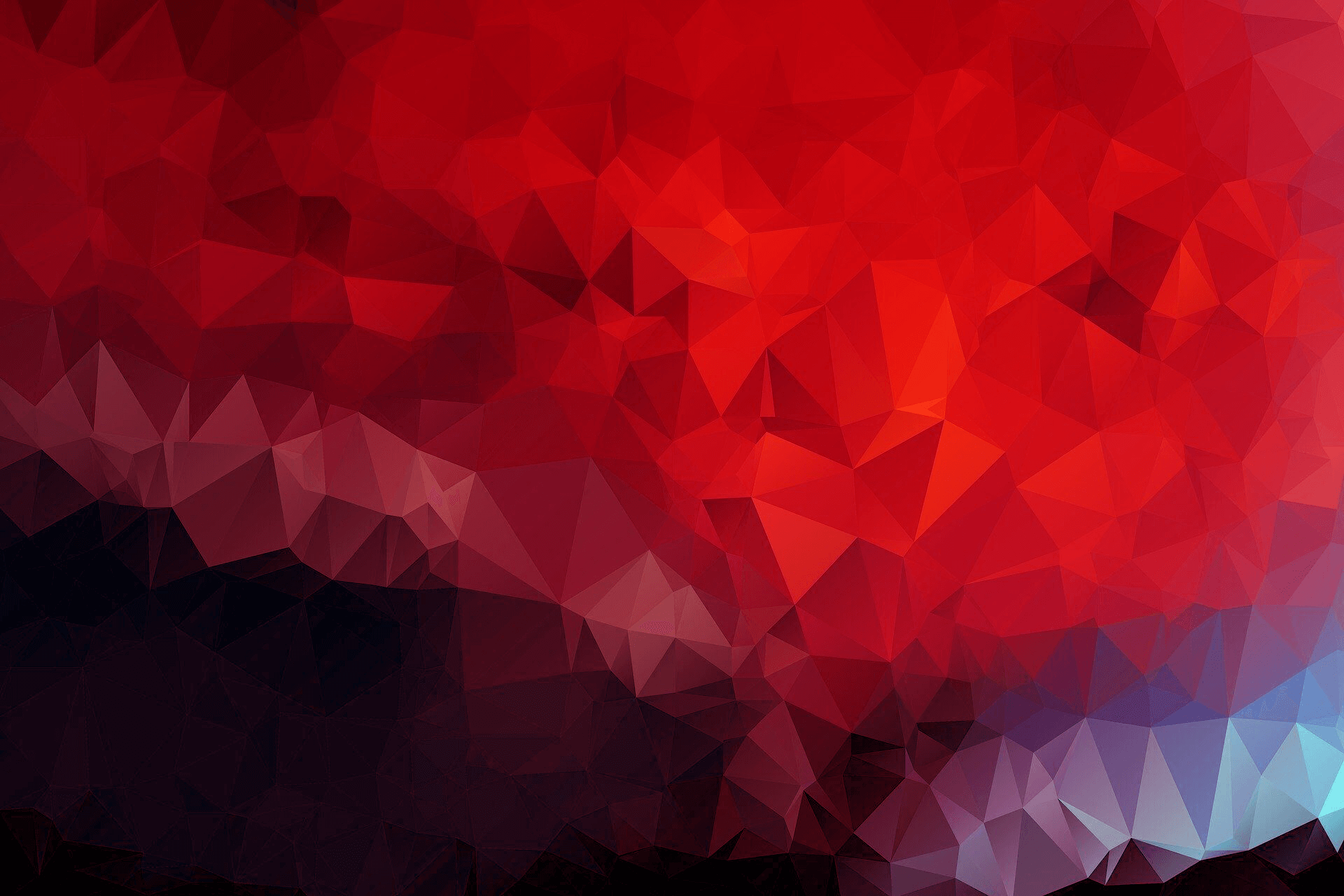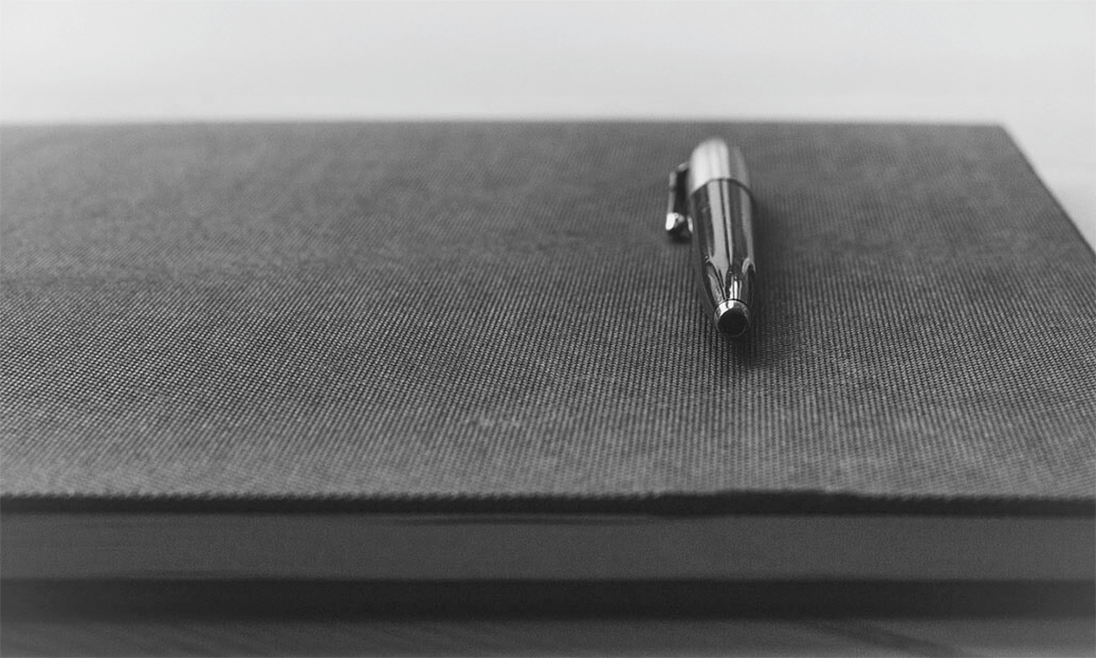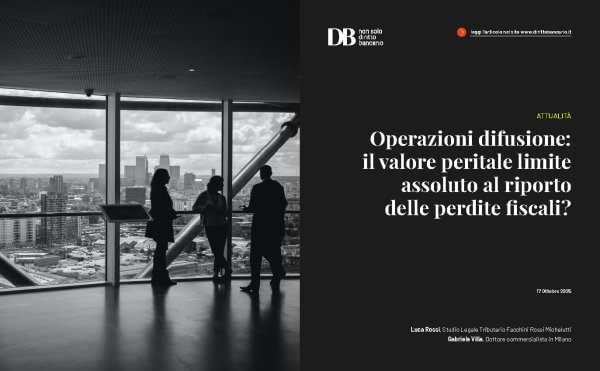Il presente contributo affronta i nuovi criteri di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie di fusione, concentrandosi in particolare sul limite del valore del patrimonio netto e sulla connessa sterilizzazione dal valore del patrimonio netto dei conferimenti effettuati dai soci nei 24 mesi precedenti l’operazione.
Come è noto, i criteri di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie di fusione sono stati recentemente modificati in maniera importante[1].
Le regole di base sono sempre rappresentate dalla vitalità del conto economico della società che intende riportare le perdite e dal limite del valore del patrimonio netto, che come vedremo più diffusamente può essere nella configurazione di patrimonio netto effettivo ovvero contabile, della stessa società. Ancora il limite del patrimonio netto deve essere ridotto dei conferimenti fatti dai soci in un certo arco temporale che precede l’attuazione dell’operazione straordinaria di fusione[2].
In questo breve scritto, ci si intende concentrare sul limite del valore del patrimonio netto e sulla connessa sterilizzazione dal valore del patrimonio netto dei conferimenti effettuati dai soci nei 24 mesi precedenti l’esecuzione dell’operazione straordinaria. E’ qui, infatti, che sono state effettuate le modifiche più rilevanti e si hanno a nostro avviso i maggiori dubbi interpretativi, nonché si nutrono talune perplessità nella scelta legislativa attuata.
Come riportato nella precedente nota, la norma prevede testualmente che le perdite possano essere riportate “per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore … deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società … il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione …”.
Il primo tema che si pone è quello di capire se il limite del valore economico derivante dalla perizia costituisce un limite quantitativo invalicabile al riporto delle perdite, oppure rappresenti sempre una prima forfettizzazione della quantità di perdite riportabili che può essere superata tramite specifici argomenti nell’ambito di apposito interpello da presentarsi all’Agenzia delle entrate.
Pare si stia formando (quanto meno in dottrina) un indirizzo interpretativo che ritiene il valore economico come limite quantitativo invalicabile (non superabile quindi neppure con la procedura di interpello), rappresentando un indice di redditività prospettica della società interessata dall’operazione straordinaria. Non siamo convinti che tale interpretazione sia corretta o quanto meno riteniamo necessario evidenziare quanto di seguito.
In primo luogo, il criterio del valore economico risultante da apposita perizia di stima si pone in alternativa al valore del patrimonio netto contabile della società.
Pertanto, è in facoltà del contribuente poter utilizzare anche il (vecchio) limite del patrimonio netto contabile, in vigenza del quale si è sempre potuto dimostrare tramite apposito interpello che tale limite (contabile) potesse essere superato in particolare valorizzando la capacità di reddito prospettica, valutata secondo un‘ottica stand alone, della società interessata dall’operazione straordinaria. Tale fattispecie può assumere rilevanza anche nei casi in cui il valore economico del patrimonio netto è inferiore alla sua dimensione contabile. In via esemplificativa, basti ricordare che le banche italiane hanno quotato per un lungo periodo e in numerose situazioni quotano ancora oggi a “sconto” rispetto al loro patrimonio netto contabile. In altri termini, il mercato restituisce la chiara evidenza di valori economici del patrimonio che si collocano significativamente al di sotto del corrispondente valore contabile tenuto conto dell’interagire di plurimi elementi, tra i quali, nel caso, ed in via esemplificativa, delle banche: (i) i livelli di redditività, in un contesto di mercato per lungo tempo influenzato da un livello dei tassi molto basso, a motivo della politica monetaria della BCE; (ii) i vincoli di patrimonializzazione imposti dalla Vigilanza; (iii) gli effetti della progressiva revisione dell’asset quality. Il valore economico si colloca al di sotto del valore contabile del patrimonio se il rendimento contabile è inferiore al rendimento richiesto dall’investitore. Si assuma per semplicità il caso in cui un’azienda presenti con carattere di stabilità un reddito di 100 e che il tasso di attualizzazione, che esprime il rendimento richiesto dall’azionista, sia pari al 10%; si assuma ancora che il patrimonio netto contabile sia pari a 1.200, anche a motivo, ad esempio, di vincoli normativi che impongono una predefinita dotazione patrimoniale. Nell’ipotesi in cui non vi sia crescita del reddito, nel semplice scenario descritto, il valore economico dell’azienda è pari a 1.000, mentre il patrimonio netto contabile è 1.200. Ora, il differenziale di valore è legato al fatto che il rendimento contabile dell’azienda (che può essere misurato dal rapporto tra il reddito di 100 e il patrimonio netto contabile di 1200 e che risulta pari all’8,3%) è inferiore al rendimento richiesto dall’azionista, indicato nel caso in esame nella misura del 10%. Nella situazione descritta, non pare corretto vincolare la riportabilità delle perdite al “valore economico” del patrimonio, che riflette per definizione le condizioni pro tempore vigenti sul mercato del rendimento richiesto dagli investitori, a fronte di un patrimonio netto contabile superiore.
In secondo luogo, e concentrando l’attenzione al caso in cui il contribuente intenda predisporre apposita perizia di stima, vale quanto segue.
Il criterio di valutazione più diffusamente utilizzato nell’ambito della prassi professionale è il metodo del discounted cash flow, che è il criterio valutativo che maggiormente evidenzia nei propri passaggi logici la capacità dell’azienda di trasformare i redditi futuri in cassa[3]. Tale valutazione si suddivide concettualmente in due componenti: i cash flows netti da piano industriale (che tendenzialmente copre un orizzonte temporale di 5 anni) ed il terminal value, che concettualmente traduce nel processo valutativo i flussi di cassa netti successivi all’orizzonte temporale del piano industriale. Per via di elementi tecnici valutativi sottostanti alla determinazione del terminal value (ed in particolare per via del processo di attualizzazione di tali flussi di cassa successivi all’arco piano), tale addendo valutativo di fatto rappresenta la generazione di cassa netta dell’ultimo anno di piano proiettata per massimi 12/14 anni[4]. In sostanza, se si considera l’ipotesi di un’azienda che produce flussi di cassa pari a 100 su un orizzonte temporale infinito, quei flussi, attualizzati, ad esempio, al 10% sul predetto orizzonte temporale restituiscono un valore attuale di 1.000; ma tale ultimo valore, che pure deriva dal riferimento a flussi proiettati su un orizzonte temporale infinito, equivale ai flussi “nominali” di dieci anni.
Il processo di attualizzazione che connota tutti i modelli valutativi basati sui flussi introduce inevitabilmente elementi di asimmetria tra flussi attualizzati e flussi nominali; tale asimmetria, come illustrato nel semplice esempio proposto, si riflette sull’ampiezza dell’arco temporale al quale i flussi nominali possono essere riferiti con l’effetto, sul piano sostanziale, di limitare la quantità di perdite riportabili.
Pertanto, la valutazione economica della entità interessata dall’operazione straordinaria incorpora una generazione di cassa netta (e quindi redditi prospettici) di 17/19 anni. Quindi, sicuramente un arco temporale importante, che però non ricattura (a causa del processo di attualizzazione dei flussi di cassa nella formula perpetua) tutto il periodo di potenziale utilizzo futuro delle perdite fiscali e di possibile produzione di redditi da parte della società interessata dalla operazione straordinaria. Infatti, come è noto, il riporto delle perdite fiscali non ha un limite temporale (cfr. art. 84 TUIR) e pertanto concettualmente la generazione di profitti della entità potrebbe riguardare un periodo ben più lungo dei 17/19 anni ricatturati dal metodo valutativo DCF: in definitiva, il processo di attualizzazione alla base del metodo valutativo DCF, ma più in generale di qualsiasi metodo valutativo basato sui flussi, non ha nulla a che vedere con i principi di utilizzo e di durata nel riporto a nuovo delle perdite fiscali.
Ci si chiede, pertanto, se in situazioni di conclamata solidità strutturale della società (ben distante quindi da qualsiasi pensiero o concetto di “bara fiscale”) non possa essere evidenziato nell’interpello all’Agenzia delle entrate che le perdite fiscali possono riportarsi a nuovo anche per l’importo eccedente la valutazione peritale, potendo evidenziare che la società oggetto di fusione non è icto oculi una bara fiscale, essendo altresì concettualmente capace di produrre una redditività prospettica (in un’ottica stand alone), anche in un arco temporale successivo a quello ricatturato dalla metodologia DCF (a causa del processo di attualizzazione dei flussi di cassa prospettici, secondo il metodo perpetuo). In pratica, in questa interpretazione, la valutazione peritale, che rappresenta come detto una alternativa al limite del patrimonio netto contabile, rappresenta sempre una forfettizzazione della produzione di reddito futura della società, e sicuramente ridurrà la necessità di predisporre interpelli all’Agenzia delle entrate, ma non costituisce un limite invalicabile alla quantità delle perdite riportabili, ben potendo, per quanto detto, la capacità di produzione del reddito futuro superare il valore (attualizzato) contenuto nella perizia di stima.
Il secondo tema che si vuole evidenziare, in un’ottica de iure condendo, è la non condivisibile scelta operata dal legislatore fiscale circa la riduzione del valore peritale di un importo pari al doppio dei conferimenti attuati nell’arco dei 24 mesi (e non invece ad un importo pari agli stessi conferimenti attuati nello stesso arco temporale); e ciò in quanto, come si legge nella Relazione di accompagnamento al provvedimento che ha introdotto il meccanismo di riduzione basato sui conferimenti effettuati dai soci “Tale valore (doppio, n.d.r.) , sia pure genericamente individuato, appare in linea con l’equity risk premium (che rappresenta il rendimento addizionale che gli investitori richiedono al mercato per detenere azioni rispetto a quello – calcolato al tasso risk free – dell’investimento in asset privi di rischio come i titoli di Stato)” .
Senza entrare in questa sede nel significato del passaggio riportato nella Relazione che riteniamo sia alquanto criptico, ci si limita ad evidenziare che nel processo valutativo peritale del DCF la posizione finanziaria netta della società (che concettualmente ricomprende anche la cassa conferita dai soci negli ultimi 24 mesi) viene considerata nella valutazione peritale sommando appunto (una volta e non due volte) la posizione finanziaria netta della società stessa. Nel metodo valutativo del discounted cash flow nella variante unlevered, la formula somma il flusso di cassa netto attualizzato da piano al terminal value ed infine alla PFN (posizione finanziaria netta), che concettualmente ricomprende con il segno positivo la cassa eventualmente apportata dai soci. Si ritiene pertanto che la norma debba essere modificata nuovamente per sottrarre (una sola volta) dalla valutazione peritale l’importo dei conferimenti effettuati dai soci negli ultimi 24 mesi precedenti l’operazione straordinaria di fusione, come peraltro avviene ove il contribuente scelga di seguire il limite del patrimonio netto contabile della società che intende riportare le perdite fiscali.
[1] Le modifiche sono state introdotte nell’ambito dell’art. 172 del TUIR in attuazione di una specifica Legge di Delega (cfr. D.Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, e da ultimo cfr. il D.L. n. 84 del 17 giugno 2025, convertito in Legge n. 108 del 30 luglio 2025).
[2] L’attuale comma 7 dell’art. 172 del TUIR, così testualmente recita: “Le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite; tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile, deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società, scelto tra quelli di cui all’articolo 2409 bis, primo comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo periodo, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504 bis del codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501 quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La possibilità di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti è subordinata alle condizioni che dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
- all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
- all’ intervallo di tempo che intercorre tra l’ inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, redatto in osservanza dei princìpi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti”.
L’attuale comma 7 prevede quindi:
- come regola base per il riporto delle perdite il limite del valore effettivo del patrimonio netto della società risultante da apposita perizia di stima predisposta da un esperto nominato dalla Società;
- che in mancanza della detta perizia di stima il limite ritorna ad essere quello del valore del patrimonio netto contabile della società che intende riportare le perdite (come era previsto nella previgente versione dell’art. 172, comma 7, TUIR);
- che i limiti sopra rappresentati devono essere ridotti dei conferimenti effettuati (tipicamente dai soci) nei 24 mesi precedenti l’operazione straordinaria. Nel caso di utilizzo della perizia di stima i conferimenti da utilizzare nel sottraendo devono essere considerati in misura doppia rispetto a quelli effettivamente effettuati dai soci nel periodo di osservazione;
- che la vitalità della società che riporta le perdite deve essere sempre misurata osservando il conto economico della stessa, in specifiche voci di ricavo e di costo ed in un determinato periodo di osservazione. In particolare, i ricavi della gestione caratteristica ed i costi di lavoro dipendente non debbono essere ridotti in misura rilevante (nell’esercizio precedente la fusione e nella frazione di esercizio interessato dalla fusione stessa i detti ricavi e costi non debbono essere uguali o inferiori al 40 per cento della media delle stesse voci dei due esercizi anteriori). Il criterio della vitalità economica non è mutato, ove si tenga conto anche delle diverse posizioni assunte dalla Agenzia delle entrate in riferimento al calcolo anche da effettuare nel periodo di imposta frazionario in cui è attuata l’operazione straordinaria.
[3] Il metodo, infatti, valuta una specifica società attualizzando tutti i suoi flussi di cassa futuri.
[4] Il terminal value rappresenta il valore attuale di tutti i flussi di cassa futuri oltre il piano, e viene calcolato attualizzando il primo flusso di cassa disponibile oltre piano, dividendolo per la differenza tra il tasso di sconto (tipicamente il costo medio del capitale) ed il tasso di crescita perpetua utilizzato nella formula: TV = CF / wacc – g. Pertanto, esemplificando, assumendo un flusso di cassa del primo anno oltre piano pari a 100, un wacc del 10%, ed un tasso di crescita perpetuo del 3%, il terminal value è pari a 1.428, cioè a circa 14 volte l’ultimo flusso di cassa disponibile.