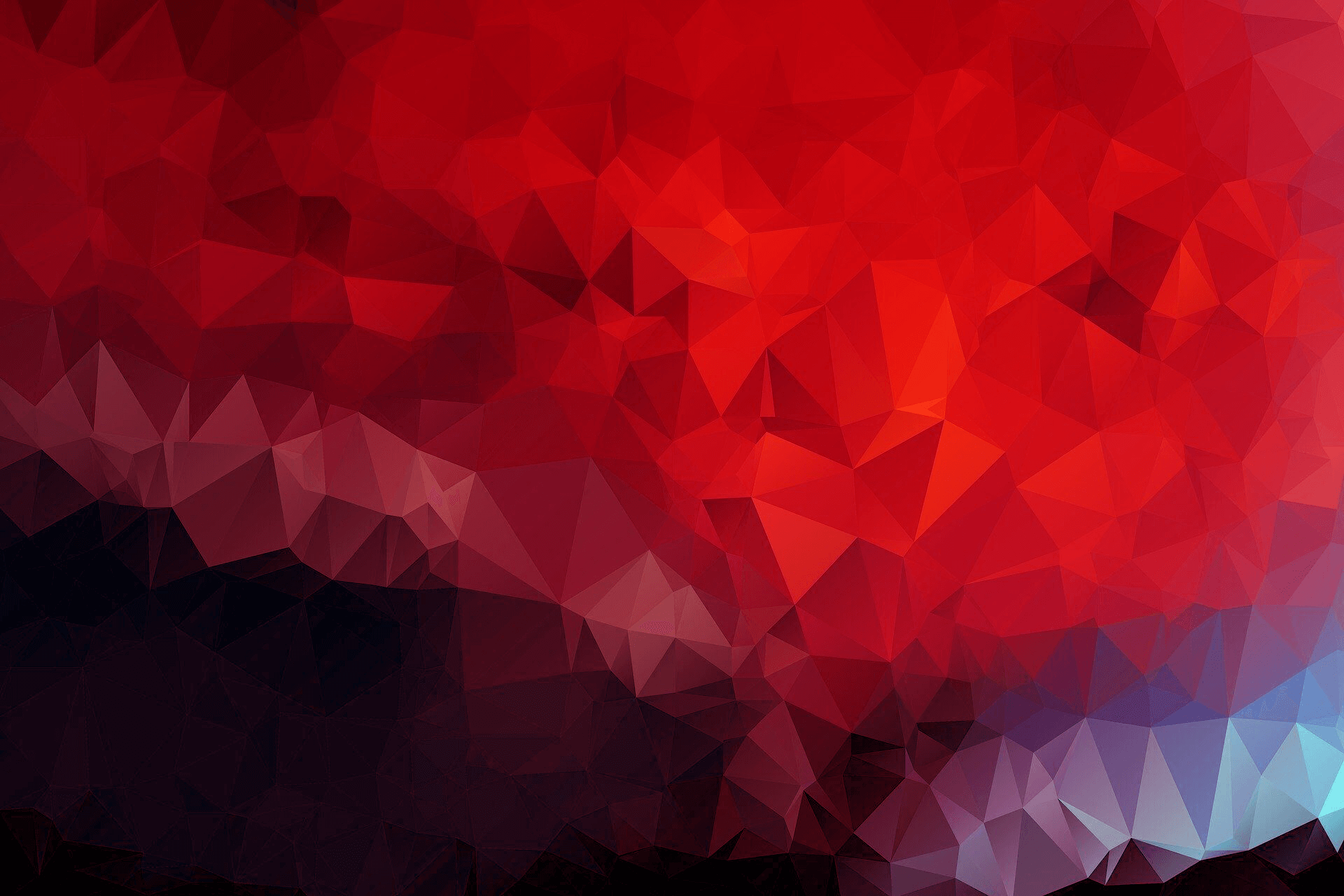Il presente contributo analizza le novità per gli intermediari del credito collegate al recepimento nazionale della Direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori (CCD2).
1. Introduzione
L’approvazione della Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (cosiddetta Consumer Credit Directive 2, o CCD2), relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (cosiddetta Consumer Credit Directive 1, o CCD1), segna un passaggio cruciale nel processo di evoluzione del diritto europeo dei consumatori e dei servizi di credito.
La necessità di tale riforma deriva da una serie di fattori concomitanti.
In primo luogo, la crisi finanziaria globale del 2008 e le successive tensioni sul debito sovrano hanno evidenziato le conseguenze negative di un accesso al credito non adeguatamente regolato, facendo emergere con forza il problema del sovraindebitamento dei consumatori[1].
La nuova disciplina si colloca, quindi, come risposta alle lacune emerse nell’attuazione della citata CCD1, la quale – pur avendo introdotto un primo corpus normativo armonizzato – non è riuscita a garantire un’effettiva uniformità regolatoria, né a far fronte alle trasformazioni economiche e della tecnologia digitale intervenute in maniera dirompente negli ultimi quindici anni[2].
La progressiva digitalizzazione dei mercati e l’espansione di modelli innovativi di concessione del credito – quali le piattaforme fintech, i servizi di buy now, pay later e i sistemi di intermediazione online – hanno introdotto una tipologia di prodotti e servizi innovativi difficilmente riconducibili nell’alveo dei paradigmi tradizionali normati dalla CCD1[3].
Infine, anche la diffusione di pratiche commerciali aggressive e opache, spesso connesse all’uso di tecniche digitali di profilazione e targeting, ha reso evidente l’insufficienza delle regole esistenti in termini di trasparenza e tutela del consumatore[4].
La CCD2 non si limita, dunque, a introdurre un aggiornamento delle norme esistenti, ma prevede una ridefinizione sistematica della materia del credito al consumo, ampliando la nozione di intermediari del credito per includervi operatori non tradizionali; rafforza gli obblighi di trasparenza e di valutazione del merito creditizio; interviene sul delicato tema dei metodi di pagamento digitali, chiarendone i rapporti con la disciplina del credito al consumo.
Le finalità perseguite dal nuovo regime sono molteplici: il legislatore vuole rafforzare la protezione del consumatore, individuato quale parte strutturalmente debole del rapporto di credito, così come intende promuovere una maggiore armonizzazione legislativa tra gli Stati membri, per favorire la creazione di un mercato unico del credito al consumo fondato sui princìpi della trasparenza, della concorrenza leale e della fiducia.
In questa prospettiva, la CCD2 si inserisce coerentemente nel più ampio disegno dell’Unione volto a coniugare innovazione digitale e tutela dei diritti fondamentali, alla luce dei princìpi di proporzionalità ed effettività che permeano il diritto europeo[5].
Nonostante l’ampliamento dell’ambito di applicazione, la CCD2 definisce anche un sistema di esenzioni. Restano, infatti, esclusi dalla sua applicazione, a esempio, i contratti di credito di modico valore, talune forme di credito agevolato o prestiti a condizioni particolarmente favorevoli (ad esempio quelli concessi da enti senza fini di lucro).
Tali deroghe rispondono a esigenze di policy regolatoria ed evitano di gravare con oneri informativi eccessivi transazioni marginali, in linea con il principio di proporzionalità sancito dal diritto dell’Unione, ma non sempre propriamente recepito dal legislatore nazionale in sede di implementazione delle norme europee.
Inoltre, la CCD2 riconosce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nella modulazione delle esclusioni, così da tener conto delle peculiarità dei mercati nazionali, creando una tensione tra esigenze di armonizzazione e di rispetto delle diversità giuridico-economiche interne all’Unione, come già evidenziato dalla dottrina nella fase applicativa della CCD1.
2. La nuova definizione di intermediario del credito
Come anticipato, la CCD2 ridefinisce la figura dell’intermediario del credito, superando l’impostazione restrittiva già presente nella CCD1, così come quella della legislazione italiana, con lo scopo di estendere la sua applicazione anche ad altri soggetti che svolgono un ruolo determinante nella messa in contatto tra consumatori e finanziatori (come ad esempio i fornitori di servizi digitali, le piattaforme fintech, marketplace, comparatori di offerte, buy now, pay later), recependo le trasformazioni del mercato.
La ratio legis appare, dunque, orientata a una regolazione di fenomeni innovativi e alla prevenzione di possibili “zone grigie” non presidiate dalla disciplina consumeristica.
Al fine di recepire il nuovo regime europeo, l’art. 121 (definizioni), comma 1, lett. h) del TUB[6] dovrebbe[7] essere modificato come segue: “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale e salve le ipotesi descritte dagli articoli 128-quater, comma 1-bis, e 128-sexies, comma 1-bis, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; […]”.
In un regime giuridico come quello Italiano, che già disciplinava la materia in modo specifico nel D. Lgs. n. 141/2010, le modifiche introdotte dallo Schema di Decreto generano alcuni dubbi interpretativi.
Ad esempio, in relazione alle modifiche introdotte all’articolo 128-quater del TUB, non è chiaro se l’attività di presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento possa intendersi quale attività diversa dalla pubblicità o meno. Se il concetto di “presentazione” si riferisse esclusivamente ad un’attività svolta nei confronti di un soggetto determinato, ne conseguirebbe che la norma non dovrebbe trovare applicazione rispetto alle ipotesi di marketing generalizzato (sponsorship, influencer, reti televisive e radiofoniche) in cui si sia in presenza di un messaggio pubblicitario indirizzato ad incertam personam.
Un altro tema interpretativo è quello connesso alla messa a disposizione di opzioni di pagamento finanziato poiché, per effetto dell’evoluzione tecnologica, non di rado accade che alcune forme di pagamento finanziato (tra cui le dilazioni di pagamento) siano messe a disposizione degli utenti online al momento del checkout del pagamento.
È il caso, a esempio, del pagamento tramite carta di credito o tramite una soluzione di buy now, pay later, quando la possibilità di utilizzare uno dei suddetti strumenti tra le opzioni di pagamento è fornita dall’esercente commerciale, senza svolgere alcuna attività di presentazione, proposta o conclusione di contratti di finanziamento.
Ciò in quanto gli strumenti di pagamento “finanziato” sono stipulati e conclusi direttamente tra il consumatore finale e il finanziatore. In tali casi, l’esercente potrebbe addirittura non essere a conoscenza della circostanza che lo strumento di pagamento utilizzato dal cliente sia finanziato (si pensi al caso delle carte di credito con opzione revolving o alla possibilità di pagare tramite operatori che, all’interno della propria interfaccia, offrono poi anche la possibilità di dilazionare il pagamento).
Ci si chiede, pertanto, se in tali ipotesi, l’esercente debba essere effettivamente assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 12-bis, commi 5 e 8, in forza della quale sarebbe tenuto a rispettare le disposizioni sul credito al consumo e alcune delle disposizioni applicabili agli intermediari del credito (sia una PMI o meno, come meglio di seguito evidenziato), anche considerando che, nella maggior parte dei casi, gli esercenti non percepiscono una remunerazione dal finanziatore, ma anzi pagano ai finanziatori delle commissioni sulle transazioni processate.
Lo Schema di Decreto posto in consultazione propone una modifica anche alla descrizione dell’attività tipica del mediatore creditizio disciplinata all’art. 128-sexies, comma 1, del TUB.
In particolare, viene proposta la seguente modifica: “È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza ovvero tramite canale informatico, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V o altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito, con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Con riferimento alla formulazione di tale disposizione, si evidenzia come il concetto di “canale informatico” non risulti definito dalla normativa né si possa considerare come un elemento tipico della definizione di intermediazione del credito; appare invero chiaro l’intento del legislatore di ricomprendere nel concetto di intermediazione del credito le piattaforme online di comparazione di prodotti bancari, ma il riferimento potrebbe essere frainteso ed esteso anche ad ogni marketplace (per il quale si ripropongono le considerazioni già espresse per gli esercenti nel paragrafo che precede).
3. Il registro per i fornitori di beni e prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio
Una rilevante novità introdotta dalla CCD2 è costituita dal sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza di cui all’art. 37.
In particolare, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che “i creditori e gli intermediari del credito siano soggetti ad un’adeguata procedura di abilitazione, a registrazione e a modalità di vigilanza stabilite da un’autorità competente indipendente”.
In considerazione dell’esistenza di un procedimento autorizzativo e di un sistema di albi, la CCD2 ha ritenuto di non estendere tale obbligo a creditori che siano, in sintesi, banche, istituti di moneta elettronica (ove abbia luogo la concessione di crediti connessi a taluni servizi di pagamento) o istituti di pagamento (per i servizi di esecuzione di operazioni di pagamento se i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento).
Nel rispetto del principio di proporzionalità, la direttiva attribuisce, tuttavia, la facoltà agli Stati membri di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi (gli esercenti) che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese[8] che agiscano come (i) intermediari del credito a titolo accessorio o (ii) creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale[9].
Pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis del novellando D. Lgs. 141/2010, banche e intermediari, così come i fornitori di beni e servizi che non si qualificano come microimprese o PMI devono comunicare al registro che sarà detenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori le informazioni che saranno definite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Schema di Decreto.
Il comma 5 del predetto articolo impone, altresì, agli esercenti (incluse le PMI, come si evince dal successivo comma 8 sul quale si dirà meglio nel prosieguo) di applicare la disciplina sul credito al consumo “ove compatibile”, locuzione che richiederà, in assenza di altre indicazioni, un certo sforzo interpretativo e potrebbe dar luogo a numerose contestazioni.
Ancora meno comprensibile appare, invece, la decisione del legislatore di stabilire requisiti di conoscenza, competenza e aggiornamento professionale anche in capo ai dipendenti e collaboratori degli esercenti (anche non PMI) che concludano contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l’acquisto di beni o servizi da essi offerti.
Con riferimento a quanto precede, merita segnalare quanto previsto dal comma 8 del nuovo art. 12-bis del novellando D. Lgs. 141/2010, secondo cui l’Organismo Agenti e Mediatori potrà, altresì, vigilare sui fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o PMI e che esercitano le attività di intermediazione creditizia in via accessoria, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche e gli intermediari finanziari, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile ai sensi del comma 5 sopra richiamato.
A tali fini, l’Organismo potrà richiedere ai fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle proprie attività di intermediazione e applicare sanzioni pecuniarie e amministrative. Tali disposizioni potrebbero quindi determinare rilevanti oneri a carico degli esercenti, tali da risultare dissuasivi sull’opportunità di offrire soluzioni di credito ai consumatori.
4. Il servizio di consulenza sul debito
Tra le novità più rilevanti, la CCD2 introduce obblighi nuovi o più stringenti anche in tema di educazione finanziaria, introducendo il concetto dei servizi di consulenza sul debito a favore dei consumatori che si trovino in difficoltà (o a rischio) nel rispettare i propri impegni finanziari. In particolare, è l’articolo 36 della CCD 2 quello che disciplina i “servizi di consulenza sul debito” come strumento di supporto ai consumatori in situazioni di fragilità finanziaria.
Lo schema di decreto definisce come segue il nuovo servizio: “…. L’assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza quali definiti all’articolo 114.1, comma 1, lettere c) ed e), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari”.
La figura del consulente sul debito non è ancora definita in modo pienamente operativo, ma lo Schema di Decreto ne prevede la regolamentazione, forse con la creazione di uno specifico albo[10], al quale il consulente potrà iscriversi, probabilmente, nel rispetto di determinati requisiti (obblighi formativi, standard etici, comprovate competenze tecniche), operando in maniera indipendente dai finanziatori.
Va ricordato che è stato proprio il MEF, con uno dei documenti posti in consultazione[11], a richiedere agli interessati di presentare ipotesi di revisione o di integrazione della normativa in corso di adozione al fine di definire, tra l’altro, le modalità di regolamentazione dei servizi di consulenza sul debito, con riferimento alle categorie di soggetti (operatori professionali indipendenti) più idonee ad offrire questa tipologia di servizi ai consumatori, e come abbiamo osservato e i requisiti specifici per l’accesso al servizio di consulenza (individuazione di forme di difficoltà finanziaria e/o livelli di indebitamento rilevanti); la consultazione ha altresì richiesto indicazioni circa la possibilità di imporre degli oneri a carico del consumatore a copertura dei soli costi operativi del servizio[12] insieme alla necessità che i dipendenti e/o i collaboratori dei soggetti individuati siano adeguatamente formati all’erogazione dei servizi di consulenza sul debito e soggetti ad obblighi di aggiornamento professionale periodico.
Resta, quindi, da capire, a mero titolo di esempio, se tutti i consumatori potranno ricevere detto servizio o se riguarderà solo determinate categorie di debitori (per esempio con debiti sopra un determinato ammontare) e se sarà altresì richiesto che il fornitore del servizio di consulenza sia a conoscenza delle norme sull’insolvenza del consumatore e del sovraindebitamento
Premesso quanto precede, fare riferimento ad un’assistenza di natura “tecnica, giuridica o psicologica” fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, finanziatori o intermediari del credito, o gestori di crediti in sofferenza o acquirenti di crediti in sofferenza, pone il lettore della norma di fronte a ulteriori rilevanti dubbi.
Il consulente appare quasi come una figura mitologica, con competenze che spaziano dal campo dell’economia e della finanza a quelle del diritto e addirittura della psicologia[13].
Il provvedimento di recepimento della CCD2, in conclusione, sembra quanto meno incompleto sotto molteplici profili sostanziali, oltreché di difficile interpretazione, con il concreto rischio che resti di incerta e difficile (se non impossibile) applicazione pratica, in assenza di rilevanti revisioni ed integrazioni.
Come troppo spesso è accaduto, la discrezionalità lasciata agli Stati membri e ai policy maker locali potrebbe ridurre il grado di armonizzazione effettiva della norma, generando importanti asimmetrie applicative, a discapito degli operatori e dei consumatori, in un contesto sempre più dominato da tecnologie digitali e da nuovi modelli di intermediazione.
[1] V. P. Rott, Consumer Credit Regulation after the Financial Crisis, in Journal of Consumer Policy, 2011, p. 227 ss.
[2] Cfr. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in GUUE L 133 del 22.5.2008.
[3] G. De Cristofaro, Credito al consumo e nuovi modelli di intermediazione: verso una disciplina europea più inclusiva, in Contratto e impresa/Europa, 2022, p. 145 ss.
[4] M. Loos – J. Luzak, Transparency of Consumer Credit Agreements in the EU: An Empirical Study, in European Review of Private Law, 2016, p. 855 ss.
[5] Cfr. considerando 7 e 8 CCD2, che richiamano espressamente il principio di proporzionalità e la necessità di garantire un livello elevato di protezione del consumatore.
[6] Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive modifiche ed integrazioni.
[7] Come riportato dallo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il recepimento della CCD2 posto in consultazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sino allo scorso 4 settembre (lo “Schema di Decreto”).
[8] Quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.
[9] Cfr. art. 37, par. 3 della CCD2
[10] Suggerisce
[11] Allegato II, Questioni specifiche su cui si ritiene opportuno un confronto con il mercato.
[12] Va tuttavia osservato come tale soluzione non appaia coerente con la normativa europea relativa ai servizi di consulenza sul debito, che dovrà essere attuata in Italia ad invarianza finanziaria, senza dover introdurre nuove figure professionali. La formulazione dell’art. 36 della CCDII prevede infatti che: “Gli Stati membri assicurano che siano messi a disposizione dei consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari servizi di consulenza sul debito indipendenti per i quali siano dovute solo spese limitate”.
[13] Osserva l’Associazione degli intermediari Bancari, Finanziari e Assicurativi, come si dovrebbe ritenere che la consulenza debba essere prestata da professionisti “indipendenti”, iscritti nei rispettivi albi professionali (i.e. Avvocati, Commercialisti e Psicologi) che ne facciano richiesta. Il che, evidentemente, assicurerebbe, che il servizio sia prestato da “operatori professionali” tenuti anche al rispetto di stringenti norme deontologiche già scritte, il cui rispetto è presidiato dai rispettivi Ordini professionali di appartenenza, posto che non è prevista nella direttiva la facoltà di istituire nuove figure professionali, la cui introduzione determinerebbe la sovrapposizione con altre figure professionali preesistenti, generando un’ingiustificata distorsione della concorrenza.