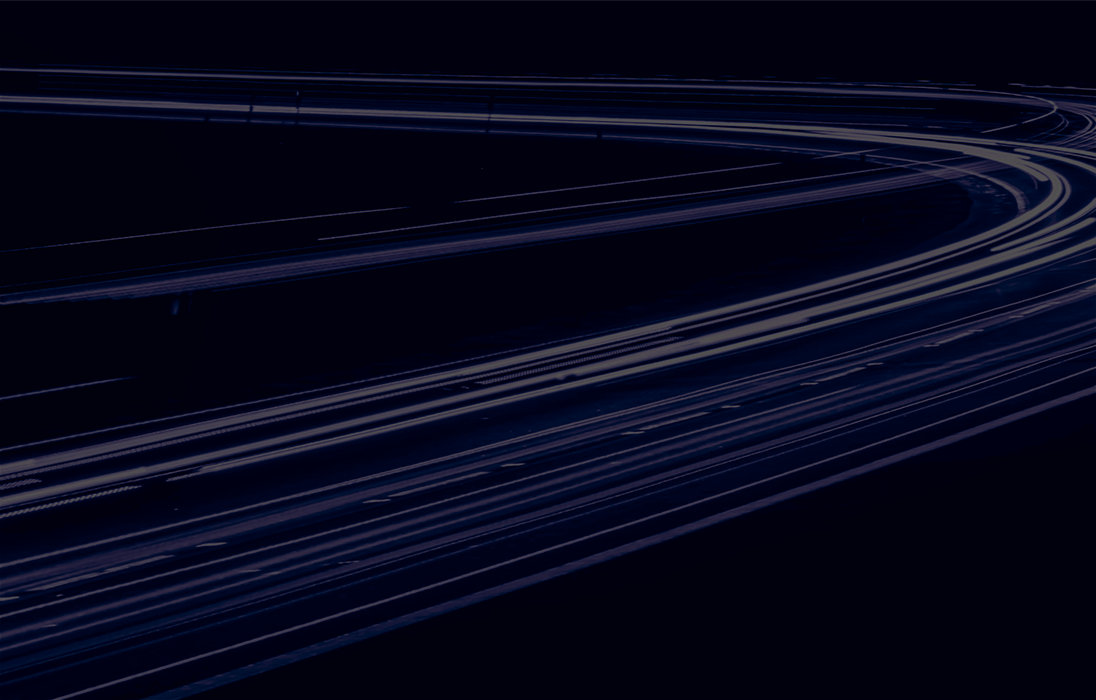Il presente contributo analizza le nuove disposizioni di coordinamento tra il principio OIC 34 e i criteri di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP dettate nel decreto Ministero dell’Economia e delle finanze 27 giugno 2025.
1. Premesse
Dopo più di due anni dalla pubblicazione del principio contabile OIC 34, il 27 giugno 2025 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle finanze lo schema di decreto (in seguito anche “il decreto”) con il quale sono state stabilite le regole di coordinamento tra i criteri di rilevazione contabile dei ricavi previsti dal nuovo principio contabile OIC (il principio OIC 34) e i criteri di determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP. Queste regole si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile OIC 34. Il presente contributo si propone, in primo luogo, di commentare le disposizioni del decreto, provando, poi, ad analizzare se e come il principio di “derivazione rafforzata” sarà stato applicato [1].
2. Riconoscimento fiscale del criterio di qualificazione contabile
Forse il punto di maggiore interesse fiscale posto dal principio OIC 34 è proprio relativo al riconoscimento fiscale del processo decisionale in cui si articola l’attività sottesa alla rilevazione (o non rilevazione) del ricavo. Infatti, in tale processo sono presenti valutazioni che, in linea teorica, potevano far supporre ad una loro sterilizzazione ai fini IRES e IRAP. Elementi a supporto della natura qualificatoria dell’intero processo decisionale di rilevazione del ricavo e l’assenza di questo decreto non hanno fatto altro che ritenere del tutto remota tale possibile sterilizzazione.
Infatti, proprio su questo punto, la Relazione illustrativa al decreto inizia ad entrare nel dettaglio dell’intervento normativo, con un chiarimento generale, cioè non illustrativo di una disposizione del decreto, affermando che con gli articoli da 1 a 5 del presente decreto si è inteso chiarire la rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione dei ricavi introdotte dall’OIC 34, sottolineando che con il decreto in commento il Ministero non è intervenuto per confermare i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti da corretti principi contabili ma soltanto per chiarire criteri di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione. Pertanto, tutte le qualificazioni contabili espressive di una valutazione, che possono portare anche alla mancata rilevazione contabile del fenomeno che si è manifestato sotto il profilo giuridico-formale, saranno riconosciute anche ai fini fiscali.
Questo passaggio della Relazione illustrativa è una vera e propria “dichiarazione programmatica” per la gestione degli effetti fiscali del principio OIC 34; la volontà, in altre parole, di riconoscere ai fini IRES e IRAP i criteri contabili dell’OIC 34 che non siano stati diversamente disciplinati dal decreto.
Una fattispecie che sarà riconosciuta ai fini fiscali, ad esempio, è quella delle vendite con opzione di acquisto e alle vendite condizionate (OIC 34, Appendice A, Guida applicativa, paragrafi A.8-A.12). Infatti, disconoscere la sostanza sottesa a tali accordi contrattuali avrebbe significato disconoscere non già una valutazione ma l’intero processo che porta alla qualificazione di un’operazione di vendita (ovvero alla non qualificazione della medesima operazione in un dato esercizio), in applicazione del postulato della rappresentazione sostanziale dell’operazione (citati art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c. e principio contabile OIC 11 par. 27). Pertanto, il processo di analisi sostanziale del contratto stipulato (o dei contratti stipulati) con il cliente richiesto per la rilevazione del ricavo di vendita, che inizia con l’identificazione di uno o più contratti stipulati con il cliente per concludersi con la rilevazione del ricavo (o quota del ricavo relativo ad una specifica unità elementare di contabilizzazione) è riconosciuto ai fini della determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione Irap.
Un’altra fattispecie di criterio di rilevazione contabile del ricavo che assume riconoscimento fiscale è quella che conduce alla imputazione a conto economico soltanto i ricavi netti della propria attività (es: le commissioni per l’attività di distribuzione effettuata) in presenza di determinate condizioni previste dai paragrafi A.5-A.7 della suddetta Guida applicativa [2].
Un altro ambito di riconoscimento fiscale è rappresentato dalla rilevazione contabile degli sconti, i quali, anche per effetto degli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati nel 2024, ora non sono più differenziati nel sistema dei principi OIC tra sconti commerciali e sconti finanziari. Pertanto, la rilevazione di uno sconto, a rettifica dei ricavi (OIC 34, par. 15), avrà sempre natura commerciale e non finanziaria, con riconoscimento integrale ed immediato ai fini IRES e IRAP. Tale qualificazione fiscale rende, a questo punto, superata l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate nella risposta n. 46/2023, che aveva identificato la natura finanziaria negli “sconti cassa”, vale a dire negli sconti concessi per incrementare le vendite [3].
3. Le disposizioni previste dal d.m. 27 giugno 2025
Articolo 2 – (Costi per l’ottenimento del contratto)
Il paragrafo A.13 del principio contabile OIC 34 prevede una serie di condizioni e di esclusioni per la rilevazione contabile dei costi sostenuti per stipulare un contratto con un cliente.
In particolare, i suddetti costi devono essere imputati a conto economico se saranno recuperati tramite il contratto di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti o se sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto. Inoltre, è consentita la scelta tra la imputazione a conto economico e la capitalizzazione per quei costi ricorrenti o di importo irrilevante; è possibile capitalizzarli se sostenuti specificatamente per un contratto di vendita, l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo, e se tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita.
Ciò premesso, l’art. 2 del decreto stabilisce che “I costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, ai sensi del paragrafo A.13 dell’Appendice A dell’OIC 34 sono deducibili ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR”. La relazione illustrativa, in linea con quanto è stato fatto per la deducibilità dei medesimi oneri sostenuti per i soggetti Ias-adopter, conferma che i costi di ottenimento di un contratto capitalizzati possono essere riconosciuti ai fini Ires e Irap soltanto come costi oneri pluriennali, disciplinati, dunque, dall’art. 108, comma 1, del TUIR (deducibili cioè in base alla quota imputata a conto economico).
Anche se l’OIC 34 ne consente l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali, ciò non dovrebbe attribuire la qualificazione civilistica di bene immateriale ai costi per l’ottenimento del contratto, i quali resterebbero pur sempre costi pluriennali iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Pertanto, se non viene acquisita una posizione giuridicamente tutelata, questi costi, laddove capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, potrebbero considerarsi ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 108 del Tuir già solo in applicazione del principio di riconoscimento fiscale del principio di qualificazione e classificazione contabile dell’onere sostenuto [4].
Articolo 3 – (Corrispettivi variabili)
I corrispettivi aggiuntivi (ad esempio, incentivi e premi di risultato) sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto di vendita solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi (principio OIC 34, par. 14). Poi, oltre ai corrispettivi aggiuntivi possono essere previste ipotesi di riduzione del corrispettivo (sconti, abbuoni, penalità e resi), che sono contabilizzate in riduzione dei ricavi sulla base della migliore stima del corrispettivo tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche (OIC 34, par. 15).
L’articolo 3, comma 1, del decreto si occupa degli effetti fiscali delle variazioni di corrispettivo dovute soltanto a penali legali e contrattuali, stabilendo che le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui diventa certa l’esistenza e determinabile in modo obiettivo l’ammontare delle penali stesse. Poi, al comma 2, si chiarisce che il principio di previa imputazione a conto economico (art. 109, comma 4, del TUIR) si ritiene rispettato dalla rilevazione contabile del ricavo (giuridico) ridotto dal valore della stima del valore della penale legale o contrattuale. Si ricorda che per le penali non è previsto dall’OIC 34 l’appostazione di un fondo rischi.
Per la Relazione illustrativa al decreto l’art. 3 intende coordinare la contabilizzazione di ricavi, di cui una quota presenta un ammontare variabile, con la “classificazione fiscale di “accantonamento” per le penali legali e contrattuali, in linea con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 e dell’articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011, applicabili ai soggetti OIC adopter in virtù dell’articolo 2 del D.M. 3 agosto 2017”. In altre parole, per la Relazione illustrativa al decreto, il valore delle penali rilevato a rettifica dei ricavi avrebbe natura di accantonamento, circostanza che renderebbe applicabile l’art. 107 del TUIR in seguito al combinato disposto dei citati articoli 9 del d.m. 8.6.2011 e 2 del d.m. 3.8.2017, e poiché tale natura non emergerebbe perché contabilizzata a riduzione dei ricavi e non come accantonamento, si è reso necessario disciplinarne gli effetti fiscali con l’articolo 3 in commento.
La motivazione indicata in tale documento [5] pone qualche dubbio sul riconoscimento fiscale del criterio di qualificazione dei ricavi in quanto essi devono essere contabilizzati al netto di un onere (sconto o penale) che sia la migliore stima al momento dell’onere che sarà sostenuto, ma che comunque non determina lo stanziamento di un fondo rischi. Al riguardo, si ricorda che l’art. 9 del d.m. 8.6.2011 qualifica come accantonamento anche oneri non contabilizzati come accantonamenti purché aventi come contropartita patrimoniale lo stanziamento di un fondo rischi/oneri. Nelle ipotesi delle penali disciplinate dal principio OIC 34 non è prevista la rilevazione di un fondo ma soltanto di un minore ricavo misurato da un minore credito commerciale, circostanza che dovrebbe far ritenere corretto l’immediato riconoscimento fiscale delle penali, quale diretta applicazione del principio di derivazione rafforzata [6].
Una conferma a tale dubbio è offerta dalla stessa Relazione illustrativa, quando si commentano gli effetti fiscali della rilevazione di operazioni e concorsi a premio (OIC 34, par. 17, lettera b); infatti, la stessa Relazione chiarisce che il regime fiscale delle operazioni e concorsi a premio deve essere differenziato in base alla natura del premio. Se il premio spettante al cliente è rappresentato da beni o servizi diversi da quelli venduti dalla società, il costo di tali beni o servizi che la società prevede di sostenere è rilevato a fondo oneri senza rettificare i ricavi. Viceversa, se il premio consiste in uno sconto su acquisti futuri, questi sconti sono contabilizzati a riduzione dei ricavi. Nel primo caso, la presenza del fondo farebbe scattare l’art. 107 del TUIR, mentre nelle ipotesi in cui i premi siano corrisposti tramite sconti da contabilizzare a riduzione dei ricavi, tale riduzione sarebbe immediatamente riconosciuta ai fini IRES e IRAP in quanto fenomeno c.d. “qualificatorio”. È evidente, dunque, come l’assenza del fondo, sia nelle ipotesi di penali legali e contrattuali che di premi corrisposti sotto forma di sconti, non abbia il medesimo effetto fiscale, in quanto la riduzione dei ricavi da penali sarebbe qualificata come accantonamento (art. 107 del TUIR) mentre la riduzione dei ricavi da sconti sarebbe qualificata come minore ricavo (artt. 83 e 85 del TUIR).
Articolo 4 – (Vendita con reso)
L’articolo 4 si occupa del regime fiscale attribuibile alle ipotesi in cui il prodotto è venduto con diritto alla restituzione.
Il principio contabile OIC 34 prevede due criteri di rilevazione contabile dei resi in funzione della tipologia di valutazione del reso. Per le vendite il cui rischio di reso non si presta ad una valutazione per massa, i ricavi sono rilevati solo se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non restituirà il bene (paragrafo 27). Viceversa, per le vendite il cui rischio di reso è valutato per massa, si determina l’ammontare della passività classificata tra i fondi oneri e il relativo onere non è contabilizzato come accantonamento bensì a rettifica il ricavo (paragrafo 28). Pertanto, se il rischio di restituzione è valutato analiticamente, il processo di valutazione del reso è inscindibilmente legato a quello di valutazione di rilevazione del ricavo, con l’effetto che se l’impresa valuta come ragionevolmente certa la restituzione, il ricavo non è rilevato, mentre per il rischio di vendita valutato per massa sarà contabilizzato un fondo oneri la cui manifestazione economica non sarà rappresentata da un accantonamento ma da una riduzione dei ricavi (così come avviene per le operazioni e i concorsi a premio rappresentati dall’ottenimento di uno sconto su acquisti futuri).
Ciò posto in termini contabili, l’articolo 4 del decreto interviene per disciplinare il regime fiscale soltanto dei resi valutati per massa. Infatti, il comma 1 stabilisce che “L’importo rilevato in base alla corretta applicazione del paragrafo 28 dell’OIC 34 corrispondente al costo dei beni restituiti dal cliente è ammesso in deduzione all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri”. Poi, come per l’art. 3 del decreto, il successivo comma 2 chiarisce che la previa imputazione a conto economico (art. 109, comma 4, del TUIR) dell’onere misurato dal fondo oneri è rispettata dalla rilevazione dell’accantonamento sotto forma di una riduzione dei ricavi.
Questa disciplina, indirettamente, conferma che la mancata rilevazione del ricavo in presenza di un reso non valutato per massa rappresenta un processo di valutazione compreso all’interno del processo di rilevazione del ricavo e, dunque, esso deve essere riconosciuto ai fini fiscali.
Questa interpretazione trova conferma dalla Relazione illustrativa al decreto, la quale afferma che “La mancata rilevazione dei ricavi realizza un fenomeno di “qualificazione” che, dunque, assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRES e IRAP.”. Viceversa, per i resi valutati per massa, la presenza di un fondo oneri impone l’attivazione dell’art. 107 del TUIR e, dunque, i resi saranno riconosciuti all’atto della restituzione da parte del cliente del prodotto venduto.
Per le vendite con diritto di restituzione, il bene venduto continua a figurare tra le rimanenze di magazzino al valore contabile di originaria iscrizione in magazzino ovvero, in caso di inattendibilità di tale valore, al costo medio (OIC 34, par. 29). Come sottolineato dalla Relazione illustrativa al decreto, i riflessi fiscali di tale contabilizzazione risulteranno diversi per le due fattispecie di vendita con reso ivi disciplinate.
Per i resi analiticamente stimati su vendite di beni (giuridicamente effettuate ma) non contabilizzate, il bene continuerà a far parte del valore del “magazzino” ai fini fiscali, e il credito verso i clienti non contabilizzato sarà anche fiscalmente non riconosciuto.
Mentre per le vendite i cui resi sono stimati per massa, l’irrilevanza fiscale della rettifica del relativo ricavo determina il riconoscimento della variazione delle rimanenze, ai fini della base imponibile IRES, nonché dell’IRAP, per l’ammontare stimato del reso. Pertanto, il costo corrispondente ai beni venduti con diritto di reso non sarà incluso nel valore del “magazzino” ai fini fiscali, e il credito verso i clienti contabilizzato sarà fiscalmente riconosciuto in misura pari al valore fiscale del ricavo.
Articolo 5 – (Disposizioni ai fini IRAP)
L’articolo 5 del decreto stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 3 (Corrispettivi variabili) e 4 (Vendita con reso) si applicano anche ai fini IRAP. Pertanto, in applicazione della c.d. “presa diretta dal bilancio”, i ricavi rilevati ai sensi dell’OIC 34 concorreranno a formare il valore della produzione IRAP; tuttavia, vi sono da considerare anche gli accantonamenti che sono stati contabilizzati a riduzione degli stessi ricavi, accantonamenti che, come noto, devono essere sterilizzati dal valore della produzione, per concorrervi nel periodo in cui gli oneri sottesi a tali accantonamenti saranno sostenuti. In particolare, gli accantonamenti relativi ai resi stimati per massa e alle penali legali e contrattuali dovranno essere ripresi in aumento della base imponibile IRAP del periodo in cui sono stati imputati a conto economico sotto forma di minori ricavi.
Articolo 7 – (Decorrenza)
Come è stato anticipato nelle premesse, le disposizioni del decreto relative al principio OIC 34 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile OIC 34. L’OIC, in una risposta ad un quesito sul principio OIC 34 pubblicata il 22 dicembre 2023, ha avuto l’occasione di precisare che “…l’OIC 34 non prevede l’adozione anticipata al 2023. Tuttavia, si osserva che il tema della mancata previsione dell’applicazione anticipata fa salvi comportamenti contabili conformi ai principi attualmente vigenti che trovano conferma nelle specificazioni contenute nell’OIC 34”. Inoltre, è stato altresì chiarito che il tema della contabilizzazione dei soli compensi spettanti agli intermediari non è una novità contabile del principio OIC 34 in quanto tale criterio di rilevazione contabile è già previsto dal sistema dei principi contabili attualmente vigenti (OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino), per il quale “laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati” [7].
Gli effetti contabili derivanti dalla c.d. “FTA OIC 34” sono rilevati nel patrimonio netto, in applicazione del paragrafo 15 e seguenti dell’OIC 29 (“applicazione retrospettiva”, paragrafo 44) [8]; in alternativa a tale rilevazione contabile “pregressa”, è consentita l’applicazione “prospettica” del principio OIC 34 (paragrafo 45). In tale ultima ipotesi, non si creano i presupposti per le c.d. “operazioni pregresse” (art. 10, comma 6, d.lgs. n. 192 del 2024), in quanto le disposizioni del principio OIC 34 saranno applicate solo ai contratti di vendita stipulati a partire dall’inizio del primo esercizio di applicazione del presente principio contabile”.
4. Conclusioni
La Relazione illustrativa al decreto ha affermato si è intervenuti per “chiarire” gli effetti fiscali di alcune rilevazioni contabili del principio OIC 34. In particolare, non sarebbero state dettate disposizioni per confermare i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti da corretti principi contabili (già rilevanti nell’ambito del reddito di impresa), “ravvisando, viceversa, l’opportunità di regolamentare quei fenomeni di qualificazione/classificazione incerta ovvero di mera valutazione”. Il decreto, dunque, conferma che le valutazioni compiute all’atto della possibile rilevazione del ricavo non devono essere sterilizzate ma sono parte del processo di rilevazione contabile della vendita e, dunque, è corretto che la rilevazione (o la mancata rilevazione) del ricavo che comprende anche una quota di valutazione deve essere riconosciuta ai fini fiscali.
In questo ambito, molto opportunamente il decreto, riconoscendo alcune peculiarità di tale principio contabile rispetto al principio IFRS 15, riconosce i resi analiticamente determinati (mentre in ambito Ias/Ifrs non sono mai riconosciuti), mentre le operazioni e concorsi a premio determinano oneri fiscalmente riconosciuti soltanto laddove il premio è rappresentato da uno sconto su acquisti futuri.
Anche per gli sconti, dopo gli emendamenti approvati definitivamente nel marzo del 2024 non deve essere più seguita la distinzione tra sconti commerciali e finanziari, rendendo a questo punto superata l’interpretazione seguita dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 46/2023.
Ciò posto, qualche dubbio lascia il decreto quando, all’art. 3, qualifica come accantonamento la rettifica ai ricavi rappresentata da penali legali e contrattuali. In particolare, poiché tali oneri sono rilevati a riduzione dei ricavi, così come gli sconti, i resi analitici e gli abbuoni, non si comprende il motivo per i quali questi ultimi siano riconosciuti ai fini fiscali nel medesimo periodo corrispondente all’esercizio in cui essi sono imputati a conto economico mentre le penali (per le quali l’OIC 34 non prevede lo stanziamento di un fondo) debbano essere riconosciuti soltanto all’atto del relativo sostenimento.
Pertanto, eccezion fatta per le penali legali e contrattuali (la cui qualificazione contabile, si ripete, avrebbe suggerito la natura fiscale di rettifica di ricavo e non di accantonamento), ci si domanda se gli effetti fiscali derivanti dalle disposizioni del decreto non potevano ritenersi applicabili semplicemente riconoscendo in ambito IRES e IRAP i ricavi contabilizzati secondo i criteri previsti dal principio OIC 34.
[1] La struttura degli articoli del decreto ricorda quella del d.m. 10.1.2018, emanato per gestire gli effetti fiscali del principio IFRS 15; infatti, sono stati disciplinati i costi per l’ottenimento del contratto (art. 2), i corrispettivi variabili per le penali (art. 3) e i resi (art. 4), l’Irap (art. 5) e la decorrenza (art. 6). Con il decreto in commento, il Mef ha colto l’occasione per disciplinare anche gli effetti fiscali derivanti dagli emendamenti ai principi contabili OIC pubblicati nel marzo del 2024 in particolare ai principi contabili OIC 16 e OIC 31. Infatti, l’articolo 6 del decreto disciplina il trattamento fiscale relativo ai costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito.
[2] Nel corso del 2024 una società che emette “buoni pasto” ha inviato una richiesta di chiarimento all’OIC sull’applicazione dei paragrafi A.5 – A.7 dell’OIC 34, e cioè, per comprendere se essa debba contabilizzare i ricavi al lordo oppure al netto dei costi sostenuti, per dare evidenza della commissione realizzata.
I buoni pasto sono forniti dalle società emittenti ai datori di lavoro che a loro volta li distribuiscono ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa. L’emittente non ha sostanzialmente alcuna responsabilità sulla qualità del pasto che l’esercizio convenzionato somministra al dipendente. A fronte dell’utilizzo da parte del dipendente del buono pasto, gli esercizi convenzionati incassano il corrispettivo per la somministrazione di alimenti sottesa il valore del buono pasto dall’emittente, al netto di uno sconto incondizionato preventivamente negoziato tra l’emittente e l’esercizio convenzionato, da applicarsi al valore facciale del buono pasto.
Poiché la società emittente non ha somministra i pasti, non decide il prezzo da praticare al pubblico e né ha il rischio magazzino, l’emittente agisce per conto di un soggetto terzo e pertanto in base al paragrafo A.7 dell’OIC 34 deve rilevare il ricavo al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati per dare evidenza del valore della commissione ricevuta.
[3] Per approfondimento su questo punto si rinvia ad Assonime, circolare n. 30/2023.
[4] Per il principio contabile Ifrs 15 (paragrafi 91-94), l’entità deve contabilizzare come attività i costi incrementali per l’ottenimento del contratto con il cliente, se prevede di recuperarli. Il dubbio se ai fini fiscali dovesse ammortizzarsi tale attività ovvero una spesa pluriennale ha indotto il d.m. 10.1.2018 a chiarire (art. 1) che tali oneri sono ammessi in deduzione ai sensi dell’art. 108 del Tuir. Pertanto, forse anche per i soggetti Ias-adopter l’applicazione dell’art. 108, comma 1, del TUIR poteva desumersi dal principio di “derivazione rafforzata”.
[5] “L’articolo 3 del decreto, è, quindi, finalizzato a regolare un fenomeno ontologicamente analogo a quello disciplinato dall’articolo 9 del D.M. 8 giugno 2011 e non intercettato dalla richiamata disposizione unicamente per la diversa contabilizzazione che non impone più la rilevazione di un costo a fronte della passività di scadenza e ammontare incerti ma la diretta rilevazione di un ricavo netto (non sono d’accordo per i motivi suddetti). Per ragioni di semplificazione ed esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, l’ambito applicativo della norma, in linea con il citato Decreto IFRS 15, è stato limitato alle sole variazioni del corrispettivo riconducibili a “penali legali e contrattuali””.
[6] Sul punto si rinvia ad Assonime, circolare n. 30/2023.
[7] Questo passaggio, poi, è stato riportato nella Relazione illustrativa al decreto per rappresentare come il processo decisionale da seguire per la rilevazione dei ricavi, per la non rilevazione dei ricavi ovvero per la rilevazione delle sole commissioni deve essere riconosciuto anche ai fini fiscali.
[8] La Relazione illustrativa al decreto, infine, ricorda che la prima applicazione dell’OIC 34 è una delle ipotesi di “variazione dei principi contabili nazionali”, di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 192 del 2024, da cui possono emergere le divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili disciplinate dagli articoli da 10 a 13 del medesimo d.lgs. n. 192 del 2024.