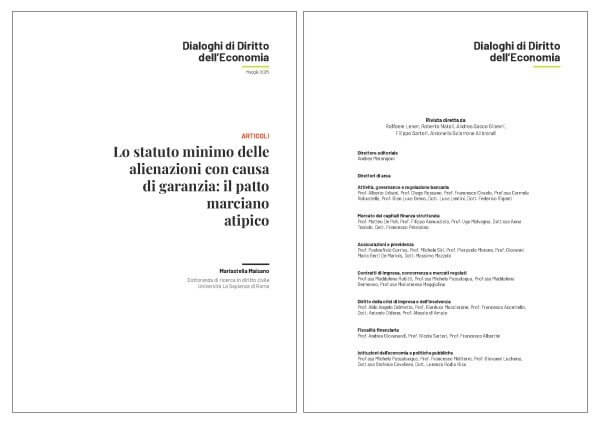SOMMARIO: Il codice civile non conosce il patto marciano; lo conosce, invece, il legislatore di settore, e lo introduce nel d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, sulle garanzie finanziarie, soprattutto all’art. 4 in materia di pegno su attività finanziarie, nell’art. 11-quaterdecies, co. 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, relativo al prestito vitalizio ipotecario, nell’art. 120-quinquiesdecies TUB, co. 3, in merito al credito immobiliare ai consumatore e nell’art. 48-bis T.U.B. Questi interventi settoriali si inseriscono nel solco di un atteggiamento già inaugurato dalla giurisprudenza, seguito poi dalla dottrina, che individua nell’accordo marciano uno strumento alternativo di realizzazione del credito, in grado di superare l’inadeguatezza di un sistema legale di garanzie reali, ancora più atrofizzato dall’esistenza del divieto di patto commissorio di cui è lecito sospettare l’anacronismo.
ABSTRACT: The Civil Code is not familiar with the Marcian covenant; on the other hand, the sector legislature is familiar with it, and introduces it in Legislative Decree No. 170 of May 21, 2004, on financial guarantees, especially in Art. 4 on pledging financial assets, in Art. 11-quaterdecies, para. 12, Decree Law No. 203 of September 30, 2005, converted into Law No. 248 of December 2, 2005, regarding life mortgage loans, in Art. 120-quinquiesdecies TUB, para. 3, regarding real estate credit to consumers, and in Art. 48-bis T.U.B. These sectoral interventions follow in the wake of an attitude already inaugurated by case law, later followed by doctrine, which identifies the marcian agreement as an alternative tool for credit realization, capable of overcoming the inadequacy of a legal system of collateral, which is even more atrophied by the existence of the prohibition of covenants of trust whose anachronism is open to suspicion.
1. Le garanzie marciane tipiche
La disciplina extra codicistica ha introdotto figure tipiche di patti marciani con l’obiettivo di favorire le occasioni di recupero dei crediti da parte dei soggetti finanziatori e di contenerne i tempi, tramite la promozione di metodi di autotutela esecutiva[1].
Se da un lato il merito delle normative di settore di seguito elencate è quello di aver tentato di avviare un processo di inversione di tendenza rispetto alla rigidità adottata dalla giurisprudenza in merito all’interpretazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c[2]., da altro lato tale processo ha messo in discussione quei principi codicistici oramai consolidati in materia di responsabilità e garanzie patrimoniali rinnovando così l’attenzione sul tema dell’autotutela dei diritti che sembrava aver subito una battuta d’arresto[3].
Il discorso si inserisce nel solco della riflessione sull’applicazione dei principi dei ragionevolezza e proporzionalità[4], declinati nell’ambito degli strumenti di agevolazione di accesso al credito che, al contempo, consentono il rafforzamento della posizione creditoria[5].
Congegni perequativi di stampo marciano[6] sono previsti nel d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, sulle garanzie finanziarie, soprattutto all’art. 4 in materia di pegno su attività finanziarie, ma pure all’art. 6, in cui si sottrae il trasferimento della proprietà di strumenti finanziari in funzione di garanzia all’applicazione dell’art. 2744 c.c., prevedendo un rinvio, circa le modalità satisfattorie, a quelle marciane dell’art. 4 (art. 6, co. 3 , che rinvia all’art. 5, co. 4, d.lgs. n. 170/2004); nell’art. 11-quaterdecies, co. 12, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, relativo al prestito vitalizio ipotecario (c.d. “prestito vecchietti”), in cui con l. 2 aprile 2015, n. 44, il legislatore ha inserito un meccanismo marciano legale; il comma 12-quater; nel d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 – attuativo della Dir. (UE) 2014/ 17 – che ha introdotto nel T.U.B. un capo I-bis – rubricato Credito immobiliare ai consumatori -, e specificamente art. 120-quinquiesdecies TUB, co. 3; nell’art. 1 (spec. co. 7, lett. a), del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119, che ha introdotto il pegno non possessorio su beni d’impresa, prevedendo per il creditore diversi modi di auto soddisfacimento sui beni dati in garanzia, ma sempre con il correttivo marciano della restituzione del supero al debitore[7]; infine, nell’art. 2 dello stesso d.l. n. 59/2016, che ha introdotto nel T.U.B. l’art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato), dove pure è prevista la possibilità di un patto di alienazione in garanzia sospensivamente condizionato all’inadempimento, salva la disciplina di un dettagliato procedimento perequativo per evitare che il creditore si appropri dell’eccedenza di valore dell’immobile rispetto al credito garantito.
Prima di entrare nel merito delle singole previsioni marciane, occorre delineare analiticamente i requisiti oggettivi e soggettivi che ne definiscono l’ambito di applicazione[8].
E ciò è funzionale ai fini del discorso in oggetto perché, nelle pagine che seguono, si tenterà di chiarire se è possibile, e in quale misura, ipotizzare che i soggetti privati, nell’ambito dell’autonomia contrattuale loro concessa ex art. 1322, 1° co c.c., possano stipulare finanziamenti assistiti da forme di autotutela esecutiva, senza il rischio di incorrere nella nullità di cui all’art. 2744 c.c., mediante il ricorso ai meccanismi marciani tipizzati dal legislatore.
Appare dunque preliminare verificare se una così puntuale definizione degli istituti in parola importi quel carattere di specialità che ne impedisce un’applicazione analogica; o se – a prescindere dal ricorso all’analogia legis – in astratto le parti possano coniare meccanismi marciani sulla scorta di quelli legislativamente previsti, cioè meccanismi privati che avrebbero anzi il pregio di consentire quegli adattamenti idonei a superare i rischi derivanti da una definitiva acquisizione degli assets[9].
Il nucleo forte e comune degli istituti sopraelencati consiste nel riequilibro della proporzionalità delle prestazioni in capo ai contraenti; proporzionalità garantita dalla previsione della restituzione dell’eccedenza del ricavato della vendita del bene rispetto al credito restitutorio[10].
Tuttavia, sono molti e rilevanti i punti di divergenza come risulta dall’analisi delle singole discipline che verranno esaminate qui di seguito.
Si parte dal prestito vitalizio ipotecario (art. 11-quaterdecies, co. 12, L. 348/2005). Si tratta di una misura di sostegno alle persone fisiche di età superiore ai sessantacinque anni, mediante concessione di un finanziamento da rimborsare in un’unica soluzione – esigibili al momento della morte del soggetto finanziato, o del più longevo, se si tratta di finanziamento cointestato-, con capitalizzazione annua di interessi[11] e spese, ed assistito da una garanzia ipotecaria su immobili residenziali[12].
Oltre tale ultima garanzia, ed in aggiunta all’effetto “esdebitativo” di cui si parlerà amplius più avanti, è previsto che, se entro dodici mesi decorrenti dalla morte del beneficiario non sia stata adempiuta l’obbligazione restitutoria, è consentito alla banca (o altro ente finanziatore) di procedere alla vendita diretta dell’immobile su cui è stata iscritta ipoteca[13], ad un valore determinato da un perito, terzo e imparziale, nominato dal creditore. E’ fatto altresì l’obbligo di restituire agli eredi l’eventuale eccedenza tra debito (oramai) estinto e ricavato dalla vendita.
Una simile impostazione – quanto meno nelle intenzioni – è riscontrabile nel T.U.B., con l’inserimento di due gruppi di norme.
Il primo è dedicato ad una nuova fattispecie di mutuo denominata «credito immobiliare ai consumatori» di cui agli artt. 120 quinquies e ss.
A fronte della concessione di un credito da parte della banca o di altro intermediario autorizzato ex art. 106 T.U.B., il debitore trasferisce, a titolo di garanzia, al medesimo soggetto finanziatore un immobile residenziale di sua proprietà, gravato da garanzia ipotecaria, sotto la condizione sospensiva dell’inadempimento la cui gravità si considera integrata se raggiunto quel coefficiente minimo stabilito dal legislatore.
Realizzatosi l’evento dedotto in condizione, e verificatosi dunque l’effetto traslativo, si procede alla stima del bene immobile da parte di un perito di nomina privata.
Alla determinazione della stima può seguire o il versamento della differenza tra il valore del bene e il debito da soddisfare in favore del debitore, se il ricavato medesimo sia superiore all’importo del debito, o l’estinzione del debito tout court quale effetto della forza esdebitativo che la legge accorda al meccanismo in parola, per il caso in cui detto valore sia inferiore all’ammontare dell’obbligazione restitutoria.
Il secondo gruppo di alienazioni in garanzia di matrice bancaria è contemplato dall’art. 48 bis T.U.B. in cui il trasferimento dell’immobile – a prescindere che sia stata o meno iscritta ipoteca – è sospensivamente condizionato all’inadempimento grave dell’imprenditore, secondo le soglie ex lege stabilite (n. tre rate), nonché alla notifica da parte della banca di volersi avvalere di tale forma di tutela e della stima effettuata dal perito nominato già in sede di stipulazione del patto. L’entità dell’inadempimento può variare notevolmente, a seconda della durata del piano di rimborso del finanziamento. Tre rate costituiscono il 25% di un mutuo da rimborsare in un anno; ma sono il 12,5% di un mutuo da rimborsare in due anni; e appena il 5% di un mutuo quinquennale. E deve persistere per nove mesi.
Ci si chiede se tale termine vada conteggiato a partire dalla prima rata rimasta insoluta o dall’ultima; con un’allusione al c.d. termine di grazia, entro il quale – cioè nelle more di questi nove mesi – il debitore può sanare la sua morosità.
Sembrerebbe che il pagamento funga da atto interruttivo del simil termine decadenziale: il debitore che abbia in ipotesi pagato le rate rimaste insolute, entro i nove mesi, non è soggetto al meccanismo marciano, e la valutazione in termine di gravità dell’inadempimento, come tipizzata dal co. 15, art 48 bis T.U.B., dovrà nuovamente essere effettuata qualora esso si verifichi nuovamente.
Ipotesi diversa è quella in cui vengono corrisposte due delle tre rate insolute. Sorge il dubbio se il termine di nove mesi decorra nuovamente o se invece è sufficiente raggiungere la soglia delle tre rate. L’inadempimento persiste, ma non è più grave.
Una risposta plausibile non è facile; invece, una risposta «pragmatica» forse è quella di ritenere che il diritto ad azionare la clausola persista sempre in riferimento a quei primi nove mesi iniziati in occasione del primo gruppo di rate insoddisfatte durante i quali la banca continua a subire l’insolvenza del debitore.
2. L’effetto esdebitativo appartiene alla “struttura logica” del meccanismo marciano
Del pari alle ipotesi precedenti, anche nell’alienazione in garanzia sospensivamente condizionata la posizione debitoria è tutelata dalla previsione della restituzione del delta tra il valore di stima e l’ammontare del creditore, da versare su apposito conto corrente indicato dal debitore.
Già prima facie è evidente che l’art. 48 bis T.U.B. tace in merito ad un eventuale effetto esdebitativo a favore del finanziato: di qui emerge un primo problema.
È oggetto di dibattito se il silenzio della norma sia nel senso di escludere una tale conseguenza[14] o se, invece, occorre ritenere che, sulla scorta di quanto disposto in tema di prestito vitalizio ipotecario e di credito immobiliare ai consumatori, ed in base ad un’interpretazione sistematica, data l’innegabile simmetria tra di essi, sia implicito concludere nel senso della necessità di riconoscere tale effetto.
Secondo la dottrina prevalente, la soluzione al dibattito prospettato dipende dalla tesi accolta in merito alla natura del patto marciano e riassuntivamente si può affermare che se si riconosce ad esso natura di garanzia[15], allora dovrebbe essere escluso qualsiasi effetto esdebitativo perché la garanzia ha ad oggetto la parte dell’obbligazione corrispondente al valore dell’oggetto su cui insiste la garanzia medesima; la parte non soddisfatta rimarrà esigibile; viceversa, se l’accordo si ritiene solutorio[16], allora si tratterebbe di una species di datio in solutum donde l’irrilevanza dei valori e l’automatica estinzione dell’obbligazione al momento della realizzazione della prestazione diversa[17].
Se all’accordo stipulato ai sensi e agli effetti dell’art. 48 bis T.U.B. si disconosce tale qualità sull’assunto della causa di garanzia che lo impronta, allora, posta la medesima natura riconosciuta anche al prestito vitalizio ipotecario e al credito immobiliare ai consumatori, dovrebbero essere indagate le ragioni che hanno spinto il legislatore all’introduzione di una simile previsione; ragioni, allora, non riscontrabili nell’ipotesi di alienazione in garanzia sospensivamente condizionate.
Laddove invece – e vi è il sospetto che questo sia il motivo di tale divergenza – la diversità di formulazione sia causata da un difetto di coordinamento, dovrebbe potersi accordare ad esso quello stesso effetto favorevole al debitore posto che la ratio a fondamento degli istituti è la medesima, vale a dire la prestazione di una garanzia che consenta di ridurre in maniera importante costi e tempi di recupero[18]; tuttavia una simile soluzione incontra come limite la natura tassativa dell’esdebitazione che può operare, quindi, solo se espressamente prevista. Sarebbe possibile argomentare che queste fattispecie sono tutte improntate dalla specialità, che autorizzerebbe l’applicazione analogica dell’esdebitazione anche all’alienazione in garanzia, ma questo sforzo appare non solo eccessivo, ma nemmeno giustificato da ragioni di ordine sistematico o di giustizia contrattuale.
Viceversa, a voler negare l’operatività dell’esdebitazione, occorre far leva sulla circostanza che il prestito vitalizio ipotecario e il credito immobiliare ai consumatori siano governati da una causa solvendi, e siano sorretti da rationes differenti rispetto alla fattispecie ex art. 48 bis T.U.B., ora avente un ruolo assistenziale, ora di tutela del consumatore.
È sicuro che la qualificazione del patto come accordo solutorio o di garanzia sia funzionale all’individuazione della disciplina applicabile, ad esempio in tema di revocatoria fallimentare se l’alienazione è sorretta da causa solvendi, potrà essere reputata – ove ne ricorrano le condizioni – un mezzo anormale di pagamento di debiti scaduti, e come tale essere revocata se compiuta nell’anno precedente all’apertura della liquidazione giudiziale, con presunzione legale iuris tantum della scientia decoctionis (art. 166, co. 1 , lett. b, c.c.i.i.; se il debito principale non fosse scaduto, ricorrerebbe il più rigoroso regime dell’art. 164 c.c.i.i.); qualora sia sorretta da una causa di garanzia, ed effettuata a garanzia di crediti già esistenti, si presumerà comunque la scientia decoctionis, salvo prova contraria, ma l’alienazione dovrà essere stata effettuata nell’anno precedente o nei sei mesi anteriori all’apertura della procedura, a seconda che i crediti da garantire siano rispettivamente non scaduti o scaduti (art. 166, comma 1 ̊, lett. c e d, c.c.i.i., dettate per pegno, ipoteca e anticresi, ma estensibili per analogia a questa garanzia reale atipica[19]); infine, ove si tratti di una alienazione in garanzia a fronte di crediti contestualmente creati, si applicherà il regime degli atti costitutivi di garanzie reali contestuali all’erogazione del credito, per cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore dovrà essere provata, e l’atto dovrà essere stato perfezionato entro i sei mesi precedenti l’apertura della liquidazione concorsuale (art. 166, co. 2, c.c.i.i.).
Non è parimenti certo se dalla qualificazione in termini di accordo di garanzia o solutorio dipenda l’effetto esdebitativo.
Nell’economia del meccanismo marciano, l’esdebitazione è un effetto ultimo che sicuramente rappresenta un favor debitoris perché è idoneo a limitare la sua responsabilità al solo bene concesso in garanzia; ma non è di certo l’elemento qualificante, perché a rilevare è l’effetto derogatorio al divieto posto dall’art. 2744 c.c., a prescindere poi che la garanzia si realizzi per un importo corrispondente all’obbligazione garantita.
Pertanto, posta la non essenzialità dell’esdebitazione come marchio di fabbrica delle clausole marciane, si ritiene che essa non si realizzi nell’ipotesi di cui all’art. 48 bis, non in ragione della sua conformazione quale garanzia precostituita in favore del creditore, ma perché, nel silenzio del legislatore, ora per atecninicalità, ora per valutazioni inerenti la qualità soggettiva del debitore (imprenditore, non soggetto di terza età o consumatore), non è una qualità intranea al tipo marciano.[20]
3. La deroga al divieto di patto commissorio
Con gli ovvi limiti di spazio del presente contributo, si sono evidenziati sinteticamente gli elementi strutturali dei meccanismi perequativi introdotti dal legislatore bancario. Presentano, quali tratti comuni, la natura di garanzia e la previsione degli elementi strutturali necessari ai fini dell’integrazione della fattispecie marciana; divergono in merito allo strumento giuridico in concreto utilizzato per la realizzazione della garanzia medesima nonché del procedimento di stima di cui, tuttavia, non si può far a meno di sottolineare l’ambiguità – in relazione alla fattispecie del prestito vitalizio ipotecario – di una nomina peritale in fase patologica del rapporto contrattuale, non già in quella genetica come accede nell’ipotesi di cui all’art. 48 bis T.U.B., ai fini della determinazione del valore del bene immobile[21].
Ad ogni modo, la loro previsione costituisce una novità nel sistema della garanzia reale creditizia e la valutazione circa il loro effettivo impatto, cioè se le stesse siano state sinora effettivamente in grado di far fronte a quell’esigenze che si è inteso presidiare con la loro introduzione, si pone come passaggio funzionale a determinarne l’attitudine ad attecchire nella prassi bancaria, e poi anche al di fuori di essa.[22]
Al fondo di ciò è agevole leggerne l’intenzione: assegnare dignità autonoma al marciano in generale, al di fuori degli angusti limiti delle normative di settore, affinchè non venga relegato a mera deroga occasionale alla pietra miliare del divieto di patto commissorio[23], ma con il precipuo scopo di collocarlo all’interno di un ordinamento che può a malapena tollerarlo.
È da tempo che si auspica l’introduzione dell’art. 2744 bis c.c. per ristabilire dialettica e sintesi di ciò che è consentito e ciò che non lo è. E non è consentito arricchimento a danno del debitore, nonché degli altri creditori del debitore medesimo, sulla scorta di quel principio – oramai ridimensionato nella sua portata – della par condicium creditorum, e uno speculare approfittamento del creditore che verosimilmente versa in una situazione di forza, sia contrattuale sia economica.
Quella dialettica, quindi, che si innesterebbe nel dialogo tra marciano «primo» e «secondo», laddove quest’ultimo coinciderebbe con una delle ipotesi di settore già analizzate.
Si parte, come già detto, da queste ultime per isolare quegli elementi da mutuare nel marciano di diritto comune che, al momento, rimane solo una costruzione sistematica di matrice dottrinale.
4. Il patto marciano di diritto comune. Riflessioni de iure condendo
Procede verso questa direzione anche la Corte di Cassazione[24] che ha approfondito la questione, non in occasione di una controversia avente ad un oggetto un marciano legale, ma in tutte ipotesi di patto commissorio «autonomo» prima facie contrastanti con il divieto di cui all’art. 2744 c.c.
Ciò accade nel contratto di sale and lease back la cui liceità è oramai pacifica, non solo in ragione dei chiarimenti operati da una granitica giurisprudenza[25], ma anche in considerazione dell’introduzione del regime di risoluzione per inadempimento introdotto dai co. 138 e 139, art. 1, l. 4 agosto 2017, n. 124: l’inadempimento dell’utilizzatore – raggiunta la soglia di gravità predeterminata dal co. 137 – dà luogo alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria con conseguente restituzione del bene concesso in leasing al concedente e alla corresponsione all’utilizzatore del ricavato della vendita effettuata al valore di mercato.
Questa disciplina presenta delle note in comune con i meccanismi perequativi di cui sopra perché àncora il ritrasferimento del bene, occasionato dall’inadempimento del soggetto finanziato, ad una preventiva definizione del c.d. valore di mercato, così da poter determinare l’importo delle rate da restituire ed evitare indebite locupletazioni da parte del finanziatore.
La ratio alla base della disciplina è la medesima, soprattutto se si tiene conto che, prima che venissero introdotte queste norme, la prassi era orientata nel senso di inserire nei contratti di leasing una clausola penale che prevedeva l’incameramento delle rate riscosse in favore del concedente, salvo la possibilità di ottenerne la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. In definitiva, la parte in bonis, non solo riotteneva la disponibilità del bene in forza degli effetti restitutori derivanti dalla sentenza di scioglimento del contratto, ma, come da prassi consolidata, tratteneva altresì quanto già versato dall’utilizzatore.
Sin qui si è detto che un contratto sfuggirebbe alla radicale sanzione della nullità[26] se l’alienazione in garanzia – sospensivamente o risolutivamente condizionata, rispettivamente, all’inadempimento o all’adempimento del debitore – rechi con sé la previsione di un meccanismo di stima, da affidare un perito terzo ed imparziale, cui affidare la determinazione del bene offerto in garanzia, così garantendo l’eventuale esubero, rispetto al debito garantito, in favore del debitore.
La necessità di stima del bene risiede pacificamente nell’esigenza di garantire la proporzionalità nella prestazioni: la stima è volta a delimitare quantitativamente la funzione di garanzia; ma a livello qualitativo, a fronte di piccoli- medi finanziamenti, lo scambio di un bene immobile, come contropartita alla prestazione di una garanzia, sembra essere rimessa esclusivamente ad una valutazione discrezionale delle parti. In questo caso, quella tutela che si vuole assicurare con il divieto di patto commissorio, garantita parimenti, a detta dei più, dalla previsione della stima, in realtà verrebbe frustata perché si restituirebbe un esubero ottenuto da un’alienazione che non si sarebbe nemmeno dovuta concludere, in un’ottica di proporzionalità tra il rapporto garantito e l’oggetto della garanzia.
Ma la proporzionalità delimita i confini della liceità della garanzia? Ha senso nel T.U.B. perché una delle parti contrattuali è la banca o intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.; ma nei finanziamenti privati, quindi nei rapporti di mutuo privati, ha senso la stima?
Preliminarmente, ci si chiede se è davvero utile un divieto espresso del patto commissorio[27]. Se la ratio è individuata nella tutela del debitore[28], questi non trova già adeguata tutela nell’istituto dell’azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.? E proprio ragionando sistematicamente in relazione al divieto e alla rescissione, si ricava che l’ordinamento non conosce un generale principio di proporzione tra prestazione[29], da intendersi in valore assoluto, né in senso quantitativo né qualitativo[30]. Tale valutazione viene effettuata dalle parti, quale esercizio della loro libertà contrattuale, che trova limite e confine nella lesione rilevante ai fini della rescissione. Fino a tale misura, il legislatore tollera la sproporzionalità oggettiva.
E allora introdurre il criterio della stima non sembrerebbe giustificato da quegli interessi che il divieto intende tutelare, ma forse più come espediente che il legislatore extra codicistico introduce per aggirare il divieto medesimo. In altre parole, si prende atto della regola introdotta dall’art. 2744 c.c. e, per consentire parimenti quelle operazioni altrimenti precluse perché nulle, una valutazione economica del bene oggetto della garanzia è considerato strumento idoneo per tutelare quegli stessi interessi protetti dalla norma in parola.
A questo punto, si accenna ad un’altra fattispecie che potrebbe verificarsi nella prassi[31]. Il creditore – e tale in base ad un pregresso rapporto debito-credito, intercorrente con il debitore, non ancora esigibile – e quest’ultimo intendono effettivamente stipulare un contratto di scambio (i.e. contratto di compravendita)[32]; il creditore, che potrebbe anche non aver a disposizione la liquidità necessaria per il pagamento del prezzo, intende stipulare un contratto sospensivamente condizionato all’evento del futuro, e solo incerto, inadempimento del debitore-alienante; poi, verificatasi la condizione, la parte di prezzo corrispondente all’importo del debito si estingue per compensazione, mentre la restante parte, che, nella logica del meccanismo perequativo del marciano, rappresenterebbe l’esubero, in realtà viene corrisposto dall’acquirente a titolo di prezzo, non invero in attuazione del predetto procedimento. A ben vedere, rispetto a fattispecie simili, ha senso discorrere di «autotutela esecutiva»? L’auspicio è sempre quello di evitare che l’esasperazione di un inattuale principio giuridico rechi con sé il più grave inconveniente di mortificare uno dei principi cardine dell’ordinamento, qual è l’autonomia privata, che non deve incontrare altri limiti se non quelli promananti da una giusta sistematica dell’ordinamento medesimo.
Quindi, si diceva che la stima e la restituzione dell’esubero appaiono inadeguati laddove è comunque sproporzionato, quale garanzia, il trasferimento condizionato di un immobile[33]. Quindi dovrebbe essere introdotto un criterio preventivo di controllo dell’idoneità qualitativa della prestazione, quale – e solo a titolo di esempio – la stima preventiva dell’oggetto della garanzia al fine di accertare che il valore, almeno nella fase genetica dell’accordo, non sia eccessivo rispetto all’ammontare del credito garantito. È vero che l’apposizione della condizione sospende l’effetto traslativo, nella speranza (rectius, illusione) per il debitore di recuperare medio tempore le somme occorrenti; è pur vero però (e questo nella maggioranza dei casi) che la condizione è dotata di quella particolare efficacia reale di cui all’art. 1360 c.c., con la conseguenza che, seppur non in via definitiva nella fase di pendenza, gli eventuali aventi causa del debitore rischiano ad ogni modo che il loro acquisto venga travolto. Ciò rende di fatto l’oggetto della garanzia indisponibile, e lo può essere anche per un periodo medio-lungo.
E se appare eccessivo sostenere un’asserita eccessiva rigidità nella previsione del divieto medesimo perché rebus sic stantibus il divieto esiste e continua ad essere vigente; non è meno vero che tale principio ha visto oramai drasticamente ridotto il proprio ambito di applicazione poiché le principali ipotesi che prima vi rientravano, oggi ne sono escluse, revocando in dubbio che i casi di trasferimento a scopo di garanzia possano ancora oggi considerarsi “eccezionali”. Si apre quindi la strada ad una concezione dell’art. 2744 c.c., non più quale espressione di un principio generale, ma degradata ad una disposizione applicabile (solo) in via residuale[34].
Quindi nella costruzione del marciano comune[35], idealmente da inserire nel futuro (o almeno così ci si augura) testo dell’art. 2744 bis. c.c., e mutuando anche delle fattispecie tipizzate elementi non connotati da quella specialità propria del settore di riferimento, appaiono essenziali:
- Un meccanismo che consenta di determinare la proporzionalità dell’oggetto dato in garanzia, dal punto di vista ora qualitativo ora quantitativo, in relazione all’obbligazione da garantire, nella forma e con le modalità sopra suggerite;
- Determinate così le entità delle poste economiche rilevanti, è da individuare lo strumento giuridico astrattamente utilizzabile dalle parti per la costituzione della garanzia privata; mutuando gli schemi proposti dal legislatore bancario, le soluzioni prospettabili sono due, molto diverse tra loro, e specificamente, l’alienazione in garanzia, sospensivamente o risolutivamente condizionata, rispettivamente, all’inadempimento o adempimento dell’obbligazione restitutoria del finanziamento nonché, in alternativa, l’inserimento di un mandato in rem propriam ad alienare in favore del creditore, sulla scorta di quanto statuito in tema di prestito vitalizio ipotecario[36], da cui diverge perché il presupposto del trasferimento non coinciderebbe con il tempo della morte del debitore, ma con il momento in cui sono integrati gli estremi dell’inadempimento rilevante.
- La determinazione della soglia di inadempimento da raggiungere ai fini dell’attivazione della garanzia medesima;
- La procedura e i criteri nella fissazione del prezzo, che dovranno essere rispettati da parte del perito, terzo ed imparziale, da nominare di comune accordo tra creditore e debitore[37];
- La previsione -essenziale – della restituzione al debitore dell’eventuale eccedenza del valore stimato rispetto all’entità residua del debito;
- Per le ragioni anzidette, e cioè che l’esdebitazione non appartiene alla struttura logica del procedimento marciano, per l’ipotesi in cui il valore stimato sia inferiore al debito, residua l’esigibilità dell’obbligazione per la parte rimasta insoddisfatta, salvo che le parti non abbiamo espressamente programmato la produzione di tale effetto, che, sempre nel presupposto che non rappresenti elemento strutturale, non è idoneo ad una riqualificazione della pattuizione in datio in solutum (o, in alternativa, pactum de in solutum dando sospensivamente o risolutivamente condizionato).
A voler concludere, si è assistito all’introduzione normativa di istituti che però hanno avuto effetti meno dirompenti rispetti a quelli attesi, sostanzialmente attestandosi su quella posizione oramai già inaugurata dalla giurisprudenza, recependo elementi volti a salvaguardare il patto marciano dal pur sempre vigente divieto di cui all’art. 2744 c.c.
[1] Cfr. Siclari, European Capital Markets Union e Ordinamento Nazionale, in Banca borsa tit. cred., 2016, p. 48 ss.
[2] Cass., 3 giugno 1983, n. 3800, in Foro it., 1984, 1, p. 212 ss.; Danusso, Patto commissorio e vendite a scopo di garanzia, in Giur. it., 1984, p. 1648 ss.; Roppo, Patto di riscatto. Patto commissorio, in Nuova giur. civ., 1985, p. 97 ss.; La Torre, Il «lease back» e il divieto di patto commissorio, in Riv. it leasing, 1985, p. 135 ss.; Paola, Riflessioni brevi sul «revirement» della giurisprudenza della Cassazione in tema di patto commissorio con particolare riguardo a taluni aspetti fallimentari del problema, in Fall., 1985, p. 160 ss.; Napoleone, Un improvviso «revirement» della Suprema Corte sulla vendita a scopo di garanzia, in Vita not., 1983, p. 966 ss.; Piepoli, Quale futuro per la proprietà-garanzia?, in Corr. giur., 1985, p. 201 ss.; Amato, Ancora sul patto commissorio e sulla vendita a scopo di garanzia, in Giust. civ., 1984, p. 1899 ss. Secondo la Corte di Cassazione, occorre valutare la causa in concreto dell’operazione economica quand’anche si tratti di contratto di vendita con patto di riscatto che, se stipulata tra le parti allo scopo di fungere da garanzia reale a favore del creditore, può esser sorretta da una causa di garanzia.
Il revirement della Cassazione fu confermato da Cass., 6 dicembre 1983, n. 7271, in Giur. it., 1984, p. 1698 ss.
Cfr. Mariconda, Ancora sull’alienazione in garanzia, in Corr. giur., 1987, p. 287 ss.; Triola, Gli effetti dell’esercizio del riscatto convenzionale, in Giust. civ., 1987, p. 545 ss.; C.M. Bianca, Il divieto del patto commissorio, Milano, 1957; ID., Il divieto del patto commissorio: un passo indietro della cassazione, in Riv. dir. civ., 1987, p. 117; Munari, Importante revirement della Corte di Cassazione sul divieto del patto commissorio, in Foro pad., 1987, I, c. 194 ss; Chianale, In margine a Cass. 7385/86, sul divieto del patto commissorio e vendita con patto di riscatto, in Resp. civ., 1987, p. 474 ss; Cipriani, Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie, Napoli, 2000; Gabrielli (a cura di), I contratti di garanzia finanziaria, Milano, 2018; Marchetti, Trasferimento di immobili ex art. 48 bis TUB: un marciano abdicativo della garanzia generica?, in giustiziacivile.com.
Si vd. Cass., sez. un., 3 aprile 1989, n. 1611. La giurisprudenza approda poi ad un punto di definitiva rigidità con le Sezioni Unite che affermano la nullità per contrarietà al divieto di cui all’art. 2744 c.c. anche di quelle pattuizioni cc.dd. autonome, cioè indipendenti dalla costituzione di un diritto reale di garanzia, privilegiando un criterio di tipo funzionale nell’individuazione delle fattispecie integranti alienazioni in garanzia. L’approccio è giustificato nonché finalizzato ad una piu` efficace tutela, tanto del debitore coinvolto in operazioni poste in essere in violazione del divieto del patto commissorio, che del principio generale della par condicio creditorum, in nome del principio di tipicità delle garanzie reali assistenti il credito. Ciò ha comportato il moltiplicarsi delle fattispecie sanzionabili, essendo astrattamente incluso ogni tipo di negozio che presentasse profili latamente rivolti alla coercizione del debitore (anche Cass., 27 maggio 2003, n. 8411, in Giust. civ., 2004, p. 3112). Pertanto in ogni ipotesi in cui quest’ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell’ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta per causa indipendente dalla predetta cessione, è ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agli artt. 1963 e 2744 c.c. Sulla stessa scia anche Cass., 17 aprile 2014, n. 8957, in Dir. giust., 2014, p. 2530; Cass., 10 marzo 2011, n. 5740, in Giust. civ., 2011, p. 1449; Cass., 5 marzo 2010, n. 5426, in Giust. civ. Mass., 2010, p. 32; Cass., 12 gennaio 2009, n. 437, in Giust. civ. Mass., 2009, p. 39.
In dottrina, Canessa, Vendita con patto di riscatto e patto commissorio, in Giust. civ., 1989, p. 2423 ss.; Di Mauro, Sul divieto del patto commissorio e le alienazioni a scopo di garanzia, in Riv. not., 1989, p. 908 ss.; Cubeddu, Patto commissorio e vendita con patto di riscatto: la risposta delle sezioni unite, in Riv. dir. civ., 1990, p. 615 ss. Cass. sez. un., 21 aprile 1989, n. 1907, in Giust. civ., 1989, p. 1821 ss.; Valcavi, Intorno al divieto di patto commissorio, alla vendita simulata a scopo di garanzia e al negozio fiduciario, in Foro it., 1990, c. 205 ss.
[3] In questo senso si vd. Ivone, Il prestito vitalizio ipotecario: luci e ombre del principale istituto della c.d. finanza della terza età, in Contratto e Impresa, 1, 2018, p. 383 e ss. L’a. mette in luce la complessità della crisi finanziaria, conseguenza della vicenda dei prestiti sub prime, cui si è tentato di far fronte con la previsione di rimedi di natura contenitiva che tuttavia si sono dimostrare inidonee ad incidere sul rafforzamento della fiducia nel pubblico degli investitori nonché dei criteri di valutazione di merito del credito.
Cfr. Panebianco, Il Parlamento fra pareggio di bilancio e federalismo fiscale, Roma, 2014, p.17, il quale afferma che «non introdurre il tema della recessione economico-finanziaria significa non capire il contesto delle norme, la saldatura delle stesse sia con il quadro giuridico europeo, sia con l’emergere di nuovi – e tradizionali, ma secondo nuove logiche e dinamiche, e comunque con forti pretese normative – regolatori del sistema economico, sia con l’autonoma crisi del sistema democratico-parlamentare italiano».
[4] Sul tema si vd. E. del Prato, Principi e metodo nell’esperienza giuridica, Torino, 2018, p. 31 e ss; G. Perlingieri, Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali, in Riv. dir. impr., 2017, p. 21 ss.; Id., Sul criterio di ragionevolezza nel diritto civile, in Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, a cura di Id. e Fachechi, I, Napoli, 2017, p. 1 ss.
[5] Si vd. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione, in Contr. e impresa, 3, 2016, p. 797. L’a. evidenzia che tanto più snella è la garanzia dell’obbligazione tanto più ne possono trarre beneficio imprese e consumi.
[6] Secondo Stefani, La neutralità causale del” meccanismo” marciano, in Riv. dir. civ., 4, 2023, p. 645, non è corretto parlare di “patti” marciani legali perché le parti non vi addivengono all’esito di trattative, ma sono veri e propri meccanismi predisposti dalla legge, attivabili nella fase patologica del rapporto, consistenti in un procedimento privato di autosoddisfacimento esecutivo da parte del creditore bancario.
[7] Sul tema, da ultimo, Battelli, Il pegno sui beni immateriali. Contributo allo studio del pegno non possessorio sugli intangible assets, Milano, 2021.
[8] Si vd. Chianale, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, in Contr. e impresa, 2019, p. 1304 e ss. L’a. denuncia l’insufficienza degli studi orientati alla nuova disciplina perché incapaci di percepire con chiarezza le linee guida che informano la normativa di settore; suggerisce quindi la necessità di una più attenta analisi che consente di percepire con chiarezza un fenomeno del tutto nuovo e preoccupante che sembra allontanare le garanzie reali – soprattutto quelle mobiliari – dal consueto paradigma proprietario per avvicinarle a un sistema di preferenza del singolo creditore ispirato a logiche tipiche degli statuti personali.
[9] In questo stesso senso vd. Stefani, op.cit., p. 642. E’ necessario scremare dalle discipline di settore quanto è oggetto di una disciplina eccezionale così da consentirne un’applicazione generalizzata e da aggirare gli ostacoli applicativi offerti dalle garanzie reali tipiche, improntate a tipicità, formalismo e specialità.
In questo senso anche D’amico, Finanziamenti alle imprese e credito immobiliare ai consumatori. I “nuovi marciani” alla prova. Un bilancio provvisorio, in I contratti, 6, 2023, p. 641, dove si legge «le soluzioni adottate dal legislatore – nonostante lo sforzo (di per sé condivisibile) di realizzare un ragionevole bilanciamento tra il rafforzamento della posizione del creditore (attraverso meccanismi di “autosoddisfacimento”, in caso di inadempimento da parte del debitore) e la tutela della posizione debitoria (nonché, in qualche misura, di quella degli altri creditori) – peccassero probabilmente di eccessiva rigidità, impedendo all’autonomia privata di operare (pur nel quadro di una diffusa “imperatività” della disciplina) quegli adattamenti, la cui praticabilità avrebbe forse consentito (agli occhi del creditore) di superare gli inconvenienti e i rischi comunque connessi all’acquisizione diretta di assets, la cui gestione non rientra nell’ambito di quella “caratteristica” dell’attività bancaria.».
In senso contrario si vd. Trimarchi, Operazione negoziale e trasferimento a scopo di garanzia: la neutralizzazione del divieto del patto commissorio, in Riv., dir. civ., 2021, p. 723, secondo cui non era nelle intenzioni del legislatore bancario introdurre la disciplina del «patto marciano» e non ha quindi concesso alcuno spazio all’autonomia privata di riequilibrare i loro rapporti, trattandosi anzi di meccanismi legali connotati da una forte inderogabilità.
[10] Tale profilo non richiede particolare illustrazione ed è pacifico, sia in dottrina e in giurisprudenza, che sia il tratto caratterizzante il patto marciano.
[11] Si tratta di un’ipotesi di anatocismo legale, nella quale gli interessi si capitalizzano. Di qui una maggiore convenienza per il creditore.
[12] Si vd. Rinaldi e Varrati, Lo sviluppo del prestito ipotecario vitalizio in Italia: potenzialità e problemi normativi, in Bancaria, 2007, 3, p. 70 e ss.
[13] Secondo Chianale, Le nuove frontiere delle garanzie reali: uno statuto personale del creditore?, cit…, p. 1304, si tratta di un mandato con rappresentanza di fonte legale in rem propriam in forza del quale la banca vende l’immobile. In generale la vendita del bene viene fatta dal creditore a nome del debitore o del terzo concedente in forza del potere di rappresentanza che scaturisce dal patto marciano.
In realtà, è vero che si tratta di un mandato ex lege; ma è un mandato sui generis, perché pur se in rem propriam, è comunque sottoposto alla regola per cui mandatur mortem finitur.
[14] In generale vd. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 2012, p. 173 ss.; Marchetti, La responsabilità patrimoniale negoziata, Milano, 2017.
[15] Cfr. C.M. Bianca, op. loc. ult. cit., p. 136 e ss.; Sassi, Garanzie del credito e tipologie commissorie, passim, spec. p. 13 e ss.
[16] Così Luminoso, Patto commissorio, patto marciano e nuovi strumenti di autotutela esecutiva, in Riv. dir. civ., 1, 2017, p. 20 ; Id., Patto marciano e sottotipi, in Riv. dir. civ., 2017, p. 1398 ss.; secondo il quale, accanto alla funzione primaria solutoria, si riscontra anche una funzione secondaria di garanzia. La funzione satisfattiva del patto si pone maggiormente in linea con gli effetti che lo stesso è idoneo a produrre.
[17] In tal senso, si vd. Pagliantini, Spigolando intorno all’art. 48 bis T.U.B.: specialità (di trattamento) e principio di proporzionalità delle garanzie?, in Giur. It., 2017, p. 1719; Scotti, Il trasferimento di beni a scopo di garanzia ex art. 48 bis T.U.B. è davvero il patto marciano?, in Corr. giur., 2016, p. 1477 ss.
Queste conclusioni sono messe in discussione da D’amico, op. cit., p. 643, il quale replica così.
L’assimilazione alla datio in solutum non comporta automaticamente l’effetto esdebitativo perché può ammettersi una datio parziale ed inoltre la clausola marciana non modificherebbe l’obbligazione restitutoria, trasformandola in un’obbligazione alternativa o in una obbligazione facoltativa.
Viceversa, la garanzia marciana potrebbe essere considerata un’implicita pattuizione di garanzia specifica volta a limitare la responsabilità del debitore esclusivamente al bene offerto in garanzia.
Ritiene che sia estranea qualsiasi forma di esdebitazione del debitore Stefani, op. cit., p. 650, poiché si tratta di uno scopo satisfattivo ed è estranea alla nozione di garanzia la liberazione del debitore per la parte dell’obbligazione residua, salvo che non intervenga un autonomo patto remissorio da parte del creditore. Anzi, laddove la garanzia poi si riveli insufficiente, ne consegue la decadenza dal beneficio del termine; se poi il mancato realizzo non sia imputabile al debitore, il creditore avrà il diritto di chiedere la prestazione di un’altra garanzia e, in mancanza, potrà tornare a chiedere l’adempimento dell’intero credito.
[18] Cfr. Luminoso, op. cit., p. 1420. secondo cui la natura eccezionale dell’art. 120 quinquiedecies, co. 3 T.U.B. è affermazione apodittica. A ben vedere, l’eccezionalità consisterebbe nell’essere una deroga al divieto di cui all’art. 2744 c.c.; qualità questa, allora, che condividerebbe con l’art. 48 bis c.c.
[19] Cfr. D’amico, op.cit., p. 646, nt. 23, il quale, sottintendendo la cavendi causa dell’accordo, sottolinea come la banca verosimilmente attiverà la tutela marciana solo se l’inadempimento interviene all’inizio del rapporto; attivarla nella parte finale del rapporto, impedisce un utile esperimento dell’azione revocatoria, né nella forma della revocatoria fallimentare né in quella ordinaria posto quanto prescritto dall’art. 48 bis, co. 12, e cioè se dopo la trascrizione del patto marciano viene dichiarato il fallimento del debitore, la banca – qualora venga ammessa al passivo – può chiedere al giudice di provvedere ai sensi dell’art. 10, ossia di accertare l’avveramento della condizione sospensiva (che, per essere opponibile al fallimento, si suppone debba essersi erogando un nuovo finanziamento destinato ad estinguere quello precedente, ma a differenza di questo (in ipotesi, sprovvisto di garanzie reali) assistito dalla garanzia marciana, o semplicemente innestando nel preesistente rapporto di finanziamento una garanzia nella forma del “marciano”. E si ha la sensazione che sia soprattutto a queste situazioni di “sofferenza” di rapporti di finanziamento preesistenti che abbia avuto lo sguardo il decreto (non a caso denominato) “salva banche”, laddove ha introdotto l’art. 48-bis. Ma, se così dovesse essere, si ridimensiona la portata dell’intervento, che appare sorretto da una ratio contingente (aiutare le banche – gravate, in quel particolare momento storico, dal pesante fardello di una massa consistente di NPL – a liberarsi, attraverso cessioni non disastrose, dei crediti in sofferenza, più facilmente e proficuamente collocabili sul mercato, se assistiti da una garanzia “marciana”), e, soprattutto, non sembra in grado di incidere (con una regolamentazione organica e ben strutturata) sul sistema delle garanzie “reali” del nostro ordinamento.
verificato prima dell’apertura della procedura concorsuale, anche se ancora non si è completata la procedura di trasferimento, ad es. perché non è stato ancora versato il prezzo), disponendo il trasferimento del bene alla banca medesima (previa effettuazione dei versamenti di cui si è sopra detto).
La norma sembra in qualche modo riecheggiare quella del comma 2 dell’art. 41 T.U.B. (in materia di credito fondiario), secondo cui «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia dei finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore”, con la precisazione che “La somma ricavata dall’esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento».
Qualora invece la condizione sospensiva (=comunicazione al debitore di volersi avvalere della clausola marciana) non si sia avverata prima della dichiarazione di fallimento, la banca avrà comunque diritto ad essere trattata come se avesse sul bene un’ipoteca (comma 12 dell’art. 48-bis), e quindi con diritto di prelazione (rispetto ai creditori chirografari) sul ricavato della vendita. Il che dovrebbe evitare alla banca la necessità di dotarsi comunque (insieme alla clausola marciana) di una garanzia ipotecaria, evitandone i relativi costi (anche se – riteniamo – quella necessità potrebbe riemergere per l’ipotesi in cui il debitore possa diventare inadempiente – ma senza che sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento −, e la banca voglia riservarsi la possibilità del ricorso alla procedure esecutive ordinarie, ma in posizione comunque privilegiata rispetto ai semplici creditori chirografari).
[20] In tal senso, si vd. D’amico, op. cit., p. 642 secondo il quale l’esdebitazione non appartiene alla struttura logica della soluzione marciana che esige solo che non vi sia approfittamento ai danni del debitore, non anche un vantaggio; non può essere predicata neppure un’applicazione analogica posto che non ricorre quella ratio di tutela che impronta il prestito vitalizio ipotecario e il credito immobiliare ai consumatori.
[21] Si reputa talmente vistosa come ambiguità che richiederebbe un intervento della Corte Costituzionale sul punto. Tuttavia le fattispecie, seppur diffuse e non prive di vischiosità, molto di rado raggiungono le sedi giudiziarie.
[22] Cfr. Brodi, Il sistema delle garanzie in Italia: una lettura economica delle disposizioni vigenti in materia di privilegio, pegno e ipoteca, in Questioni di Economia e Finanza, n. 356, 2016, dove si sottolinea la necessità di introdurre dei correttivi, quali l’introduzione di un parametro a partire dal quale l’inadempimento può considerarsi grave, valida ai fini dell’attivazione della tutela sia giurisdizionale sia stragiudiziale.
In più, suggerisce l’introduzione di una definizione di default rilevante, al fine di non tutelare, non già l’indistinta classe di debitori interessati, ma debitori persone fisiche (siano qualificabili o meno come consumatori), che abbiano concesso ipoteca sulla loro unica abitazione o che – anche a causa di alcuni shock esogeni – versino in condizioni di indigenza. Sarebbe preferibile accordare tutela ai soli prenditori che effettivamente la necessitino, anziché, indistintamente, a tutti quelli tenuti a trasferire il collateral al creditore.
[23] Anche se non mancano ancor oggi voci che ritengono il marciano comunque inidoneo a superare il divieto dell’art. 2744 c.c. Cfr. Carbone, Patto commissorio e patto marciano, in Enc. giur. Treccani online, per il quale il divieto del patto commissorio intende tutelare specialmente la «libertà morale del debitore», mentre il marciano incide unicamente sull’«aspetto patrimoniale del negozio».
[24] Cass., 18 gennaio 2015, n. 1625; Cass. 17 gennaio 2020, n. 844 in il Corr. Giur., 7, 2021, p. 929 , con nota di Suppa, Patto commissorio e patto marciano: la sottile linea tra negozi nulli e negozi leciti; Cass., 9 maggio 2013, n. 10986 in Vita Not., 2013, p 719; Cass., 5 maggio 2004, n. 4507: «nn dà luogo a patto commissorio la convenzione mediante la quale un istituto di credito, titolare di un pegno irregolare sulle somme depositate presso di esso, si appropri, in caso di inadempimento, della somma corrispondente al credito garantito».
[25] Sul punto si vd. Natale, Lease back e strutture utili di patto marciano, in Riv. dir. civ., 6, 2015, p. 1595 e ss.
[26] Si vd. Alcini, Il divieto del patto commissorio tra bizantinismi e prospettive, in Contr. impr., 3, 2024, p. 816 e ss.
[27] Cfr. M. Trimarchi, Operazione negoziale e trasferimento a scopo di garanzia: la neutralizzazione del divieto del patto commissorio, in Riv. dir. civ., 2021, p. 723, il quale evidenzia come si tratti di un principio in realtà entrato in crisi: può constatarsi come il principio della par condicio creditorum – sempre che potesse considerarsi tale – è sicuramente in declino, allo stesso tempo derogabile, caratterizzato da così ampie limitazioni da non poter essere applicato al di fuori del proprio ambito applicativo. A ciò si aggiunga il moltiplicarsi di esempi di separazione patrimoniale e di limitazione della responsabilità, ricorrendo fattispecie aperte e a portata generale (ad esempio trust, art. 2447-bis, art. 2645-ter) che inducono quantomeno a dubitare della vigenza dei principi dell’unicità del patrimonio e della parità di trattamento tra i creditori.
Le medesime considerazioni possono essere proposte in riferimento al principio secondo il quale lo Stato si riserverebbe in via esclusiva la gestione dell’esecuzione sui beni del debitore, trascurando che in realtà l’ordinamento conosce già ipotesi di autotutela esecutiva, e che semplicemente si sta orientando maggiormente a consentire o favorire la realizzazione in autotutela del diritto del creditore.
E da qui può quantomeno revocarsi in dubbio la loro inderogabilità e di conseguenza la loro inutilizzabilità per fondare il divieto del patto commissorio.
Acquisita allora l’insufficienza della previsione codicistica sul patto commissorio e provando, ora, a coglierne il rapporto con la legislazione extra codicistica relativa ai trasferimenti con funzione di garanzia, la disposizione di cui all’art. 2744 c.c. non è caratterizzata da quella cogenza tale da far ritenere che le ipotesi di patto marciano siano in realtà deroghe a detta disciplina, trattandosi invece di precise scelte di campo dell’ordinamento dotate di capacità applicativa anche oltre i confini loro propri dettati dal legislatore di settore.
In particolare l’accentuazione delle logiche del mercato, specie bancario e finanziario, ha richiesto facilità e rapidità nella circolazione dei capitali nonché ́, per quanto rileva in questa sede, una maggiore sicurezza e quindi adeguate garanzie per gli operatori nella gestione dei loro investimenti, assumendosi quale prevalente l’esigenza di favorire l’utilizzo e la movimentazione dei capitali per la realizzazione di dati obiettivi socialmente rilevanti.
[28] Autorevole dottrina (C.M. Bianca, Diritto Civile. La responsabilità, 5, p. 283 e Id., voce Patto commis- sorio, in Noviss. dig. It., Torino, 1965, p. 718) individua il fondamento del divieto in ragioni di ordine pubblico economico, in quanto sarebbe forte la «dannosità sociale» di un patto che, ove consentito, verrebbe aggiunto a qualsiasi transazione economica divenendo, con ciò, un pura clausola di stile.
Contra Triola, Il problema della liceità del c.d. patto commissorio obbligatorio, in aa.vv., Scritti in onore di Guido Capozzi, Milano, 1992, 2, pp. 1259-1260), secondo il quale non avrebbe senso discorrere di dannosità sociale in quanto principio apodittico ed indimostrato. Si veda anche Nardi, Appunti in tema di patto commissorio e violazione del principio di solidarietà`, in Giust. civ., 2005, 9, pp. 329-333).
Alla luce di tali considerazioni è lecito porsi il dubbio se veramente il divieto del patto commissorio sia privo di fondamento razionale.
[29] Fatta eccezione per le norme dettate in tema di riduzione dell’ipoteca agli artt. 2872 e ss. c.c.: la proporzionalità è garantita dalla possibilità di ottenere una rettifica della somma iscritta in conservatoria per un importo corrispondente al residuo debito.
[30] Da un punto di vista puramente tecnico, in particolare, una delle critiche più serrate attiene al rimedio posto contro la violazione del divieto e consistente nella nullità del patto in quanto il negozio lesivo è un negozio ingiusto ma non illecito, e quindi nullo. (Cfr. Enrietti, Patto commissorio ex intervallo, in Riv. dir. priv., 1939, IX, p. 21 ss., p. 25- 26).
Inoltre, se presupposto di partenza è che debba essere evitata una sproporzione di valori tra credito e bene dato in garanzia, resta comunque un dato indimostrato che l’ordinamento si preoccupi di regolamentare ipotesi del genere. Del pari è indimostrato che è piena espressione dell’autonomia privata la circostanza che i paciscenti siano liberi di impegnarsi in negoziati non. Affermare, allora, che il legislatore si muova per evitare sproporzione tra valori, per tutelare un soggetto che si indica come bisognoso di protezione, è indice di una visione paternalistica del ruolo statuale, almeno in questo ambito (Cfr. Carbone, Debitoris suffocatio e patto commissorio, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2012, 4, p. 1087 ss., nonché Pardi, Preliminare di vendita e divieto del patto commissorio, in Giur. merito, 2004, 1, p. 49, p. 53).
Inoltre, ai fini della declaratoria di nullità del patto deve prescindersi dalla reale sproporzione tra valori concretamente messi in campo (Cfr. Fragali, Del Mutuo, Art. 1813-1822, in Comm. c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2a ed, 1966, p. 236 ss., p. 258; in senso contrario Luminoso, Lease back, mercato e divieto del patto commissorio, in Giur. comm., 2000, 4, p. 489 ss., p. 495-496; Radoccia, La ratio del divieto del patto commissorio, in Giur. mer., 1997, 1, p. 220 ss., p. 222; C.M. Bianca, Diritto Civile, Le garanzie reali. La prescrizione, Milano, 2012, 7, p. 281).
Questa stessa impostazione che pretende di accordare un’effettiva tutela al debitore può rivelarsi controproducente quando produce conseguenze paradossali nel caso in cui il bene dato in garanzia sia di valore inferiore a quello del debito .
Diversa tesi – Gazzoni, In Italia tutto è permesso, anche quello che è vietato (lettera aperta a Maurizio Lupoi sul trust e su altre bagattelle, in Riv. not., 2001, 6, p. 1247 ss. – ritiene che si tratti di uno strumento volto ad evitare eccessiva locupletazione in favore del creditore, trascurando però che già i creditori hanno a disposizione il sequestro conservativo ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c. l’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., ed anche in via successiva, attraverso l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria e fallimentare (rispettivamente artt. 2901 c.c. e 67 L.F.). Tutti caratterizzati dalla circostanza che sono inidonei a riflettersi sulla validità dell’atto che pertanto continua a fungere da fonte di regolamentazione del rapporto tra i contraenti e si limitano a sancirne eventualmente l’inefficacia, relativa o assoluta.
Altri autori ancora rinvengono i motivi ispiratori degli artt. 2744 e 1963 c.c. in ragion di tutela debitoria e creditoria insieme. Cfr., Ferrarini, La locazione finanziaria («Leasing»), in Trattato di diritto privato diretto da Pietro Rescigno, Torino, 11, 1984, p. 17; Sartori, I contratti di garanzia finanziaria nel D.lgs 21 maggio 2004, n. 170: Prime riflessioni, in Rivista di diritto bancario, http://www.dirittobancario.it/rivista/garanzie/i-contratti-di-garanzia-finanziaria-nel-d-lgs- 21-maggio-2004-n-170-prime-riflessioni.
[31] Si vd. E. del Prato, Le basi del diritto civile, V ed., Torino, 2023, p. 746 il quale ammonisce sulla necessità di essere cauti nella valutazione di un contratto in rapporto al divieto di patto commissorio perché esiste la vendita con patto di riscatto nonché la vendita con patto di retrovendita, posto che «non è dato ipotizzare la nullità di un contratto tipico in assenza di note che ne alterino la funzione».
[32] Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, in Diritto civile. Metodo- teoria- pratica, Milano, 1951, p. 337. In passato si assumeva l’incompatibilità tra funzione di scambio e funzione di garanzia e però presupponendo un concetto di garanzia in senso tecnico e pieno e cioè una forma di garanzia reale. L’incompatibilità, in altri termini, veniva fatta dipendere dal rilievo secondo cui la causa di garanzia era dall’ordinamento ritenuta propria e quindi riservata a quei contratti, tipicamente quelli costitutivi di ipoteca o di pegno, costruiti e ricorrenti per adempiere a quella funzione, certamente non riscontrabile viceversa nella vendita o in altri contratti di scambio o di trasferimento della proprietà, con la conseguenza che l’utilizzo di una vendita, in ipotesi accludendovi un patto di riscatto, per conseguire una funzione di garanzia avrebbe integrato un accordo fraudolento e quindi nullo. «L’adozione di quel negozio, non già pel conseguimento del suo fine naturale, ma per la realizzazione della funzione di garanzia, che si sarebbe naturalmente realizzata con un negozio di garanzia, e cioè la scelta di un mezzo non congruente (ed eccedente) e l’esclusione del mezzo congruo, è già in astratto una elusione. E in concreto non può essere altro. Infatti lo schema della vendita viene prescelto non tanto pel conseguimento del fine di garanzia, nell’ambito definito dalla legge: a questo fine sarebbe sufficiente e maggiormente idoneo un negozio di garanzia. Piuttosto quello schema si utilizza pel conseguimento del plus (che risponde all’eccedenza del mezzo) consistente nell’automatico acquisto della proprietà»: Pugliatti, op. cit., p. 511 s. Pugliatti, peraltro, nota che dal punto di vista non della scienza giuridica ma di quella economica potrebbe anche affermarsi che un negozio di scambio possa assolvere una funzione di garanzia (op. cit., p. 467).
Ribadisce l’inconciliabilità del patto commissorio con la funzione di garanzia e con la struttura dell’obbligazione Scozzafava, Note in tema di garanzia, in Contratto e impr., 2008, p. 857 ss.
Sul pensiero di Pugliatti in materia vd. D’amico, Il contributo di Pugliatti alla dottrina della fraus legi e all’interpretazione del divieto di cui all’art. 2744 c.c., in AA.VV., Salvatore Pugliatti, a cura di Ciccarello-Gorassini-Tommasini, Napoli 2016, p. 239 ss.
Nello stesso senso si vd. anche Panuccio, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento, Milano, 1965, passim.
[33] In questo senso anche Vignudelli, La portata del divieto del patto commissorio alla luce dell’espansione della clausola marciana, in Contr. impr., 1, 2024, p. 139 e ss., il quale sottolinea che, pur in presenza di tale auspicata valutazione preventiva, ad ogni modo residuerebbe la necessità di assicurare un’adeguata pubblicità al patto medesimo.
[34] Così D’amico, Il patto marciano “atipico”, in I contratti, 5, 2022, p. 502, il quale tuttavia ritiene che l’ingresso del marciano atipico sia legittimato da un’applicazione analogica dei marciani legali, senza che possa obiettarsi il difetto di lacuna legis perché si potrebbe replicare adducendo l’oramai residuale applicazione del divieto in questione che impone di adottare un’interpretazione più aderente al tenore letterale della disposizione medesima.
[35] Cfr. Dolmetta, La ricerca del marciano «utile», in Riv. dir. civ., 4, 2017, p. 811 e ss.
[36] Se ne differenzia altresì per la natura del meccanismo marciano: nel prestito vitalizio ipotecario ha naturale legale; nell’ipotesi di marciano c.d. atipico, invece, avrebbe natura convenzionale.
[37] Cfr. Brianda, Le prospettive del divieto del patto commissorio tra normativa comunitaria, lex mercatoria e tradizione…cit., p. 814, secondo cui la necessità che il terzo sia nominato dalle parti e rispetto ad esse sia terzo ed imparziale risiede nella circostanza che in tal modo, sotto forma di surrogato, viene introdotto un controllo esterno, cioè quel controllo esterno che, in assenza di previsione marciana, sarebbe stato effettuato dall’autorità giurisdizionale.