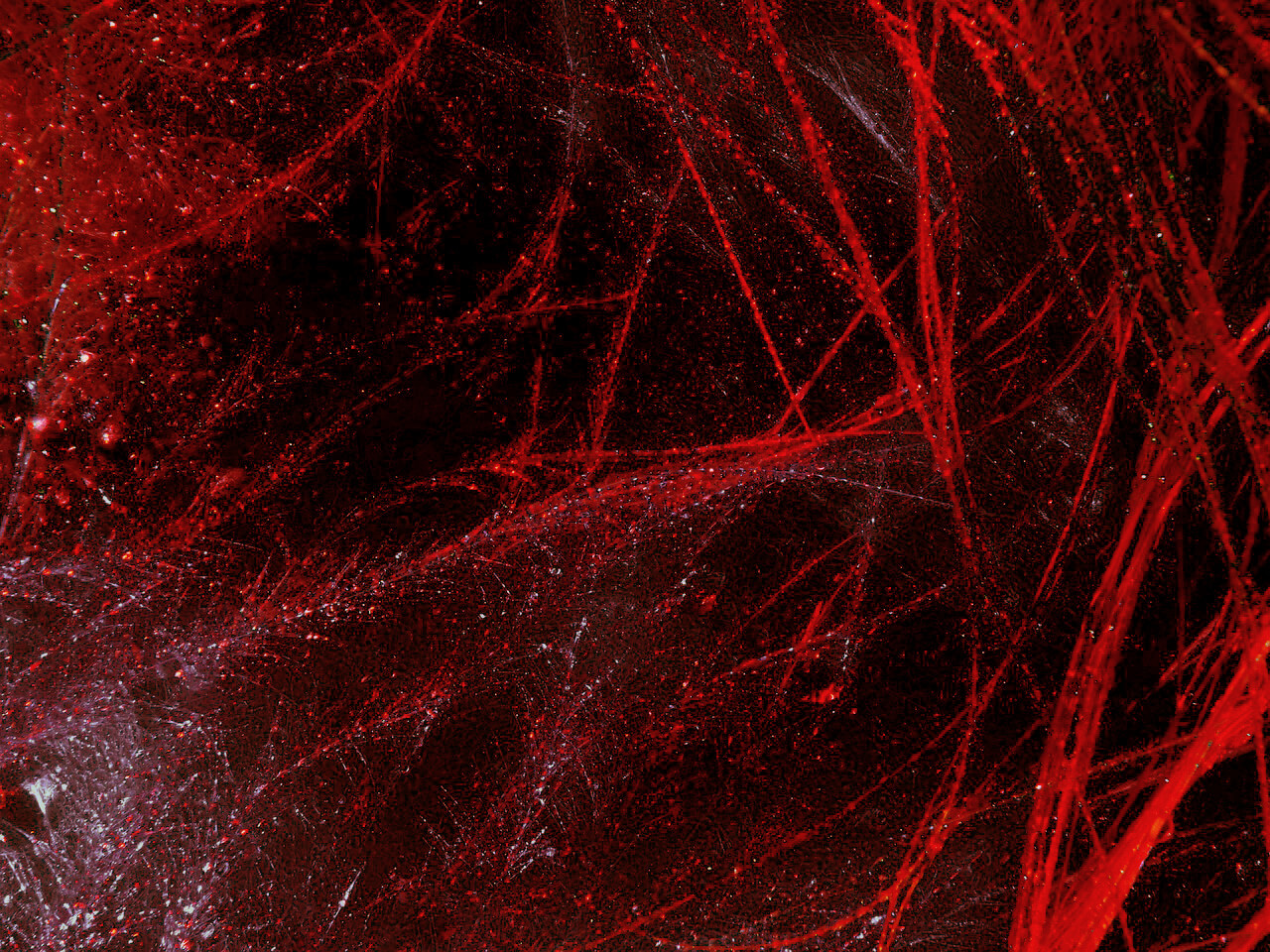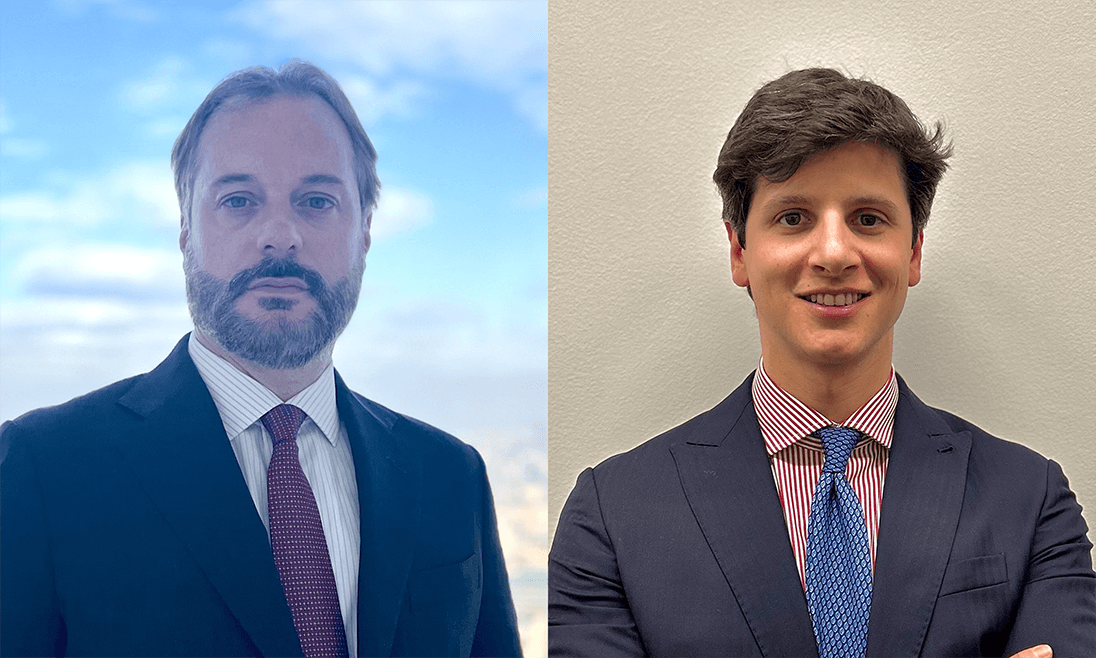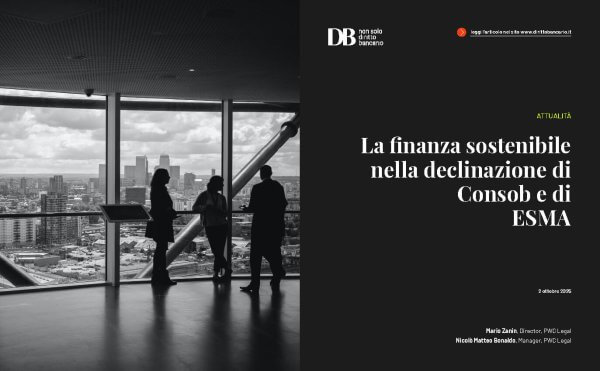Il presente contributo analizza la disciplina della finanza sostenibile, come declinata dai richiami di attenzione della Consob ed alla luce dei nuovi spunti, delle best and bad practice, e dei commenti forniti da ESMA rispetto ai risultati delle analisi condotte dalle varie Autorità di Vigilanza nazionali.
1. La Common Supervisory Action e il Final Report ESMA – i precedenti interventi di Consob
Al fine di garantire una corretta ed omogenea attuazione delle regole ESG nel mondo dei servizi finanziari, ESMA aveva lanciato, nel luglio 2023, una Common Supervisory Action con la quale aveva richiesto alle Autorità di Vigilanza dei vari Stati membri dell’Unione di vagliare le prassi applicative del quadro normativo fondato sul Regolamento (UE) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation; “SFDR”).
L’analisi condotta dalle varie Autorità ha riguardato, per ciascun ordinamento, le entità vigilate di maggiore e minore dimensione, e ha avuto svariati obiettivi [1].
Nello specifico, l’analisi in questione si è principalmente concentrata, da un lato, sulla valutazione del livello di integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno delle procedure delle singole entità vigilate e dei “prodotti finanziari” [2] e, dall’altro, sulla conformità rispetto agli obblighi di trasparenza in relazione ai rischi di sostenibilità e ai PAI (“Principal Adverse Impacts“).
Infine, ESMA ha vagliato le prassi applicative dei due diversi principi (o condizioni) caratterizzanti gli investimenti sostenibili: il rispetto di prassi di buona governance (c.d. “fattore G”) e l’obbligo di non causare danni significativi ad alti fattori di sostenibilità (“Do Not Significantly Harm Principle” – “DNSH Principle”).
A conclusione del lungo lavoro di analisi svolto, il 30 giugno 2025 ESMA ha pubblicato il Final Report [3] che offre una ricognizione sistematica delle prassi osservate nei diversi Stati membri, individuando esempi di best e bad practice atti a consentire di misurare lo stato di attuazione della disciplina del SFDR e delle relative norme di secondo livello.
Come noto, proprio nell’ambito delle attività di analisi di mercato svolte in adempimento della menzionata Common Supervisory Action, Consob aveva pubblicato due richiami di attenzione, in data 24 luglio 2024 e 11 febbraio 2025, il cui contenuto è stato analizzato in un precedente contributo [4].
Le recenti considerazioni svolte nel Final Report costituiscono un prezioso strumento, altresì, di interpretazione ed integrazione delle raccomandazioni a suo tempo fornite da Consob. Di conseguenza, ci si propone di richiamare alcuni dei punti trattati in tema di rischi di sostenibilità, PAI e corretta declinazione delle regole sui requisiti di buona governance, anche alla luce del Final Report ESMA.
2. La trasversalità caratterizzante l’integrazione dei rischi di sostenibilità
Uno degli elementi sui quali Consob aveva focalizzato la propria attenzione era quello della valutazione, sotto vari profili, dei rischi di sostenibilità.
In particolare, con il Richiamo del febbraio 2025, che rimarcava la trasposizione dei principi recati dal SFDR all’interno delle Direttive AIFM e UCITs, Consob ha inteso chiarire l’ampiezza dell’obbligo dei gestori di valutare il rischio di sostenibilità. L’analisi di tale rischio, secondo i principi tratti dal SFDR e dalla disciplina attuativa, deve essere integrata in modo trasversale nell’attività dei gestori. Infatti, essa rileva non solo nell’ambito delle generali politiche ed attività di risk management, ma anche negli specifici processi di selezione degli investimenti, di gestione e valutazione dei rischi degli OICR, nella identificazione e mappatura dei conflitti di interessi, nonché nella declinazione delle politiche di remunerazione.
Consob aveva poi messo in risalto la diffusa confusione tra il concetto di rischio di sostenibilità e il diverso concetto di considerazione dei PAI. Inoltre, anche alla luce di tale diffusa confusione, l’Autorità domestica aveva rappresentato l’importanza fondamentale di un progressivo irrobustimento dell’organico degli intermediari, specie mediante l’assunzione di figure professionali dotate di competenze ed esperienze specifiche in materia di rischio ESG. In assenza di un adeguato rafforzamento del personale, i destinatari del SFDR rischiano di recepire i nuovi obblighi in modo passivo ed inefficace, senza alcuna vera consapevolezza della loro importanza.
Le considerazioni dell’ESMA in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità paiono in linea con quanto dedotto da Consob. Anche l’Autorità europea tiene ad evidenziare la trasversalità dei rischi di sostenibilità, ad esempio rimarcando come la valutazione degli stessi debba riguardare tutti gli OICR gestiti, a prescindere dalla loro qualificazione quali investimenti dotati di ambizioni ESG (quindi qualificati ex art. 8 o 9,SFDR). Pertanto, ESMA rimarca che anche nella gestione di fondi meramente qualificati ex art. 6,SFDR, la valutazione dei rischi di sostenibilità e della loro eventuale rilevanza sul valore degli investimenti deve essere effettivamente svolta [5].
Allo stesso tempo, al pari di Consob, ESMA mette in luce un caso di confusione che può minare la corretta gestione del rischio di sostenibilità. Mentre Consob, come ricordato anche nel nostro precedente contributo, tiene ad evidenziare l’importanza di non confondere i rischi di sostenibilità con la considerazione dei PAI, ESMA rileva l’esistenza nel mercato di casi in cui i rischi di sostenibilità sono confusi con il rischio di greenwashing [6]. Questa circostanza appare interessante se si considera che il greenwashing può al massimo rappresentare un classico esempio concreto di rischio di sostenibilità. Il greenwashing, infatti, costituisce una prassi ingannevole nei confronti del mercato e, conseguentemente, è un elemento di rischio in grado di incidere negativamente sul valore di un investimento.
Sempre in linea con i rilievi di Consob, ESMA ha tenuto a rimarcare l’esigenza di introdurre nell’organico dei gestori personale qualificato dal punto di vista ESG, rilevando come, paradossalmente, siano stati finora i gestori più piccoli, in proporzione rispetto al loro personale complessivo, ad allocare alla gestione dei temi ESG un numero di risorse più consistente rispetto a quanto siano riusciti a fare i gestori di maggiore dimensione [7]. La necessità di dedicare alla gestione dei temi ESG e, in particolare, alla valutazione ed integrazione dei rischi di sostenibilità, un numero congruo di soggetti dotati di adeguata esperienza e seniority, che non siano fondate esclusivamente sulla partecipazione ad attività e corsi di formazione, ma siano state effettivamente acquisite sul campo, è stata ulteriormente stressata da ESMA in uno specifico esempio di bad practice [8].
In conclusione, emerge una sostanziale linea di continuità tra Consob ed ESMA in tema di rischi di sostenibilità, concetto che deve tendere a permeare integralmente e trasversalmente l’attività dei gestori.
2.1 Sempre sui rischi di sostenibilità: i granulari rilievi di ESMA
Un interessante aspetto dell’analisi svolta da ESMA è la ricognizione dei sistemi di valutazione dei rischi di sostenibilità adottati dai vari gestori nell’ambito delle procedure di investimento. Anche Consob, nel menzionato Richiamo del 2025, aveva tenuto a fornire un’indicazione dei passaggi chiave che devono essere rispettati nell’ambito del processo di investimento degli OICR qualificabili ex art. 8 e 9, SFDR, senza tuttavia identificare esempi di criteri di valutazione del rischio di sostenibilità degli asset selezionati.
ESMA ha osservato che molti asset manager gestiscono il rischio di sostenibilità degli investimenti attenendosi al rispetto di liste di esclusione di specifici attivi, che si presumono particolarmente rischiosi, ma anche mediante l’impiego di strumenti operativi più complessi. Questi ultimi consentono di selezionare gli investimenti mediante uno screening fondato sulla definizione ed attribuzione di punteggi interni (scoring) calcolati grazie a dettagliati indicatori di performance (KPI). È opportuno, secondo ESMA, che tali strumenti operativi siano impiegati anche al fine di monitorare nel continuo i livelli di rischio di sostenibilità affinché il gestore sia in grado, se necessario, di intervenire sulla strategia di investimento garantendo un profilo di rischio nella norma [9]. Inoltre, sempre secondo ESMA, l’efficacia dei menzionati sistemi operativi dovrebbe essere oggetto di un vaglio periodico [10].
Un ulteriore ambito in cui i rischi di sostenibilità devono essere declinati, nel rispetto dell’art. 5,SFDR, è quello delle politiche di remunerazione del personale degli intermediari. Consob, nel Richiamo del luglio 2024, ha toccato questo tema principalmente dal punto di vista della corretta trasparenza, evidenziando nelle proprie buone prassi alcuni esempi più o meno virtuosi di costruzione della specifica informativa.
ESMA non si limita ad evidenziare l’importanza che le politiche di remunerazione siano chiare nella descrizione dell’impatto dei rischi di sostenibilità sulla componente variabile dei compensi [11], ma entra più nel concreto indicando quali metodologie, rilevate nelle prassi di mercato, possono consentire una considerazione efficace dei rischi di sostenibilità nei processi di remunerazione. Tra queste rilevano, ad esempio, l’integrazione di criteri e livelli di rischio di sostenibilità all’interno degli obiettivi o negli indicatori di performance dei dipendenti, nonché l’indicazione dei rischi di sostenibilità come fattori di determinazione del livello di remunerazione e/o scatenanti delle clausole di clawback [12].
Nel Final Report si manifesta, quindi, l’effetto di un’indagine condotta su tutto il mercato europeo, che ha evidentemente consentito ad ESMA di elaborare raccomandazioni ancor più operative e concrete per i gestori.
3. I rilievi di ESMA sulla metodologia di valutazione dei PAI
Un’ulteriore questione affrontata sia da Consob che da ESMA è quella della trasparenza sui PAI che le decisioni di investimento o consulenza possono determinare sui fattori di sostenibilità.
Consob si era concentrata sulla necessità di chiarire cosa fossero i PAI e come gli obblighi di valutazione degli stessi dovessero essere ben distinti da quelli inerenti alla valutazione dei rischi di sostenibilità.
ESMA traccia un quadro delle lacune riscontrate nell’informativa sui PAI, a livello di entità e prodotto, dalle varie Autorità nazionali.
Innanzitutto, si pone un tema di scorretta applicazione delle regole di utilizzo degli indicatori di cui all’Allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2022/1288. In alcuni casi, ad esempio, non si riscontra nell’informativa di trasparenza alcuna illustrazione degli indicatori utilizzati per rilevare i PAI, venendo così a mancare il dato fondamentale che dovrebbe consentire agli investitori di comprendere come i PAI stessi sono stati calcolati. In altri casi, la struttura dell’Allegato 1, che dovrebbe essere replicata pedissequamente ai fini della costruzione dell’informativa ex art. 4, SFDR, viene stravolta o parzialmente cancellata rimuovendo alcuni degli indicatori. In linea con questa bad practice sono stati rilevati casi di vero e proprio cherry-picking degli indicatori di sostenibilità consistenti, di fatto, nell’impiego di soli alcuni degli indicatori obbligatori di cui alla tabella 1 dell’Allegato 1, con conseguente irrilevanza di alcuni altri indicatori, la cui valutazione sarebbe però altrettanto obbligatoria.
Quest’ultimo fenomeno si è manifestato, in particolare, nelle operazioni di valutazione del DNSH Principle [13], quindi ai fini della certificazione della natura di investimenti sostenibili degli asset che compongono prodotti finanziari qualificati ai sensi come art. 9 o 8 plus (in quanto contenenti una quota parte di investimenti sostenibili), SFDR.
È chiaro, pertanto, che numerose difficoltà operative ed incomprensioni nell’adempimento degli obblighi di trasparenza sui PAI si sono manifestate nell’intero mercato europeo, probabilmente a causa della complessità tecnica della normativa in questione.
4. Le considerazioni sul rispetto del fattore G
Un ultimo aspetto interessante sul quale ESMA si è soffermata, al pari di Consob, è quello relativo ai processi di accertamento del rispetto di prassi di buona governance.
Come richiamato nel nostro precedente contributo, tutti i prodotti finanziari ex articoli 8 e 9, SFDR, devono garantire che le imprese target rispettino prassi di buona governance. Tuttavia, osserva ESMA, alcuni OICR classificati come prodotti finanziari ex art. 8, SFDR, non dispongono né di processi di valutazione del rispetto del fattore G, tantomeno prevedono criteri che indichino per quanto tempo le partecipazioni in imprese non in linea con prassi di buona governance possano essere mantenute in portafoglio o debbano essere dismesse. Infine, risultano spesso assenti criteri di selezione ab origine che chiariscano quali prassi, condotte o fatti consentono di escludere la sussistenza del requisito della buona governance [14].
Davanti a tale scenario, ESMA ha indicato quale esempio di good practice la predisposizione, da parte del gestore (con illustrazione nella documentazione di trasparenza) di solidi criteri di selezione a monte degli asset investibili basati sul fattore G, nonché di criteri funzionali alla medesima valutazione su base continuativa [15].
Allo stesso tempo, è stata indicata da ESMA quale bad practice la mancata adozione di soglie massime di limite temporale e di materialità oltre le quali la violazione dei principi di buona governance debba essere giudicata come non più tollerabile e comporti, conseguentemente, la dismissione degli investimenti non compliant [16].
Anche in punto di corretta valutazione del fattore G, la prassi di mercato europea ha rivelato alcune debolezze che necessitano rimedio da un punto di vista più pratico e sostanziale che formale.
5. Prospettive
L’opera svolta da ESMA con il supporto delle Autorità nazionali ha consentito di tracciare un quadro complessivo dello stato di recepimento del quadro normativo originatosi dal SFDR che, in generale, appare confortante. Come osservato, l’intervento unionale si pone in linea con i richiami Consob, introducendo in relazione alla valutazione dei rischi di sostenibilità una serie di considerazioni ed esempi dotati di maggiore granularità.
Ad ogni modo, è lecito supporre che le indicazioni fornite nel Final Report condurranno ad una maggiore omogeneizzazione a livello Unionale nelle prassi di vigilanza e nell’adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori e, di conseguenza, ad un auspicato vantaggio di una più semplice adozione anche dell’incipiente riforma del quadro normativo ESG. Ciò in particolare potrebbe avvenire con riferimento alla elaborazione e rappresentazione dei PAI.
Si rammenta, in tale ottica, come a maggio di quest’anno la Commissione abbia lanciato una Call for Evidence finalizzata a raccogliere dai vari stakeholders spunti su una possibile riforma del SFDR e una proposta formale della Commissione è attesa entro la fine del 2025.
[1] https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-and-ncas-assess-disclosures-and-sustainability-risks-investment-fund.
[2] “Prodotto finanziario” come da definizione di settore “allargata” datane dal SFDR, all’art. 2, n. 12).
[3] ESMA – Final Report 2023-2024 CSA on the integration of sustainability risks and disclosures.
[4] Cfr. Zanin M., Bonaldo N. M., Finanza sostenibile: Consob sugli obblighi per investimenti e gestori, in https://www.dirittobancario.it/art/finanza-sostenibile-consob-sugli-obblighi-per-investimenti-e-gestori/, 24 febbraio 2025.
[5] Final Report ESMA, punto 24, pag. 12.
[6] Sempre Final Report ESMA, punto 25, pag. 14.
[7] Ancora Final Report ESMA, punti 31 e 32, pag. 16.
[8] Quale esempio di bad practice, ESMA, infatti, riporta “The experience of the senior management in relation to ESG and the integration of sustainability risks into their governance is one year and acquired through trainings and seminars. Senior management has an inadequate level of resources and expertise for the effective integration of sustainability risks and senior managers do not have a proven track record linked to sustainability, complemented by adequate training” (sempre Final Report, esempio 3, pag. 17).
[9] Final Report ESMA, punto 27, pag. 14
[10] Sempre Final Report ESMA, esempio 1, pag. 17.
[11] In merito, si veda la bad practice riportata nell’esempio 5 a pag. 21 del Final Report.
[12] Sempre Final Report ESMA, punto 41, pag. 19.
[13] Final Report ESMA, punto 73, pag. 28.
[14] Final Report ESMA, punto 66, pag. 26.
[15] Ancora Final Report ESMA, esempio 9, pag. 30.
[16] Sempre Final Report ESMA, esempio 14, pag. 31.