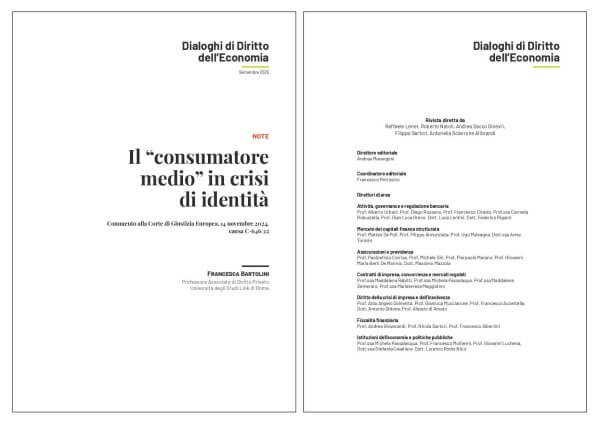SOMMARIO: Commentando il caso Compass (sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C‑646/22), l’autrice riflette sul difficile bilanciamento tra libertà d’impresa e tutela del consenso del consumatore, in un contesto segnato da strategie di comunicazione manipolative come il framing. La Corte valorizza il ruolo dell’interprete nazionale nel valutare se pratiche apparentemente neutre incidano significativamente sulla libertà di scelta economica. Il contributo propone una lettura dinamica del parametro, aperta alle vulnerabilità contestuali, ma attenta a non scivolare in derive soggettivistiche.
ABSTRACT: The author reflects on the challenging balance between business freedom and the protection of consumer consent, within a context marked by manipulative communication strategies such as framing, taking as a starting point the Compass case (judgment of the Court of Justice of the European Union in Case C‑646/22). The Court emphasizes the role of the national interpreter in assessing whether seemingly neutral practices significantly affect economic freedom of choice. This contribution proposes a dynamic interpretation of the standard, one that is open to contextual vulnerabilities yet careful to avoid subjective distortions.
1. Introduzione
Nel periodo delle serie tv, mentre spopola – e fa discutere anche in ambiti extra televisivi[1] – la serie Adolescence, che scoperchia l’inquietante condizione del genitore che prende atto di non conoscere il proprio figlio, anche il consumatore, figlio primogenito dell'(allora Comunità) Unione europea si mostra ancora in preda a una persistente crisi di identità. La definizione di consumatore – che, con la direttiva sulle clausole abusive[2], è per la prima volta divenuta di applicazione generale estesa a tutti i “contratti dei consumatori”[3] – è certamente precettiva perché segna i confini dell’ambito di applicazione di discipline fondamentali per il buon funzionamento del mercato unico, ma ciò non ha impedito che, su di essa, si sia avviato un intenso dibattito[4]. Oggi, a suscitare nuovi dubbi è la variante del consumatore esposto alle pratiche commerciali degli operatori di mercato, il “consumatore medio”, del quale il Consiglio di Stato prospetta, con un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia[5], la necessità di un aggiornamento, nel contesto di una vicenda piuttosto comune: la proposta, da parte dell’intermediario, di polizze assicurative associate a un finanziamento. La risposta della Corte di Giustizia è, come emergerà nel seguito, apprezzabilmente tiepida[6].
2. La vicenda
Tra il 2015 e il 2018 una banca propone ai clienti finanziamenti abbinati a polizze assicurative, non necessariamente funzionali alla copertura di rischi che minassero il buon andamento del rapporto di finanziamento; le assicurazioni non sono obbligatorie, ma vengono comunque offerte insieme al prestito, generando, potenzialmente, un’impressione di obbligatorietà; è il c.d. framing, una strategia di marketing che consiste nel presentare un’informazione o un’offerta in modo tale da influenzare la percezione e la decisione del consumatore, al fine di orientarne le scelte cambiando il contesto o la formulazione di una comunicazione sul prodotto o il servizio offerto.
Nel 2018 l’AGCM apre un’istruttoria, volta proprio a vagliare la possibile riconducibilità di questa prassi al novero delle «pratiche commerciali sleali» di cui alla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette[7]; la banca reagisce manifestando il proprio impegno a incrementare le informazioni precontrattuali per chiarire la facoltatività della polizza e a garantire il diritto di recesso dalla polizza senza effetti sul finanziamento; rifiuta, tuttavia, di aderire alla richiesta dell’AGCM di introdurre un periodo di riflessione di 7 giorni tra la firma del contratto di finanziamento e quello di assicurazione; troppo poco per L’Autorità, che, rigettata la proposta, sanziona la banca con una multa dell’importo di 4,7 milioni di euro, definendo la pratica aggressiva. La banca impugna le decisioni dell’AGCM, ma il TAR del Lazio respinge il ricorso[8]; la banca insiste al Consiglio di Stato, che sospende il giudizio e si avvale dello strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sottoporle una “proposta interpretativa” sensibile agli approdi della scienza comportamentale. Alla Corte europea il giudice amministrativo pone cinque questioni pregiudiziali: (i) se la definizione di “consumatore medio” debba tener conto dei limiti cognitivi che caratterizzano il comportamento fisiologico dei consumatori secondo quanto emerge della teoria comportamentale della razionalità limitata; (ii) se una pratica commerciale possa essere considerata aggressiva già per come viene presentata; (iii e iv) se l’AGCM possa vietare le vendite abbinate in caso di rischio di condizionamento psicologico, imponendo un periodo di riflessione; (v) se porre a carico dell’intermediario l’onere della prova sulla non aggressività della pratica costituisca una violazione del principio di proporzionalità e della direttiva 2005/29, che vieta agli Stati membri di adottare misure più restrittive[9].
Nel commento che segue mi soffermo, in particolare, sul primo profilo, con un cenno al secondo.
3. La storia travagliata della definizione di consumatore
Il problema della definizione (giuridica) di consumatore non è nuovo, e nemmeno di poco conto, perché, come è noto, la protezione del consumatore implica “mutazioni genetiche” del paradigma classico del contratto: forma scritta protettiva, nullità parziale, recesso di pentimento sono solo alcuni degli strumenti di protezione cui si può accedere solo se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione circoscritto dalla definizione.
La discussione sui confini della figura ha riguardato l’estensibilità di strumenti, regole e meccanismi propri del contratto del consumatore – i cc.dd. rapporti B2C – anche a fattispecie soggettivamente diverse da quelle ictu oculi descritte nella definizione normativa e in particolare a professionisti e piccole e medie imprese che in effetti agiscano «per fini che non rientrano nel quadro della [loro] attività professionale»[10]. Nonostante la chiarezza del dato testuale, ancora immutato sul punto (il consumatore è la «persona fisica che» …) molte e autorevoli voci hanno argomentato le ragioni, sostanziali, della equiparabilità, in termini di fisiologica disparità di potere informativo e forza contrattuale di soggetti diversi dalla persona fisica, ma il legislatore ha preferito regolare casi specifici con apposite discipline, senza estendere i confini della definizione. Anche la giurisprudenza ha mantenuto ferma la posizione aderente al dato testuale[11].
Le ragioni di questa scelta di politica legislativa sono varie, e senz’altro c’entra l’efficace lavoro di lobbying svolto dalle imprese di maggiori dimensioni nella fase di gestazione del dettato normativo[12]. Tuttavia non mancano profili di sostanza, per capire le quali bisogna fare qualche passo indietro (e anche di lato).
Quella del decisore irrazionale è una figura nota anzitutto a settori della scienza diversi da quella giuridica[13], i cui approdi hanno ‘nutrito’ i legislatori che si cimentavano nel progetto di dare, appunto, effetti giuridici alle peculiarità caratteristiche di questo attore del mercato, confezionando apposite regole e specifici rimedi. Come si è efficacemente segnalato, dunque, «il consumatore [c’è] prima del diritto»[14]: è, non da oggi, il protagonista dal lato della domanda di beni e servizi, per l’economista; è un complesso processo cognitivo per gli psicologi e uno dei temi centrali degli studi dell’economia comportamentale. E infatti a partire dagli anni Cinquanta negli Stati Uniti si sviluppò un forte interesse per lo studio dell’agente del mercato calato nel contesto della realtà, non più appiattito sul modello dell’homo oeconomicus, individuo razionale che massimizza la propria utilità nelle scelte che compie. Alcuni economisti iniziarono a mettere in discussione questa visione troppo semplificata, aprendo la strada a modelli più realistici di comportamento; parallelamente, le scienze comportamentali (come la psicologia e la sociologia) iniziarono a esplorare i fattori cognitivi, emotivi e sociali che influenzano le decisioni d’acquisto; in questo contesto nacquero i primi studi di marketing moderno, psicologia del consumo e comportamento del consumatore, di talché questa convergenza tra economia e comportamento umano generò la nascita di discipline originariamente ibride come, appunto, l’economia comportamentale e il neuromarketing, che avrebbero preso slancio nei decenni successivi[15].
Il legislatore europeo ha attinto in modo significativo dagli studi sul comportamento del decisore nel mercato dei beni e dei servizi, per costruire un quadro normativo volto alla protezione del consumatore come tassello per attuare il sistema concorrenziale[16]. La rottura del soggetto unico di diritto (e quindi del – e nel – contratto), allora, deve molto agli approdi delle scienze comportamentali che hanno mostrato i modi, non razionali, non efficienti, non pienamente consapevoli dell’agire del contraente non professionista; in altri termini, proprio gli studi di economia comportamentale «revocano in discussione più d’uno degli a priori profondamente imbricati nelle pietre angolari del diritto privato classico»[17].
Qualche esempio appare significativo: la Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), protegge il consumatore bersaglio di attività che precedono il contratto, e che appunto, incidono sul consenso a costituire un rapporto contrattuale (pubblicità ingannevole e, più in generale, pratiche manipolative), il diritto di recesso nei contratti a distanza riflette la consapevolezza che i consumatori agiscono d’impulso o sotto pressione, e subiscono il c.d. “effetto sorpresa”; del resto la spinta sulla “trasparenza informativa” non lavora solo in termini quantitativi, ma anche in base alla comprensibilità e alla chiarezza per il consumatore. Se questo è vero, l’archetipo tradizionale – “il comportamento razionale elevato a dogma dell’economia classica e divenuto fonte di produzione di regole giuridiche implicite”[18] – si rivela non più in grado di sussumere, proprio in quanto presunto archetipo, tutte le possibili situazioni soggettive e oggettive in cui il consumatore può trovarsi ad operare.
4. Consumatore medio vs consumatore tout court
La nozione di “consumatore medio” è una figura ricorrente nel diritto dell’Unione Europea, introdotta in materia di pratiche commerciali scorrette e diritto dei marchi ed impiegata per valutare come il consumatore tipico percepisce messaggi pubblicitari, informazioni contrattuali o segni distintivi. Le direttive europee più rilevanti in cui il concetto di “consumatore medio” è esplicitamente o implicitamente utilizzato sono: la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che all’art. art. 5(2) stabilisce che una pratica commerciale è sleale se «falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio» e al Considerando 18 chiarisce che il “consumatore medio” è “ragionevolmente informato, osservatore e avveduto”, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici[19]; la Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità ingannevole e comparativa, in cui non si menziona sempre testualmente il consumatore medio, ma la nozione è richiamata implicitamente nel riferimento alla percezione della pubblicità da parte del pubblico; la Direttiva 2001/83/CE (codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), in cui nella regolamentazione della pubblicità dei medicinali, la valutazione delle comunicazioni rivolte al pubblico si riferisce anche al modo in cui un consumatore medio potrebbe interpretare tali messaggi. Da ultimo, il consumatore medio è confermato quale benchmark soggettivo nel Regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 sul mercato unico dei servizi digitali – Digital Service Act – per valutare la correttezza della condotta delle piattaforme online.
Nella giurisprudenza della Corte di giustizia, si è ritenuto che il consumatore medio – nozione «non statistica» come precisa il Considerando 18 della Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette – si identifichi in una persona normalmente informata e ragionevolmente attenta e avveduta[20], «tenuto conto di fattori sociali, culturali e linguistici»[21]. Nella decisione qui commentata, tuttavia, la Corte europea è chiamata a esprimersi sulle perplessità sollevate dal giudice amministrativo italiano, mosse dalla constatazione che, in talune situazioni, la razionalità del consumatore è limitata dall’assenza di tutte le informazioni necessarie per una decisione (realmente) razionale, specialmente laddove il decisore subisca quelle distorsioni che le scienze cognitive chiamano di «incorniciamento» (framing) e, in ragione di queste, modifichi le sue preferenze o assuma decisioni irrazionali rispetto a quelle che prenderebbe una persona ragionevolmente avveduta e informata in modo trasparente (per esempio se il consumatore venisse indotto a credere che il finanziamento si possa ottenere solo stipulando anche un’assicurazione).
La Corte rievoca qui i propri precedenti, da cui, essenzialmente, si ricava che “consumatore medio” è categoria oggettivamente identificabile che prescinde dalla situazione specifica e concreto di quel consumatore più o meno avveduto; dunque si conferma pienamente l’idea che la nozione identifichi «una persona, da un lato, normalmente informata e, dall’altro, ragionevolmente attenta e avveduta» senza, però, che questo comporti un approccio esclusivamente astratto o generalizzato. E infatti, secondo la Corte di Giustizia, la “normale” informazione è comunque oggetto di obblighi gravanti sui professionisti, di talché non si può escludere che proprio la carenza informativa, imputabile alla parte forte, determini nel consumatore “medio” una deviazione dal normale e razionale percorso decisionale. Non solo. Secondo la Corte di Giustizia, anche le distorsioni cognitive possono essere apprezzate dal giudice, purché valutate oggettivamente nella loro idoneità a influenzare, distorcendolo, il processo decisionale di un consumatore dotato di normale razionalità e capacità cognitiva (rimanendo irrilevanti se, invece, non si riscontri detta idoneità). In altri termini, il giudice può e deve determinare la reazione del consumatore medio di fronte alle circostanze in cui si viene a trovare, alla pratica commerciali di cui è destinatario, valutando se, sul piano oggettivo, la sua reazione consista nel “cedere” alla pratica distorsiva o, viceversa, nel “resistere” ad essa. La risposta della Corte di Giustizia appare condivisibile sotto molti aspetti, ma, principalmente, per il modo con cui si è fornita una risposta calibrata su esigenze diverse, tutte parimenti meritevoli di tutela: da una parte, è necessario tenere l’oggettività della nozione (di consumatore tout court, di consumatore medio, nello specifico) perché essa costituisce il presupposto per l’applicazione di intere discipline settoriali o di specifici rimedi riconosciuti a favore del consumatore, di talché si possa mantenere, tra l’altro, anche l’oggettiva verificabilità del ragionamento giudiziale, senza impaludarsi in derive soggettivistiche, legate a caratteristiche dello specifico consumatore, caso per caso. Per altro verso, però, la Corte di Giustizia mostra di: (i) conoscere e governare i risultati delle teorie cognitive in materia, (ii) comprendere che, nell’indagine sul consumatore/decisore, possono concorrere le circostanze concrete e (iii) invitare a non chiudere ma, anzi, a tener ben presenti queste circostanze concrete, di talché va «debitamente dimostrato che, nelle specifiche circostanze di una situazione concreta, una siffatta pratica sia tale da incidere sul consenso di una persona normalmente informata nonché ragionevolmente attenta ed avveduta, e ciò in misura tale che il suo comportamento ne sarebbe falsato in misura rilevante»[22]. Proprio in questa affermazione sta la sintesi efficace che rende apprezzabile questa decisione: la distorsione cognitiva, per l’affermazione della sua rilevanza, va riferita a un modello “medio” di persona normalmente avveduta e informata; modello la cui cognizione e individuazione spetta al giudice e solo a lui.
Il consumatore medio è, dunque, una locuzione specificamente introdotta per contesti di mercato nei quali è significativamente avvertita l’esigenza di bilanciare la protezione del consumatore con l’altrettanto importante valore della libertà di impresa e nei quali vanno individuate le pratiche che, oltre a orientare il comportamento dei consumatori verso prodotti o servizi, sono in grado di manipolare le determinazioni del decisore attraverso diverse tecniche che il professionista associa al fisiologico proporsi sul mercato.
Non ha molto senso, dunque, riferirsi alle debolezze tipiche del consumatore tout court, perché in questi ambiti il consumatore medio si presume un po’ meno mediocre di quello tout court, e, appunto, ragionevolmente razionale e avveduto[23]. Questo non significa che non debba esser possibile vincere questa presunzione e accertare che, nel caso di specie, quella pratica, per come articolatasi in concreto, era in grado di determinare una manipolazione del consenso per quel consumatore. Una nozione, come si è detto, “situazionale”[24] in cui la condizione concreta in cui il consumatore assume la propria determinazione giustifica la sua protezione, potendosi peraltro ipotizzare circostanze in cui la “verità è così palese che un affidamento diverso non ha da darsi[25]” (il consumatore ingenuo, per così dire, immeritevole di protezione).
Il compito dell’accertamento spetta al giudice nazionale, e nel nostro ordinamento, il diritto comune dei contratti può offrire un adeguato apparato di strumenti recuperabili dalla disciplina dei rimedi contrattuali: non è vero, in fondo, che la “qualità” dei contraenti incide sulla diligenza esigibile da un contraente che ha/non ha riconosciuto l’errore altrui? Così, in fondo, la gravità della violenza morale incide sulla capacità di resisterle di una “persona sensata”? Per quanto in contesti diversi e nell’ambito di una tutela individuale, il giudice può utilizzare questi parametri per determinare qual era l’attenzione esigibile dal consumatore, escludendone la protezione se il suo comportamento non è stato improntato alla normale diligenza esigibile in quelle specifiche condizioni.
In estrema sintesi: il consumatore medio è meno mediocre del consumatore tout court, e lo è perché, secondo una precisa scelta di politica del diritto, negli ambiti in cui detta nozione è legislativamente utilizzata la libertà d’impresa è un valore che gioca un ruolo importante, da porre sulla bilancia degli interessi in gioco in una posizione non eccessivamente subalterna. Un equilibrio ben presidiato dalla possibilità, ricordata in questa occasione dalla Corte di Giustizia UE, che nel caso concreto emerga, attraverso apposita istruttoria e dialogo fra impresa e autorità regolatoria, che quella condotta è in grado di incidere sulla libera determinazione del consenso del consumatore.
5. Il framing
Il framing è un concetto originariamente sviluppato nelle scienze cognitive e comportamentali che ha assunto crescente rilievo anche nell’ambito del diritto dei consumatori, in particolare nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette[26]; è noto come tecnica di presentazione delle informazioni volta a influenzare la percezione e il comportamento del consumatore, attraverso la manipolazione del contesto comunicativo piuttosto che del contenuto oggettivo dell’informazione stessa. Nel quadro delle condotte idonee a falsare in modo significativo il comportamento economico del consumatore medio, il framing può integrare una modalità subdola di comunicazione commerciale, finalizzata a distorcere la valutazione razionale del consumatore, senza ricorrere necessariamente a false affermazioni o a omissioni materiali.
Il framing può integrare (i) una pratica ingannevole (artt. 21 e 22 c.cons.) qualora la presentazione delle informazioni, pur formalmente veritiera, possa indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche principali del prodotto o al reale vantaggio economico dell’offerta; (ii) una pratica aggressiva (artt. 24-26 c.cons.), qualora la struttura comunicativa della proposta commerciale limiti significativamente la libertà di scelta del consumatore, sfruttando pressioni psicologiche o situazioni di vulnerabilità; (iii) una violazione del dovere di trasparenza, con riferimento al principio di buona fede oggettiva e alla necessità che le informazioni precontrattuali siano fornite in modo chiaro, comprensibile e completo.
Siccome il framing, non vietato in quanto tale, diventa giuridicamente rilevante e potenzialmente illecito quando la modalità di presentazione dell’offerta altera in modo sostanziale la libertà contrattuale e la capacità di autodeterminazione del consumatore, violando i principi cardine della correttezza, trasparenza e lealtà nelle relazioni commerciali, è cruciale il ruolo dell’operatore (l’Autorità di controllo prima, eventualmente l’interprete giudicante dopo) che svolge l’istruttoria sulle circostanze di fatto: come detto sopra, infatti, la presunzione del consumatore medio, normalmente avveduto e razionale, giustamente mantenuta ferma dalla Corte di Giustizia in commento, deve poter cedere di fronte a situazioni che, incrociando la condotta dell’operatore del mercato e la vulnerabilità in concreto del consumatore/decisore, dimostrino la vis manipolatoria dell’atteggiamento del professionista. A voler garantire anche il consumatore medio rispetto a certe pratiche in grado di abbattere la presunzione di (sua) avvedutezza.
Così, l’AGCM ha in più occasioni sanzionato condotte riconducibili al framing come pratiche commerciali scorrette, in particolare nei settori del commercio elettronico, del turismo online e dei servizi digitali. Tra i casi più rilevanti quelli riguardanti operatori di prenotazioni alberghiere online, in cui l’AGCM ha ritenuto scorretto l’uso di messaggi allarmistici come “ultima stanza disponibile” o “altri 10 utenti stanno guardando questo hotel”, privi di reale fondamento[27]. Altre sanzioni hanno riguardato piattaforme di e-commerce che occultavano costi accessori fino alle fasi finali del processo di acquisto, violando così il principio di trasparenza[28]. In diversi provvedimenti l’AGCM ha sottolineato che queste pratiche, sebbene non ingannevoli nei contenuti, risultano ingannevoli nella forma, in quanto sfruttano bias cognitivi e condizionano indebitamente il processo decisionale del consumatore, compromettendone la libertà di scelta economica. L’Autorità fa, dunque, largo uso, nel momento dell’indagine istruttoria e in quello della restituzione del provvedimento formale, degli approdi cui è giunta l’economia comportamentale.
Offrendo allora un precipitato concreto dell’approccio poco sopra descritto, la Corte UE ha giustamente affermato che nell’offerta congiunta di un finanziamento e di una polizza assicurativa non collegata non c’è sic et simpliciter una pratica sleale o aggressiva, ma, considerato l’equilibrio fra i due valori da tenere presenti (protezione del consumatore ovvero della libertà del suo consenso e libertà di impresa) la condotta va valutata caso per caso secondo proporzionalità. E, allora, misure nazionali come l’imposizione di un periodo di riflessione tra i due contratti, possono esser ritenute dall’operatore nazionale proporzionate, purché idonee a mitigare il potenziale impatto del framing sulle decisioni dei consumatori.
6. Per concludere
La decisione è certamente equilibrata, come osservato dai primi commentatori[29]. La necessità di un consumatore meno mediocre serve a bilanciare l’impatto paternalistico della disciplina dei contratti calata dall’Europa massicciamente fin dagli anni Ottanta con la libertà d’impresa, il cui perseguimento fa bene a tutti, consumatori compresi[30]. Il freno della Corte di Giustizia alle istanze del giudice amministrativo merita apprezzamento anche perché lascia uno spazio per una possibile evoluzione del concetto di consumatore medio, evoluzione necessaria nel contesto in cui beni e servizi cambiano rapidamente e radicalmente sulla spinta della digitalizzazione e dell’impiego diffuso di sistemi di IA. L’apertura alla scienza comportamentale, che non è inibita dalla sentenza di cui si è fin qui detto, consente senza rinunciare all’oggettività del parametro del consumatore medio, di integrarlo con innesti ragionevoli di vulnerabilità contestuali, per bilanciare certezza giuridica ed effettività della tutela[31]. L’equilibrio da mantenere, infatti, è fra la tentazione di pendere verso un’oggettività al rialzo, implicitamente confidando che i più di trent’anni di discipline di protezione abbiano “educato”, almeno un po’, il consumatore[32], e quella di ‘assorbire’ acriticamente le intuizioni dell’economia comportamentale per trasferirle nei contesti delle nuove vulnerabilità – prodotti e servizi digitali, uso di sistemi di IA –.
[1] A mo’ di esempio, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna il 20 maggio 2025 si è tenuto il convegno Oltre “Adolescence”: serialità, violenza, mascolinità e media digitali.
[2] Direttiva 93/13/CE, in GU L 95 del 21.4.1993, 29 ss., concernente le «clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori», A ben guardare, il primo compiuto intervento comunitario in tema può indicarsi nella Carta europea di protezione dei consumatori, approvata dal l’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa con risoluzione n. 543/1973. Consumatore, in quella sede, è la «persona, fisica o morale, alla quale siano venduti beni o forniti servizi per uso privato». Cfr. Alpa, Introduzione al diritto dei consumatori, Roma, 2002, 21 ss.
[3] Sulla nozione di contratto del consumatore, specialmente per quel che riguarda i suoi aspetti soggettivi, v., tra i tanti, S. Pagliantini, voce «Contratti del consumatore (diritto europeo)», in Enc. dir., I Tematici. Contratto, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, p. 67 ss.
[4] In prima battuta si discuteva sull’estensibilità della definizione di consumatore a soggetti diversi dalla persona fisica, con autorevoli voci a valorizzare l’analogia di posizioni di debolezza fisiologica nel mercato, senza, tuttavia, generare iniziative legislative di intervento sul testo normativo (su questo può vedersi F. Bartolini, Il consumatore: chi era costui? in Danno e responsabilità, 2009, 386 ss.
Il dibattito più recente si è invece centrato sulla flessibilità della nozione di consumatore, in relazione a contesti specifici quali contratti di garanzia, composizione del sovraindebitamento, e rapporti transnazionali. Emerge una tendenza a superare la definizione basata esclusivamente sulla qualità soggettiva, valorizzando natura e finalità del contratto. Qualche esempio: G. De Cristofaro, Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori, in Nuove leggi civ. comm., 2021, 352 ss. sull’estensione della definizione di consumatore anche ai contratti stipulati da condomìni, alla luce della sentenza della C. Giust. UE 2 aprile 2020, C‑329/19; G. Salvi, La nozione di consumatore e la garanzia fideiussoria, in Teoria e prassi del diritto, 2022, 383 ss., in cui la nozione di consumatore è esplorata nel contesto dei contratti di garanzia, e G. Zarra, Brevi note sulla nozione di consumatore rilevante nel diritto internazionale privato dell’UE alla luce della piú recente giurisprudenza di Lussemburgo, in Rassegna di diritto civile, 2023, 607 ss.
[5] C. Stato, ord. 10 ottobre 2022, n. 8650, in Nuova giur. comm., 2023, 781 ss., con nota di L. Sposini, Dal consumatore medio alla razionalità limitata nella Direttiva n. 29/2005; in Foro It., 2023, III, 529 ss., con nota di C. Bona e N. Bonini, Tutela del consumatore e nuovi paradigmi scientifici (scienze cognitive e neuroscienze varcano la soglia di palazzo Spada). Vd. altresì i commenti di E. Bacciardi, Lo standard del consumatore medio tra homo oeconomicus e homo heuristicus, in Accademia, 2023, 77 ss., F. Trubiani, Le incerte sorti del “consumatore medio” tra condizionamenti cognitivi e nuove aperture della giurisprudenza, ivi, 101 ss. e A. Magliari, Consumatore medio, razionalità limitata e regolazione del mercato, in Rivista della regolazione dei mercati, 2023, 374 ss.
[6] C. Giust. UE, 14 novembre 2024, causa C‑646/22, Compass c. AGCM, commentata da C. Bona e N. Bonini, Una formidabile partita a scacchi: Consiglio di Stato, Corte di giustizia e pratiche commerciali sleali, in Foro It., 2025, 30 ss., F. Trubiani, I “tipi” di consumatore tra categorie tradizionali e nuove qualificazioni, in Accademia, 2025, 43 ss., E. Bacciardi, La Corte di giustizia e il consumatore euristico: (non) tutto ciò che è reale è razionale, ivi, 63 ss., F. Mezzanotte, Né Homo Oeconomicus né Homer Simpson: il «consumatore medio» nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali, in Nuova giur. comm., 2025, 374 ss.
[7] A.G.C.M., Provv. 27 novembre 2019, n. 28011, che chiude il procedimento PS11198.
[8] T.A.R. Lazio 6 settembre 2021, n. 9516.
[9] C. Giust. UE, 14 novembre 2024, causa C‑646/22, Compass c. AGCM, § 33.
[10] È la definizione di consumatore della Dir. 93/13, cit. – art. 2, lett. b) –. Per ricostruire i passaggi fondamentali della menzionata discussione in letteratura basta vedere A.M. Benedetti, voce «Contratto asimmetrico», in Enc. dir., Annali V, Milano, 2012.
[11] Per la Corte di Giustizia (C. Giust UE, 22 novembre 2001, procedimenti riuniti C-541/99 e C-542/99, Soc. Cape c. Soc. Idealservice, in Contratti, 2002, 519, con nota di E. Guerinoni, Sulla nozione di consumatore), adita con rinvio pregiudiziale ex art. 234 TCE, «non rientra nella nozione di consumatore l’impresa che stipula un contratto con un’altra impresa per l’acquisto di beni o servizi», includendo la suddetta nozione unicamente le persone fisiche. Sul fronte nazionale, anche la Consulta, in più occasioni, richiesta di vagliare la costituzionalità dell’art. 1469-bis c.c. «nella parte in cui non equipara al consumatore le piccole imprese e quelle artigiane», sui parametri degli artt. 3, 25 e 41 Cost., ha negato le “ragioni espansionistiche” del giudice a quo[11]: C. Cost., 20 novembre 2002, n. 469, in Foro It., 2003, 332, con nota di A. Palmieri, Consumatori, clausole abusive e imperativo di razionalità della legge: il diritto privato europeo conquista la Corte Costituzionale e di A. Plaia, Nozione di consumatore, dinamismo concorrenziale e integrazione comunitaria del parametro di costituzionalità, ma vd. già ord. 30 giugno 1999, n. 282, in Foro. It., 1999, I, 3118, con nota di A. Palmieri, L’ibrida definizione di consumatore e i beneficiari (talvolta pretermessi) degli strumenti di riequilibrio contrattuale.
[12] Osserva V. Roppo, La nuova disciplina delle clausole abusive nei contratti fra imprese e consumatori, in Riv. dir. civ., 1994, 282.
[13] Sono le scienze economiche, psicologiche e sociologiche che convergono nella Behavioral Economics, le cui linee essenziali, del pensiero nella sua evoluzione, sono ben rappresentate in J.F. Tomer, Behavioral Economics, E. Elgar, Cheltenham-Northampton, 2017. Per una recente rassegna dei diversi fattori che influenzano il comportamento del consumatore, raggruppati nelle quattro dimensioni psicologica, sociale, culturale ed economica, N. Shaw, A Study of the Factors Influencing Consumer Behaviour, in Global Research Journal of Social Sciences and Management, 2024, 48 ss.
[14] È il titolo di un paragrafo del volume di A. Zambon, Primi argomenti per una filosofia del diritto dei consumatori, Pisa, 2020, 46, dove giustamente si discorre di «concetto ordinario di consumatore» per contrapporlo al «concetto giuridico».
[15] Su questi passaggi, J.F. Tomer, Behavioral Economics, spec. 3 ss.
[16] Questa permeabilità fra le scienze bene emerge in A. Zoppini, voce «Contratto ed economia comportamentale», in Enc. dir., I Tematici. Contratto, diretto da G. D’Amico, Milano, 2021, 316 ss.
- Rojas Elgueta, N. Vardi (a cura di), Oltre il soggetto razionale, Roma, 2014.
[17] Così scrive A. Zoppini, voce «Contratto ed economia comportamentale», cit., 315.
[18] Così ancora A. Zoppini, voce «Contratto ed economia comportamentale», cit., 316.
[19] Sulla disciplina delle pratiche commerciali v. De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali, diritti dei consumatori e contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, Pisa, 2025.
[20] Così le sentenze Gut Springenheide, C-210/96 nella quale si è fatto riferimento alla «aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto», Medion, C-120/04, per cui «il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi», Lloyd, C-342/97, in ambito di diritto dei marchi; Konsumentenombudsmannen vs. Ving Sverige, C-122/10, che ribadisce l’importanza del consumatore medio anche in ambito di trasparenza informativa.
[21] Locuzioni ripetute nelle plurime decisioni menzionate offerte in rassegna in De Cristofaro (a cura di), Pratiche commerciali, diritti dei consumatori e contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, cit., 48-50. L’osmosi fra le corti è ben rappresentata in Cass., ord. 15 febbraio 2024, n. 4182, in Pactum, 2024, 442, con commento di L. Guffanti Pesenti, Pratiche commerciali scorrette nel settore della telefonia.
[22] È il paragrafo 57 della sentenza in commento, che si apre con la constatazione per cui «se è vero che la capacità di decisione di un consumatore può essere falsata da un insieme di limitazioni, come le distorsioni cognitive, ciò non implica tuttavia che si debba necessariamente ritenere che qualsiasi rischio di insorgenza di una distorsione cognitiva in occasione di una pratica commerciale abbia necessariamente l’effetto di falsare, in misura rilevante, il comportamento di tale consumatore virtuale».
[23] Questo mi pare sia l’approccio implicitamente sotteso alla sentenza JC c. Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, in cui in cui la Corte UE ha stigmatizzato la prospettiva, innescata dal legislatore tedesco, che, nell’ambito dei contratti di credito al consumo, aveva creato un modello di informativa “sicuro”, ma rivelatosi poi giuridicamente inadeguato, tale per cui il consumatore era costretto a interpretare riferimenti normativi per conoscere i propri diritti – nello specifico il diritto di recesso –. Nel commento a questa decisione, P. Rott, The Average Consumer Is Not a Lawyer! Case C-66/19 JC v Kreissparkasse Saarlouis, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2020, 379 ss., evidenzia, criticamente, come il Bundesgerichtshof (BGH) tedesco, in contrasto con la Corte UE, continuasse a richiedere un livello eccessivo di competenza giuridica al consumatore, proponendo il ritorno a un modello realistico e più protettivo.
[24] Così S. Pagliantini, voce «Contratti del consumatore (diritto europeo)», cit., p. 73.
[25] Ancora S. Pagliantini, ibidem.
[26] Si tratta di uno degli ambiti classici dello studio di BE: ne dice infatti J.F. Tomer, Behavioral Economics, cit., 46-47.
[27] Ad es. v. i casi Unieuro, MediaWorld, Leroy Merlin, Monclick, sanzionati nel dicembre 2021 con 11 milioni di Euro per «false indicazioni sulla disponibilità dei prodotti», presentati come disponibili quando non lo erano, e aumenti del prezzo dopo il primo inserimento nel carrello. Qui l’ingannevolezza stava proprio nella forma comunicativa, non nel contenuto.
[28] Ad es., nel novembre 2022 l’AGCM ha sanzionato MediaMarkt/MediaWorld per 3,6 milioni di Euro per condotte aggressive e di framing nel cross-selling forzato, per aver sostanzialmente obbligato ad acquistare accessori insieme ai prodotti esposti come “in offerta”, manipolando così la percezione del prezzo
[29] Sono adesivi i commenti di F. Mezzanotte, Né Homo Oeconomicus né Homer Simpson: il «consumatore medio» nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali, cit., il quale esprime sostanziale condivisione dell’approccio della Corte, e apprezza il valorizzare di un impiego contestualizzato e probatorio delle scienze comportamentali, capace di adattarsi al caso concreto, evitando il rischio di dar voce a un diritto consumerista eccessivamente paternalista; di E. Bacciardi, La Corte di giustizia e il consumatore euristico: (non) tutto ciò che è reale è razionale, in in Accademia, 2025, 63 ss., che apprezza l’uso della proporzionalità per evitare una tutela eccessiva dei consumatori acritici, a scapito della libertà d’impresa; di F. Trubiani, I “tipi” di consumatore tra categorie tradizionali e nuove qualificazioni, cit., il quale pure apprezza l’equilibrata presa di posizione della Corte UE.
[30] È molto apprezzabile la lettura offerta sulla figura del consumatore medio di R. Senigaglia, Consumatore, vulnerabilità e principio di trasparenza tra razionalità e bias cognitivi, in Nuova giur. comm., 2024, 2024, 1522 ss., il quale peraltro accoglie con favore l’apertura della Corte a una concezione più concreta e contestualizzata del consumatore medio, che tenga conto delle distorsioni cognitive e dei limiti effettivi della razionalità, interpretando la decisione come un segnale di evoluzione interpretativa coerente con le trasformazioni del mercato.
[31] Interessante, in tal senso, l’analisi di S. Cámara Lapuente, ¿In medio virtus? A favor del canon jurisprudencial objetivo del “consumidor medio” para el control de transparencia de las cláusulas no negociadas in Cuadernos de Derecho Transnacional, 2024, v. 16, n. 2, 186 ss., che racconta l’evoluzione del concetto di consumatore medio nel diritto UE, difendendo l’approccio giurisprudenziale oggettivo e sostenendo che il parametro del decisore informato, attento e perspicace sia idoneo a garantire un efficace controllo ex ante della trasparenza, svincolato da valutazioni soggettive del consenso, segnalando alcune derive soggettiviste nella giurisprudenza del Tribunale Supremo spagnolo.
[32] Secondo C. Bailloux, The “Average Consumer” in European Consumer Law, in Exeter Law Review, 2017, 158 ss. il modello di consumatore medio non è in grado di garantire un’alta protezione, soprattutto perché le aspettative poste sul consumatore sono spesso irrealistiche, alla luce di quanto insegna l’economia comportamentale. Occorre, secondo l’Autrice, riflettere sulla funzione ideologica e politica di questo standard, che può rischiare di attribuire eccessiva responsabilità al consumatore, mascherando i limiti strutturali della tutela giuridica.