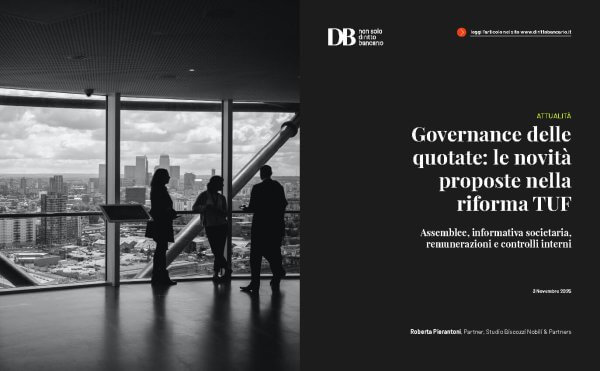Il presente contributo analizza le novità in materia di corporate governance degli emittenti quotati previste nello schema di decreto di riforma del TUF, con particolare riguardo ai profili concernenti assemblee, informativa societaria, remunerazioni e controlli interni.
Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della Legge Capitali[1] (lo “Schema di Decreto”)[2] rappresenta il primo intervento organico volto a ripensare la disciplina nazionale dei mercati dei capitali e delle società di capitali nel loro complesso.
Il provvedimento incide su diverse parti del Testo Unico della Finanza (il “TUF”), su alcune disposizioni del codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti e su ulteriori normative di settore.
Pur trattandosi di un testo non ancora definitivo, lo Schema di Decreto offre già un’indicazione chiara della direzione di marcia del legislatore delegato, orientata alla modernizzazione del diritto dei mercati finanziari italiani in coerenza con la Capital Markets Union e con le recenti iniziative europee in materia di digitalizzazione e trasparenza[3].
L’esame che segue illustra le modifiche proposte dall’articolo 6 dello Schema di Decreto alla disciplina degli emittenti quotati contenuta nel TUF[4], che incidono sull’assetto del sistema di governo delle società quotate, con particolare riferimento alla disciplina delle assemblee, all’informativa societaria, alla politica di remunerazione e al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, anche in relazione all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi di governance.
1. Finalità e linee d’intervento
L’articolo 19 della Legge Capitali ha delegato il Governo a intervenire sulla disciplina degli emittenti per semplificarne l’impianto, garantire la proporzionalità delle regole rispetto alla dimensione delle società e rafforzare la chiarezza dei rapporti tra legge, regolazione e autodisciplina. In tale quadro, lo Schema di Decreto, come evidenziato nella relazione illustrativa che lo accompagna (la “Relazione Illustrativa”), orienta le modifiche al Titolo III, Parte IV, del TUF verso una “semplificazione selettiva”, finalizzata a ridurre gli oneri amministrativi e a modernizzare il sistema di corporate governance in coerenza con la regolazione Consob e con il Codice di Corporate Governance. In particolare, lo Schema di Decreto prevede interventi mirati, tra l’altro, a:
- riformare la disciplina delle assemblee, riordinando nel nuovo articolo 125-bis.1 del TUF la materia già prevista dagli articoli 135-undecies.1 e 135-duodecies del TUF (rappresentante designato in via esclusiva), attribuendo al Consiglio di Amministrazione la scelta della modalità di svolgimento delle adunanze (presenza, mista, telematica o tramite rappresentante designato) e riconoscendo a una percentuale qualificata di soci la facoltà di chiederne lo svolgimento in presenza quando la convocazione preveda l’esclusiva partecipazione tramite rappresentante designato;
- razionalizzare la governance interna, intervenendo da un lato sull’art. 123-ter del TUF, che riforma la disciplina della politica di remunerazione introduce un modello più flessibile e proporzionato e ampliando l’autonomia statutaria consentendo il carattere consultivo del voto assembleare sulla Prima Sezione della relazione; dall’altro codificando nel nuovo art. 147-sexies del TUF il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, volto a chiarire la distribuzione delle competenze tra organi delegati, consiglio e comitato controllo e rischi e a rafforzare il coordinamento informativo sulle esposizioni al rischio della società;
- aggiornare la disciplina dell’informativa societaria, attraverso le modifiche all’art. 123-bis del TUF, che introducono specifici obblighi di disclosure relativi alle politiche sull’utilizzo delle nuove tecnologie e dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché ai rischi informatici e alle politiche aziendali in materia tecnologica, in linea con i principi OCSE di corporate governance e con il Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (“AI Act”).
Secondo la Relazione Illustrativa, tali misure sono funzionali a semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri non essenziali e assicurare coerenza del quadro regolatorio, mantenendo adeguati livelli di trasparenza e tutela del mercato. Il principio ispiratore è quello della proporzionalità, inteso come adeguamento delle regole alle caratteristiche operative e dimensionali degli emittenti, nel rispetto dei valori di integrità e correttezza del mercato.
2. La nuova disciplina delle assemblee
L’introduzione del nuovo articolo 125-bis.1 del TUF e le modifiche introdotte agli articoli 125-bis, 126-bis e 127-ter del TUF riscrivono in modo organico la disciplina delle assemblee delle società quotate, con l’obiettivo di coniugare semplificazione procedurale, digitalizzazione e tutela della partecipazione azionaria.
a) Convocazione e informazione preliminare
L’art. 125-bis del TUF è novellato al fine di eliminare l’obbligo di pubblicare l’avviso di convocazione per estratto su quotidiani nazionali, sostituito da forme di diffusione esclusivamente telematica, e prevedendo che l’avviso riporti anche le candidature individuali presentate.
L’intervento si inserisce nel percorso di modernizzazione dei flussi informativi e di pieno coordinamento con la disciplina europea in materia di trasparenza.
b) Modalità di svolgimento dell’assemblea
Il nuovo articolo 125-bis.1 del TUF riordina e sistematizza le modalità di tenuta dell’assemblea, assorbendo la disciplina del rappresentante designato in via esclusiva precedentemente contenuta negli articoli 135-undecies.1 e 135-duodecies del TUF, che vengono abrogati.
Come evidenzia la Relazione Illustrativa «la modifica è finalizzata a favorire la funzionalità e la fluidità di svolgimento delle assemblee delle società quotate mediante ricorso, anche in via concorrente, a modalità alternative alla riunione “in presenza”, in una logica efficientista, di semplificazione organizzativa, di piena trasparenza informativa e parità di accesso alle informazioni, e di razionalizzazione della dialettica assembleare, in linea con le esigenze di contenimento della durata dei lavori, di incremento del livello qualitativo dell’illustrazione dell’organo amministrativo sulle questioni più rilevanti, nonché di snellimento degli interventi».
L’organo di amministrazione assume un ruolo centrale nella scelta della modalità di svolgimento dell’assemblea, deliberando – con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o, nei sistemi dualistici, con l’approvazione del consiglio di sorveglianza – se l’assemblea, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, debba tenersi: (i) in presenza; (ii) in modalità mista (presenza e collegamento da remoto); (iii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; ovvero (iv) esclusivamente tramite rappresentante designato anche ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF, con possibilità di sub-delega ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF[5].
Per l’attuazione di tale facoltà, l’organo amministrativo è chiamata ad approvare un regolamento assembleare, da pubblicare sul sito internet dell’emittente e richiamare nell’avviso di convocazione, volto a disciplinare le condizioni di partecipazione e garantire l’esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti. La nuova disposizione si coordina con la modifica dell’art. 2364, comma 1, n. 6), del codice civile introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. a), dello Schema di Decreto, che aggiunge all’incipit della norma la clausola «salvo diversa disposizione di leggi speciali». Tale integrazione consente, dunque, di derogare alla regola generale secondo cui l’approvazione del regolamento dei lavori assembleari spetta all’assemblea, permettendo – nel caso delle società quotate – che tale competenza sia attribuita al consiglio di amministrazione ai sensi del nuovo art. 125-bis.1 del TUF[6].
È inoltre previsto che lo statuto – in alternativa alla deliberazione consiliare – possa determinare che l’assemblea si svolga solo secondo una o più delle modalità indicate dalla norma al comma 3, valorizzando l’autonomia statutaria.
Sempre lo statuto o, in alternativa, il regolamento assembleare possono fissare, in caso di partecipazione fisica o telematica, una soglia individuale di possesso azionario, non superiore all’uno per mille del capitale sociale, quale requisito per la partecipazione alla discussione, restando invariati i diritti di voto, di proposta e di informazione.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, tale disposizione «è diretta a prevenire abusi o ostruzionismi, in un’ottica di funzionalità e ordine dei lavori».
Di rilievo anche il meccanismo di garanzia per i soci di minoranza: quando l’assemblea è convocata per svolgersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione o tramite rappresentante designato in via esclusiva, i soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale con diritto di voto – o la misura inferiore prevista dallo statuto – possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, che l’assemblea si tenga in luogo fisico.
L’esercizio di tale facoltà è reso pubblico entro tre giorni mediante integrazione dell’avviso di convocazione.
Si tratta di un presidio di equilibrio tra autonomia dell’organo amministrativo e diritti partecipativi dei soci, come osserva la Relazione Illustrativa[7].
La nuova disciplina è estesa anche alle società le cui azioni sono negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (fatta eccezione per la disposizione dettata dal comma 4 che consente di prevedere statutariamente una soglia di possesso azionario per la partecipazione alla discussione assembleare) e, in parte, alle società cooperative, per le quali sono previste soglie differenziate di attivazione del diritto di richiedere la convocazione in presenza.
c) Integrazione dell’ordine del giorno e diritto di porre domande
Gli articoli 126-bis e 127-ter del TUF sono modificati in funzione di coordinamento con il nuovo assetto assembleare.
In particolare, le modifiche introdotte all’art. 126-bis del TUF adeguano la procedura di integrazione dell’ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione alle modalità telematiche di svolgimento delle assemblee, semplificando i termini e le modalità di comunicazione alla società.
All’art. 127-ter del TUF, che disciplina il diritto di porre domande prima dell’assemblea, è introdotto il nuovo comma 3-ter, che riprende, con modifiche, il contenuto dell’attuale comma 3 dell’art. 135-undecies.1 – destinato all’abrogazione – al fine di garantire la continuità delle tutele informative dei soci nelle assemblee tenute tramite rappresentante designato.
La nuova formulazione specifica che le risposte alle domande presentate prima dell’adunanza possono essere fornite anche mediante pubblicazione sul sito internet della società entro il termine previsto, integrando così la fase preparatoria del voto con strumenti coerenti con la partecipazione digitale.
Nel loro complesso, queste modifiche realizzano una disciplina unitaria e coordinata delle assemblee, che consolida a regime l’esperienza del rappresentante designato in via esclusiva e delle assemblee da remoto, rafforzando – per usare le parole della Relazione Illustrativa – «la trasparenza, la funzionalità e la tempestività del processo deliberativo».
3. Le integrazioni all’articolo 123-bis del TUF in materia di informativa societaria e nuove tecnologie
Lo Schema di Decreto interviene anche sull’articolo 123-bis del TUF, che disciplina la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (la “Relazione CG”), con l’obiettivo di adeguarne il contenuto alle nuove esigenze di trasparenza legate all’evoluzione tecnologica.
La Relazione Illustrativa chiarisce che le modifiche introdotte all’art. 123-bis del TUF— attraverso le nuove lettere d-ter) e d-quater) del comma 2 e il correlato adeguamento del comma 4 — mirano ad «allineare il contenuto della relazione alle emergenti esigenze informative dettate dalla diffusione delle nuove tecnologie e, in particolare, dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale».
Le nuove previsioni richiedono che, ove adottate, la Relazione CG includa:
- una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e monitoraggio delle nuove tecnologie, e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili (lett. d-ter));
- una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e quelli derivanti dall’integrazione di nuove tecnologie nei processi aziendali (lett. d-quater)).
Come precisato nella Relazione Illustrativa, tali informazioni costituiscono un ulteriore strumento di disclosure al mercato, volto a rendere conoscibili non solo le scelte adottate in materia tecnologica, ma anche le modalità con cui gli emittenti si conformano alla normativa europea applicabile (tra cui l’AI Act e il Regolamento DORA).
La modifica estende inoltre il perimetro di verifica della società di revisione, che dovrà accertare l’avvenuta fornitura di tali informazioni, come previsto dal nuovo testo del comma 4 dell’art. 123-bis del TUF.
In tal modo, l’intervento introduce nel diritto positivo un livello di trasparenza tecnologica coerente con il principio IV.A.8 del Codice OCSE di Corporate Governance[8], che considera i rischi di sicurezza digitale tra i rischi materiali da comunicare al mercato.
La Relazione CG si arricchisce quindi di un profilo informativo innovativo, destinato a riflettere — ove esistenti — le politiche aziendali di gestione dei rischi informatici e di uso responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale, ovvero, in mancanza, a dare atto, in modo trasparente, della mancata adozione delle stesse.
4. Le modifiche all’articolo 123-ter del TUF in materia di remunerazioni
Le modifiche all’articolo 123-ter del TUF, introdotte dalla lettera g) dell’articolo 6 dello Schema di Decreto, intervengono in un’ottica di semplificazione e allineamento al diritto europeo sulla disciplina della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
L’intervento, coerente con la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. SHRD II), è finalizzato a eliminare forme di gold-plating del diritto dell’Unione e a rafforzare la coerenza del sistema informativo verso il mercato.
In particolare dette modifiche riguardano quattro profili principali:
(i) perimetro soggettivo della politica di remunerazione.
È introdotto un meccanismo di opt-out statutario: la politica di remunerazione continua a riferirsi, come regola generale, ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti dell’organo di controllo, ma lo statuto può prevedere l’esclusione dei dirigenti con responsabilità strategiche dal relativo perimetro.
Tale previsione, che modifica il comma 3 dell’articolo in commento, mira a uniformare la normativa interna al lessico della SHRD II, che fa riferimento ai soli “amministratori”, evitando un’applicazione più estesa rispetto alla direttiva;
(ii) natura del voto assembleare sulla politica di remunerazione.
Lo Schema di Decreto interviene sui commi 3-bis e 3-ter e introduce il nuovo comma 3-quater, confermando come regola il carattere vincolante del voto dell’assemblea sulla politica di remunerazione (Prima Sezione della relazione), ma consentendo allo statuto di disporre diversamente, prevedendo un voto consultivo (c.d. opt-out statutario).
In tal caso, l’esito della votazione deve essere reso pubblico ai sensi dell’art. 125-quater, comma 2 del TUF e, se è negativo, la società sarà tenuta a ripresentare una nuova proposta di politica di remunerazione alla prima assemblea utile e, al più tardi, in occasione dell’assemblea di bilancio.
La Relazione Illustrativa chiarisce che la modifica è volta a «confermare la centralità del voto assembleare, ma con un grado di flessibilità coerente con le esperienze europee»;
(iii) contenuto informativo della seconda sezione della relazione sulla remunerazione.
È modificato il comma 4, che ora prevede che – qualora la politica disciplini anche la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche – le informazioni relative a tali soggetti siano fornite solo in forma aggregata, con la conseguente eliminazione del potere della Consob di imporre, con regolamento, la pubblicazione di dati nominativi.
È inoltre espunto il riferimento alle società collegate tra quelle tenute a fornire informazioni sui compensi corrisposti, in quanto tale obbligo non è previsto dalla direttiva europea;
(iv) poteri regolamentari della Consob.
È modificato il comma 8, che consente all’Autorità di differenziare il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nella seconda sezione della relazione non solo in base alla dimensione dell’emittente, ma anche in relazione al sistema di amministrazione e controllo adottato (monistico, dualistico o tradizionale).
Nel complesso, le modifiche apportate all’articolo 123-ter del TUF perseguono una finalità di semplificazione e proporzionalità, eliminando oneri informativi non richiesti dal diritto dell’Unione e attribuendo maggior spazio all’autonomia statutaria nella definizione della politica di remunerazione e nella scelta della natura del voto assembleare. Al riguardo la Relazione Illustrativa sottolinea che la revisione «mantiene inalterati i presidi di trasparenza e responsabilità verso gli azionisti», ma «riduce le aree di sovra-attuazione rispetto al quadro europeo, in linea con gli obiettivi di efficienza e competitività della Legge Capitali».
5. Il sistema di controllo interno e l’intelligenza artificiale nei processi di governance (artt. 147-sexies e 149-ter TUF)
Il nuovo articolo 147-sexies del TUF codifica per la prima volta la disciplina del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (il “SCIGR”), finora contenuta solo nel Codice di Corporate Governance, con l’obiettivo di chiarire la ripartizione delle competenze tra gli organi sociali e di rafforzare il coordinamento informativo sulle esposizioni al rischio della società.
Come evidenziato nella Relazione Illustrativa, la disposizione mira infatti a «chiarire l’equilibrio all’interno dell’organo amministrativo quanto alle competenze in materia di controllo interno e gestione dei rischi», rendendo espliciti a livello normativo i principi già affermati dalla prassi di autodisciplina.
In particolare: (i) il comma 1 attribuisce agli organi delegati la responsabilità di curare il buon funzionamento e l’efficacia del SCIGR, recependo l’impostazione del Codice di Corporate Governance secondo cui il chief executive officer è incaricato dell’istituzione e del mantenimento del sistema; (ii) il comma 2 stabilisce che il consiglio di amministrazione assicura e valuta il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nel presidio dei rischi, con l’obiettivo di disporre di una rappresentazione unitaria e tempestiva dell’esposizione complessiva della società; (iii) il comma 3 prevede che il comitato controllo e rischi – o, in alternativa, l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno – assicuri tale rappresentazione unitaria, tenendo conto di criteri di materialità proporzionati alla natura e alle dimensioni dell’impresa e includendo anche indicatori non finanziari.
Di tale rappresentazione deve essere dato conto nella Relazione CG ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.
La norma consolida così la funzione del SCIGR come presidio trasversale della governance, assicurando un raccordo stabile tra gli organi esecutivi e di controllo e promuovendo la circolazione integrata delle informazioni. Rispetto alla disciplina di soft law contenuta nell’art. 6 del Codice di Corporate Governance, l’intervento legislativo conferisce forza vincolante a principi già consolidati nella prassi: la distinzione tra compiti di indirizzo e di valutazione del sistema nel suo complesso (attribuiti al consiglio di amministrazione), compiti di attuazione e di gestione operativa dei presìdi di controllo (in capo agli organi delegati) e compiti di supervisione e di monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema (attribuiti al comitato per il controllo e i rischi).
Accanto a tale previsione, lo Schema di Decreto introduce il nuovo articolo 149-ter del TUF, dedicato ai sistemi di monitoraggio e strumenti di controllo, volto a ricondurre in un quadro unitario l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (“IA”) nei processi di controllo interno.
Come si legge nella Relazione Illustrativa, la norma «intende prendere atto dell’ingresso dell’IA nell’organizzazione societaria, riconoscendone le implicazioni positive», ma al tempo stesso «previene l’imposizione, in via di prassi, di oneri eccessivi a carico delle imprese, optando per soluzioni graduate in ragione delle relative caratteristiche ed esigenze specifiche».
L’impiego dell’IA nei presidi di controllo interno e nelle funzioni di audit consente di sviluppare modalità di monitoraggio continuo e capacità predittive, favorendo una visione integrata e anticipatoria dei rischi. La Relazione Illustrativa sottolinea, tuttavia, che l’ingresso di tali tecnologie nella governance aziendale pone questioni giuridiche attinenti all’organizzazione societaria, con ricadute sulla responsabilità relativa alla predisposizione, cura e valutazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società, ivi inclusa la configurazione di assetti di controllo orientati alla gestione dei rischi e alla neutralizzazione di quelli connessi alla cybersicurezza.
A tale riguardo, il documento richiama gli artt. 2086 e 2380-bis del codice civile, che attribuiscono agli amministratori il compito di istituire assetti societari adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
In questa prospettiva, l’art. 149-ter del TUF non introduce nuovi obblighi formali, ma valorizza l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati come componente degli assetti organizzativi e dei presidi di controllo, da applicare secondo criteri di proporzionalità e coerenza con la complessità dell’attività sociale.
Il combinato disposto degli articoli 147-sexies e 149-ter del TUF configura così un sistema di controllo interno dinamico e integrato, in cui la disciplina legislativa si coordina con i principi del Codice di Corporate Governance e con le sfide poste dalla digitalizzazione dei processi aziendali.
[1] Legge 5 marzo 2024, n. 21, come integrata dalla legge 11 marzo 2025, n. 25.
[2] L’Atto del Governo n. 331 – recante lo «Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge n. 21/2024, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» – è stato approvato dal Governo l’8 ottobre 2025 e trasmesso il successivo 17 ottobre alla Camera dei Deputati; il 21 ottobre 2025 è stato assegnato per il parere parlamentare alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) con termine al 30 novembre 2025, e sottoposto ai rilievi della Commissione V (Bilancio e Tesoro) da formularsi entro il 10 novembre 2025. Il testo del provvedimento e della relativa relazione illustrativa sono consultabili al seguente link.
[3] L’iniziativa della Capital Markets Union, avviata dalla Commissione europea nel 2015 e rilanciata con il Piano d’azione del 24 settembre 2020, costituisce il quadro di riferimento delle recenti misure di modernizzazione del diritto dei mercati dei capitali, tra cui il Regolamento (UE) 2023/2859 sull’European Single Access Point (ESAP) e il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) in materia di resilienza operativa digitale, espressamente richiamati nella Relazione Illustrativa allo Schema del Decreto quali strumenti cardine della strategia europea per l’integrazione e la modernizzazione dei mercati dei capitali.
[4] Le modifiche in esame riguardano disposizioni contenute nel Titolo III (“Emittenti”), Parte IV (“Disciplina degli Emittenti”) del TUF.
[5] La norma consente inoltre che l’espressione del diritto di voto possa essere prevista anche per corrispondenza o in via elettronica (comma 1).
[6] La nuova previsione, pur rispondendo a finalità di semplificazione e di maggiore efficienza operativa, incide sull’assetto tradizionale delle competenze tra assemblea e organo amministrativo, trasferendo a quest’ultimo una funzione che, nel modello codicistico, costituisce espressione dell’autonomia assembleare. Tale scelta, seppur giustificata dalla natura tecnico-organizzativa del regolamento, solleva interrogativi sull’equilibrio tra potere gestorio e diritti partecipativi degli azionisti, soprattutto nei casi in cui la disciplina incida sulle modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto.
[7] L’introduzione di questo meccanismo solleva dubbi sulle implicazioni organizzative che potrebbero far seguito alla richiesta degli azionisti di modificare la modalità di svolgimento dell’assemblea, nonché sulle altre modificazioni che, in tal caso, dovranno essere apportate al contenuto dell’avviso di convocazione (si pensi, ad esempio, al diritto di porre domande).
[8] OECD, G20/OECD, Principles of Corporate Governance (2023), Principle IV.A.8.