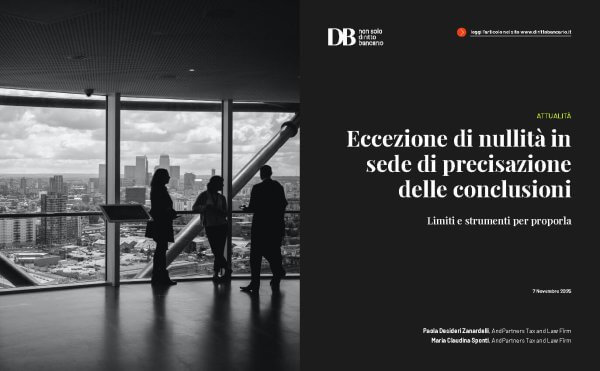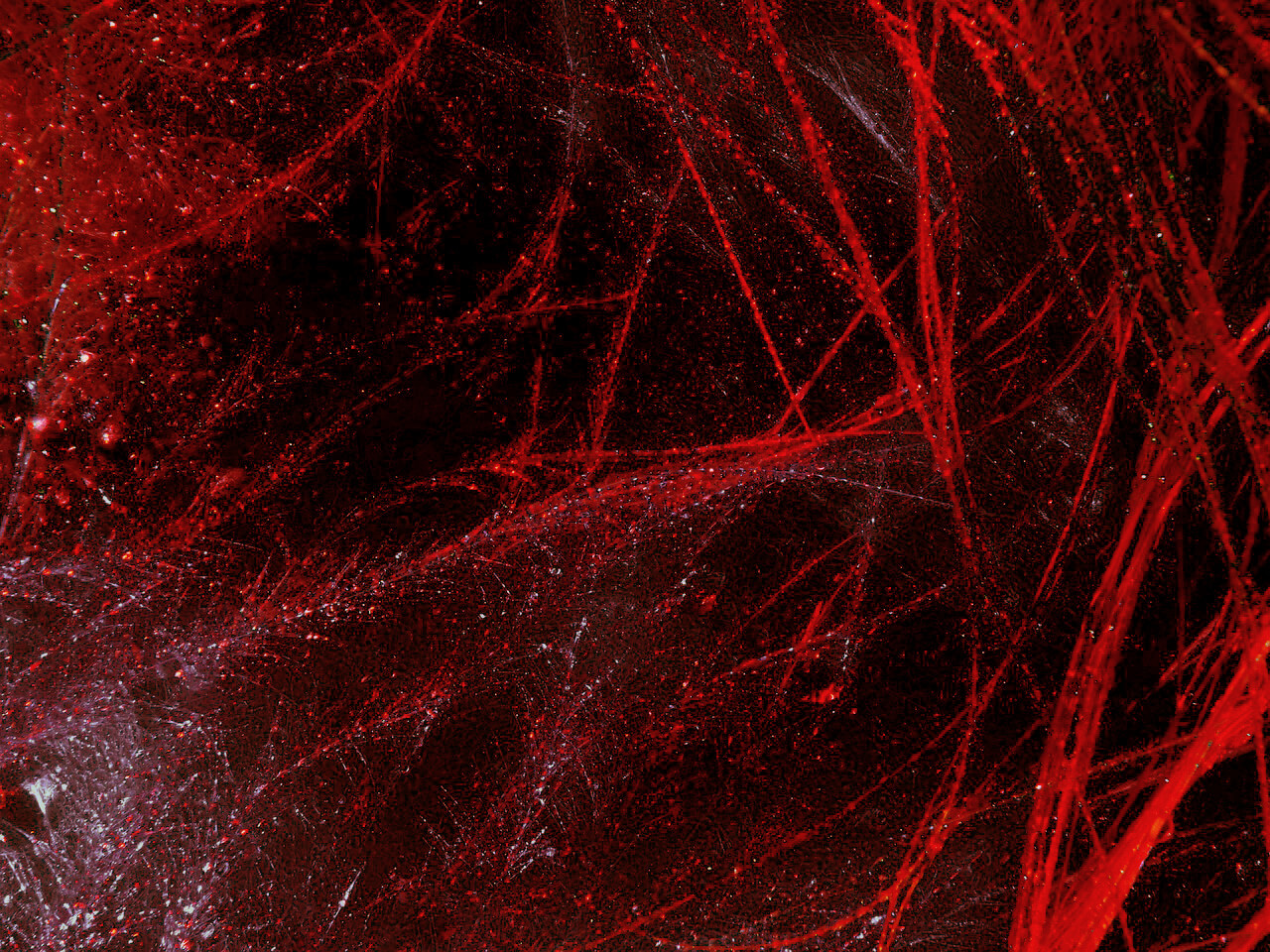Il presente contributo si propone di analizzare alcuni profili pratici dell’attività degli operatori di diritto nei casi di nullità dei contratti, alla luce della pronuncia della Cassazione n. 26459/2025 pubblicata il 30/09/2025, che ha chiarito la rilevanza processuale del momento in cui viene sollevata l’eccezione di nullità.
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha fornito delle precisazioni in merito all’art. 1421 c.c.: tale norma, di portata generale, prevede che la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, non senza alcuni accorgimenti.
1. La vicenda processuale
Il giudizio trae origine dalla richiesta di riforma di una sentenza di appello con cui una Banca è stata condannata a risarcire al proprio cliente i danni subiti per la perdita economica a seguito dell’acquisto di quote di un fondo di investimento, a causa dell’inadempimento degli obblighi informativi contrattuali in capo all’Istituto.
In particolare, la Corte di appello aveva ritenuto che fosse stata correttamente eccepita la nullità del contratto da parte del cliente in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio.
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione, riformando la sentenza impugnata, ha svolto un esame analitico della normativa e della giurisprudenza in materia, individuando i limiti della proponibilità dell’eccezione di nullità alla luce dei principi codicistici.
2. La nullità del contratto
Il ragionamento della Suprema Corte parte dal presupposto che, nonostante la nullità del contratto possa essere fatta valere in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell’art. 1421 c.c., la stessa opera solo se una delle parti ne abbia richiesto l’adempimento.
Infatti, il giudice, nel verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione, potrà rilevare d’ufficio le eccezioni che, pur senza ampliare l’oggetto della controversia, possono comportare il rigetto della domanda. Tra queste vi è l’eccezione di nullità del contratto.
Il giudice sarà, anche in tali ipotesi, tenuto al rispetto del principio dispositivo, al fine di evitare ampliamenti dei poteri d’iniziativa officiosa delle parti.
In un’ottica di correttezza e parità tra le parti, queste hanno la facoltà di introdurre domande alternative, con i limiti dettati dai termini processuali che, ante Riforma Cartabia, coincidevano con le memorie ex art. 183 c.p.c. e, ad oggi, con le memorie 171 ter c.p.c.
Tuttavia, vi sono come sempre alcune eccezioni che devono in ogni caso, rispondere ai canoni della correttezza processuale, di cui all’art. 88 primo comma C.p.c.
Questi casi eccezionali, nella pratica non elencabili, implicano una “struttura complessa” basata su principi processuali richiamati dalla Costituzione, che servono a garantire un processo giusto e imparziale.
Dunque, la nullità di un contratto e la possibilità che venga eccepita in sede di precisazione delle conclusioni può essere accolta e il rilievo officioso può avvenire anche quando le preclusioni processuali di merito sono già maturate, ma ad una condizione: che il motivo di nullità risulti per tabulas.
In poche parole, la parte che formula la domanda dovrà aver quanto meno narrato i fatti su cui si fonda la stessa e depositato la documentazione idonea a provare la fondatezza della domanda “tardiva”.
Questa regola è applicabile anche quando si tratta della nullità per violazione di norme imperative, il cui rilievo è riservato alla volontà della parte.
3. Profili pratici
La decisione della Suprema Corte costituisce un altro tassello di un’ampia serie di pronunce sull’applicazione processuale dell’art. 1421 c.c.
Partendo dai soggetti legittimati a proporre la domanda – ovvero chiunque vi abbia interesse può sollevare la questione di nullità – bisogna tracciare ulteriori limiti.
Occorrerà, infatti, fare attenzione alle preclusioni processuali.
Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione il giudice dell’impugnazione non potrà rilevare d’ufficio la nullità parziale del contratto, nel caso in cui la parte interessata non abbia impugnato il capo della sentenza relativo alla nullità totale del contratto e si sia, pertanto, formato un giudicato interno (Cass. 1010/2024).
Altro discorso riguarda i contratti che richiedono la forma scritta ad subsantiam. Anche in tali ipotesi, l’eccezione di nullità del contratto è sottesa alle preclusioni sopra evidenziate.
La giurisprudenza di legittimità, già con l’ordinanza n. 25849/2023, aveva ritenuto non tardiva l’eccezione di nullità proposta in appello, perché fondata su documentazione già presente in giudizio. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’assenza, tra i documenti prodotti dalle parti in causa, del contratto sottoscritto, concretizzasse la prova dell’assenza della forma scritta ad substantiam.
Un’altra ipotesi di applicazione pratica dell’eccezione di nullità del contratto nel rispetto delle preclusioni processuali è rinvenibile nella richiesta di risoluzione del contratto preliminare di vendita concluso oralmente (Cass. 4867/2024).
Anche in questo caso l’eccezione proposta in appello è stata ritenuta ammissibile in quanto:
- si trattava di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo;
- i presupposti della domanda erano stati già acquisiti nel corso del giudizio di primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Tante sono le applicazioni pratiche che si potrebbero ancora esaminare, ma il principio base è uno solo: qualunque eccezione di nullità, pur se rilevabile d’ufficio, deve avvenire nel rispetto delle preclusioni processuali. Altrimenti vi sarebbe una violazione dei principi del contraddittorio.
4. Spunti di riflessione
Valutare tecnicamente un provvedimento, quale è quello in commento, è molto più semplice che immaginarlo nella sua incidenza pratica nella vita quotidiana di un litigation lawyer.
L’ordinanza n. 26459/2025 insegna ad avere attenzione a quanto viene allegato nel giudizio, ma ancor di più ai documenti depositati da controparte.
Sebbene un documento possa provare i fatti narrati dalle parti, in esso, è possibile, che vi siano prove anche su accadimenti diversi da quelli enunciati. L’elemento probatorio, dunque, anche in caso di nullità di un contratto, ha un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che lo abbia inizialmente offerto in comunicazione.
Quindi, è opportuno, prima del deposito, analizzare integralmente ogni pagina del materiale probatorio, onde evitare che possa risultare fonte di conoscenza non solo per il giudice, ma anche per la controparte che ne potrebbe usufruire.
Allorquando, di contro, l’avverso documento si scopra utile per la domanda tardiva di nullità – di una clausola o dell’intero contratto – tale elemento va reiterato nel tempo, affinché possa costituire elemento probatorio per il giudice, mediante deposito della copia rilasciata dall’ufficio a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c. Potendosi, così, avvalere di quel documento, anche nel caso in cui non venga riprodotto in secondo grado o in caso di contumacia della parte che lo aveva inizialmente offerto in comunicazione.
Sul punto, torna alla mente la sentenza della Cassazione Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2023, n. 4835, che, tra le altre indicazioni, racconta come i giudici oggi possano apprezzare il contenuto degli allegati in appello anche nella loro versione trascritta o indicata nella decisione impugnata, ma non possano trarre dai documenti allegati, fatti non richiamati dalle parti (mediante richiamo di essi nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte).