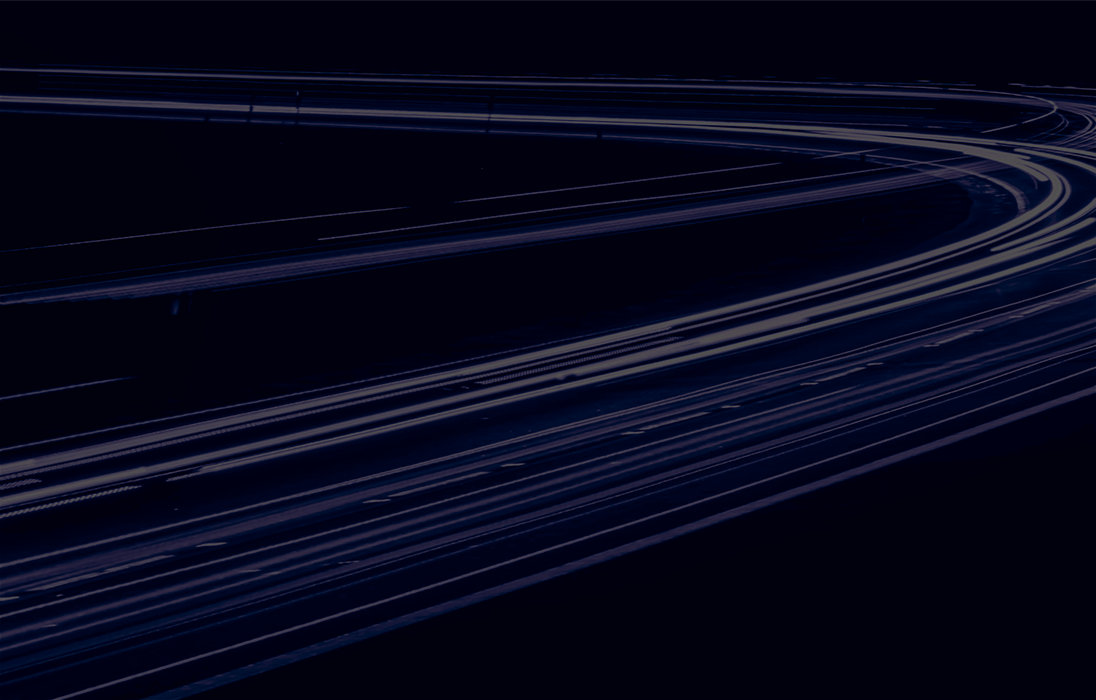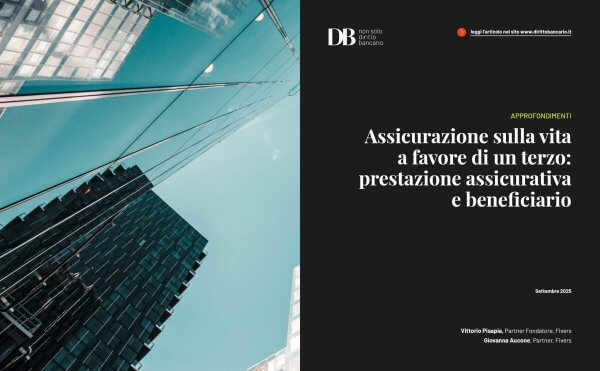Il presente contributo analizza i temi della prestazione assicurativa e del beneficiario assicurativo nei contratti di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, che presentano aspetti giuridici rilevanti e di notevole interesse sia sotto il profilo sistematico che sotto quello pratico.
1. Premessa: inquadramento generale, funzione dei contratti di assicurazione sulla vita e riconducibilità allo schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 del Codice Civile
1.1. I contratti di assicurazione sulla vita sono negozi in forza dei quali l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio unico o periodico, si impegna a corrispondere una rendita o un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (il c.d. rischio demografico)[1].
Nella pratica, il mercato assicurativo conosce diverse tipologie di contratti di assicurazione sulla vita[2].
In generale, essi sono riconducibili a tre categorie:
- assicurazione per il caso morte, in cui l’assicuratore si impegna a eseguire la prestazione alla morte dell’assicurato in qualunque momento essa si verifichi (assicurazione sulla vita intera) o soltanto entro un determinato arco temporale (assicurazione temporanea);
- assicurazione per il caso vita, in cui l’assicuratore è chiamato a corrispondere un capitale se la persona assicurata è ancora in vita a una data espressamente prestabilita in polizza;
- assicurazione mista, in cui l’assicuratore è tenuto a eseguire la prestazione assicurativa in un dato momento soltanto nell’ipotesi di sopravvivenza dell’assicurato e con pagamento di un capitale in caso di premorienza.
Nel presente contributo verranno esaminati i contratti di assicurazione sulla vita per il caso morte a favore del terzo, disciplinati dagli articoli 1920 e seguenti del Codice Civile; tali tipologie di contratti – oltre ad avere una notevole diffusione commerciale – presentano aspetti giuridici rilevanti e di notevole interesse sia sotto il profilo sistematico che sotto quello pratico.
1.2. I contratti di assicurazione sulla vita assolvono principalmente a una funzione di carattere previdenziale e di risparmio.
In particolare, come si è accennato, il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso morte è quel negozio con il quale il contraente si obbliga a versare, in vita, premi all’assicuratore; ciò a fronte dell’impegno, da parte di quest’ultimo, a corrispondere, alla morte dell’assicurato, la prestazione assicurativa a colui che è stato designato come beneficiario della polizza.
In virtù di tale meccanismo negoziale, il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo, oltre ad adempiere a una funzione previdenziale, consente al contraente di disporre del proprio patrimonio al verificarsi della propria morte.
In tale prospettiva, il contratto di assicurazione ex art. 1920 del Codice Civile assolve a una funzione di trasmissione della ricchezza post mortem; esso rappresenta, cioè, uno strumento per regolare i propri interessi per il tempo successivo alla propria vita[3].
1.3. In quest’ottica, il contratto in esame presenta evidenti punti di contatto con l’istituto del testamento.
Infatti entrambi hanno la funzione di regolare assetti patrimoniali per il periodo successivo alla morte di un soggetto.
Tuttavia, il contratto di assicurazione a favore del terzo presenta caratteristiche peculiari che lo distinguono e, per certi versi, lo pongono, anzi, come strumento alternativo al testamento.
In particolare:
A) ai sensi dell’art. 1920, comma 3, del Codice Civile, “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.
Ciò significa che il beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita – ossia il soggetto che riceverà la prestazione assicurativa al momento della morte dell’assicurato – acquista un diritto autonomo, ossia un diritto proprio, nei confronti dell’impresa di assicurazione[4].
Non vi è, dunque, alcun trasferimento diretto dal contraente in favore del terzo beneficiario; in altre parole, diversamente da quanto accade con il testamento, non si verifica alcun effetto successorio.
B) Al contrario, il patrimonio dell’assicurato – nelle forme del premio assicurativo – transita nel patrimonio dell’assicuratore, il quale, a fronte dell’incasso del premio assicurativo, si impegna a corrispondere la prestazione assicurativa al terzo beneficiario al verificarsi dell’evento assicurato.
Come è stato rilevato dalla dottrina, “la prestazione assicurativa fuoriesce dal patrimonio dell’assicuratore e non vi è alcun passaggio nella successione ereditaria dell’assicurato né alcuna incidenza delle vicende di quest’ultima su una attribuzione che segue le regole dettate per il contratto”[5].
C) Proprio in virtù del fatto che il beneficiario acquista un diritto autonomo nei confronti dell’assicuratore, la prestazione assicurativa rimane esclusa dalle vicende successorie e non segue le sorti della successione del de cuius.
Anche in ragione di tali caratteristiche, dunque, i contratti di assicurazione sulla vita a favore del terzo sono strumenti che consentono di superare i vincoli che l’ordinamento pone alla libertà di disporre liberamente del proprio patrimonio dopo la morte.
D) Peraltro, l’art. 1923, comma 2, del Codice Civile stabilisce che “sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni”.
In virtù di questa previsione, l’assicurazione sulla vita a favore del terzo non rimane del tutto indifferente alle vicende successorie del contraente assicurato; in particolare, le somme da questi versate a titolo di premio assicurativo possono essere calcolate ai fini della determinazione della quota di legittima e possono essere altresì oggetto di collazione[6].
1.4. È ormai pacifico che il contratto di assicurazione a favore del terzo è sussumibile – seppur con alcune peculiarità – nello schema del contratto a favore di terzi disciplinato dagli articoli 1411 e seguenti del Codice Civile[7].
Tale inquadramento del contratto di assicurazione sulla vita consente di individuare quali norme di diritto comune applicare anche al negozio assicurativo.
A differenza, però, di quanto previsto nello schema generale del contratto di cui all’art. 1411 del Codice Civile – ove l’acquisto del diritto del terzo verso il promittente nasce (salvo patto contrario) al momento della stipulazione del contratto – nei contratti di assicurazione sulla vita il terzo acquista il diritto alla prestazione assicurativa per effetto della designazione.
Tale peculiarità trova la propria ragione nel fatto che nei contratti di assicurazione sulla vita a favore del terzo per il caso morte il beneficio assicurativo non può essere goduto dal contraente. In questo senso, la designazione del terzo beneficiario è elemento strutturale del contratto: infatti la prestazione assicurativa deve essere attribuita a persona diversa dal contraente.
Corollario di quanto sopra è che il diritto di credito a favore del terzo nei contratti di cui all’art. 1920 del Codice Civile sorge per l’effetto della mera designazione; infatti la morte è soltanto l’evento che rende liquida ed esigibile la prestazione assicurativa.
La riconducibilità del contratto in esame allo schema del contratto a favore di terzi comporta altresì l’applicazione della disposizione cui all’art. 1412, comma 2, del Codice Civile, secondo cui, “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”[8].
2. La designazione e la revoca del beneficiario
2.1. Come si è già evidenziato, l’atto di designazione del beneficiario rappresenta un momento determinante del contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo[9].
L’art. 1920, comma 2, del Codice Civile indica le modalità e i tempi con cui il contraente può individuare il beneficiario.
Secondo tale disposizione, il beneficiario del contratto di assicurazione sulla vita può essere designato anche “genericamente”: a) mediante dichiarazione scritta, al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione; b) con dichiarazione scritta, successiva alla stipula del contratto e comunicata all’assicuratore; c) con disposizione testamentaria.
L’art. 1920, comma 2, del Codice Civile non è annoverato tra le norme inderogabili dall’art. 1932 del Codice Civile; pertanto è riconosciuta la facoltà di effettuare la designazione del beneficiario con modalità diverse rispetto a quelle espressamente previste dal Codice Civile.
L’atto di designazione è un atto personale; pertanto, può essere effettuato esclusivamente dal contraente, il quale non può essere sostituito né dai suoi eredi, né dai creditori in via surrogatoria[10].
La designazione del beneficiario è inoltre un atto unilaterale e non recettizio; infatti, per la sua efficacia, non sono necessari il consenso o l’adesione né dell’assicuratore[11] né del beneficiario[12].
È inoltre pacifica la natura di atto inter vivos[13] della designazione; ciò soprattutto quando essa avvenga direttamente con il contratto di assicurazione o per mezzo della dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore (più controversa è, invece, la qualificazione dell’atto di designazione qualora questa sia fatta dal contraente in sede testamentaria).
2.2. L’art. 1921, comma 1, del Codice Civile stabilisce che il contraente può sempre e liberamente revocare la designazione con le medesime forme e modalità con cui ha provveduto a individuare il beneficiario della prestazione assicurativa.
Salvo il caso di beneficiario irrevocabile, dunque, il contraente può disporre in ogni tempo la revoca della designazione effettuata.
Se, come abbiamo illustrato, per effetto della designazione il beneficiario acquista un diritto proprio e autonomo alla prestazione assicurativa derivante dal contratto, tale situazione giuridica soggettiva è comunque condizionata risolutivamente all’eventuale revoca del beneficio.
In altre parole, il diritto del beneficiario è subordinato alla volontà del contraente, volontà che può infatti mutare nel tempo.
La revoca, al pari della designazione, è atto personale, e non può essere esercitata dagli eredi del contraente dopo la sua morte (cfr. art. 1921, comma 1, del Codice Civile).
Va poi evidenziato come nel contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo al contraente sia riconosciuto un potere di revoca molto più ampio rispetto a quanto previsto dall’art. 1411 del Codice Civile.
Infatti:
- secondo la disciplina generale del contratto a favore di terzi, una volta che il terzo abbia dichiarato di voler profittare della nomina, lo stipulante non può più sostituire il terzo nominato;
- per contro, nel contratto di assicurazione sulla vita, la dichiarazione del terzo di voler profittare della designazione è ininfluente; essa non fa venir meno, cioè, la facoltà in capo al contraente di revocare e/o nominare un nuovo beneficiario.
La revoca del beneficio può essere anche implicita; il che si verifica ogni volta che il contraente abbia posto in essere atti univocamente incompatibili con la volontà di confermare l’attribuzione al terzo già designato (come nel caso in cui il contraente abbia esercitato il diritto di riscatto[14] o abbia cessato di pagare i premi).
Allo stesso modo, è considerata revoca implicita la designazione di un nuovo beneficiario che risulti oggettivamente incompatibile. Ad esempio, si ha revoca implicita quando il contraente, con il testamento, attribuisca la somma assicurata oggetto del contratto di assicurazione a un nuovo e diverso soggetto rispetto a quello in precedenza designato[15].
La nomina di un soggetto quale erede universale, al contrario, non costituisce, di per sé, revoca implicita dell’atto di nomina del beneficiario precedentemente indicato[16].
3. L’indicazione dei beneficiari per relationem: difficoltà interpretative e soluzioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza
3.1. Fatte queste considerazioni introduttive, passiamo ora a esaminare alcune delle più rilevanti questioni che si pongono in relazione a questa tipologia di contratto, e le soluzioni che sono state offerte al riguardo dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La circostanza che la designazione dei beneficiari nei contratti sulla vita in favore di terzi possa essere:
- revocata in ogni momento (salvo l’ipotesi di designazione irrevocabile),
- fatta anche genericamente, e quindi indicando una categoria di soggetti (quali, ad esempio, “i figli”, gli “eredi legittimi” o “gli eredi testamentari”),
- indicata in un momento successivo alla stipulazione del contratto,
è coerente sia con la funzione previdenziale che con la natura stessa dell’assicurazione sulla vita.
Infatti, a fronte delle particolari esigenze che tale contratto mira a soddisfare, è fisiologico che il contraente possa avvertire la necessità di riconoscere i vantaggi economici derivanti dall’assicurazione sulla vita a favore di una pluralità di soggetti non necessariamente individuati e/o individuabili al momento della stipulazione del contratto.
Nel tempo la prassi assicurativa ha individuato modalità di designazione del beneficiario c.d. per relationem, ove il criterio di selezione dei destinatari della prestazione assicurativa viene individuato indicando un determinato status familiare, una data qualità o posizione giuridica.
Naturalmente, la designazione del beneficiario e/o dei beneficiari nei termini sopra illustrati può determinare, in concreto, non poche difficoltà di interpretazione e individuazione dei soggetti effettivamente legittimati a percepire la prestazione.
Ciò, a maggior ragione, se si considera che il contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo è, come si è detto, un contratto di durata; pertanto, nella vigenza del contratto – ossia tra il momento della stipula, la designazione del/i beneficiario/i e il sorgere dell’obbligo in capo all’assicuratore di eseguire la prestazione assicurativa – l’individuazione del/i soggetto/i che può/possono essere legittimamente qualificato/i come beneficiario/i è suscettibile di variazione.
Per far fronte a tali difficoltà, tra l’altro, anche l’IVASS, con il Regolamento n. 41/2018, ha imposto alle imprese di assicurazione di richiamare l’attenzione del contraente al momento dell’indicazione/individuazione del beneficiario invitando a effettuare un’indicazione nominativa.
Le imprese di assicurazione sono tenute, quindi, a inserire nel contratto l’avvertenza che un’indicazione generica o per relationem potrebbe rendere difficoltosa la liquidazione del beneficio assicurativo.
In relazione alle difficoltà che possono sorgere nella individuazione dei soggetti beneficiari, vediamo, dunque, quali sono le situazioni che nella pratica si presentano con maggiore frequenza e le soluzioni che sono state offerte (anche) dalla giurisprudenza.
3.2. Una prima classica designazione per relationem è quella che viene fatta a favore del coniuge senza l’indicazione del nominativo.
Secondo un primo, tradizionale, orientamento, il beneficiario va individuato nel soggetto che rivestiva lo status di coniuge al momento della designazione[17].
Secondo un diverso orientamento, il beneficiario sarebbe, invece, il soggetto che riveste la qualità di coniuge alla morte del contraente[18].
Infatti – considerata l’evoluzione del diritto di famiglia e, quindi, il fatto che una persona possa contrarre nel tempo più matrimoni – è oggi più ragionevole ritenere che l’indicazione generica del coniuge come beneficiario della polizza debba essere intesa in favore di chi abbia tale qualità al momento dell’apertura della successione.
3.3. Altra ipotesi non rara di designazione generica è quella in cui il beneficiario viene individuato nella categoria dei “figli” o “nipoti”.
Al riguardo, possono individuarsi i seguenti orientamenti:
- secondo un primo orientamento, il/i beneficiario/i va/vanno individuato/i in chi aveva tale/i status alla data della designazione; ciò sulla base della considerazione per cui, ove sopravvengano nuovi figli o nipoti, il contraente ha sempre il potere di modificare o revocare le precedenti disposizioni[19];
- secondo altro orientamento, invece, se il contraente abbia designato genericamente i figli, ciò equivarrebbe a ricomprendere tutti i figli, nati e nascituri, fino al momento della morte dedotta in contratto[20];
- secondo un terzo orientamento, il beneficiario andrebbe individuato, come nel caso del coniuge, nel soggetto o nei soggetti che rivestono la qualità di figli o nipoti al momento della morte del contraente.
Tale ultima soluzione eviterebbe che si verifichino ingiustificate disparità di trattamento tra soggetti che, nei confronti del contraente, abbiano un medesimo grado di parentela e che restino esclusi determinati soggetti soltanto perché, alla data della designazione, essi non erano ancora nati o non rivestivano tale qualità.
3.4. Più incerto è invece il caso in cui il figlio o il nipote premuoiano all’assicurato.
In questi casi, bisogna distinguere se la premorienza del figlio o del nipote sia avvenuta in un’epoca successiva o anteriore all’atto di designazione.
Nel primo caso, la soluzione più convincente è quella di applicare il secondo comma dell’art. 1412 del Codice Civile e, pertanto, riconoscere la prestazione assicurativa in favore degli eredi del discendente premorto.
Più delicata è, invece, l’ipotesi in cui la designazione avvenga nel momento in cui il figlio o il nipote siano già defunti. In questi casi, infatti, il diritto alla prestazione assicurativa sorgerebbe in un momento in cui il soggetto è già deceduto, ed è dunque privo della capacità ad acquistare; in tali ipotesi, ai fini dell’individuazione del beneficiario potrebbero venire in considerazione gli istituti della rappresentazione e dell’accrescimento[21].
3.5. L’ipotesi più frequente nella prassi è, peraltro, quella per cui l’indicazione dei beneficiari viene fatto in favore degli “eredi legittimi”, “eredi testamentari”, “eredi testamentari, in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi”.
Tali modalità di designazione hanno dato luogo a un vivace dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
Infatti, in considerazione dell’esplicito richiamo agli istituti tipici del diritto delle successioni, è sorto il dubbio se l’individuazione dei beneficiari nei termini sopra illustrati debba seguire o meno le vicende successorie dell’assicurato.
In particolare, la questione che è emersa è se l’espressione “eredi legittimi” e/o “eredi testamentari” debba essere intesa:
- in senso tecnico, ossia come riferita a coloro che, all’apertura della successione, abbiamo effettivamente acquistato la qualità di erede;
- in senso atecnico, ossia come riferita a coloro che, alla data dell’apertura della successione, rivestano la qualità astratta di chiamati all’eredità.
La questione è stata risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021.
La Corte ha chiarito che l’identificazione soggettiva dei beneficiari nella persona degli “eredi legittimi” e/o “eredi testamentari” deve avvenire con riferimento a coloro che, al momento della morte dell’assicurato, rivestano la qualità di eredi in forza dell’astratta delazione ereditaria.
E ciò, indipendentemente dall’eventuale rinuncia all’eredità.
La Suprema Corte ha chiarito che il termine “erede” ha l’esclusiva funzione di attribuire un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, che prescinde dalle vicende relative all’allocazione del patrimonio ereditario secondo le modalità e i termini propri delle vicende successorie.
La soluzione offerta dal Giudice di legittimità è, ad avviso di chi scrive, condivisibile sotto diversi profili.
Anzitutto presenta evidenti vantaggi pratici; infatti essa consente all’assicuratore di liquidare immediatamente la prestazione assicurativa senza dover attendere l’evoluzione e la cristallizzazione di dinamiche ereditarie che possono avere tempistiche lunghe e possono sfociare in vicende giudiziarie anche molte complesse.
La soluzione, poi, appare coerente anche sotto un profilo sistematico; infatti, ai sensi dell’art. 1921, comma 3, del Codice Civile, i terzi designati acquistano un diritto iure proprio nei confronti dell’assicuratore, ossia un diritto che non deriva da una vicenda successoria.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l’indennizzo deve essere ripartito fra coloro che al momento della morte del contraente rivestano la qualità astratta di eredi legittimi.
In particolare, è stato precisato che “nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli eredi legittimi come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione”[22].
4. La liquidazione della prestazione assicurativa
4.1. Un’ulteriore questione attiene alla ripartizione delle quote in sede di liquidazione della prestazione assicurativa nel caso di pluralità di beneficiari.
Va premesso che il contraente è libero di determinare, sia al momento della designazione dei beneficiari che successivamente, le percentuali di ripartizione della prestazione assicurativa in favore della pluralità dei beneficiari.
Ci si è, peraltro, interrogati sulla base di quali criteri liquidare la polizza quando il contraente non abbia indicato le percentuali di ripartizione tra i diversi beneficiari; anche in questo caso, le ipotesi più problematiche rilevate sono state quelle in cui i beneficiari erano individuati negli “eredi legittimi” e/o negli “eredi testamentari”.
La questione era, dunque, se la ripartizione della prestazione assicurativa dovesse avvenire o meno secondo l’ordine e i criteri tipici del diritto successorio.
Dottrina e giurisprudenza sono state per lungo tempo concordi nel ritenere che, in mancanza di una specifica indicazione da parte del contraente, il capitale assicurato doveva essere suddiviso tra i beneficiari/eredi in parti uguali senza tener conto delle eventuali quote loro spettanti iure successionis.
Questo orientamento valorizzava la natura autonoma e prettamente contrattuale del diritto di credito che i beneficiari vantavano nei confronti dell’assicuratore, e che pertanto imponeva che la liquidazione della prestazione assicurativa dovesse avvenire seguendo le regole tipiche della disciplina obbligatoria.
In questo senso, e dato che, ai sensi dell’art. 1314 del Codice Civile, nelle ipotesi di solidarietà attiva vige la presunzione di parità delle quote spettanti a ciascun creditore, si riteneva che la prestazione assicurativa in difetto di espressa indicazione del contraente andasse ripartita in misura uguale fra tutti gli aventi diritto.
Tale impostazione era stata, poi, messa in discussione da un orientamento della Corte di Cassazione; infatti, quest’ultima, nell’ottica di valorizzare il tenore letterale nonché il comune senso di interpretazione delle espressioni contenute nell’atto di designazione, aveva ritenuto che con la formula “eredi legittimi” il contraente, oltre a individuare per relationem i beneficiari della prestazione assicurativa nella persona degli eredi legittimi, avrebbe inteso stabilire anche che la misura della prestazione assicurativa ad essi spettanti avrebbe dovuto rispettare la quota proporzionale in cui ciascuno erede subentrava nella successione[23].
Tale contrasto è stato risolto dalla già menzionata sentenza a sezione unite della Corte di cassazione.
Infatti le Sezioni Unite hanno ribadito la natura inter vivos della fonte del credito derivante dalla prestazione assicurativa, con conseguente esclusione dell’applicazione delle regole della comunione ereditaria.
Esse hanno quindi concluso affermando il principio per cui “la designazione generica degli eredi come beneficiari del contratto, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza dell’eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo”.
4.2. La Corte di cassazione, con la medesima sentenza a sezioni unite, ha poi chiarito che, in caso di premorienza del beneficiario designato rispetto all’assicurato, trova applicazione la fattispecie cui all’art. 1412, comma 2, del Codice Civile, per cui “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”[24].
Secondo la Corte di cassazione, nel caso in cui il beneficiario premuoia all’assicurato, si verifica un meccanismo di “rappresentazione” atecnica per cui gli eredi del beneficiario premorto acquistano iure hereditatis il diritto all’indennizzo e in proporzione delle rispettive quote ereditarie trattandosi di una successione nel diritto di fonte contrattuale già entrato a far parte del patrimonio del beneficiario prima della sua morte[25].
In realtà, il passaggio della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l’operatività del meccanismo di trasmissione del diritto contrattuale in favore degli eredi del terzo designato, è uno dei più controversi della sentenza, ed è stato oggetto di critiche e dubbi interpretativi.
In questo senso, infatti, è stato rilevato come nei contratti sull’assicurazione sulla vita a favore del terzo il meccanismo previsto dell’art. 1412, comma 2, del Codice Civile sia applicabile solamente nel caso di designazione nominale del beneficiario mentre risulterebbe incompatibile nel caso in cui, ad esempio, vengano indicati beneficiari “gli eredi legittimi” o gli “eredi testamentari”.
Va qui evidenziato che la soluzione offerta dalle Sezioni Unite, di cui si è detto, in particolare per quanto riguarda l’istituto della rappresentazione, è stato oggetto di critica da parte della giurisprudenza di merito, che è giunta, in alcuni casi, a soluzioni differenti[26].
In quest’ultimo caso, seguendo l’orientamento critico della sentenza delle Sezioni Unite, la premorienza di uno degli eredi del contraente comporterebbe l’accrescimento della quota da liquidare in favore dei restanti eredi beneficiari, e non il subentro, per rappresentazione, degli eredi del beneficiario premorto.
5. La prescrizione
Infine, un’ulteriore questione – di rilevante importanza pratica – è quella relativa al termine di prescrizione.
L’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, nella sua vigente formulazione, prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (vale a dire, la morte dell’assicurato).
Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza del 7-29 febbraio 2024, n. 32, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, del Codice Civile nel testo successivo a quello introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n.134 del 2008, come convertito, e antecedente a quello sostituito con l’art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale[27].
6. Conclusioni
Dall’analisi svolta emerge come il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo costituisca uno strumento di particolare rilievo non solo sul piano economico-previdenziale, ma anche su quello giuridico-patrimoniale. La sua natura di contratto a favore di terzo, con le specificità introdotte dagli articoli 1920 e seguenti del Codice Civile, consente infatti di realizzare attribuzioni patrimoniali post mortem al di fuori delle regole successorie tradizionali, pur con i limiti imposti dall’art. 1923, comma 2, del Codice Civile.
La designazione del beneficiario assume un ruolo centrale, sia nella sua fase costitutiva che nella possibilità di revoca, e rappresenta l’elemento qualificante dell’intero meccanismo. Le difficoltà interpretative legate alle designazioni generiche o per relationem hanno trovato soluzione, almeno in parte, grazie all’intervento della giurisprudenza – e in particolare delle Sezioni Unite del 2021 – che hanno chiarito i criteri di individuazione dei beneficiari e le modalità di ripartizione dell’indennizzo.
Rimane comunque evidente la tensione tra la funzione previdenziale e quella successoria che l’istituto inevitabilmente richiama. Proprio tale ambivalenza spiega l’importanza pratica e teorica dei contratti in esame, che si pongono come strumenti di pianificazione patrimoniale sempre più diffusi, in grado di offrire soluzioni flessibili ma al contempo bisognose di un attento inquadramento sistematico.
[1] Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto: a) sinallagmatico: infatti, dietro il pagamento di un corrispettivo, l’assicuratore assume su di sé la copertura di uno o più rischi espressamente previsti; b) aleatorio: infatti non è dato prevedere se e quando l’assicuratore sarà tenuto a eseguire la prestazione assicurativa; c) di durata: infatti tra il momento in cui il contratto viene concluso e quello in cui l’assicuratore dovrà eseguire la prestazione intercorre uno spazio temporale; in tale spazio temporale l’assicuratore è tenuto a mantenere la propria struttura organizzativa per garantire l’esecuzione della prestazione assicurativa al verificarsi dell’evento assicurato.
[2] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, “1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana; II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; V. le operazioni di capitalizzazione; VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa”.
[3] Infatti la prestazione assicurativa diventerà esigibile soltanto alla morte dell’assicurato; il che comporta che essa non potrà che essere eseguita a vantaggio di un soggetto diverso dal contraente.
[4] Cass., 21 dicembre 2016, n. 26606: “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c. c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità”. Nello stesso senso anche la giurisprudenza successiva e, in particolare, Cass., s.u., 30 aprile 2021, n. 11421, su cui ci soffermeremo infra. Per la giurisprudenza di merito si veda, tra le tante, App. Firenze, 19 settembre 2023, in www.dejure.it, per cui “l’assicurazione sulla vita ex art. 1920 c.c., si configura come un negozio inter vivos con effetti post mortem, nel senso che la morte dell’assicurato segna il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento di un diritto di credito già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata totalmente estranea dal patrimonio del de cuius che cade in successione, poiché già assegnata in virtù del contratto inter vivos. Il diritto di credito ad ottenere l’indennizzo è dunque acquisito in capo al beneficiario come un diritto proprio, in forza dello stesso contratto di assicurazione sulla vita, mentre l’evento ‘morte’ dell’assicurato/contraente segna soltanto il momento dell’adempimento dell’obbligo dell’assicuratore”.
[5] N. Gasperoni, voce Assicurazione: assicurazione sulla vita a favore di terzi, in Enc. giur., Roma, 1998, III, pagg. 1 e ss.
[6] In questo senso, ad esempio, il legittimario leso può contestare la liberalità fatta dall’assicurato a vantaggio del terzo beneficiario e agire nei suoi confronti con azione di riduzione. Cfr. anche Cass., sez. II, 22 ottobre 2021, n. 29583: “l’obbligo di collazione previsto dall’art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l’altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l’ipotesi dell’assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, ‘sub specie’ di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del ‘de cuius’), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi – che costituiscono, in linea di principio, l’oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. – l’obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l’ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l’onere della relativa prova”.
[7] Come la dottrina ha avuto modo di evidenziare, non sempre il contratto di assicurazione a favore del terzo si configura come tale. Infatti, potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui venga revocata la designazione del terzo beneficiario senza che si proceda poi a nuova designazione. In casi come questo, il diritto di credito alla prestazione assicurativa, una volta divenuto esigibile alla morte dell’assicurato, entrerà a far parte dell’asse ereditario del contraente e verrà devoluto secondo le ordinarie regole del diritto di successione. I. Riva, Assicurazione sulla vita per il caso morte ‘a vita intera’ e individuazione del beneficiario, in Contratto e impresa 1/2024.
[8] Cass., sez. un., 30 aprile 2021, n. 11421 per cui, “quando uno dei beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo”.
[9] Secondo la dottrina prevalente, tuttavia, la designazione del beneficiario, sebbene costituisca un elemento strutturale del contratto di assicurazione sulla vita in favore del terzo, non è altresì un elemento essenziale di tale contratto. Anche la giurisprudenza ha affermato che la designazione del beneficiario “costituisce elemento normale ma non essenziale”, con la conseguenza che, “in caso di mancata designazione del terzo o di stipulazione del contraente a proprio favore, non si riconnette l’effetto tipico della stipulazione a favore del terzo del diritto all’indennità, ma alla morte dello stipulante (e solo in questo caso) la somma assicurata verrà conseguita iure successionis, in quanto bene entrante nel suo patrimonio” (Trib. Brescia, 20 dicembre 2018, n. 3461, in www.bdp.giustizia.it).
[10] Cfr., peraltro, Trib. Vercelli, 13 gennaio 2023, n. 21, in www.bdp.giustizia.it: “la polizza sulla vita, come qualunque altro contratto di assicurazione, può essere oggetto di mandato e procura per cui (…) non vi è ragione che osti alla possibilità che la designazione del terzo beneficiario, che potrebbe avvenire direttamente nel contratto o con successivo atto scritto, rivesta le stesse formalità e possa essere parimenti oggetto di una procura, in questo caso generale, che copra, come tale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta esclusione per le donazioni, ma solo quelle ‘dirette’. Non avrebbe, quindi, “senso parlare di atto personalissimo (come se fosse un atto del testatore) perché, in realtà, ci si muove nell’ambito, diverso, della designazione del beneficiario di polizza sulla vita”. In particolare, “la designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell’assicurazione sulla vita, infatti, l’art. 1920 c.c., per la designazione, e l’art. 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento”.
[11] In proposito la giurisprudenza ha osservato che “la conoscenza dell’atto, da parte dell’assicuratore, rileverebbe al solo fine di consentirgli di individuare il soggetto a favore del quale deve pagare il capitale o la rendita, di modo che, dunque, tra più designazioni successive, a prevalere dovrebbe ritenersi quella cronologicamente posteriore” (App. Genova, 6 giugno 2024, n. 796, in www.bdp.giustizia.it).
[12] L’eventuale volontà del beneficiario di voler profittare del beneficio rileva semmai ai fini della facoltà di revoca ex art. 1921 del Codice Civile.
[13] Cass., 6 marzo 2025, n. 5985, in www.dejure.it, secondo cui “la clausola di designazione, quale atto inter vivos, presuppone l’esistenza in vita sia del disponente che del beneficiario, dovendosi conseguentemente escludere che, in tal caso, l’indennizzo vada ripartito ‘per stirpi’ facenti capo ai soggetti premorti’”.
[14] Sul punto la giurisprudenza ha precisato che la “conseguenza dell’esercitato diritto di riscatto della polizza è la caducazione della designazione del beneficiario”; infatti, “qualsiasi atto che porti alla risoluzione del rapporto assicurativo ha gli effetti della revoca. Ciò perché l’attribuzione del beneficio è di regola revocabile, anche se il beneficiario acquista, attraverso la designazione, un vero diritto autonomo alla somma assicurata. Si dice in proposito che questo diritto è essenzialmente subordinato alla condizione risolutiva della revoca e che l’accettazione del beneficiario, a differenza di quanto previsto dall’articolo 1411 c.c. per i contratti a favore di terzo, non è di ostacolo alla revoca dell’attribuzione del beneficio” (Trib. Cosenza, 14 marzo 2022, in www.bdp.giustizia.it).
[15] Al riguardo la giurisprudenza ha considerato revoca implicita del beneficiario “l’espresso riferimento”, in sede testamentaria, “al denaro contante e a titoli di qualsiasi tipo”, in quanto tale espressione “non può non comprendere anche il capitale assicurato” (Trib. Bologna, 1° aprile 2024, in www.bdp.giustizia.it); tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza, il “testamento può costituire un valido strumento di revoca solo se risulti implicitamente incompatibile con la precedente designazione contrattuale del beneficiario” (Trib. Catania, 21 settembre 2022, n. 3866, in www.bdp.giustizia.it).
[16] Cass., sez. I, 3 gennaio 2023, n. 39, secondo cui “l’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
[17] Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958, pagg. 659 e ss.; Scalfi, Manuale delle assicurazioni private, Milano, 1994, pag. 230; Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956, pag. 605.
[18] Steidl, L’assicurazione sulla vita, in DPA, 1961, pag. 177.
[19] Buttaro, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958, pag. 659.
[20] Fanelli, Assicurazioni sulla vita, in NN.D.I., I, 2, Torino, 1968.
[21] I. Riva, Assicurazione sulla vita per il caso morte “a vita intera” e individuazione del beneficiario, voce Contratto e impresa 1/2024.
[22] Cass., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24951.
[23] Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210, in www.dejure.it, secondo cui, “quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto per il caso di morte dello stipulante che l’indennizzo debba corrispondersi agli eredi – tanto con formula generica, quanto a maggior ragione con formulazione evocativa degli eredi testamentari o in mancanza degli eredi legittimi -, tale clausola dev’essere intesa sia nel senso che le parti abbiano voluto tramite dette espressioni individuare per relationem con riferimento al modo della successione effettivamente verificatosi negli eredi chi acquista i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore, sia nel senso di correlare l’attribuzione dell’indennizzo a più soggetti così individuati come eredi in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto secondo la modalità di successione effettivamente verificatasi, dovendo invece escludere, per la mancata precisazione della clausola contrattuale di uno specifico criterio di ripartizione che a quelle modalità di individuazione delle quote faccia riferimento, che le quote debbano essere dall’assicuratore liquidate in misura equale”.
[24] La giurisprudenza di merito ha recentemente ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite, affermando quanto segue:
a) “il beneficiario acquista il diritto soggettivo al pagamento della indennità già per effetto della designazione, secondo il chiaro disposto dell’art. 1921, comma 3, c.c. (…) il beneficio matura post mortem, ma appartiene al beneficiario già prima dell’evento, a meno che non venga revocato”;
b) “la morte del contraente non costituisce causa dell’acquisto del diritto in capo al designato, ma rappresenta l’evento che vi attribuisce efficacia, allontanando così il contratto di assicurazione sulla vita dai patti successori”;
c) “il diritto sorge in capo al terzo beneficiario già in virtù della designazione (art. 1920, comma 3, c.c.). Pertanto, esso cade nella successione ereditaria del beneficiario. In base alla disciplina del contratto di assicurazione, il contraente potrebbe revocare la designazione, salvo rinuncia per iscritto al potere di revoca e a meno che il contraente abbia dichiarato di voler profittare del beneficio (art. 1921 c.c.)”:
d) tale “soluzione discende anche dall’applicazione della disciplina del contratto a favore di terzo, cui l’assicurazione sulla vita a favore del terzo è riconducibile, e in particolare dell’art. 1412, comma 2, c.c., relativo all’ipotesi in cui la prestazione va eseguita da parte del promittente dopo la morte dello stipulante”;
e) “l’applicazione dell’art. 1412, comma 2, c.c. all’assicurazione sulla vita è suffragata, a livello storico, anche dalla Relazione al codice del 1942, nella quale si legge al par. 645: “Figura particolare di contratto a favore di terzi e quella in cui la prestazione deve eseguirsi posteriormente alla morte dello stipulante. Essa ha precipuo riguardo ai contratti di assicurazione sulla vita a beneficio di terzi […]. Se il terzo premuore allo stipulante, appare meglio rispondente alla presumibile volontà di questo ritenere che egli abbia voluto estendere il beneficio agli eredi del terzo; se non avesse voluto tale effetto avrebbe manifestato una diversa volontà revocando il beneficio o limitandone l’attribuzione alla persona del terzo medesimo (art. 1412, secondo comma)” (Tribunale di Milano, con sentenza n. 89 del 7 gennaio 2025, in bdp.giustizia.it). Cfr. anche Cass., sez. III, 27 aprile 2023, n. 11101: “allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuoia al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. (Nella specie, in un caso in cui erano pervenuti alla successione legittima della stipulante, insieme alla sorella di costei, gli eredi dell’altro fratello premorto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ripartito l’indennizzo assicurativo in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, anziché riconoscere a coloro che erano succeduti all’originario beneficiario premorto la sola quota di metà che a quest’ultimo sarebbe spettata)”.
[25] Cass., Sezioni Unite n. 11421 del 30 aprile 2021, in www.dejure.it., secondo cui “la premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per ‘rappresentazione’ in forza dell’art. 1412 c.c., comma 2”. Cfr. anche Cass., sez. III, 21 agosto 2023, n. 24951: “l’indicazione generica degli ‘eredi legittimi’ come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’inclusione anche degli eredi per rappresentazione tra i beneficiari Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius”.
[26] Al riguardo, la sentenza n. 646 del 14 aprile 2023 del Tribunale di Treviso (in www.bdp.giustizia.it) ha criticato la tesi delle Sezioni Unite sulla base delle seguenti argomentazioni:
a) “il richiamo all’istituto della ‘rappresentazione’ non può essere condiviso, innanzitutto, perché si applicano meccanismi propri degli atti mortis causa ad un negozio giuridico che ha natura inter vivos con effetti post mortem”;
b) “l’utilizzo dell’istituto della ‘rappresentazione’ appare, altresì, improprio non essendo quest’ultimo applicabile in via generale a tutti gli eredi del de cuius ma unicamente ad alcuni soggetti particolari. L’art. 468, primo comma, cod. civ., infatti, prevede che ‘la rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto’”;
c) “il richiamo all’istituto della rappresentazione non pare persuasivo in quanto considerata l’adesione alla tesi che dà rilievo al momento della morte dello stipulante ai fini dell’individuazione dei beneficiari non può configurarsi alcuna astratta delazione prima del verificarsi di tale evento; fino al decesso del de cuius non sussiste alcun diritto all’indennizzo”;
d) inoltre, prosegue il Tribunale, fino all’evento morte non possono neppure “essere individuati gli eredi”, e ciò in base allo stesso orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui la generica designazione dei beneficiari negli “eredi”, “eredi legittimi” o “eredi legittimi o testamentari” comporta “l’individuazione degli stessi in coloro che, al momento della morte, rivestirebbero astrattamente tale qualifica”;
e) “qualora il contratto di assicurazione sulla vita individui quali beneficiari in via generica “gli eredi legittimi o testamentari”, “gli eredi legittimi” o solo “gli eredi”, non è possibile individuare ab origine chi astrattamente ricoprirà tale qualifica al momento della morte dello stipulante. Non è, pertanto, configurabile la sussistenza del diritto ad ottenere l’indennizzo in capo a coloro che sarebbero “eredi” al momento della stipulazione del contratto stesso ma unicamente di un’aspettativa di diritto”;
f) “la sopravvivenza del beneficiario sarà unicamente la condizione necessaria affinché la designazione compiuta possa avere effetto. Non si può, dunque, ritenere operante, nel caso di specie, l’istituto della ‘rappresentazione’ di cui all’artt. 467 cod. civ. ss. e dell’art. 1412, secondo comma, cod. civ. non potendo verificarsi successione nel diritto all’indennizzo del premorto non essendo possibile, in presenza di una designazione generica e fino alla morte dello stipulante, individuare quali siano i beneficiari”.
[27] La Cassazione ha precisato che “la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall’art. 3, comma 2-ter, D.L. n. 134 del 2008 di cui alla sentenza della Corte cost. n. 31 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale” (Cass., sez. III, 11 luglio 2024, n. 19148, in www.dejure.it).