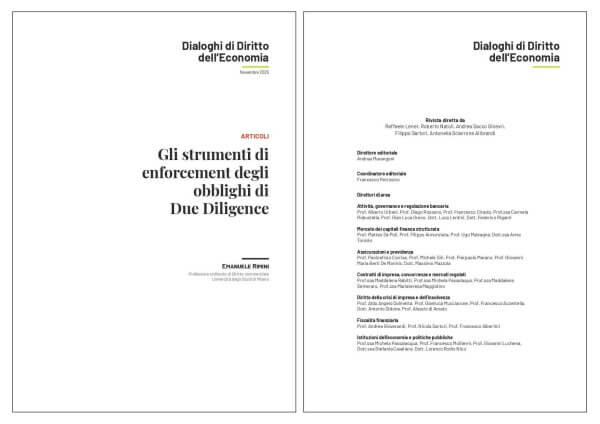[*] SOMMARIO: Il contributo propone una riflessione critica sull’evoluzione delle politiche e delle strategie normative in materia di sostenibilità d’impresa nell’ambito dell’Unione europea, in un contesto segnato non solo da profonde discontinuità economiche tra Paesi (che si riflettono anche sul versante tecnologico), ma anche da radicali diversità geopolitiche. Muovendo da recenti interventi regolatori (in particolare la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, c.d. CSDDD e il c.d. Omnibus Package), l’analisi evidenzia il progressivo ed evidente superamento di una visione settoriale della governance societaria, a favore di un approccio integrato che considera i profili ambientali, sociali e digitali come elementi tra loro interconnessi. Emergono quindi tanto le potenzialità quanto al contempo i limiti del modello europeo, che rendono evidente la necessità di un ripensamento degli assetti istituzionali e di una maggiore coerenza tra obiettivi di sostenibilità, innovazione e competitività globale.
ABSTRACT: This study provides a critical reflection on the evolution of corporate sustainability policies and regulatory strategies within the European Union. The context is characterized by significant economic disparities among member states, which are manifested in technological gaps and profound geopolitical differences. Recent regulatory initiatives, including the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) and the Omnibus Package, have catalyzed a gradual shift towards an integrated approach to corporate governance, wherein environmental, social, and digital factors are acknowledged as interconnected elements. This analysis highlights the strengths and weaknesses of the European model, emphasizing the urgent need to reassess institutional frameworks to ensure greater alignment between sustainability, innovation, and global competitiveness objectives.
1. L’evoluzione della governance sostenibile nell’Unione europea
L’8 marzo 2018 la Commissione europea ha pubblicato l’Action Plan Financing Sustainable Growth[1]: un elaborato dell’High Level Expert Group on Sustainable Finance. All’interno del documento assume particolare rilevanza – ai fini che qui interessano – la c.d. “Action 10”, rubricata “Fostering sustainable corporate governance and attenuating short-termism in capital markets”[2], finalizzata a promuovere un modello di governance societaria orientata nel lungo periodo e volta alla realizzazione di una economia più sostenibile in grado di consentire alle imprese di adottare tutte le strategie necessarie per i) develop new technologies, ii) strengthen business models e iii) improve performance. Tuttavia, come si legge all’interno del paragrafo 4.2. del Piano di azione, sebbene varie società abbiano già da tempo conformato le proprie strategie di governance a tali obiettivi, resta ferma la consapevolezza del fatto che le “short-term market pressures” possano rendere difficoltoso l’allungamento dell’orizzonte temporale nelle decisioni imprenditoriali.
L’impatto di tali statuizioni, così come di quelle poi racchiuse nella Direttiva UE 2024/1760 (d’ora innanzi, CSDDD)[3], è – d’altra parte – trasversale, in quanto riguarda tanto le imprese che hanno sede legale e direzione generale in un Paese dell’Unione europea, quanto quelle che, pur non avendole, possiedono un fatturato rilevante in Europa.
Si tratta, in tutti i casi, di un percorso, decisamente travagliato, che è stato ed è – forse ancor più – al centro di un ampio e contrastato dibattito dal momento che l’imposizione di prescrizioni stringenti in materia ESG è stata considerata da alcuni attenti osservatori una forma di vero e proprio “imperialismo economico”[4] e, al contempo, un freno alla competitività delle imprese comunitarie a livello globale. Un dibattito che si è decisamente rivitalizzato anche dopo la approvazione della final version della CSDDD, a seguito delle nuove elezioni comunitarie e soprattutto a causa delle purtroppo sempre maggiormente estese instabilità geopolitiche su scala ormai planetaria.
Il contenuto della Direttiva – che alla base, proprio in considerazione della poc’anzi richiamata Action 10, aveva l’obiettivo del “Fostering sustainable corporate governance and attenuating short-termism in capital market” da meglio perseguire attraverso la possibilità di pretendere dai vertici delle organizzazioni imprenditoriali presi in considerazione dall’atto normativo unionale la esternazione delle scelte adottate e dei presidi conseguentemente predisposti in materia di sostenibilità (latamente intesa) mediante la elaborazione di una “due diligence”[5] – avrebbe dovuto abbracciare l’intera “supply chains” e pervenire ad una misurazione dei target di sostenibilità. Effettuate queste preliminari considerazioni, i pilastri fondanti della CSDDD possono essere così agevolmente descritti: i) un processo di due diligence risk-based; ii) l’adozione di un piano di transizione climatica; iii) l’introduzione di meccanismi specifici di enforcement; iv) l’implementazione di misure di accompagnamento e sostegno da parte della Commissione.
La Direttiva è entrata formalmente in vigore il 25 luglio 2024 e ha rappresentato – non sembra proprio una casualità – uno degli ultimi atti approvati nella fase terminale della penultima legislatura europea, a seguito di un compromesso raggiunto politicamente in extremis, ed era stato previsto che dovesse entrare in vigore negli Stati membri attraverso leggi interne di attuazione entro il 26 luglio 2026. Nonostante ciò – come è risaputo – dopo l’insediamento della nuova Commissione europea, pur sempre presieduta da Ursula von der Leyen (e in seguito all’aggravarsi su scala mondiale delle frizioni geopolitiche a cui si è già fatto cenno) il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è stato successivamente prorogato al 26 luglio 2027, per effetto del provvedimento noto con l’appellativo di “Omnibus Package, fase 1- Stop the clock”, volto a concedere più tempo ai Paesi membri e ai soggetti destinatari della Direttiva per adeguarsi a fonti normative (che in realtà non riguardano soltanto la CSDDD, ma anche la precedente, e per di più un aspetto, problematicamente sovrapponibile, Direttiva UE 2014/95, denominata Corporate Sustainability Reporting Directive, d’ora innanzi, CSR, oltre che la c.d. Taxonomy Regulation) probabilmente dalle maglie ottimisticamente troppo strette.
La prima fase di applicazione della CSDDD è per il momento attesa a partire dal 26 luglio 2028, secondo un approccio graduale e differenziato in funzione del duplice parametro delle dimensioni e della tipologia delle imprese coinvolte. Questa impostazione risulta assolutamente in linea con la struttura finalmente approvata della Direttiva, posto che le misure da essa contemplate avrebbero dovuto applicarsi con una diversa scalettatura temporale non solo alle società con decrescenti soglie legate sia al numero dei dipendenti, sia al fatturato netto, aventi sede legale e direzione generale in un Paese membro dell’Unione europea, ma anche alle società che, pur non avendole, realizzano un net turn over rilevante all’interno del vecchio continente.
Ad ogni modo la Commissione Europea, rebus sic stantibus, risulta ancora tenuta a presentare entro la data del 30 luglio 2030 una relazione al Parlamento Europeo – che potrebbe accompagnarsi ad una proposta legislativa – per valutare l’attuazione e soprattutto gli effetti della CSDDD su vari versanti, tra i quali: i) l’impatto sulle PMI; ii) la ampiezza del perimetro soggettivo della Direttiva – e quindi la cerchia delle imprese da essa vincolate – nonché una eventuale revisione delle soglie; iii) la individuazione dei settori ad alto rischio ed infine iv) la ipotetica ridefinizione del concetto di “chain of activities”[6].
2. L’ampliamento della responsabilità di impresa nella CSDDD: diritti umani, ambiente e catena del valore
Lo scopo prefissato a livello unionale è decisamente chiaro: stimolare una reazione da parte delle imprese che operano sul mercato europeo rispetto agli impatti negativi sui versanti dei diritti umani e dell’ambiente, in quanto gli adverse impacts sul fronte dei diritti umani possono indirettamente coinvolgere la dimensione ambientale.
La CSDDD ha adottato, in proposito, un approccio estensivo con riguardo alla responsabilità di impresa, avendo riguardo non soltanto alla organizzazione di gruppo che può caratterizzare il business model (e quindi coinvolge direttamente pure le cc.dd. subsidiaries, che potrebbero di frequente trovarsi anche molto lontane geopoliticamente tra loro), ma anche la schiera dei business partners, originariamente posizionati – sia up-stream, che down-stream – lungo la chain of activities. Va anticipato sin d’ora che con l’entrata in vigore della fase 2 dell’Omnibus Package, ci si riferirà ai soli “direct suppliers”, ovvero ai fornitori diretti situati a monte della catena di attività[7], con la finalità di assicurare, da intendersi come una “obbligazione di mezzi”[8]: i) il c.d. stakeholder engagement, senza trascurare – in tal senso è self explicative l’art. 3(1) (n) della CSDDD – le civil society organizations; ii) un sistema di notifiche per recepire le segnalazioni di coloro che hanno informazioni o preoccupazioni in merito a actual or potential adverse impacts; iii) il rispetto di modalità specifiche di reporting[9]; iv) la elaborazione e l’attuazione di un transition plan to address climate change. Conviene sottolineare che quest’ultima previsione che dava luogo – lo si ribadirà nel prosieguo – all’imposizione di un obbligo specifico a carico dei vertici gestionali delle società coinvolte[10], con l’entrata in vigore dell’Omnibus Package, verrà sensibilmente ridimensionata.
3. Le sfide operative legate all’attuazione della CSDDD
Nascono quindi le evidenti criticità, a cui si è in parte già fatto cenno, sia in termini di duplicazioni e complessità degli adempimenti da eseguire e rispettare, sia dal punto di vista della lievitazione dei costi gestionali. Oneri oltre modo consistenti, che rilevano su diversi piani: e più precisamente, su quelli: i) degli impatti ESG; ii) della disclosure sui temi dei labour rights; iii) dello stakeholder engagement; iv) della due diligence sulle catene di valore; nonché, v) della corporate governance e della corporate strategy, le quali coinvolgono evidentemente: a) il reporting sui controlli di sostenibilità (e potrebbero fare emergere l’opportunità di nominare un dirigente a ciò preposto); b) l’accountability, e cioè la consapevolezza, e quindi non solo la trasparenza, a proposito del dovere di agire informati a livello consiliare alla stregua di quanto impone all’interno del nostro ordinamento l’art. 2381, ultimo comma, c.c.; e da ultimo c) la responsabilità da allocare all’interno dell’assetto organizzativo prescelto sulla business conduct globale.
In questo modo la Direttiva impone alle imprese comunitarie – e non – dalla medesima interessate, di identificare[11] i rischi generati e i rischi subiti, soppesando vuoi l’impatto dell’azione imprenditoriale sui fattori di ESG, vuoi il modo con cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento della attività imprenditoriale, descrivendo il quadro con modalità comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e soprattutto senza opacità o addirittura manipolazioni (da autentico greenwashing)[12], specificando, ancor più in particolare, i rischi riguardanti i diritti umani e l’ambiente che si riscontrano nelle business operations estensivamente intese. Il tutto con la ulteriore finalità di convogliare questo processo, decisamente articolato – e, come si è posto in risalto, non di mera mappatura dei rischi (posto che sono stati richiesti comportamenti proattivi che sfociano in doveri di condotta specifici a carico dei gestori delle imprese) – all’interno delle policy interne (e dunque intervenendo non soltanto sugli assetti organizzativi, ma pure su quelli amministrativi) e quindi sui c.d. management systems.
Le procedure amministrative interne dedicate alla due diligence in tema di corporate sustainability dovrebbero comunque: i) descrivere l’approccio della impresa (e più frequentemente di un gruppo di esse) nei confronti della due diligence stessa, seguendo criteri prudenziali, volti a tener adeguatamente conto dei seguenti fattori di rischio: a) quello delle business operations; b) quello del contesto, non solo logistico, in cui si agisce; c) quello del level of law enforcement al manifestarsi dei possibili adverse effects; d) quello legato alla natura e tipologia dei prodotti e dei servizi offerti e, più in generale, del settore in cui si opera; e) ed infine quello del c.d. “scoping exercise”, se il business partner non è direttamente sottoposto alla CSDDD[13]; ii) elaborare un codice di condotta che descriva le regole e i criteri da seguire tra la impresa, le sue subsidiaries e i suoi business partners e la descrizione del procedimento messo in opera per inserire la due diligence nelle policy aziendali ritenute rilevanti; iii) individuare i presidi adottati per verificare il rispetto – ossia, la compliance – del codice di condotta adottato e da estendere ai business partners[14] e contemplare un set di remediation remedies.
Nell’agire in questo modo, i centri decisionali apicali dell’organizzazione aziendale dovrebbero preservare – proteggendoli – i “trade secrets”, soprattutto nel momento in cui decidano di interfacciarsi con i business partners[15]e dovrebbero, al contempo, prestare attenzione alle antitrust implications[16].
4. Il difficile rapporto tra l’utilizzo di approcci coercitivi e premiali
Tanto doverosamente premesso, siccome sono evidenti le intersezioni tra, da un lato, un sempre più dettagliato insieme di disposizioni normative che accrescono – talora, come si è già rimarcato, con significativi aspetti anche di caoticità – il livello di compliance e, dall’altro lato, le previsioni e/o gli scenari (a maggior ragione, se riguardano le previsioni in materia di monitoraggio e di reazione in caso di loro violazione) che riprendono più in generale il tema dell’enforcement[17], occorre prendere atto di un altrettanto significativo cambio di rotta rispetto al passato.
Pure dando uno sguardo oltre confine, l’attenzione verso le modalità di misurazione degli indicatori ESG con il passar del tempo si è intensificata in maniera sempre più rilevante e tale tendenza ha progressivamente ristretto gli ambiti, originariamente più estesi, delle c.d. soft laws[18], specialmente se si discute dei doveri di disclosure e di successivo reporting in materia di diritti umani e di tutela ambientale.
Tuttavia, se da questi piani, per così dire di regolamentazione “preventiva”, ci si sposta sul piano “repressivo” – ovvero ci si sofferma sul distinto versante dell’enforcement – e segnatamente, su quello del public enforcement, si può affermare che le disposizioni normative in materia hanno mantenuto (per lo meno fino all’approvazione della CSDDD) una natura non particolarmente coercitiva[19]. Basti rammentare che tanto nei riguardi delle più recenti regole in materia di revisione legale dei conti e di attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità[20], quanto nei riguardi delle previsioni riconducibili alla Direttiva UE 2017/828 (la cd. Direttiva Shareholders Rights II), aventi ad oggetto l’engagement degli azionisti istituzionali e le politiche di remunerazione degli amministratori che potrebbero concernere la rilevanza degli interessi degli stakeholders (ed eventualmente pure di quei portatori di interessi che non intrattengono relazioni di carattere mercantile con le società e/o il gruppo di imprese di riferimento), i profili correlati agli obblighi di ESG fanno perno sul principio di “comply or explain”[21]. Quell’ormai diffuso principio, ab origine intimamente connesso alle fonti di autodisciplina, che fa leva sul presupposto che i comportamenti “ESG friendly” possono venire adottati dalle imprese – non per coazione – bensì perché ritenuti virtuosi, e quindi in grado di giocare favorevolmente nell’ottica della competitività del mercato. Ne è disceso che in questo scenario le regole di carattere marcatamente sanzionatorio non si sono riferite al mancato perseguimento degli obiettivi di sostenibilità tout court, ma piuttosto hanno colpito la opacità – se non la falsità[22] – delle ragioni addotte per cercare di raggiungerli – evidentemente – senza successo.
La riluttanza verso l’introduzione di forme di public enforcement più rigorose e soprattutto armonizzate (dovendosi, al riguardo, ribadire che i rischi derivati dagli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente presenti nelle catene del valore hanno effetti transfrontalieri che si estendono all’interno di altri Stati membri della Unione europea e sempre più con il diretto coinvolgimento di Paesi terzi) è stata spiegata con diversità di accenti.
Infatti, non si tratterebbe soltanto dei differenti criteri culturali o dei divergenti interessi economici riconducibili ai distinti nazionalismi, in quanto, nei settori ESG[23], più che in altri campi, si è preferito ricorrere alle previsioni di forme dirette o indirette di incentivi, piuttosto che elaborare reticolati normativi stringenti di coercizione sanzionatoria[24]. In proposito, è stato osservato che un approccio premiale potrebbe essere più efficiente del “tallone di ferro della sanzione”, soprattutto se la forma di inducement immaginata possiede una matrice squisitamente economica o, meglio ancora, remunerativa[25].
D’altro canto, giova far presente che se da recenti verifiche risulta che nel nostro ordinamento non è stato portato a termine alcun procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi ESG da parte della Consob[26], per converso si registra un incremento delle considerazioni in materia di sostenibilità, latamente intesa, nel contesto delle strategie di governance e dei modelli di business degli emittenti italiani – e non – quotati nel principale mercato regolamentato nazionale (e segnatamente nella “pianificazione aziendale”, nei “piani industriali”, nella “disclosure informativa” e nelle politiche di remunerazione degli amministratori delegati)[27].
5. La necessità di considerare le PMI in un’ottica di differenziazione rispetto alle imprese di grandi dimensioni
Andando oltre quanto si è già osservato risulta che forse sono ancora altre le riflessioni da effettuare.
Il peso regolatorio che grava sulle imprese dell’Unione europea, complessivamente considerate, è molto rilevante e soprattutto diverge da Stato membro a Stato membro[28]. E proprio in quest’ottica merita di essere rammentato un monito espresso da Mario Draghi, nel rapporto dal rinomato titolo “The future of European Competitiveness”, laddove si è affermato che a causa degli effetti, soprattutto a cascata (i c.d. trickle-down effects), delle catene del valore, tanto il report sulla sostenibilità, quanto la Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence non differiscono adeguatamente le PMI dalle imprese di più grandi dimensioni”, con la conseguenza che sin da un prossimo futuro dovrebbe essere meglio soppesata la caratura delle società quale parametro per stabilire gli oneri di compliance, utilizzando appropriate misure di mitigazione in linea con il noto principio di proporzionalità[29].
Un suggerimento, presto raccolto dalla Presidente della Unione europea, Ursula von der Leyen, la quale nell’estate del 2024 ha invitato i Commissari a ridurre le “reporting obligations del 25%”: una percentuale che dovrebbe salire al 35% nel caso delle PMI, con l’idea di introdurre “a new cathegory of small Mid-caps” e di verificare se la “existing regulation” impedisce ingiustificatamente il loro sviluppo[30].
In buona sostanza, sembra evidente che l’approvazione della CSDDD non abbia affatto posto termine all’acceso dibattito sulla opportunità di un simile approccio, soprattutto se calato all’interno dell’ambizioso progetto di migliorare la competitività dell’Unione europea nel panorama mondiale.
6. L’approccio della CSDDD in materia di vigilanza, sanzioni e tutele
Con specifico riferimento alla tematica del public enforcement, la CSDDD, soprattutto nella sua impronta primigenia[31], ha senz’altro contribuito a marcare un significativo cambio di passo. La Direttiva nella versione definitivamente approvata ha introdotto, infatti, un nuovo modello di riferimento, che si discosta significativamente dall’impostazione pregressa.
Da un lato, ogni Stato membro dovrà designare un’Autorità di vigilanza con il compito di monitorare la compliance degli obblighi riguardanti la due diligence di sostenibilità ed in aggiunta era stato contemplato l’espresso dovere non soltanto di predisporre, ma anche – si noti bene[32] – di adottare (in lingua inglese “to put into effect”) un transition plan e di aggiornarlo periodicamente.
Dall’altro lato, la medesima Autorità di vigilanza dovrà avere sia il potere di imporre alle società monitorate di fornire informazioni; sia il potere di svolgere autonomamente indagini ogniqualvolta che si manifesti una possibile violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva.
Inoltre, le predette indagini – ai sensi e per gli effetti dell’art. 25(2) della CSDDD – potranno essere avviate dall’Autorità di Vigilanza o di propria iniziativa; o “a seguito di una segnalazione circostanziata trasmessa secondo le modalità presenti nel successivo art. 26 della Direttiva, rubricato emblematicamente “Segnalazioni circostanziate” [33]. Quella disposizione che sancisce che gli Stati membri dovranno provvedere affinché “ciascuna persona fisica o giuridica abbia il diritto di trasmettere – mediante canali facilmente accessibili[34], una segnalazione circostanziata all’Autorità di Controllo, se ha motivo di ritenere in base a circostanze obiettive, che una società non rispetti le disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della Direttiva”[35].
Ancora merita di essere rimarcato il fatto che – ai sensi e per gli effetti dell’art. 26(2) della CSDDD – gli Stati membri dovrebbero poter proteggere – se lo richiedono – le persone che presentano segnalazioni circostanziate sia dal punto di vista delle loro identità, sia dal punto di vista delle informazioni personali, se queste ultime, qualora divulgate, appaiono in grado di recar danno a chi ha effettuato le segnalazioni[36].
Infine, per un verso, l’Autorità di Vigilanza dovrebbe avere a disposizione “un periodo di tempo appropriato” per valutare la segnalazione e dovrebbe informare chi ha segnalato in merito all’esito della propria valutazione, fornendo le relative motivazioni e comunicare la decisione di accogliere o respingere eventuali richieste d’intervento, nonché una descrizione delle misure e dei provvedimenti successivi, dando informazioni pratiche sull’accesso alla procedura di ricorso amministrativo e giurisdizionale.
Per altro verso, le persone che hanno segnalato e che in base alla legislazione nazionale sono portatrici di un interesse legittimo, dovrebbero poter vantare il diritto a veder riesaminata la legittimità e la correttezza “procedurale e sostanziale” delle decisioni, degli atti o delle omissioni delle Autorità di controllo.
Relativamente alle sanzioni, l’art. 27 della Direttiva sancisce che le stesse “devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”. Più in particolare, esse sono di due tipi, ma gli Stati Membri – sempre stando alla versione definitivamente approvata dalla Direttiva – potrebbero introdurne di altra matrice: la prima, di carattere pecuniario, risultava basata quantitativamente sul fatturato netto mondiale ottenuto dalla società nell’esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria[37]; la seconda consiste invece nella pubblicazione della decisione indicante la società colpevole della violazione e la natura della violazione, ogni qual volta che la società incolpata non si sia “conformata” alla decisione che dato luogo alla pena pecuniaria.
Passando al versante del private enforcement, la CSDDD aveva previsto che il mancato rispetto degli obblighi da essa imposti avrebbe pure potuto dare origine a forme di responsabilità civile. Si trattava di una responsabilità per danni qualora gli stessi fossero stati cagionati dal non aver ottemperato “intenzionalmente” o “per negligenza” agli obblighi imposti dalla Direttiva e se questi ultimi, in particolare, erano intesi a tutelare una persona fisica o giuridica. Al tal riguardo sono stati specificamente menzionati – in un particolare Allegato alla CSDDD – i diritti, i doveri e gli obblighi da tenere in considerazione[38]. Per contro, la Direttiva non ha mai regolato in alcun modo i profili attinenti al nesso di causalità e alla ripartizione degli oneri probatori, essendo oltre modo chiaro che quest’ultima non intendeva affatto procedere ad una armonizzazione dettagliata su scala unionale in materia di “tort law”. Tant’è che la CSDDD disponeva apertamente che potevano essere fatte salve le norme previste dai diritti nazionali in materia di violazione di diritti umani o di impatti ambientali che prevedano anche casi diversi da quelli contemplati dalla Direttiva o prevedano forme di responsabilità addirittura più severe.
In tutti i casi, la Direttiva ha sancito che quando una società viene dichiarata civilmente responsabile, il soggetto danneggiato ha diritto ad un pieno risarcimento, senza, tuttavia, che ciò comporti che si possa pervenire ad una “overcompensation” del danno subito “né sottoforma di danni punitivi, né di danni multipli o di altra natura”.
Da ultimo, i termini di prescrizione per intentare azioni di risarcimento del danno sono stati fissati in almeno cinque anni e comunque non inferiori al termine stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile in generale. Ad ogni modo, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le spese processuali non siano eccessivamente onerose “per rivolgersi alla giustizia”.
3. Alcune ulteriori considerazioni sulle più evidenti criticità della CSDDD ed uno sguardo all’autodisciplina settoriale
La sopradescritta impostazione – che, come già si è riferito, ricalca l’approccio tedesco e francese – ha suscitato, ancor prima dell’approvazione definitiva dello strumento legislativo comunitario, notevoli perplessità.
Esse sono già state in buona parte riassunte: i) ampi margini di ambiguità determinati dal dover interloquire con sistemi e tradizioni giuridiche eterogenee; ii) la scopertura del fianco nei riguardi non soltanto di azioni pretestuose e ricattatorie (visto anche il basso costo di accesso), ma soprattutto di contenziosi assai complessi avanti a magistrati europei condizionati non soltanto dalla lontananza geografica di eventuali imprese controllate situate in altri sistemi giuridici e/o dei partners commerciali coinvolti, ma soprattutto dal fatto che le fonti di prova potrebbero trovarsi tutte all’estero; iii) la possibilità di dare rilievo a forme di colpa – e quindi di responsabilità – in eligendo (se non, addirittura, a forme di responsabilità oggettiva per fatto altrui) per quanto avvenuto alla periferia del raggio di azione dell’impresa madre[39]; iv) la possibilità di dare rilievo a “condotte semplicemente omissive”, che possano ledere peraltro beni non sempre ben definiti, come quelli condizionati da diritti umani, occupazionali e sociali, dell’ambiente o del clima[40]; v) l’eventualità che sulla originaria azione di danno che da diritto al primo risarcimento si possano innestare “azioni rimediali” in prevenzione e/o misure cautelari pure sotto il profilo dell’imposizione di obblighi di fare o di non fare.
A tali criticità se ne possono aggiungere altre: i) la difficoltà di reperire informazioni affidabili dai partner commerciali e soprattutto da parte di quei fornitori collocati in Paesi logisticamente lontani e in ordinamenti contrassegnati da una scarsa “certezza del diritto”; ii) la opportunità di coinvolgere altri Stati extra UE, per tentare di creare un campo di gioco, per lo meno omogeneo, allo scopo di tutelarsi da profili di concorrenza sleale da parte di imprese di Paesi terzi che non si assumono analoghe responsabilità in materia di sostenibilità, risultando tutt’altro che semplice da sostenere la tesi secondo cui le disposizioni di diritto interno derivanti dall’attuazione della CSDDD abbiano il carattere e la portata delle “norme di applicazione necessaria”; iii) la opportunità di sottoporre alla verifica di soggetti esterni indipendenti e dotati di professionalità la sustainability due diligence, in sintonia con quanto è stato previsto in tema di assurance nella attuazione della CRS in Italia, che ha recentemente visto anche lo spiegarsi dell’intervento regolatorio da parte della Consob[41].
Questa ampiezza e varietà di ragioni potrebbe disincentivare – posto che la schiera degli stakeholders “interessati” è tutt’altro che allineata – la propensione a raggiungere accordi transattivi, in quanto risulta difficile scongiurare il rischio dell’avvio di ulteriori azioni giudiziali da parte di altri soggetti legittimati (a maggior ragione se si considerassero – come si è anticipato – anche coloro che non intrattengono rapporti mercantili con le imprese interessate).[42] Non senza aggiungere che all’interno della Unione europea non è neppure sempre agevolmente invocabile la dottrina, di matrice prevalentemente nordamericana, del “forum non conveniens”, che risponde chiaramente ad alimentare esigenze di “giustizia sostanziale”, non sempre privilegiate nei diversi ordinamenti nazionali dei Paesi membri dell’Unione europea[43].
Non per caso in questo intricato scenario – ed ancor prima delle controspinte pianificate con l’Omnibus Package pure per l’effetto dei venti contrari che soffiano nell’altro versante dell’Atlantico nei riguardi dei fattori ESG[44] – si sono presto diffuse le opinioni di coloro che si sono domandati se realisticamente sussista il bisogno di forme aggiuntive di responsabilità civile in un contesto nel quale è stato chiaramente dichiarato – lo si è già ricordato – che la Direttiva non intende affatto procedere ad una armonizzazione della tort law a livello comunitario. Opinioni che hanno fatto leva sul fatto che il “diritto vivente” di diversi sistemi giuridici – come pure riscontrato da una ricerca realizzata su scala mondiale dal noto studio legale internazionale A&O Sherman – attesta che risulta possibile sanzionare anche civilmente, quanto meno come fatti illeciti (ma ci sono anche criminal laws che riguardano e puniscono il greenwashing di prodotti e/o servizi e che oltre a ciò contemplano disposizioni specifiche più severe che si concentrano su “ESG credentials”), tutte quelle condotte che determinano sia sul piano commissivo, che su quello omissivo, violazioni di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché ambientali e talora addirittura climatici[45].
In questa prospettiva merita di essere menzionato – per richiamare una circostanza rilevante ancor più di attualità – il “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda”, a protezione dei diritti umani e dei lavoratori sottoscritto il 26 maggio 2025 da una serie di enti promotori, come la Prefettura di Milano, la Regione Lombardia, il Tribunale di Milano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano, l’Ispettorato di Area Metropolitana di Milano, il Politecnico di Milano, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Monza Brianza e Lodi, Associazioni rappresentative del settore della moda ed Organizzazioni Sindacali, in risposta all’andamento di alcune indagini penali attivate nell’hinterland milanese sulla base del d.lgs. 231/2001 nei riguardi di alcune tra le più rinomate fashion industries, per illecita intermediazione di mano d’opera e soprattutto per non aver disposto modelli organizzativi adeguati a prevenire il compimento della sempre più ampia schiera dei c.d. reati presupposto[46].
Un documento, di matrice palesemente autodisciplinare, volto a costruire forme di responsabilizzazione e strumenti premiali a favore delle imprese operanti nel settore della moda che: i) intendono contribuire alla realizzazione di sistemi di controllo finalizzati al contrasto dell’illegalità; ii) che vogliano assicurare la piena trasparenza lungo la filiera, secondo “coni di visibilità” che garantiscano la necessaria riservatezza tanto delle informazioni concernenti la stessa filiera produttiva, quanto delle modalità concrete di esecuzione dei singoli contratti di appalto/subappalto e fornitura/subfornitura ed ancora iii) che desiderino promuovere specifiche azioni di attuazione del Protocollo tramite opportune procedure operative e attività formative indirizzate ai dipendenti e comunque ai lavoratori impiegati nel settore[47].
8. L’impatto dell’Omnibus Package
Al di là delle perplessità originate sia prima che dopo la definitiva approvazione della CSDDD nella sua formulazione ante Omnibus Package, è il già segnalato ed originario obbligo non solo di predisporre, ma anche di attuare (ossia, “to put into effect”) un piano di transizione per la mitigazione degli effetti negativi a livello climatico, che ha maggiormente inciso sulle discussioni tuttora aperte, sulla sussistenza o meno di un ampliamento su base normativa – e quindi non volontaria – dei business purposes – per lo meno di alcune società – attraverso la individuazione di uno di questi legato alla sostenibilità. Si tratta, in altre parole, di un passaggio che risulta astrattamente in grado di dare un appiglio ulteriore a un già rintracciabile – ma tutt’altro che ampiamente condiviso – percorso interpretativo[48], teso a porre a carico delle imprese private la produzione e la tutela di “beni pubblici o semi-pubblici”, quali: la protezione dei diritti umani, la tutela dell’ambiente e il benessere della comunità, anche attraverso una “buona governance”[49].
Un innalzamento quindi dei doveri di condotta degli amministratori verso l’obiettivo, emblematicamente definito, dello shareholder welfare, più che quello dello shareholder value[50], attraverso le vie del c.d. “profitto ragionevole”. Doveri da riguardare pure nella prospettiva patologica della responsabilità da attribuire a chi gestisce l’impresa secondo il noto iter argomentativo della business judgement rule o secondo la declinazione del duty of care, alla cui base si rintracciano pur sempre i parametri della ragionevolezza e della proporzionalità[51].
Una visione non priva di forti criticità per i costi di transazione elevati e le complicazioni anticoncorrenziali sia su scala globale, sia intra UE. Non senza dimenticare che i fattori ESG e il progresso tecnologico soprattutto attraverso il supporto dell’intelligenza artificiale sono sempre più divaricati: essi, a ben vedere, configurano due diversi modi di “fare impresa” – o meglio, di intendere l’attività imprenditoriale – che si contrappongono in modo tendenzialmente dialettico[52].
Senonché, indipendentemente dai toni decisamente smorzati che deriveranno dall’entrata in vigore anche nella fase 2 dell’Omnibus Package, un ruolo decisivo viene comunque attribuito agli amministratori. E dunque è cruciale riflettere sui meccanismi che riguardano la loro nomina, senza trascurare la possibile investitura, in alcuni particolari frangenti, di capi d’impresa non designati “democraticamente”, ovvero dalla base degli investitori, bensì per altre vie. Ci si riferisce, più precisamente, alle già menzionate figure dei Political Chief Executive Officers, spesso in grado di incrinare, per effetto dell’origine della nomina, l’originaria missione imprenditoriale, votata tradizionalmente alla massimizzazione del profitto[53].
La ponderazione tra gli internal affairs e gli interessi – lo si ribadisce – spesso confliggenti tra gli stakeholders con il riguardo pure all’attuazione dei transition plans, viene comunque inquadrata anche dalla CSDDD come una obbligazione di mezzi: di conseguenza, i criteri di diligenza invocabili sono quelli richiamati dal Considerando 73 e dell’art. 5 della CSDDD, che sono stati descritti in termini di autentica “scintilla cinetica degli assetti societari”[54].
Ma è sulla spinta del dibattito accesosi dopo la approvazione della Direttiva sulla sustainability due diligence e dei sempre più inquietanti fatti di cronaca geopolitica, nonché delle riflessioni all’interno dell’Unione Europea alimentate dal prima d’ora citato rapporto di Mario Draghi sul futuro della competitività[55], che sono state approvate le “Proposals” che costituiscono parte integrante dell’Omnibus Package. Un provvedimento comunitario del 26 febbraio 2025 che avrebbe la già richiamata finalità di: i) incrementare la competitività; ii) semplificare le regole e iii) sbloccare le potenzialità di investimento, in ogni caso “still meeting” – almeno a parole – “the core policy objectives of the European Green Deal”, tramite, comunque, una semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei costi[56].
Per quanto riguarda la CSDDD, le modifiche programmate soprattutto con la fase 2 dell’Omnibus Package sono, come si è già segnalato, molto rilevanti e consentono soprattutto a livello sistematico ripensamenti importanti. Il quadro di riferimento che ne deriva – come se si fosse dato un colpo ad un caleidoscopio – è sensibilmente diverso, soprattutto in dimensione prospettica. Del rinvio di un anno del termine di recepimento della Direttiva (ora stabilito al 26 luglio 2027) e della prima fase di applicazione (a far tempo del 26 luglio 2028), si è già detto, e si aggiunga che, entro luglio 2026, la Commissione europea dovrà fornire gli orientamenti di supporto per le imprese e le Autorità di controllo ai fini dell’applicazione della CSDDD (questa volta in anticipo rispetto ai tempi inizialmente ipotizzati al momento della approvazione della Direttiva), al fine di ridurre la dipendenza delle imprese dalla consulenza legale.
Le catene del valore prese in esame dalla due diligence riguarderanno – lo si è prima d’ora riferito – solo i partners commerciali diretti (in direzione quindi esclusivamente up-stream). La frequenza del monitoraggio e delle valutazioni periodiche passerà da annuale a quinquennale (nell’ottica inequivoca di abbassare il tasso di compliance ed i correlati costi). Le definizioni di stakeholders saranno meglio puntualizzate e lo stakeholder engagement sarà razionalizzato.
Per passare alle questioni di enforcement, strettamente intese, l’obbligo di terminare il rapporto commerciale con soggetti non allineati ai dettami della CSDDD, che nella Direttiva rappresentava la misura rimediale di ultima istanza, sarà sostituito dalla possibilità di disporre più lievemente “una sospensione temporanea” della relazione.
Ma, ancora più significativo, ci sarà un allineamento – verso il basso – dei requisiti relativi all’adesione di piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, sulla falsariga di quanto già dispongono le norme di attuazione della CSR. Più precisamente, sarà eliminato l’obbligo di attuare un piano di transizione climatico, ma resisterà soltanto il dovere di predisporlo, ricorrendo alle tecnicalità volta per volta ritenute necessarie e l’obbligo di aggiornarlo periodicamente. Inoltre, sarà ridotto l’effetto a cascata verso le PMI e le Mid Cap attraverso la limitazione delle informazioni che le imprese tenute alla CSDDD possono richiedere ai loro partners commerciali di minor cabotaggio, a meno che non ricorrano circostanze particolari.
in aggiunta, con decisive ricadute sul profilo delle disposizioni introdotte in tema di private enforcement, è stata prevista la soppressione del regime di responsabilità civile immaginato a livello comunitario, rinviando la regolazione del tema della responsabilità civile, alla disciplina vigente nei singoli Stati membri, lasciando soltanto in essere i principi più “high level”, dell’accesso alla giustizia “agevolato” e del “risarcimento integrale”. Ed ancora, verrà eliminata la previsione dell’obbligo di agevolare i presunti danneggiati a consentire che l’azione risarcitoria possa esser proposta in via rappresentativa da sindacati o da organizzazioni non governative o da istituzioni nazionali per la protezione dei diritti umani, precludendo la introduzione da parte dei Paesi membri di norme più severe per contrastare abusi sui diritti umani e dell’ambiente.
Infine, è stato annullato qualsiasi espresso riferimento di natura quantitativa alle sanzioni pecuniarie. La semplice menzione – all’art. 24 (4) della CSDDD – al 5% del fatturato mondiale netto aveva creato discussioni in merito alla sua valenza interpretativa e pertanto si è più semplicemente proposto che sia la Commissione europea a introdurre al più presto delle linee guida per garantire criteri sanzionatori omogenei tra gli Stati membri, basati su “efficacia”, “proporzionalità” e “capacità di dissuasione”.
9. Governance sostenibile e futuro dell’Europa
In questo modificato contesto, che tra l’altro, come è stato opportunamente notato, ha significativamente ridimensionato l’area dell’impatto che la CSDDD avrebbe determinato con la sua iniziale portata[57], conviene conclusivamente porsi un quesito di fondo.
Posto che il percorso tracciato dal legislatore europeo per lo meno in occasione dell’approvazione finale della CSDDD, da un canto, e quello seguito dalle imprese e dagli individui, dall’altro canto, non si sono allineati – con il risultato che la individuazione di doveri specifici non è coincisa con la scelta di dare voce a condizionamenti funzionali ad interessi esterni collegati ad istanze di tutela di carattere generale e connesse ai fattori ESG – si possono ancora rintracciare vincoli di matrice pubblicistica, assicurati da misure coercitive di enforcement, in grado di incidere sensibilmente sulle attività imprenditoriali svolte da società di diritto comune? È, infatti, indubbio che i responsabili delle politiche dell’Unione europea non sono ancora riusciti ad andare oltre i particolarismi statali e a connettere i cittadini comunitari ad una visione più ampia ed ambiziosa di Europa, soprattutto perché anche all’interno del vecchio continente si sono diffusi presidi, sostanzialmente protezionistici, volti a mantenere sotto il controllo nazionale un numero sempre più significativo di imprese strategiche.
Fenomeni in grado di delegittimare sempre più quanto programmaticamente proclamato nell’ambito dello speranzoso progetto di un Green Deal europeo[58], in grado di influenzare positivamente, con la forza della persuasione soltanto, anche un maggior numero di altri Paesi.
Tanto constatato, va del pari riscontrato che le politiche sociali e di welfare di matrice comunitaria paiono comunque aver dato frutti evidenti, specialmente ad avviso di coloro che misurano le aspettative di vita degli esseri umani (ottantuno anni e mezzo è l’aspettativa di vita media nei ventisette Paesi dell’Unione europea calcolata nell’anno 2023, mentre, per fare un emblematico confronto, negli Stati Unita d’America tale dato è sceso ai livelli del 1996, e cioè a settantasei anni di età[59]).
Sarebbe pertanto auspicabile che le avvertenze e le cautele in termini di sostenibilità se non potranno essere ancora viste – in conseguenza della applicazione dell’Omnibus Package sull’impianto originario della CSDDD – come fonte di rules dotate di un impianto di enforcement decisamente più stringente rispetto al passato, possano per lo meno essere ritenute una solida e persistente opportunità di forward looking, e cioè come forme di incentivazione di obiettivi di medio-lungo termine per promuovere necessariamente all’interno di prospettive ideate a livello sovra-statale, le capacità di innovazione e di collaborazione con altri suppliers.
In altre parole, un tragitto impegnativo e sfidante, pur sempre da proseguire nel rispetto della trasformazione tecnologicamente innovativa, per acquisire nuovi know how attraverso investimenti nei settori di ricerca e sviluppo, di sempre maggior ampiezza, posto che per reperire le risorse per affrontare seriamente le sfide che arrivano dall’estero anche in tempi ordinari, non si può pensare di affidarsi a sforzi nazionali, per di più frammentati.
Insomma, laddove la azione comunitaria – nonostante gli sforzi, frequentemente frutto di grandi compromessi, compiuti – non è ancora riuscita a creare solide basi per la realizzazione di un sistema imprenditoriale imperniato sulla sostenibilità, potranno forse supplire le prassi gestionali seguite da coloro che operano privatamente sul mercato, facendo necessariamente i conti con l’insopprimibile criterio di calibrare scrupolosamente i costi con i benefici[60]. Al riguardo, è stato recentemente constatato che nonostante la grande instabilità delle relazioni commerciali, il settore delle imprese private comunitarie ha mostrato solidità nell’effettuare sforzi di adattamento, con un ritmo nell’adozione delle nuove tecnologie di ultima generazione comparabile con quello osservabile negli Stati Uniti[61].
Si tratterebbe, quindi, di voler continuare ad accettare una sfida decisamente ambiziosa in un palcoscenico planetario, a dir poco demoralizzante, come quello attuale, all’interno del quale si ravvisano, anche a livello politico, plurime manifestazioni di short terminism, che sembrano impedire – al di là delle sempre meno frequenti affermazioni di facciata – la realistica attraibilità di una corporate governance sostenibile. Tuttavia “distruggere l’integrazione europea per tornare alla sovranità nazionale non farebbe altro che esporci ancor di più al volere delle grandi potenze” e di conseguenza sarebbe quanto mai opportuno “trasformare lo scetticismo in azione”, in quanto “la passività e la rigidità creano inazione” e “l’inazione è il peggior nemico dell’Europa”[62].
In tutti i casi, è innegabile che si sia ormai radicato pure tra i giuristi un cambiamento concettuale, ancor prima che culturale, che induce a non tenere più nettamente separati gli ambiti strettamente finanziari da quelli non finanziari, per effetto di una sempre più intensa relazione di integrazione e di reciproco condizionamento tra questi distinti comparti[63].
Ricorre, in definitiva, un movimento bidirezionale tra le regole generali di corporate governance ed i sustainability issues sia per ragioni politico-istituzionali, che per motivazioni di natura economico-sociale e quest’ultimo trend non andrebbe soffocato del tutto e così gettato nel cestino delle sole buone intenzioni.
I cambiamenti in corso, sempre più caratterizzati dall’introduzione di politiche industriali di ampio respiro non più affidate ai superati criteri della fede nel libero scambio, della apertura dei mercati e nel rispetto di regole multilaterali, imporrebbero però una revisione rapida dell’organizzazione politica europea[64]. Il tutto all’insegna di una maggiore integrazione sia per arrivare finalmente a realizzare l’ormai da tempo invocato mercato unico interno, tuttora caratterizzato dal permanere di troppe barriere, sia per realizzare progetti di comune interesse, trovando una intesa pure sulle modalità del loro finanziamento. Non si può che, infatti, che convenire sulla tesi che soltanto la definizione di nuove politiche commerciali di stampo sovra-nazionale, soprattutto se si tratta di affrontare la delicata tematica delle “tecnologie critiche” – coniugando necessariamente sostenibilità e digitalizzazione pure a livello del settore pubblico – potrà evitare il dilagare di forme di eccessiva sudditanza geopolitica da parte di ciascun Paese del vecchio continente[65].
[*] (Relazione al Convegno “Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD). Alla ricerca di una sostenibilità sostenibile”, organizzato dalla Associazione Gian Franco Campobasso presso l’Università del Molise (Termoli), 27 e 28 giugno 2025.
[1] Il documento è consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097.
[2] Così recita l’“Action 10” (Fostering sustainable corporate governance and attenuating short-termism in capital markets): “1.To promote corporate governance that is more conducive to sustainable investments, by Q2 2019, the Commission will carry out analytical and consultative work with relevant stakeholders to assess: (i) the possible need to require corporate boards to develop and disclose a sustainability strategy, including appropriate due diligence throughout the supply chain, and measurable sustainability targets; and (ii) the possible need to clarify the rules according to which directors are expected to act in the company’s long-term interest. 2.The Commission invites the ESAs to collect evidence of undue short-term pressure from capital markets on corporations and consider, if necessary, further steps based on such evidence by Q1 2019. More specifically, the Commission invites ESMA to collect information on undue short-termism in capital markets, including: (i) portfolio turnover and equity holding periods by asset managers; (ii) whether there are any practices in capital markets that generate undue short-term pressure in the real economy”.
[3] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj?locale=it.
[4] Si tratta di una serie di discussioni così accese da aver condotto più di qualcuno a considerare che il tragitto intrapreso dalla Unione europea e prima ancora di quest’ultima, da Germania e Francia fosse al centro di un fenomeno di autentico reflusso. Alcuni osservatori, soprattutto dopo la emanazione del c.d. provvedimento “plurifasico”, denominato Omnibus Package (di cui, si tornerà a dire), hanno senza mezzi termini parlato di un percorso e di una Direttiva – la CSDDD – in stato di “coma farmacologico”. Cfr. Davies, Emmenegger, Ferrarini, Hopt, Opalski, Pietrancosta, Recalde Castells, Roth, Schouten, Skog, Winner, Wymeersch, The European Parliament’s Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability, 2021, in https://europeancompanylawexperts.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/01/2021_ecgi_19-april-2021_corporate-due-diligence.pdf; Enriques, The European Parliament Draft Directive on Corporate Due Diligence and Corporate Accountability; Stakeholder – Oriented Governance on Steroids, in Riv. Soc., 2021, 319 ss.; Malberti, The Corporate Sustainability Due Diligence Directive: European Neo-Imperialism or an Innovative Approach to Tackling Abuses in Global Supply and Value Chains?, consultato per cortesia dell’Autore e in corso di pubblicazione in Revue Juridique Thémis de l’Université de Montréal.
[5] Una espressione non del tutto felice, se si pone mente a cosa si descrive con questo termine, nei processi diffusissimi nella prassi, di M&A, verosimilmente adottata utilizzando la “lingua inglese di Bruxelles”: la efficace locuzione è stata utilizzata da Carlo Angelici, nel corso della Presidenza della prima sessione pomeridiana del Convegno, Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD). Alla ricerca di una sostenibilità sostenibile.
[6] Questa è la definizione utilizzata dal legislatore europeo, che ha preferito non esprimersi in termini di “supply chain”. Così facendo quest’ultimo ha senz’altro conferito rilevanza giuridica ad una nuova “dimensione imprenditoriale”, che meriterebbe di essere approfondita analiticamente, frutto dell’esplicito collegamento attuato tra i gruppi di imprese e coloro che fanno parte delle relative “catene di attività”. Su tali interessanti aspetti si è soffermato Santagata, Gestione sostenibile dei gruppi e “catene di attività”: questo il titolo della relazione presentata al Convegno: Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD). Alla ricerca di una sostenibilità sostenibile.
[7] Quindi si dovrà ragionare, più semplicemente in prospettiva up-stream.
[8] In questo senso assume esplicito rilievo il Considerando 73, nonché l’art. 5 della CSDDD, rubricato, non per caso, “Dovere di diligenza”.
[9] Un aspetto che crea un overlapping evidente, e dunque una palese necessità di coordinamento con la CSR.
[10] Si noti che nelle organizzazioni di gruppo si potrebbe, più che legittimamente, prevedere che il compito di predisporre la “due diligence di sostenibilità” venga affidato ad una delle società che rientrano all’interno del perimetro della direzione e coordinamento, come opportunamente riferito da Santagata, “Gestione sostenibile dei gruppi e “catene di attività” al Convegno Impresa e sostenibilità ESG dopo la Direttiva UE 2024/1760 (CSDDD). Alla ricerca di una sostenibilità sostenibile.
[11] E qui rileva l’ormai rinomato criterio della c.d. “doppia materialità”.
[12] Cfr. il Considerando n. 11 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852 e la Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, in https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?locale=it. In una prospettiva più ampia, parlare di greenwashing significa anzitutto disquisire su un fenomeno dalle molteplici sfaccettature e che volgarmente è stato definito come “ambientalismo di facciata”. In tal senso Condemi, Greenwashing: cos’è e come difendersi, in https://www.agendadigitale.eu/smart-city/greenwashing-cose-e-come-difendersi/, 4 agosto 2022. Si tratta di sfaccettature la cui esistenza è testimoniata anche dagli innumerevoli contributi dedicati al tema che, di fatto, trascendono i confini nazionali. La letteratura in proposito è, quindi, particolarmente ampia. Pare tuttavia utile richiamare – a titolo meramente esemplificativo – Vieira de Freitas Netto, Falcão Sobral, Bezerra Ribeiro, Da Luz Soares, Concepts and forms of greenwashing: a systematic review, in Environ Sci Eur, ma agilmente consultabile al link in https://link.springer.com/article/10.1186/s12302-020-0300-3, 2020, 6, ove si legge anzitutto che il termine greenwashing è stato coniato per la prima volta nel 1986 da Jay Westervelt, e si sottolinea il fatto che molti dizionari definiscono il fenomeno: “Webster’s New Millennium Dictionary of English defines greenwash as ‘practice of promoting environmentally friendly programs to deflect attention from an organization’s environmentally unfriendly or less savoury activities’. In 1999 the term was added to the Concise Oxford English Dictionary, that defines it as: ‘Disinformation disseminated by an organization so as to present an environmentally responsible public image; a public image of environmental responsibility promulgated by or for an organization, etc., but perceived as being unfounded or intentionally misleading’”. Ciò che viene rimarcato è che, comunque “According to Lyon and Montgomery, there is no rigid definition of greenwashing due to its multifaceted nature”. Anche al di fuori del contesto strettamente dottrinale, il fenomeno ha suscitato e continua a suscitare un grande interesse: cfr. Stecconi, Greenwashing, quanto è diffuso e come si contrasta in Italia e in Europa, in https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/04/04/greenwashing-normative-regolazione/?refresh_ce=1, 4 aprile 2024; Argentesi, Rapporto Greenwashing: i numeri – ingannevoli – del marketing “verde”, in https://ilgiornaledellambiente.it/rapporto-greenwashing-2025/, 21 maggio 2025.
[13] Cfr. Malberti, op. cit., 13.
[14] È chiara a questo riguardo la necessità di dare avvio ad apposite consultazioni e confronti con le sfere anche esterne all’impresa, soprattutto per conferire priorità agli impatti negativi ESG più significativi.
[15] Si veda sul punto il Considerando 23 della CSDDD.
[16] Il Considerando 23 e l’art. 5(3) della Direttiva sanciscono espressamente che “the mapping of the chain of activities doesn’t oblige business partners to disclose trade secrets”. Senonché, è al contempo fuor di dubbio che lo scambio di informazioni tra business partners possa impattare sui delicati profili dei c.d. horizontal cooperation agreements.
[17] Una intersezione fatale in quanto le forme di enforcement, siano esse pubbliche o private, sono condizionate dai sempre più severi ed onerosi obblighi di condotta imposti alle imprese.
[18] Merita di essere ricordata in proposito la Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2137 del 13.12.2020, in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52020IP0372; sul punto si veda anche Genovese, La gestione ecosostenibile dell’impresa azionaria fra regole e contesto, Il Mulino, Bologna 2023, 65, la quale sottolinea come la trasparenza autoregolata non sia stata, alla prova dei fatti, sufficiente per correggere la traiettoria dello sviluppo economico.
[19] In proposito si veda già Trovatore, Sull’enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario, in Giur. Comm., 2024, I, 616 ss. e anche ESMA, Guidelines on Enforcement of Sustainability Information, consultabile in https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-04/ESMA32-992851010-1815_Guidelines_on_Enforcement_of_Sustainability_Information__GLESI_.pdf, 29 aprile 2025.
[20] Il tema è stato recentemente oggetto del convegno “La rendicontazione di sostenibilità: un diritto in cerca di regole”, tenutosi presso il Centro Svizzero di Milano il 24 ottobre 2025. A tal proposito, si segnala in particolare l’intervento di M. Rescigno, L’evoluzione normativa della rendicontazione di sostenibilità.
[21] Questo meccanismo regolatorio è sempre più diffuso su larga scala. A tal proposito si veda Genovese, La gestione ecosostenibile, cit., 115, nonché Montalenti, Il Nuovo Codice di Corporate Governance (The New Italian Corporate Governance Code), in Corporate Governance, 1/2021, 45.
[22] Falsità che hanno consentito la realizzazione di condotte misleading, talora in grado di realizzare manifestazioni di autentico greenwashing.
[23] Di interesse sul tema, anche e soprattutto in ottica ancor più ampia, il volume di Riganti (a cura di), Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori e operatori nella “galassia” ESG, Giappichelli, Torino, 2025.
[24] Giova anche in questo frangente ricordare che in una visione quasi “fumettistica” è stato riferito che una “spinta gentile” può rappresentare la strada più efficacemente percorribile: alla base di questa teoria vi è la convinzione che se si vuole che le persone facciano qualcosa, ed agiscano quindi in un determinato modo, occorre “rendere la cosa semplice”. Si tratta del complesso fenomeno del c.d. nudge –, che ha consentito a Richard Thaler, il noto studioso di scienze comportamentali, di vincere nell’anno 2017 il premio Nobel per l’Economia. Sul tema qui richiamato mediante una consapevole iper-semplificazione cfr. anzitutto Thaler, Sunstein, Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Universale Economica Feltrinelli, 2024; per approfondire l’argomento invece si rimanda senza pretesa di completezza a AA.VV. Nudge Theory in Action. Behavioral Design in Policy and Markets, Sherzod Abdukadirov, 2016 e a Olya, N. Kim, M.J. Kim, Climate change and pro-sustainable behaviors: application of nudge theory, in https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2023.2201409, 2023, 1077 ss..
[25] In argomento, nuovamente, Trovatore, op. cit., 620 s.
[26] Si veda ancora Trovatore, op. cit., 618. Tale negativo riscontro permane ancora oggi, come anche recentissimamente è stato possibile riscontrare informalmente attraverso la cortesia degli interna corporis di Consob.
[27] In tal senso, è decisamente interessante il recente resoconto effettuato nel marzo 2025, curato dai componenti del Tavolo Metriche ESG e Piani strategici, istituito nell’ambito dello Steering Committee Consob sulla sostenibilità: uno studio che deliberatamente esula dall’attività di vigilanza della Consob. Si tratta del volume dal titolo “Integrazione dei fattori ESG nella Strategia aziendale, un’analisi della disclosure societaria. Primi spunti di riflessione”. Tale studio ha, in particolare, esaminato le seguenti distinte categorie di documenti su un campione di 50 emittenti quotati negli anni 2021 e 2022: i) i prospetti pubblicati; ii) le, allora ancora definite, dichiarazioni non finanziarie (le c.d. DNF, oggi sostituite dai rendiconti di sostenibilità); iii) le relazioni finanziarie annuali; iv) la documentazione relativa ai piani industriali (anche se – lo si è subito anticipato da parte degli autori – il numero di società che forniscono informativa sugli obiettivi ESG “è ancora limitato, con una disclosure prevalentemente quali-quantitativa”). Si è infine rilevato che le società che forniscono informazioni più dettagliate su specifici obiettivi ESG connessi al proprio piano industriale sono quelle “maggiori dal punto di vista dimensionale” e appartengono prevalentemente al settore finanziario.
[28] E non è ora il caso di svolgere commenti in merito alla “via verso Amsterdam” intrapresa ormai da qualche tempo da molte società italiane che hanno abbandonato i mercati regolamentati nazionali. Uno scenario, per contro, sempre più caratterizzato dall’ingresso di un progressivamente crescente numero di PMI in sistemi multinazionali di negoziazione, come, primo tra tutti, l’Euronext Growth Milan.
[29] Draghi, The Future Of European Competitiveness, in https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en, 2024.
[30] Von der Leyen, Europe’s Choice. Political guidelines for the next european commission 2024 – 2029, in https://commission.europa.eu/document/download/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en, 18 luglio 2024.
[31] Come si è già avuto occasione di rilevare, l’impatto che sarà determinato da parte della fase 2 dell’Omnibus Package specialmente in materia di public e private enforcement, deve ritenersi assai consistente e per diversi aspetti “regressivo”. Per questa ragione nel testo ci si riferirà in alcuni passaggi al passato e in altri frangenti si è preferito fare uso del condizionale.
[32] Questa disposizione normativa era di per sé in grado di rappresentare un limite esterno, seppur di matrice tecnica, alle ampie possibilità di modulare l’oggetto sociale – come chiaramente risulta dal Considerando 73 della Direttiva – in grado di incidere, tramite uno strumento legislativo, sia sulla discrezionalità dell’organo gestorio, sia sulla autonomia decisionale dei soci.
[33] Ed è questa una ulteriore disposizione degna di attenzione dal punto di vista sistematico.
[34] Il peggior nemico del “nudge” è lo “sludge”: su tali profili, cfr Occhio allo sludge, antitesi del nundge: la battaglia di Thaler, 19 marzo 2019, in https://professione finanza.com/occhio-allo-sludge/.
[35] È evidente che qui ci si espone al rischio di azioni che possano essere attivate con puro spirito di chicane.
[36] In questi passaggi sono facilmente rintracciabili assonanze con l’istituto del whistleblowing.
[37] Si fa presente che la originaria previsione di un riferimento quantitativo commisurato al 5% del fatturato mondiale ha subito dato origine a discussioni interpretative, poi espressamente considerate dal già richiamato provvedimento plurifasico Omnibus Package.
[38] Anche in questo caso il provvedimento plurifasico Omnibus Package ha profondamente inciso sulla materia, depotenziando anche la portata sistematica delle previsioni originarie della CSDDD, come si avrà modo di chiarire nel prosieguo.
[39] Anche se, stando alla CSDDD – sia pure con oneri probatori molto pesanti – l’impresa può essere considerata esente da responsabilità “se il danno è stato causato solo dai propri partner commerciali nella sua catena di attività”: si veda, in tal senso, l’art. 29.1, secondo comma, della Direttiva.
[40] In una prospettiva squisitamente commercialistica ci si domanda come ci si dovrebbe atteggiare nei confronti di danni prefigurati come conseguenti al “mancato rispetto della buona governance”. È peraltro superfluo notare che qualsiasi danno cagionato da una impresa – specie col senno di poi – è sempre asseribile a una “governance not good”: in tal senso, condivisibilmente, Ventoruzzo, Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence, in Riv. soc. 2021, 380 ss.
[41] Si veda in tal senso, sia la delibera Consob n. 23463 del 12 marzo 2025 avente ad oggetto: Modifiche del Regolamento Emittenti in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, sia la Delibera Consob n. 23585 avente ad oggetto: Determinazione per l’anno 2025 dei parametri previsti dagli artt. 89-quater e 89-quinques del Regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche, che ha tenuto conto anche dell’ultima versione delle già citate ESMA Guidelines on Enforcement of Sustainability Information. Come si è già ricordato il tema, di grande interessem è stato recentemente oggetto del convegno “La rendicontazione di sostenibilità: un diritto in cerca di regole”, tenutosi presso il Centro Svizzero di Milano il 24 ottobre 2025.
[42] Essendo peraltro pacifica la criticità dei c.d. accordi asimmetrici nel campo dei settlement agreements stipulati con parti deboli a valle della promozione in giudizio di class actions.
[43] Su tali profili, già, Ventoruzzo, Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence, in Riv. soc., 2021, 380 ss.
[44] A dir poco inquietanti sono le espressioni utilizzate da Donald Trump in data 23 settembre 2025 all’ONU sul tema specifico del cambiamento climatico. Per citarne soltanto alcune: “Tutto ciò che è green è in bancarotta. Non è politicamente corretto, sarò criticato duramente per averlo detto, ma sono qui per dire la verità… è la più grande truffa mai perpetrata al mondo, secondo me” ed ancora: “L’energia rinnovabile è un’energia che fa perdere denaro. Molte di queste attrezzature vengono costruite in Cina ma loro non le usano, le esportano soltanto. Loro usano il gas”. Per maggiori dettagli si rinvia a Vigna, E quelle bugie sul clima che il clima smentisce ogni giorno, ne Il Punto del Corriere della Sera. Prima Ora. 24 settembre 2025; nonché, Bonpan, Trump all’assemblea Onu, discorso fiume contro clima, Nazioni Unite ed Europa, 24 settembre 2025, in renewablematter.eu.
[45] Questa è la espressione usata nel report di A&O Sherman, intitolato Manage ESG-related enforcement risk: tightened reporting requirements, supply chains, and illicit labor practices, che rappresenta una parte della più ampia indagine Cross-border white-collar crime and investigations review 2025.
[46] Cfr. Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda, in https://tribunale-milano.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM23294&modelId=55, 26 maggio 2025.
[47] Per completezza, giova segnalare che proprio il settore del fashion ha indotto negli Stati Uniti sin dal mese di ottobre 2021 la promozione di un progetto di legge – si tratta più precisamente dello State Senate Bill S4746B – da applicarsi a tutte quelle società che operano commercialmente nello Stato di New York e volto ad imporre a queste compagnie l’obbligo di redigere, entro una relativamente serrata time line, una Environmental Due Diligence allied with the Organisation for Economic Co-Operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises (OECD). Guidelines for the Responsible Supplies Chain, mappata su quattro livelli: i) final product manufactured; ii) material processors; iii) raw material processors e iv) raw material producers. Tale progetto normativo, noto con l’appellativo di New York Fashion Act, prevede anche disposizioni analitiche in materia di enforcement che comportano l’applicazione di civil fines di alcune migliaia di dollari per ogni violazione, da indirizzare al Fashion Remediation Fund che avrebbe poi lo specifico scopo di finanziare sostegni e benefici a vantaggio dei lavoratori delle comunità colpite da condotte non compliant.
[48] Sia consentito rinviare, senza pretesa di completezza, a Genovese, La gestione ecosostenibile, cit., 128 e Rolli, L’impatto dei fattori ESG sull’impresa. Modelli di governance e nuove responsabilità, Il Mulino, Bologna, 2020, 131.
[49] E così facendo si è dato origine al “canone normativo emergente” della c.d. Sustainable Corporate Governance: in argomento si veda ancora Genovese, La gestione ecosostenibile, cit., 99 e si legga anche Denozza, Rendere lo sviluppo sostenibile e democratico, in L’impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi, a cura di Caterino e Ingravallo, EuriConv, Lecce, 2020, 38, che ha riferito di aver contato nell’ordinamento italiano più di cento definizioni di sostenibilità. Senonché, a tal proposito, occorre ricordare che in prospettiva domestica le società, de iure condito, non possono perseguire finalità non economiche al di fuori di previsioni specifiche di diritto scritto che comunque possono porre problemi di compatibilità con alcuni solidi principi ravvisabili tanto nel libro I, quanto nel libro V del codice civile. Tanto rammentato, se, in aggiunta, si tiene conto del fatto che nel Considerando 63 della Proposta di CSDDD del 2022 si leggeva che il dovere degli amministratori di prendere in esame i profili di sostenibilità dell’impresa “do not require changing existing national corporate structures” (si veda, sul punto, Tombari, Riflessioni sullo “statuto organizzativo” della “impresa sostenibile”, in AGE, 1/2022,142 ed ancora Strampelli, La strategia dell’Unione europea per il capitalismo sostenibile: l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders, in Riv. soc., 2021, 374; Fimmanò, Articolo 41 della Costituzione e valori ESG: esiste davvero una responsabilità sociale delle imprese?, in Giur. comm, 2023, I, 777 ss.; Tombari, Corporate purpose e diritto societario: dalla “supremazia degli interessi dei soci” alla “libertà di scelta dello scopo sociale”?, in Riv. soc., 2021, 3; nonché E. Rimini, Sostenibilità e nuova governance delle imprese azionarie nel diritto interno e comunitario tra realtà, criticità e prospettive, in Giur. Comm., 2024, I, 290 ss.). Ne consegue che in questa prospettiva i fattori ESG potrebbero realisticamente impattare nelle società di diritto interno solo se in grado di migliorare la consistenza dell’utile o se sono in grado di eliminare i rischi di perdita. Uno scenario sul quale anche gli amministratori, pur se di nomina “politica”, non potrebbero sorvolare. Sul diffuso fenomeno dei c.d. Political Chief Executive Officers, ossia sulla non rara eventualità che si verifichino designazioni “non democratiche”, bensì di derivazione politica, degli esponenti aziendali apicali di importanti società in alcuni particolari contingenze, sia nuovamente consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a E. Rimini, Sostenibilità e nuova governance, cit., 290.
[50] In argomento si veda Cian, Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione, in Orizzonti del diritto commerciale, 2021, 1144.
[51] Sui controversi rapporti tra la business judgement rule e i doveri organizzativi, si vedano, senza pretesa di completezza, Montalenti, Assetti organizzativi e organizzazione dell’impresa tra principi di corretta amministrazione e business judgement rule, in Il Nuovo dir. soc., 2021, 9 ss. e Benazzo, Assetti organizzativi, diritto dell’impresa e diritto delle società: dal passato a un (possibile) futuro, in https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/assetti-organizzativi-diritto-dellimpresa-e-diritto-delle-societa-dal-passato-a-un-possibile-futuro, 2 gennaio 2025.
[52] Soprattutto nel day to day management e a livello di PMI, ambiti nei quali l’intelligenza artificiale non si è ancora, soprattutto per i suoi costi elevati, particolarmente diffusa. La bibliografia sul tema è sterminata; per tale ragione, ci si limita qui al richiamo di alcune tra le più recenti pubblicazioni. Tra queste Meo, La macchina amministratrice, indipendente e irresponsabile, e il povero vecchio diritto societario, in AGE, 2022, 607 ss. e Spagnoletti – Volpentesta, Intelligenza artificiale generativa nelle piccole e medie imprese: evidenze empiriche nel contesto italiano, in Rivista di politica economica, 2024, 113 ss.
[53] In argomento, ancora, Tombari, Corporate Social Responsibility (CSR), Environmental Social Governance (ESG) e “scopo della società”, in https://www.rivistadeldirittocommerciale.com/fascicoli/2021-numero-2/44979-corporate-social-responsibility-csr-environmental-social-governance-esg-e-, 2021, 225 ss. e E. Rimini, Sostenibilità e nuova governance, cit., 243.
[54] L’espressione è di Abriani, Successo sostenibile e regole statutarie: il ruolo del board nel Codice di Corporate Governance (Sustainable success and companies’ bylaws: the role of the board in the Corporate Governance Code) in RCG, 1/2021, 12 ss.
[55] E successivamente dalla Bussola per la competitività dell’UE del 29/01/2025 della Commissione europea, in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_25_339/IP_25_339_IT.pdf.
[56] Si veda in questa prospettiva la citatissima lettera di Maria Luís Albuquerque, Commissaria ai Financial Services, del 27 marzo 2025 inviata ai vertici dell’European Financial Reporting Advisory Group: il c.d. EFRAG, in https://www.efrag.org/sites/default/files/media/document/2025-03/Commissioner%20Albuquerque%20Letter%20to%20EFRAG%20March%202025.pdf ed ancora il più recente discorso della Presidente Ursula Von der Leyen sullo stato dell’Unione 2025, che può leggersi in State of Union 2025, in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_25_2053, 10 settembre 2025, nel corso del quale si è affermata, tra l’altro, la necessità di mantenere la rotta verso gli obiettivi climatici ed ambientali, sfruttando il Fondo sociale per il clima ed è stato ricordato il pilastro europeo dei diritti sociali che otto anni fa ha sancito il diritto sociale all’alloggio in Europa, aggiungendo che è tempo di concretizzare questa promessa.
[57] Ab origine la Direttiva avrebbe potuto coinvolgere circa diciassettemila imprese: tredici mila imprese UE e quattro mila imprese extra UE. A seguito dell’entrata in vigore dell’Omnibus Package, l’effetto sistemico della CSDDD risulterà decisamente depotenziato, posto che i nuovi limiti finiranno con il circoscrivere il numero delle imprese obbligate a circa seimilanovecento, di cui seimila grandi imprese UE e novecento grandi imprese extra UE. Questi dati sono stati indicati da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sostenibilità, Governance e Finanza dell’Impresa. Impatto degli ESG con particolare riguardo alle PMI, in https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/04/CNDCEC-Sostenibilita-governance-e-finanza-dellimpresa-revised-4-2025-170425.pdf, 17 aprile 2025, 45.
[58] È sintomatico che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista al Corriere della Sera del 24 agosto 2025, abbia dichiarato che nel settore dell’automotive “il dazio maggiore è quello interno, imposto dalle folli regole del Green Deal che hanno portato alla crisi del comparto in tutta Europa, con la chiusura di interi stabilimenti e il licenziamento di decine di migliaia di operai”, aggiungendo che “occorre procedere in fretta sulla revisione del Regolamento sulla CO2, applicando il principio della piena neutralità tecnologica”.
[59] In tal senso i dati riportati da Eurostat nel 2024.
[60] Come si è avuto occasione di fare presente in altra sede, non lascia indifferenti la lista nera delle società redatta dal noto investitore istituzionale Black Rock che già nell’anno 2020 aveva individuato e “bocciato” ben duecentoquarantaquattro imprese che avrebbero “compiuto progressi insufficienti nell’integrare il rischio climatico nei rispettivi business model e informative”: a tal proposito si veda E. Rimini, Sostenibilità e nuova governance, cit., 295, nota 49. Questa linea di pensiero è stata condivisa anche nella prefazione di P. Vernero al volume, Sostenibilità, Governance e Finanza dell’Impresa. Impatto degli ESG con particolare riguardo alle PMI, in https://commercialisti.it/wp-content/uploads/2025/04/CNDCEC-Sostenibilita-governance-e-finanza-dellimpresa-revised-4-2025-170425.pdf, 17 aprile 2025, VIII.
[61] In tal senso Mario Draghi nel discorso integrale tenuto al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini in data 22 agosto 2025, il cui testo è reperibile all’indirizzo https://www.corriere.it/politica/25_agosto_22/discorso-mario-draghi-meeting-rimini-2025-7cc4ad01-43e3-46ea-b486-9ac1be2b9xlk.shtml.
[62] I virgolettati sono tratti dal poc’anzi citato discorso di Mario Draghi tenuto al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini in data 22 agosto 2025.
[63] In tal senso già M. Rescigno, Note sulle «regole» dell’impresa «sostenibile». Dall’informazione non finanziaria all’informativa sulla sostenibilità, in AGE, 1/2022, 168.
[64] Particolarmente significativo, da ultimo, è il monito di Ursula Von der Leyen, sollevato nel suo già richiamato discorso sullo Stato dell’Unione 2025, in https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_25_2053, 10 settembre 2025.
[65] Va in proposito richiamato quanto affermato da Mario Draghi al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini in data 22 agosto 2025, e cioè la necessità che l’Europa si impegni a cambiare celermente la sua organizzazione politica, visti e considerati i segni di fragilità e vulnerabilità emergenti nello scenario e assetto attuale. Su questo argomento, che ha comprensibilmente attirato l’attenzione dei mass media, si veda a titolo esemplificativo, De Bortoli, Il nuovo capitalismo. Il ritorno dello Stato, ne L’Economia del Corriere della sera, 25 agosto 2025, il quale ha, tra l’altro, ricordato il pensiero espresso da Martin Wolf secondo cui ci si dovrebbe rassegnare “al fatto che è la geopolitica che condiziona l’economia, non il contrario come nell’era iperliberista”. Ed ancora possono essere ricordate le parole della storica e premio Pulitzer Anne Applebaum, raccolte da Cremonesi, Anne Applebaum: “Trump ha convinto Putin che può vincere sul campo. Ora l’Europa è sola”, in https://www.corriere.it/esteri/25_agosto_31/anne-applebaum-intervista-ac6a1c70-2000-4444-b0c0-a5f66557fxlk.shtml, 31 agosto 2025, secondo la quale “se l’Unione europea aspira a mantenere la propria sovranità, la sua libertà, allora non necessita soltanto di una nuova strategia di difesa militare, ma anche di una propria autonoma politica estera unitaria”, ribadendo così il concetto che l’Europa dovrebbe dare manifestazioni ancora più consistenti in termini di coordinamento ed unità.