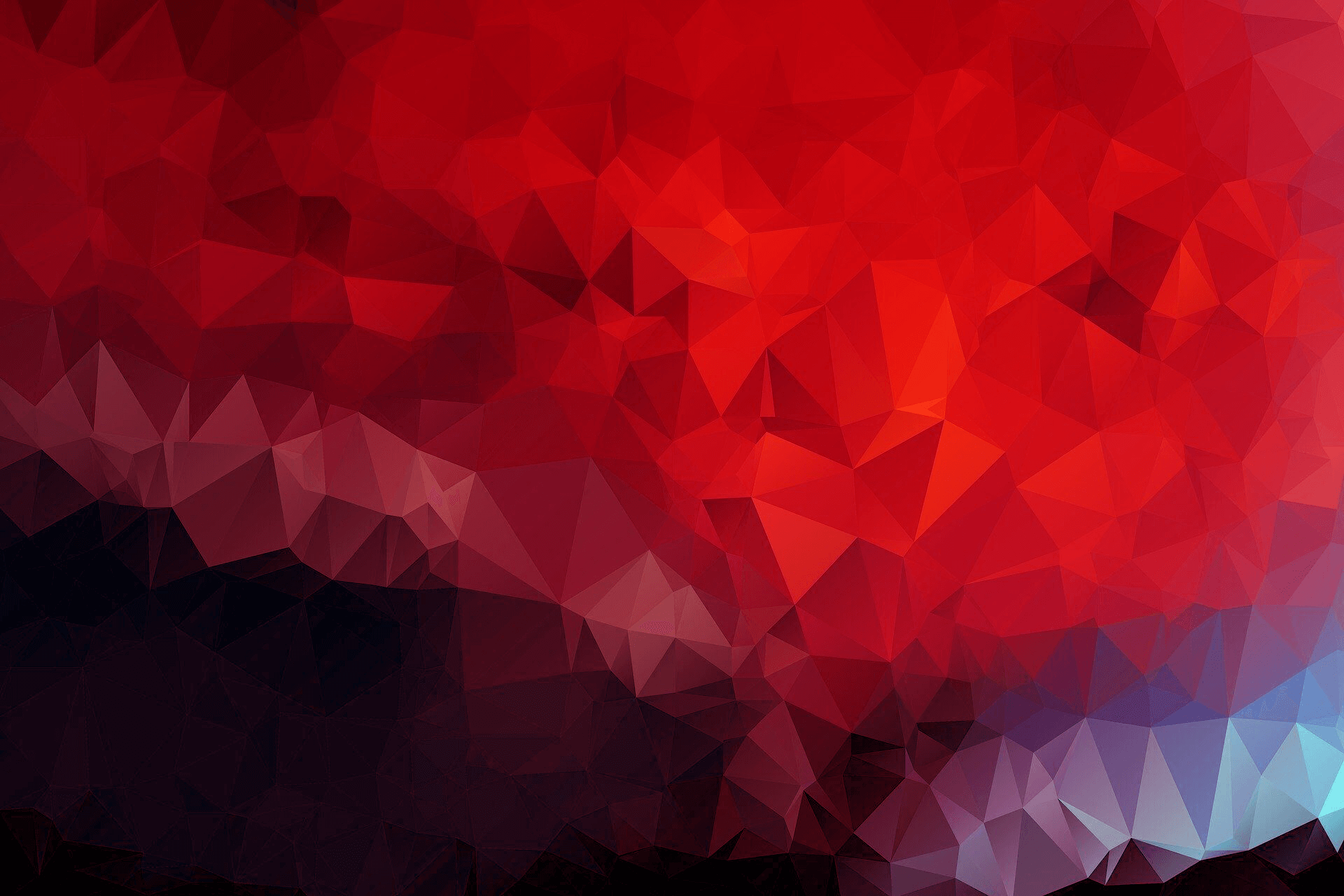Il presente contributo analizza lo scenario attuale in tema di riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato nei contratti di credito ai consumatori, a sei anni di distanza dalla nota sentenza Lexitor.
A sei anni di distanza dalla sentenza Lexitor sembra lecito dubitare che la questione della riduzione del costo totale del credito nei rimborsi anticipati dei contratti di credito ai consumatori abbia trovato una definitiva sistemazione.
1. Prologo
Si vuole descrivere lo “stato dell’arte” in materia di riduzione del costo totale del credito per il consumatore nel caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato del contratto di credito soggetto alla disciplina del: (i) Credito ai Consumatori (finanziamenti non ipotecari di importo inferiore a 75.000 Euro), o (ii) alla disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori (mutui solitamente garantiti da ipoteca immobiliare, senza limite di importo).
La materia da anni è disciplinata da direttive europee recepite nel Testo Unico Bancario, nonché da normative di rango secondario (del CICR o del Ministro dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia), e la relativa applicazione concreta è oggetto di vaglio costante da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario e della Giurisdizione ordinaria.
A partire dalla ben nota sentenza Lexitor del settembre 2019, che ha avuto un effetto dirompente sulla materia, si sono succeduti interventi del Legislatore e della Corte Costituzionale, nonché ulteriori decisioni della CGUE che, a parere di chi scrive, lungi dal costruire una disciplina chiara, sembrano dare vita a ulteriori incertezze e contenziosi.
2. Gli effetti collaterali della Lexitor nel Credito Immobiliare ai Consumatori
Sono ormai trascorsi sei anni da quando la CGUE, pronunciò in data 11 settembre 2019, la sentenza Lexitor in materia di riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato nelle operazioni di Credito ai Consumatori.
Come è ben noto, essendo stata ampiamente commentata, la sentenza Lexitor decise una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice della Repubblica di Polonia avente ad oggetto la corretta interpretazione dell’art. 16, “Rimborso anticipato”, par. 1[1], della Direttiva 2008/48/CE, del 23 aprile 2008, in materia di Credito ai Consumatori (Consumer Credit Directive, di seguito, la CCD), sancendo che: “[…] il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Di questa sentenza si vuole qui soltanto rammentare – riportandolo testualmente nella sua versione in lingua italiana – un passaggio che si ritiene particolarmente significativo per lo sviluppo delle successive considerazioni:
“24. […] la menzione della «restante durata del contratto», che compare all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto.
25. Un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione […].
26. Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte […]”.
Da quanto sopra riportato, emerge con disarmante evidenza – da una parte – l’inadeguatezza del dato normativo di partenza, ossia del tenore letterale dell’art. 16, par. 1, della CCD, che è norma di carattere evidentemente troppo programmatico, e quindi priva di un solido contenuto precettivo, inidonea per la sua stessa formulazione a dare vita – all’interno dei singoli Ordinamenti nazionali – a quella “[…] piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi”[2] e – dall’altra – il problema costituito dalle differenze linguistiche e lessicali all’interno dell’Unione.
Dell’impatto della sentenza Lexitor è importante rammentare che quanto in essa stabilito venne tempestivamente recepito dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, con l’altrettanto nota Decisione del 17 dicembre 2019, n. 26.525, secondo la quale:
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
Nella stessa Decisione il Collegio si pronunciò quindi anche sul criterio da utilizzare – nel caso specifico che gli era stato sottoposto – per il rimborso dei costi up-front, optando per quello cd. della “curva degli interessi” [3] [4].
La Banca d’Italia, dal canto suo, intervenne parimenti sulla questione, con una Comunicazione del 4 dicembre 2019, contenente “linee orientative volte a favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela”.
Con tale Comunicazione al Sistema, la Banca d’Italia specificò che: “Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte” [sottolineatura aggiunta, ndr], e che: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte” [sottolineatura aggiunta, ndr], pur avendo ricordato in una nota a piè di pagina che – in base alle ben note Definizioni – il costo totale del credito include anche le imposte, il che avrebbe meritato, a parere di chi scrive, almeno una spiegazione[5] [6].
Successivamente alla CCD era stata adottata anche la Direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, finalizzata ad agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori nello specifico settore (Mortgage Credit Directive, di seguito MCD).
Per quel che qui interessa si vuole rammentare che l’art. 25, par. 1, della MCD (che, nella versione in lingua italiana, è rubricato “Estinzione anticipata”), aveva enunciato una norma il cui tenore letterale era – ed è – sostanzialmente coincidente con quello dell’art. 16, par. 1, ultimo periodo, della CCD.
Poiché in Italia il disposto dell’art. 16, par. 1, della CCD, era stato recepito con l’art. 125-sexies, comma 1, TUB[7], il nostro Legislatore, nel recepire la MCD, attuò il recepimento di quanto disposto dall’art. 25, par. 1, della MCD, mediante l’inserimento nel TUB dell’art. 120-noviesdecies, il quale – nella sua formulazione originaria[8] (oggi modificata nel “nuovo” art. 120-noviesdecies, TUB) – si limitava a stabilire, mediante un semplice rinvio, che ai contratti di credito soggetti alla specifica disciplina MCD[9], si dovesse applicare – tra gli altri – anche il vecchio articolo 125-sexies, comma 1, dettato nell’ambito della disciplina CCD[10].
In altre parole, nel 2016, il Legislatore italiano, prendendo evidentemente atto della sostanziale coincidenza tra la norma enunciata dall’art. 25, par. 1, della MCD e quella già in precedenza enunciata dall’art. 16, par. 1, della CCD, ritenne – puramente e semplicemente – di stabilire che all’estinzione anticipata dei contratti di credito MCD si dovesse applicare la stessa norma di legge a suo tempo introdotta nel TUB, per il rimborso anticipato dei contratti di credito CCD[11].
La seguente tabella permette di dare – anche visivamente – conto di ciò:
| Art. 16, par. 1, della Direttiva
2008/48/CE (CCD) Rimborso anticipato |
Art. 25, par. 1, della Direttiva
2014/17/UE (MCD) Estinzione anticipata |
| 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto | 1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto |
| Vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB
(vigente fino al 24-7-2021) Attuativo dell’art. 16, par. 1 della CCD |
Vecchio art. 120-noviesdecies, TUB
(vigente fino al 24-7-2021) Attuativo dell’art. 25, par. 1 della MCD |
| 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. […] | 1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1. |
Dalla tabella comparativa di cui sopra emerge quindi con chiarezza che:
- la regola enunciata dall’art. 25, par. 1, ultimo periodo, della MCD, coincide sostanzialmente con quella enunciata dall’a 16, par. 1, ultimo periodo, della CCD[12] [13] [14];
- il vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB, riproduceva sostanzialmente l’a 16, par. 1, ultimo periodo, della CCD[15];
- il vecchio art. 120-noviesdecies, TUB, disciplinava l’estinzione anticipata delle operazioni MCD mediante un puro e semplice rinvio al vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB.
Si vuole con ciò evidenziare anche che, una volta affermato in via generale il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, le ulteriori espressioni letterali utilizzate dal Legislatore (sia europeo, sia italiano), anche se lievemente diverse tra loro (“che comprende gli interessi e i costi dovuti”; “che riguarda gli interessi e i costi dovuti”; “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti”; “per la restante durata del contratto”; “per la vita residua del contratto”), non consentono di desumere principi e/o regole e/o criteri sostanzialmente differenti tra le due discipline, comunitarie e nazionali[16] [17].
Può essere altresì opportuno ricordare che l’art. 3, della CCD enunciava le Definizioni di: “costo totale del credito per il consumatore”; di “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” e di “importo totale del credito” [18], e che anche l’art. 4, della MCD ha enunciato Definizioni di: “importo totale del credito”; “costo totale del credito per il consumatore”; e di “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare”, mediante un rinvio testuale a quelle analoghe già enunciate nell’art. 3, della CCD integrate da precisazioni connesse alla natura immobiliare delle operazioni creditizie[19].
Nella disciplina del Credito ai Consumatori, all’art. 121, comma 1, TUB, le lett. e), e g), riportavano le Definizioni del “costo totale del credito” e di “importo totale del credito”[20], laddove nella disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori, le medesime Definizioni sono riportate nell’art. 120-quinquies, TUB, al comma 1, lett. d), ed f).
Inoltre, il medesimo art. 120-quinquies, TUB, al successivo comma 2, specifica che:
“2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della valutazione dei beni se essa è necessaria per ottenere il credito [sottolineatura aggiunta, ndr]. Sono esclusi i costi di [sic, ndr] connessi con la trascrizione dell’atto di compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’inadempimento degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.
Dal rinvio operato dal vecchio art. 120-noviesdecies, TUB, al vecchio art.125-sexies, comma 1, TUB, doveva necessariamente derivare che – anche nel caso di estinzione anticipata di un contratto di credito MCD – il consumatore avrebbe avuto: “[…] diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con l’ulteriore corollario che, per queste operazioni, nel costo totale del credito, sarebbero stati da ricomprendere, per espressa previsione di legge, anche i “costi della valutazione dei beni” (ossia le spese di perizia del bene immobile), e naturalmente anche le imposte, in quanto già ricomprese nella Definizione di costo totale del credito nell’ambito della disciplina CCD.
Tali voci di costo, costantemente e pacificamente ritenute di tipo up-front, non erano mai state ritenute rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto di credito MCD.
A fronte di un tale contesto normativo, all’indomani della pubblicazione della sentenza Lexitor apparve chiaro a molti che, sebbene la stessa fosse stata resa in relazione all’art. 16, par. 1, della CCD, (e non anche in relazione all’art. 25, par. 1, della MCD), esisteva la concreta possibilità che l’Arbitro Bancario Finanziario, nonché il Giudice ordinario – tenendo presenti le sottostanti analoghe esigenze di tutela del consumatore perseguite dal Legislatore europeo, nonché le coincidenti testuali previsioni normative riscontrabili nella CCD e nella MCD (nonché nelle relative discipline nazionali di attuazione) – potessero ritenere che l’ambito applicativo del principio di diritto Lexitor, fosse da estendere (si sarebbe tentati di dire: automaticamente), anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD[21] [22].
Appare pertanto sorprendente che né l’Avvocato Generale della CGUE Gerard Hogan, nelle Conclusioni presentate in data 23 maggio 2019, nella controversia Lexitor, né la stessa CGUE nella conseguente sentenza, svolsero considerazioni relative alla sostanziale coincidenza di ratio legis e di tenore letterale delle due direttive CCD e MCD, per porsi almeno il dubbio che quanto detto a proposito dell’una, avrebbe potuto (o avrebbe senz’altro dovuto), avere – si direbbe: “automaticamente” – ripercussioni anche sull’altra.
Detto in altre parole si ha l’impressione che la CGUE nel rendere l’interpretazione autentica dell’art. 16, par. 1, della CCD, non si sia resa conto di un importante effetto collaterale, ossia quello di rendere – ma evidentemente senza volerlo – anche l’interpretazione autentica dell’art. 25. par. 1, della MCD.
3. Decisioni dell’ABF
Il Collegio ABF di Napoli, con la Decisione del 9 ottobre 2020, n. 17.588, escluse la possibilità di applicare il principio di diritto Lexitor in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito MCD: “È bene rimarcare, innanzi tutto, il fatto che la richiamata sentenza della Corte di Giustizia si riferisce esclusivamente alla prima delle due direttive più volte citate e che, dunque, non può postularsene la diretta ed automatica applicazione anche alla seconda, a quella cioè sul credito immobiliare al consumatore […] la non perfetta coincidenza tra i due testi normativi induce a dubitare che le conclusioni raggiunte in tema di credito ai consumatori a seguito dell’arresto della Corte di Giustizia del 2019 possano essere riproposte negli stessi termini per la fattispecie in esame”.
Il Collegio ABF di Bari, con la Decisione del 12 novembre 2020, n. 20.119, affermò il contrario: in quest’ultima Decisione venne infatti precisato che: “Sul punto, il Collegio ritiene che quand’anche la richiamata decisione della Corte di Giustizia si riferisca espressamente alla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, i principi di diritto espressi nella sentenza Lexitor siano applicabili anche alla Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE). Molteplici sono infatti le indicazioni che collocano la seconda Direttiva, quella sul credito immobiliare ai consumatori, in continuità logica con la prima Direttiva relativa al credito ai consumatori”.
Tali Decisioni erano comunque state precedute da diverse altre Decisioni ABF (cronologicamente precedenti la sentenza Lexitor), che – sulla base della sola circostanza che il Cliente fosse un consumatore e con argomentazioni che non sembrano del tutto condivisibili – “menzionavano” il principio enunciato dal vecchio art. 125-sexies, TUB (in ambito CCD), anche in controversie relative a “mutui immobiliari”[23] – per lo più di credito fondiario ex art. 38 e ss., TUB, e indicizzati al Franco svizzero – stipulati ed estinti in epoca precedente all’entrata in vigore della MCD (in tal senso: ABF Bologna n. 11.702/2017; Milano n. 2.119, n. 10.183 e n. 27.090/2018; Palermo n. 12.908/2018; Napoli n. 20.437/2018).
Altre Decisioni dell’Arbitro, in analoghe fattispecie, evidenziarono che: “[…] i principi sopra enunciati trovano applicazione in relazione alle sole operazioni di credito al consumo con cui i consumatori finanziano la loro spesa corrente (non a caso l’art. 125 sexies del D. Lgs. 385 del 1993, che è la norma cardine di tale disciplina, è ricompresa nel Capo del Titolo VI relativo al Credito ai consumatori), di talché non può invocarsene l’applicazione all’operazione oggetto di controversia, qualificabile invece come mutuo fondiario (sebbene anche nelle operazioni di finanziamento che esulano dal credito al consumo si ponga in via teorica un problema di ingiustificato arricchimento dell’intermediario su cui la resistente nulla ha argomentato)”; così ABF Napoli n. 24.594/2018; ma v. anche n. 5.509/2019; Bari n. 21.102/2018 e Collegio di Roma n. 1.350/2019; tali Decisioni correttamente (a parere di chi scrive), avevano escluso l’applicabilità del vecchio art. 125-sexies, TUB, ai “mutui immobiliari” stipulati ed estinti precedentemente alla MCD.
L’orientamento dell’Arbitro non è sembrato condivisibile neppure nel caso di “mutui immobiliari” stipulati precedentemente all’entrata in vigore della MCD ed estinti nel vigore della MCD stessa; emblematica la Decisione del Collegio di Napoli del 10 ottobre 2018, n. 21.049, dove si legge: “Preliminarmente si rappresenta che, in base a quanto letteralmente statuito dall’art. 122 lett. f) TUB la disciplina di cui al Capo II Titolo VI TUB (credito ai consumatori) non è applicabile alla fattispecie in questione. Purtuttavia, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, l’orientamento di questo Arbitro (e v. Collegio di Bologna, decisione n. 11702/17) milita nel senso dell’applicazione di quanto statuito dall’art. 125-sexies TUB anche a fattispecie analoghe a quella in esame”; ma sulla scia di questo approccio, v. anche ABF Bologna, n. 21.075/2018 e n. 12.023/2019; Roma n. 4.755/2019; Milano n. 5.729/2019; Napoli n. 8.382/2019[24] e 14.918/2019).
Sulla base di tali precedenti, dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor, furono poi assunte altre Decisioni, tutte nel senso della non applicabilità del principio di diritto Lexitor ai contratti di credito MCD.
In sostanza, alcune controversie sottoposte all’ABF avevano per oggetto la pretesa del ricorrente di ottenere l’applicazione del principio di diritto Lexitor all’estinzione anticipata di mutui a lungo termine con garanzia ipotecaria (normalmente, “mutui casa” soggetti alla disciplina del credito fondiario, quindi non soggetti alla disciplina CCD), il cui contratto era peraltro stato stipulato precedentemente all’introduzione della MCD (quindi, contratti non soggetti alla disciplina MCD), e in qualche caso addirittura estinti prima dell’introduzione della MCD stessa.
In tali fattispecie i ricorrenti, dopo aver estinto anticipatamente un “mutuo immobiliare”, e – normalmente – ottenuto il rimborso pro quota degli oneri assicurativi pagati anticipatamente ma “non goduti”, avevano poi chiesto alla Banca – a seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor – la restituzione della quota parte di oneri asseritamente non maturati a seguito dell’estinzione anticipata (principalmente, ma non solo, commissioni di istruttoria e spese di perizia), che – ove valutati con il metro di giudizio ante Lexitor – avrebbero avuto pacificamente natura di costi up-front e come tali “non rimborsabili”.
In tali controversie l’ABF ha negato che il principio di diritto Lexitor fosse applicabile alle estinzioni anticipate di questi contratti, argomentando però – e ciò appare nuovamente opinabile – dalla non perfetta coincidenza degli interessi tutelati dalle due Direttive europee CCD e MCD (Collegio di Napoli n. 1.753, del 21 gennaio 2021[25]; n. 1.887, del 22 gennaio 2021; n. 5.853 del 4 marzo 2021).
Su un piano diverso si collocano le Decisioni del Collegio di Roma del 12 marzo 2021, n. 6.901, e del Collegio di Palermo del 11 agosto 2021, n. 18.803; nella prima – relativa a una controversia relativa ad un mutuo di credito fondiario stipulato il 20 gennaio 2011 ed estinto anticipatamente il 15 luglio 2011 – si legge che: “ […] occorre osservare l’inapplicabilità al caso in esame della disciplina […] del […] credito ai consumatori e in particolare dell’articolo 125-sexies […] Essendo stato stipulato nel 2011, il finanziamento oggetto del ricorso non può nemmeno essere ricompreso nell’ambito di applicazione del […] credito immobiliare ai consumatori. Non può quindi trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 120-noviesdecies del TUB, che prevede che ‘1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli […] 125-sexies, comma 1’”; nella seconda – parimenti relativa ad un mutuo di credito fondiario stipulato il 26 novembre 2015 ed estinto anticipatamente il 17 marzo 2017, l’Arbitro ha evidenziato che: “[…] il finanziamento non potrebbe essere qualificato come credito al consumo. Il rapporto in esame, dunque, va inquadrato nell’ambito di applicazione del […] Credito Immobiliare ai Consumatori, introdotto […] in data posteriore alla stipula del contatto ma anteriore alla sua anticipata estinzione […]. Alla luce della sopra riportata disciplina, risulta applicabile, al caso di specie, seppur indirettamente, l’art. 125-sexies T.U.B. introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010. Tuttavia, la questione che qui è sollevata da parte ricorrente è se al contratto controverso (mutuo fondiario ipotecario), rientrante nella disciplina predetta, siano applicabili i princìpi espressi dalla nota sentenza c.d. “Lexitor” […]. A tale quesito i Collegi territoriali hanno fornito risposta negativa sia nei casi, come quello di specie, in cui il mutuo ipotecario sia stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore del Capo I bis del Titolo VI del T.U.B., introdotto con d.lgs. 21.4.2016, n. 72, sia nei casi in cui il mutuo sia stato estinto successivamente alla sua entrata in vigore. Secondo il costante orientamento dei Collegi ABF, infatti, ‘la […] sentenza della Corte di Giustizia si riferisce esclusivamente alla direttiva 2008/48/CE e non è perciò corretto, sul piano formale, postularne sic et simpliciter la diretta ed automatica applicazione anche alla direttiva 2014/17/UE, sul credito immobiliare al consumatore’ (cfr. Coll. Napoli, n. 1753/2021). Ne discende, pertanto, che non potendosi applicare al caso in esame i principi formulati nella nota sentenza ‘Lexitor’, così come invece espressamente richiesto da parte ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento”.
In relazione a tali Decisioni sembra quindi plausibile evidenziare quella che potrebbe essere stata una “svista” da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario, che in esse sembra non aver tenuto conto di una ben precisa norma di legge (salvo poi farne un utilizzo “distorto” in altre Decisioni).
Si vuole con ciò evidenziare che già nella Decisione del Collegio di Bari, del 21 dicembre 2020, n. 23.408, era stata menzionata la norma di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, attuativo della MCD, la quale aveva stabilito che: “[…] le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”; tale norma di diritto intertemporale era (ed è), chiaramente finalizzata a rendere inapplicabile (tutta) la disciplina della MCD alle operazioni di “mutuo immobiliare” stipulate precedentemente ad essa[26].
Si vuole quindi evidenziare che a queste operazioni creditizie, che non erano sottoposte né alla CCD, né alla MCD (quindi: “operazioni non CCD e non MCD”), il vecchio art. 120-noviesdecies, TUB – che rimandava al vecchio art. 125-sexies, TUB – risultava del tutto inapplicabile, il che escludeva “in radice” il problema dell’applicabilità, o meno, del principio di diritto Lexitor a queste fattispecie. A queste “operazioni non CCD e non MCD” non era parimenti applicabile neppure la disposizione contenuta nell’originario articolo 125, comma 2, TUB, vigente dal 1° gennaio 1994, in materia di Credito al Consumo.
Non è francamente chiaro il motivo per il quale i Collegi ABF – anziché escludere l’applicabilità del principio di diritto Lexitor alle “operazioni non CCD e non MCD” sulla base della predetta norma di legge – abbiano scelto la strada ben più insidiosa e opinabile di delineare ipotetiche differenze tra le due normative europee CCD e MCD che – se esistono in relazione alla tipologia delle operazioni creditizie interessate – ben difficilmente si traducono – a parere di chi scrive – in esigenze diverse di tutela del consumatore.
4. La reazione maldestra del Legislatore: l’articolo 11-octies del D.L. 73/2021
A seguito dello stravolgimento provocato dalla sentenza Lexitor sulla situazione che si era – più o meno pacificamente – consolidata negli anni precedenti in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito CCD[27] ed anche in considerazione del rischio che – in sede arbitrale o giudiziale – il principio di diritto Lexitor fosse ritenuto applicabile anche all’operatività MCD, il nostro Legislatore intervenne – peraltro non tempestivamente – con la Legge 23 luglio 2021, n. 106 – di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, conosciuto come “Decreto Sostegni-bis” – introducendo, nello stesso DL n. 73/2021, l’art. 11-octies, contenente modificazioni al TUB[28].
Con le modificazioni apportate al TUB, la materia ha ricevuto un nuovo assetto:
- il testo del vecchio art. 125-sexies, è stato modificato (oggi è quindi vigente un nuovo art. 125-sexies);
- il rinvio operato dal vecchio art. 120-noviesdecies, TUB, al vecchio art. 125-sexies, TUB, è stato eliminato, in modo tale che ad oggi, il nuovo art. 125-sexies, si applica soltanto ai rimborsi anticipati dei contratti di credito CCD e non è applicabile ai contratti di credito MCD;
- infine il rimborso anticipato[29] dei contratti di credito MCD è stato disciplinato mediante l’introduzione di una specifica previsione, contenuta in un nuovo a 120-quaterdecies.1, con regole – almeno apparentemente – diverse da quelle enunciate in ambito CCD dal nuovo art. 125-sexies.
In particolare, per quel che qui rileva, il nostro Legislatore ha riformulato – sostituendolo – il vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB, introducendo il nuovo art. 125-sexies, TUB, che recita:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Inoltre, mediante un’espressa previsione normativa contenuta nel secondo comma, del predetto art. 11-octies, del DL 73/2021, era stato altresì stabilito che:
“L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, […], come sostituito dal […] presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” [sottolineatura aggiunta, ndr].
Con lo stesso art. 11-octies, del DL 73/2021, oltre a introdurre il nuovo art. 125-sexies, TUB, il nostro Legislatore ha modificato anche la disciplina dell’estinzione anticipata (d’ora in poi: rimborso anticipato), dei contratti di credito MCD.
Ad oggi quindi il nuovo art. 120-quaterdecies.1, “Rimborso anticipato”, stabilisce che:
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” [sottolineatura aggiunta, ndr].
Nella documentazione parlamentare di cui è stato possibile prendere visione, appare del tutto sorprendente riscontrare come il Legislatore – a fondamento delle modificazioni apportate – non abbia addotto la necessità di recepire il principio di diritto Lexitor nella nostra disciplina del Credito ai Consumatori (e del Credito Immobiliare ai Consumatori), quanto piuttosto la necessità di: “[…] rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica”[30].
A tutto voler concedere, in effetti, la normativa emanata sarebbe volta a rendere certe e trasparenti non le condizioni di “accesso”, ma le condizioni di rimborso anticipato, quindi le condizioni di “uscita” dalle operazioni creditizie (non solo di Credito ai Consumatori ma anche di Credito Immobiliare ai Consumatori); non si vede poi – in tutta franchezza – la presenza di un nesso così stringente con gli effetti economici dell’emergenza epidemiologica.
Al di là di tale opinabile affermazione di principio, appare ragionevole ipotizzare, in mancanza di specifici chiarimenti in tal senso, che il Legislatore:
- da una parte, abbia inteso recepire il principio di diritto Lexitor[31], ma al contempo circoscrivendone l’ambito applicativo ai soli rimborsi anticipati dei contratti di credito CCD di nuova stipulazione, ossia facendo salva – per i rimborsi anticipati già effettuati o da effettuare in futuro in relazione a contratti di credito CCD stipulati fino al 24 luglio 2021 compreso – l’applicazione della disciplina previgente, di rango sia primario (vecchio art. 125-sexies), che secondario, con particolare riferimento alle “disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”, che distinguevano tra costi up-front e costi recurring[32] [33]; ciò all’evidente scopo di bloccare sul nascere il potenziale contenzioso riguardante il passato[34] [35] [36] [37].
- dall’altra, abbia voluto “differenziare” la disciplina applicabile al rimborso anticipato dei contratti di credito MCD da quella applicabile nell’ambito CCD, nell’intento – si ripete, presumibile – di “separarne le sorti” e di destituire quindi di fondamento quegli orientamenti interpretativi (dottrinali e/o giurisprudenziali), già manifestatisi e tendenti a ritenere il principio di diritto Lexitor applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD[38] [39].
A margine di tale constatazione, sembra però opportuno tenere in debita considerazione anche quanto di seguito esposto.
Il vecchio art. 125-sexies, TUB, come detto, era attuativo dell’art. 16, par. 1, della CCD; il nuovo art. 125-sexies, TUB – entrato in vigore dal 25 luglio 2021, per i rimborsi anticipati dei contratti di credito CCD di nuova stipulazione – deve intendersi pur sempre attuativo del medesimo art. 16, par. 1, della CCD, tenendo conto però del principio di diritto Lexitor; sembra pertanto utile riportare nella tabella seguente i detti testi normativi – unitamente al principio di diritto Lexitor – per un immediato raffronto letterale:
| Art. 16, par. 1, della
Direttiva 2008/48/CE (CCD) |
Vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB (vigente fino al 24-7-2021)
Attuativo dell’art. 16, par. 1, della CCD |
| 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto | 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. |
| Principio di Diritto Lexitor | Nuovo art. 125-sexies, comma 1, TUB
(vigente dal 25-7-2021) Attuativo dell’art. 16, par. 1 della CCD e del Principio di Diritto Lexitor |
| “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE […], deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” | 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. |
| Art. 11-octies, comma 2, del DL 73/2021 |
| “L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, […], come sostituito dal […] presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” |
La disamina comparativa fin qui condotta tra l’art. 16, par. 1, della CCD, e le due versioni – vecchia e nuova – dell’art. 125-sexies, TUB, vuole porre in evidenza che il comma 1, del nuovo art. 125-sexies, non sembra in realtà enunciare – da un punto di vista strettamente letterale – una norma radicalmente e/o sostanzialmente diversa da quella del comma 1, del vecchio art. 125-sexies, e che entrambi in realtà riproducono quasi pedissequamente il tenore letterale dell’art. 16, par. 1, della CCD[40].
Il recepimento del principio di diritto Lexitor sarebbe stato quindi attuato dal Legislatore sostanzialmente stabilendo che la riduzione del costo totale del credito – che in origine era “pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con implicita “esclusione” quindi degli interessi e dei costi “dovuti” per la fase precedente (e quindi, in particolare, dei costi up-front, che restavano così definitivamente acquisiti dal finanziatore) – oggi deve essere comprensiva “degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, pur dovendo essere proporzionale “alla vita residua del contratto”.
A parere di chi scrive, ciò che soprattutto sembra differenziare la regola enunciata dal nuovo art. 125-sexies, rispetto a quella enunciata dal vecchio, non è tanto il modo in cui essa è scritta, quanto la consapevolezza che essa sarebbe stata scritta dal Legislatore tenendo conto del principio di diritto Lexitor e inoltre il fatto che il nostro Legislatore ha stabilito un criterio di diritto transitorio, in forza del quale il nuovo art. 125-sexies, TUB, si sarebbe dovuto applicare ai contratti di credito sottoscritti dal 25 luglio 2021 in poi, mentre ai rimborsi anticipati dei contratti di credito sottoscritti in precedenza si sarebbe dovuto continuare ad applicare le disposizioni del vecchio art. 125-sexies e delle norme secondarie della Banca d’Italia, con la volontà di “ripristinare” – relativamente ai contratti di credito “in corso” alla data del 24 luglio 2021 – la distinzione tra costi up-front (non rimborsabili), e costi recurring (rimborsabili), distinzione che era stata viceversa “superata” dalla sentenza Lexitor.
Sostanzialmente il nostro Legislatore, nel modificare l’articolo 125-sexies, TUB, volle sancire l’ultrattività della previgente versione dell’articolo stesso, sebbene le differenze lessicali tra le due versioni – vecchio e nuovo – non conducano ad interpretazioni sostanzialmente diverse; la differenza risiede quindi non nel mero tenore letterale del nuovo art. 125-sexies, TUB, ma nel fatto che, nel vigore della formulazione originaria (comunque conforme all’art. 16, par. 1, CCD), le norme secondarie della Banca d’Italia sancivano la distinzione tra costi up-front e costi recurring, (in un modo quindi che a posteriori è risultato non conforme al principio di diritto Lexitor), e l’art. 11-octies, comma 2, intendeva fare salve tali norme secondarie per il pregresso, mentre la formulazione attualmente vigente del nuovo art. 125-sexies, TUB (sostanzialmente – a parere di chi scrive – uguale alla precedente), deve essere interpretata alla luce del principio di diritto Lexitor e applicata senza più tener conto delle norme secondarie della Banca d’Italia di cui sopra.
La tecnica adottata dal Legislatore del DL 73/2021 è sembrata dare vita anche ad un problema di diritto intertemporale.
Acutamente Natale M., op. cit., ha segnalato che: “[…] diversamente dalla tecnica di redazione impiegata per il credito ai consumatori, nel settore del credito immobiliare il legislatore non risolve espressamente il problema circa l’applicabilità dei princìpi Lexitor per i contratti sottoscritti ed estinti anticipatamente. Se per il nuovo art. 125-sexies TUB è prevista espressamente una disposizione intertemporale finalizzata ad evitare l’applicazione retroattiva della sentenza della corte di giustizia, per il credito immobiliare nulla è specificato sul punto”.
In effetti, come già messo in evidenza, le originarie disposizioni in materia di Credito Immobiliare ai Consumatori avevano stabilito che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito MCD, doveva ritenersi soggetta al vecchio art. 125-sexies, TUB, per effetto del rinvio ad esso operato dal vecchio art. 120-noviesdecies, TUB. Nel momento in cui il Legislatore ha introdotto il nuovo art. 120-quaterdecies.1, avrebbe dovuto precisare se il rimborso anticipato dei contratti di credito MCD in essere alla data del 25 luglio 2021 sarebbe rimasto disciplinato dal vecchio art. 125-sexies, TUB (ossia, secondo quanto sostanzialmente previsto per i contratti di credito CCD), oppure se – a seguito dell’introduzione dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB – sarebbe stata quest’ultima norma a dover essere applicata.
Come è infatti noto – in mancanza di una previsione di diritto intertemporale – l’applicazione dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB, anche in relazione ai rimborsi anticipati dei contratti di credito MCD già in essere alla data del 25 luglio 2021, sarebbe del tutto plausibile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale si è affermata: “[…] l’applicabilità della norma sopravvenuta ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla legge ed ancora pendenti, che ben possono essere disciplinati – sotto il profilo degli effetti – della legge successiva. Il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 preleggi, implica, secondo l’orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, che la legge nuova può applicarsi ad effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando essa sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia generati” [41].
In effetti, i veri elementi di novità del nuovo art. 125-sexies, rispetto al vecchio, non si trovano quindi nel comma 1, quanto piuttosto nei successivi commi 2 e 3, i quali stabiliscono che:
“2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”.
Queste previsioni sono infatti del tutto nuove rispetto al testo del vecchio art. 125-sexies.
In questa sede non è possibile dilungarsi sul comma 2, del nuovo art. 125-sexies, concernente l’introduzione di un obbligo di esplicitazione del criterio da utilizzare per la riduzione del costo totale del credito e con la regola di applicare, per default, quello del “costo ammortizzato”, per il quale si rimanda alle osservazioni di altri Autori[42] [43] [44][45], ma ci si limita a esporre che – secondo quanto evidenziato da qualche Autore – il criterio del “costo ammortizzato” non coinciderebbe con il criterio della “curva degli interessi” [46].
Neppure è qui di interesse la previsione del comma 3, del nuovo art. 125-sexies, sul diritto di regresso del finanziatore nei confronti dell’intermediario del credito, ma anche questa previsione è stata oggetto di ampi commenti critici da parte di vari Autori[47] [48] [49] [50].
Comunque sia, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies, a partire dal 25 luglio 2021 le Banche furono legittimate ad opporre alla Clientela interessata la diversità di trattamento stabilita per legge a seconda che il rimborso anticipato riguardasse un contratto di credito CCD (od anche MCD), sottoscritto precedentemente o successivamente al 25 luglio 2021.
Tuttavia questo tentativo del Legislatore italiano – espletato in un modo che si potrebbe definire “sotterraneo” e ad oltre 22 mesi di distanza dalla sentenza Lexitor – di dirimere nel modo suddetto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale determinatosi a seguito della sentenza Lexitor, si pose con ogni evidenza e fin da subito in relazione problematica con il principio di diritto Lexitor[51] [52].
Una nota Sentenza del Tribunale di Savona (la n. 680, del 15 settembre 2021), evidenziò infatti sin da subito che gli elementi di reale ed effettiva novità del nuovo art. 125-sexies, TUB – rispetto al vecchio – erano costituiti quasi esclusivamente dalle previsioni contenute nei commi 2 (che impone di indicare nel contratto di credito i criteri da utilizzare per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, optando tra quello della “proporzionalità lineare” e quello del “costo ammortizzato”), e 3 (sul diritto di regresso – salvo patto contrario – del finanziatore nei confronti dell’intermediario del credito), restando sostanzialmente invariato il resto, con particolare riferimento quindi al comma 1, che già sanciva, anche nel vecchio art. 125-sexies, secondo l’interpretazione datane dalla sentenza Lexitor, il diritto del consumatore al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti.
In conseguenza della sostanziale “invarianza” del comma 1, del nuovo art. 125-sexies, TUB, rispetto al vecchio, la previsione di legge sulla “ultrattività” delle “[…] norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia […]” si sarebbe posta: “[…] in contrasto con la normativa europea e con la giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia”, con l’effetto pratico – nel caso concreto sottoposto al Tribunale di Savona – che il principio di diritto Lexitor doveva essere ritenuto applicabile anche al rimborso anticipato di un contratto di credito sottoscritto prima del 25 luglio 2021; il Tribunale concluse infatti affermando che: “[…] o si ritiene che del nuovo art. 125 sexies TUB sia possibile un’interpretazione conforme alla normativa europea ed alla giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia […] oppure a fronte dell’evidente contrasto fra diritto interno e diritto unionale non potrebbe che procedersi alla parziale disapplicazione dell’art. 11 octies […]”.
I Collegi territoriali dell’ABF, dopo qualche tentennamento, si allinearono all’orientamento sancito dal Collegio di Coordinamento con la Decisione del 15 ottobre 2021, n. 21.676, secondo il quale – in applicazione della norma di legge vigente – il principio di diritto Lexitor si sarebbe dovuto applicare soltanto ai rimborsi anticipati dei contratti di credito sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021, ponendo così un “blocco” al potenziale contenzioso[53].
La Banca d’Italia dal canto suo, con un ulteriore comunicato del 3 dicembre 2021 – con il quale, dando atto di quanto disposto dall’art. 11-octies, del DL 73/2021, aveva reputato “che le proprie ‘linee orientative’ del 4 dicembre 2019 siano da considerarsi superate dal disposto della nuova previsione di legge” – comunicò altresì che: “[…] con ordinanza del 2 novembre scorso il Tribunale di Torino ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 11-octies, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, con conseguente trasmissione degli atti del processo alla Corte costituzionale, muovendo dal doppio rilievo circa l’impossibilità dell’interpretazione conforme del disposto di legge alla sentenza “Lexitor” e, nel contempo, dell’assenza delle condizioni per applicare in via diretta la norma UE disapplicando la norma di diritto interno che risulti incompatibile con la prima”[54].
E’ anche da rammentare che a seguito della rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del DL 73/2021, la Conferenza dei Collegi dell’ABF, riunitasi in data 17 novembre 2021, convenne: “[…] che non sussistano i presupposti per sospendere la trattazione dei ricorsi pendenti presso l’ABF in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori”, e che: “[…] a tali ricorsi continuino a essere applicabili i principi stabiliti dal Collegio di coordinamento con la decisione nr. 21676/21, con la quale è stato chiarito che, per i contratti sottoscritti antecedentemente all’entrata in vigore della nuova normativa, gli oneri retrocedibili al consumatore in conseguenza del rimborso anticipato del finanziamento sono limitati ai costi recurring, con esclusione di quelli up-front”.
5. L’intervento della Corte Costituzionale
Investita, come detto, della questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Torino, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263, del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del DL 73/2021, limitatamente alle parole: “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”; sostanzialmente, tale pronuncia – attraverso un percorso logico-giuridico molto articolato e per certi versi complesso[55] – ebbe l’effetto di annullare il tentativo del Legislatore italiano di “sterilizzare” gli effetti della sentenza Lexitor per il periodo precedente il 25 luglio 2021.
A seguito di tale declaratoria di illegittimità costituzionale, il principio di diritto Lexitor poté (nuovamente) dispiegare tutti i suoi effetti, e – avendo valenza retroattiva – deve essere applicato a tutti i rimborsi anticipati, indipendentemente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di credito, legittimando così tutti quei consumatori che avevano effettuato rimborsi anticipati – anche se in passato – a pretendere dai finanziatori i rimborsi attinenti ai costi up-front, a suo tempo ritenuti non rimborsabili.
Ai fini del presente scritto, si richiamano i seguenti passaggi del pronunciamento della Corte Costituzionale, anche questo ormai ampiamente commentato:
“9.3.– Nei primi anni di applicazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, l’interpretazione della disposizione, accolta dalla giurisprudenza di merito e dall’ABF, ha visto riferire il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), con esclusione di quelle relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). […] si ritengono recuperabili i costi riferiti a prestazioni che conferiscono utilità collegate con la durata del contratto e, per converso, irripetibili costi relativi a prestazioni, la cui giustificazione causale abbia già trovato compimento. A fronte della distinzione fra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, nella realtà sono emerse condotte abusive nella qualificazione e nella imputazione dei costi; a esse l’ABF ha reagito – nelle sue decisioni – prevedendo che, a fronte di condotte poco trasparenti, in sede di predisposizione delle condizioni contrattuali, si sarebbero dovuti ritenere rimborsabili tutti i costi le cui ragioni fossero state opacamente manifestate. […].
9.5.- La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell’ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia.
In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). [sottolineatura aggiunta, ndr].
Si è, dunque, escluso che l’interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale.
La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l’esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. […].
12.– Chiarita la portata dei vincoli derivanti dalla sentenza Lexitor, che è stata pronunciata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, senza che fosse disposta alcuna modulazione temporale dei suoi effetti, si può ora procedere all’esame della norma censurata.
Il legislatore – come anticipato – ha sostituito, con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125-sexies t.u., bancario, riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor. Di seguito, con il comma 2, ha limitato l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
12.1.– Fra gli indici ermeneutici che evidenziano l’intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore è costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati, che continua a operare per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti, richiamo che non è, invece, previsto in relazione alla nuova formulazione della disposizione, la quale ha inteso rendere esplicita la conformità alla sentenza Lexitor.
Ebbene, il contesto oggettivo del rimando alle norme secondarie, che opera solo in rapporto al precedente art. 125-sexies t.u. bancario, e la sua delimitazione temporale, circoscritta alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti – quelli per i quali resta in vigore la formulazione antecedente dell’art. 125-sexies – guidano con precisione verso le norme secondarie che il legislatore del 2021 ha inteso richiamare.
Il riferimento è alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che ha introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, vale a dire le disposizioni che il 9 febbraio 2011 hanno emendato quelle approvate il 29 luglio 2009 (punto 9.3.). […].
12.3.1.– Il legislatore ha voluto proteggere l’affidamento che ha ritenuto ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall’interpretazione, che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d’Italia. Peraltro, ha inteso tutelare finanche chi avesse concluso il contratto dopo la pubblicazione della sentenza Lexitor.
Non sembra, viceversa, che il legislatore abbia ritenuto che un affidamento fosse stato ingenerato solo dal dato testuale della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario.
Se così fosse stato, se cioè tale disposizione avesse avuto un contenuto univoco, nel senso della possibile riduzione dei soli costi recurring, il legislatore non avrebbe dovuto precisare che per il passato continuava a operare la disposizione antecedente la novella, unitamente al contestuale doveroso rispetto delle norme secondarie, che cristallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring.
12.3.2.– In ogni caso, si deve confutare la tesi che vorrebbe affermare la netta divergenza del dato testuale del vecchio art. 125-sexies da quello dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, deducendone l’impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza Lexitor.
Innanzitutto, la distinzione fra il testo dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva e quello del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza [sottolineatura aggiunta, ndr].
Se è vero, infatti, che l’espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi» è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi», tuttavia, il perno dell’interpretazione della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali.
Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione [sottolineatura aggiunta: si tratta di argomentazioni desunte dalla Sentenza Lexitor, ndr]. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell’interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor.
12.4.– Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.
A margine del prevedibile epilogo del maldestro tentativo italiano di “aggirare” il principio di diritto Lexitor – sia pure allo scopo di evitare un nuovo filone di litigiosità Banche-Clienti – resta il dato di fatto che il consumatore che nel nostro Paese abbia cercato di far valere il suo diritto – come riconosciutogli dalla sentenza Lexitor – nel periodo compreso (con buona approssimazione), tra il 17 dicembre 2019 (data della Decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 26.525), e il 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore dell’art. 11-octies, del DL 73/2021), ha verosimilmente ottenuto ragione, mentre il medesimo consumatore che abbia agito a tutela del medesimo diritto nel periodo compreso tra il 25 luglio 2021 e il 22 dicembre 2022, si è visto – verosimilmente – negare quello stesso diritto.
6. La situazione dopo l’intervento della Corte Costituzionale
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 22 dicembre 2022, n. 263, la situazione determinatasi poteva essere riassunta come segue.
6.1. Il rimborso anticipato dei contratti di credito CCD sottoscritti prima del 25 luglio 2021, è regolato dal vecchio art. 125-sexies, TUB, ma da interpretare secondo il principio di diritto Lexitor.
Ciò comporta che laddove la norma stabiliva che il consumatore: “[…] ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, la detta riduzione del costo totale del credito avrebbe comunque dovuto includere: “[…] tutti i costi posti a carico del consumatore”, quindi sia quelli considerati di natura up-front sia quelli di natura recurring; tuttavia, stante la mancanza di una norma – europea o nazionale – per la determinazione del criterio logico-matematico da utilizzare per calcolare la riduzione del costo totale del credito, si dovrebbe ritenere tutt’ora valido quanto indicato dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con la Decisione del 17 dicembre 2019, n. 26.525, secondo la quale, in mancanza di idonee previsioni contrattuali, si dovranno adottare due diversi criteri per la determinazione degli importi da rimborsare: quello della “curva degli interessi” per i costi up-front e quello del “pro rata temporis” per i costi recurring (v. nota n. 3).
Una considerazione a margine dovrebbe essere fatta a proposito delle imposte; come si è detto, sulla base delle Definizioni formulate nell’articolo 3, della CCD e recepite nell’articolo 121, TUB, le imposte devono essere (sono) incluse nel costo totale del credito; se il consumatore ha diritto – come ha diritto – a una riduzione del costo totale del credito che deve includere: “[…] tutti i costi posti a carico del consumatore”, non si vede francamente per quale ragione dovrebbero restarne escluse le imposte[56]; se ne parlerà ancora di seguito[57].
6.2. Il rimborso anticipato dei contratti di credito CCD sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021, è regolato dal nuovo art. 125-sexies, TUB, il quale – come detto – sarebbe stato scritto dal Legislatore tenendo in debito conto il principio di diritto Lexitor, (o meglio: da interpretare secondo il principio di diritto Lexitor), con due importanti differenze; la prima è quella che il nuovo art. 125-sexies, comma 1, TUB – a differenza del vecchio – esclude espressamente la rimborsabilità delle imposte; la seconda – per quel che qui rileva – è quella enunciata dal comma 2, del nuovo art. 125-sexies, TUB, il quale stabilisce che: “2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
A commento di tale quadro normativo, si dovrebbe osservare – da una parte – che l’espressa esclusione “per legge” della rimborsabilità delle imposte (applicabile però – a rigore – soltanto ai rimborsi anticipati dei contratti di credito CCD, stipulati a partire dal 25 luglio 2021), potrebbe essere oggetto di censura, o da parte della nostra Corte Costituzionale, o dalla CGUE, ove investite della questione; dall’altra, che il criterio del “costo ammortizzato” si trova definito nella documentazione parlamentare[58] come segue: “Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore”, il che – francamente – sembra esulare dalla capacità di comprensione, non soltanto del consumatore, ma anche di molti “addetti ai lavori”.
6.3 Il rimborso anticipato dei contratti di credito MCD offre problemi interpretativi ancor più complessi.
Si è già detto al precedente par. 3, che – per effetto dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 – il problema dell’applicabilità del principio di diritto Lexitor alle estinzioni anticipate dei “mutui immobiliari” stipulati prima del 1° luglio 2016 (“operazioni non CCD e non MCD”), dovrebbe essere escluso in radice[59].
Secondo il Collegio di Bari dell’ABF, 23 maggio 2023, n. 5.008, i contratti di stipulati precedentemente alla data del 1° luglio 2016: “[…] continuano ad essere disciplinati dalle norme del testo unico bancario, oltre che da quelle del codice civile, in applicazione delle quali non può essere riconosciuto un diritto del consumatore che abbia sottoscritto un contratto di mutuo ipotecario alla riduzione del costo del finanziamento in conseguenza della sua anticipata estinzione”.
Tuttavia, in un modo che – come già detto – non risulta agevolmente comprensibile, in alcune Decisioni l’Arbitro Bancario Finanziario aveva continuato a ignorare la norma di diritto intertemporale enunciata dall’articolo 3, del D.Lgs. n. 72/2016, secondo la quale le disposizioni in materia di MCD si sarebbero dovute applicare a partire dal 1° luglio 2016 e (soltanto) ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data, mentre ai contratti sottoscritti anteriormente le dette disposizioni non si sarebbero dovute applicare.
Nella Decisione del Collegio di Napoli del 21 gennaio 2021, n. 1.753, relativa ad un mutuo di credito fondiario stipulato il 20 settembre 2010 ed estinto anticipatamente nel 2020, per il quale il ricorrente – a seguito della sentenza Lexitor – chiedeva il rimborso pro quota degli oneri up-front, l’Arbitro – inspiegabilmente – dapprima affermava che: “Va anche precisato sul punto che l’art. 120-noviesdecies Tub, per quanto inserito nel Testo unico bancario posteriormente (dall’art. 1, 2° comma, d.lgs. 72/2016 a seguito del recepimento della Direttiva “MCD” 2014/17/UE del 4.2.2014) alla stipula del contratto di mutuo fondiario in esame (20.9.2010), è comunque applicabile alla data di estinzione del contratto (14.5.2020) […]”, poi ripeteva la frase ricorrente “[…] malgrado sia ben noto il diffuso orientamento tra i Collegi di questo Arbitro incline ad applicare l’art. 125-sexies anche a fattispecie diverse dal credito ai consumatori […]” (inciso reso necessario per emendare l’approccio – si sarebbe tentati di dire: la svista – del Collegio di Bari del 12 novembre 2020, n. 20.119), giungeva infine – dopo una lunga ma disutile dissertazione – “[…] a stimare non decisive presunte esigenze di omogeneità e coerenza interpretativa fra le due Direttive che, ben lungi dal potersi predicare in astratto, esigono piuttosto specifica dimostrazione con riguardo ai singoli precetti dei due testi legislativi europei e che, almeno a prima vista, sembrano condurre, talora (ad esempio, in tema di verifica del merito creditizio), ad interpretare norme della direttiva del 2008 alla luce dei più recenti princìpi stabiliti dalla direttiva del 2014 e non viceversa” e quindi a non accogliere il ricorso.
Ugualmente a dirsi è in relazione ad altra Decisione del medesimo Collegio di Napoli del 22 gennaio 2021, n. 1.887, dove – sempre in relazione ad una analoga richiesta di rimborso pro quota delle spese di istruttoria di un mutuo di credito fondiario stipulato alla fine del 2010 ed oggetto di estinzione anticipata nel 2020 – l’Arbitro, dopo aver: “[…] premesso che lo specifico mutuo ipotecario in questione è, ad avviso del Collegio, estraneo anche alla disciplina del credito immobiliare ai consumatori […] malgrado sia ben noto il diffuso orientamento tra i Collegi di questo Arbitro incline ad applicare l’art. 125-sexies anche a fattispecie diverse dal credito ai consumatori […]” rigetta il ricorso escludendo che: “[…] le conclusioni raggiunte in tema di credito ai consumatori a seguito dell’arresto della Corte di Giustizia del 2019 e, di riflesso, dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 26525 del 17.12.2019) nell’interpretazione dell’art. 125-sexies Tub, possano essere riproposte negli stessi termini per la fattispecie in questione, ove, proprio in tema di estinzione del contratto, le parti sono libere di convenire tecniche di tutela della parte debole che tengano conto delle tipiche e contingenti istanze del mercato finanziario, non essendo l’intermediario qui affatto vincolato alla restituzione dei costi del credito sulla base della interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48/CE”. Negli stessi termini di cui sopra anche la Decisione del medesimo Collegio n. 5.853/2021.
Più correttamente il Collegio di Roma con Decisione del 22 febbraio 2021, n. 4.662, osservava che: “[…] deve rilevarsi come il contratto su cui è sorta controversia sia stato stipulato in data 14 aprile 2010. Ebbene, l’applicabilità dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB sul rimborso anticipato del finanziamento e sui diritti che ne scaturiscono in capo al soggetto finanziato anche ai rapporti di credito immobiliare ai consumatori – come quello di specie – discende, come noto, dalla introduzione nel TUB del Capo I-bis relativo proprio al Credito immobiliare ai consumatori ad opera del D. Lgs. 72 del 2016 […]. Tuttavia, ai sensi della norma di diritto transitorio di cui all’art. 3, comma 1, del suddetto D. Lgs. 72 del 2016, […] discende che il contratto oggetto di ricorso è fuori dall’ambito applicativo della norma ratione temporis e pertanto non può ritenersi fondata la pretesa del ricorrente nemmeno in relazione alla restituzione della quota non goduta delle spese di istruttoria”.
In effetti in tutte le controversie ascrivibili alla fattispecie delle “operazioni non CCD e non MCD”, sarebbe stato sufficiente tenere a mente la detta norma di diritto intertemporale per dichiarare non applicabile la normativa e i principi di diritto invocati dal ricorrente.
Per quanto riguarda l’estinzione anticipata dei contratti di credito MCD sottoscritti tra il 1° luglio 2016 e il 25 luglio 2021, chi scrive non è in grado di affermare se la stessa debba intendersi regolata dal vecchio art. 125-sexies, TUB, (per effetto del rinvio ad esso operato dal vecchio art. 120-noviesdecies, TUB), sia pure da interpretare secondo il principio di diritto Lexitor, oppure dal nuovo art. 120-quaterdecies.1, TUB; nella prima ipotesi dovrebbe essere riconosciuto il rimborso anche dei costi up-front (quindi: delle spese di istruttoria e delle spese di perizia), ed anche delle imposte, in quanto il loro rimborso è stato espressamente escluso (peraltro con norma di dubbia legittimità costituzionale), soltanto dal nuovo art. 125-sexies, TUB, quindi soltanto per i rimborsi anticipati dei contratti di credito CCD stipulati a partire dal 25 luglio 2021.
In alternativa a quanto sopra, si potrebbe ritenere che – in virtù del principio giurisprudenziale già menzionato, secondo il quale: “[…] la legge nuova può applicarsi ad effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando essa sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o fatto giuridico che li abbia generati” (Cass. n. 9972/2008) – il nuovo art. 120-quaterdecies.1, TUB, sia applicabile (debba essere applicato) anche ai rimborsi anticipati dei contratti di credito MCD sottoscritti prima del 25 luglio 2021, oltreché – ovviamente – a quelli sottoscritti dopo tale data.
Sennonché, l’interpretazione di tale norma rimane tuttavia complessa, perché come si cercato sin qui di evidenziare, il suo mero tenore letterale – in sé soltanto considerato – non sembra consentirne una lettura incontrovertibilmente certa[60]; si assume che essa sia stata scritta con l’intento di escludere la rimborsabilità dei costi up-front[61], ma non sembra del tutto certo che possa essere interpretata esclusivamente in questo senso[62]. Laddove l’art. 120-quaterdecies.1, TUB, venga interpretato nel senso di ammettere la rimborsabilità anche dei costi up-front, allora detta rimborsabilità avrebbe dovuto riguardare anche le imposte, in quanto espressamente escluse – come detto – soltanto dal nuovo art. 125-sexies, TUB, in ambito CCD.
7. La Sentenza UCBA della CGUE
In data 9 settembre 2021 una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale veniva formulata alla CGUE (causa C-555/21 UniCredit Bank Austria AG – VKI), questa volta però sull’interpretazione dell’art. 25, par. 1, della MCD, da parte di un Giudice (Corte Suprema), della Repubblica d’Austria.
Il punto di partenza di tale domanda risiedeva nella legge nazionale austriaca attuativa della MCD, secondo la quale: “Il mutuatario ha diritto, in qualsiasi momento, di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito. Il rimborso anticipato dell’intero importo del credito, maggiorato degli interessi, è considerato come risoluzione del contratto di credito. In caso di rimborso anticipato del credito, gli interessi dovuti dal mutuatario sono ridotti in funzione della riduzione del debito residuo ed eventualmente in funzione della conseguente riduzione della durata del contratto. I costi dipendenti dalla durata del contratto sono ridotti proporzionalmente”[63].
L’ente creditizio austriaco coinvolto nella controversia (UniCredit Bank Austria AG – UCBA), utilizzava nei propri contratti di credito MCD una clausola contrattuale standard volta a stabilire che, in caso di estinzione anticipata da parte del consumatore, gli interessi, nonché i costi dipendenti dalla durata del credito, sarebbero stati ridotti proporzionalmente, mentre “le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito” non sarebbero state rimborsate, neppure proporzionalmente.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale erano espliciti i riferimenti ai parallelismi tra l’art. 16, par. 1, della CCD e l’art. 25, par. 1, della MCD, in forza dei quali veniva sostanzialmente ipotizzata una analoga interpretazione[64].
Più in particolare il Giudice austriaco aveva chiesto alla CGUE: “Se l’articolo 25 […] debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che prevede, in caso di esercizio del diritto del mutuatario di rimborsare […] prima della scadenza […] che gli interessi dovuti […] e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata”; sostanzialmente chiedendo così alla CGUE se la legge nazionale austriaca in materia si potesse ritenere conforme all’art. 25, par. 1, della MCD e quindi – di fatto – se il principio di diritto Lexitor dovesse trovare applicazione anche in relazione alla MCD.
In data 29 settembre 2022 furono depositate le Conclusioni dell’Avvocato Generale Manuel Campos Sanchez-Bordona, conclusioni delle quali si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi[65]:
“70. Tali considerazioni corroborano la mia convinzione […] che la riduzione applicabile sia limitata alle somme che il consumatore dovrebbe pagare per prestazioni ancora da effettuare in esecuzione del contratto. […].72. Per le stesse ragioni, la mia convinzione si estende anche ai costi pagati a terzi a titolo di imposte, oneri amministrativi o servizi professionali, quali la perizia immobiliare o l’intermediazione. 73. Non metto in dubbio che i costi pagati a terzi formino parte del costo totale del credito: diversamente il consumatore non riceverebbe tutte le informazioni necessarie per scegliere tra le offerte dei diversi creditori. 74. Non sono invece del parere che, per tale motivo, il diritto alla riduzione sancito dall’articolo 25 della direttiva 2014/17 sia applicabile a costi che non corrispondono a servizi del creditore ancora da eseguire al momento del rimborso anticipato. 75. Alcuni di tali costi sono retribuzioni di singole prestazioni preparatorie del futuro rapporto contrattuale (l’intermediazione). Altri contribuiscono a sostenere gli oneri pubblici (imposte) o remunerano attività o servizi della pubblica amministrazione […]. Il fatto che tali costi debbano essere computati per informare il consumatore del ‘prezzo’ totale del credito […] non implica, insisto, che essi formino parte dei costi che saranno oggetto di riduzione in caso di rimborso anticipato”.
Queste lucide e condivisibili argomentazioni dell’Avvocato Generale, dovevano tuttavia – in qualche modo – essere rese “non incompatibili” con il principio di diritto Lexitor, portando così l’Avvocato Generale a spiegare che:
“83. […] Ne consegue che, ribadisco, detta sentenza [Lexitor, ndr] non può essere semplicemente applicata a tali crediti [immobiliari, ndr]. 84. Accogliere la tesi della sentenza Lexitor non dovrebbe necessariamente condurre ad estendere la riduzione inerente al rimborso anticipato ai costi del credito immobiliare finalizzati alla remunerazione di un terzo […] 86. Non vedo quindi alcun motivo per trattare le somme versate a terzi allo stesso modo di quelle esaminate nella sentenza Lexitor”.
L’Avvocato Generale – dopo un’ampia ricostruzione del contesto normativo, CCD e MCD, e del principio di diritto Lexitor, sottopose alla CGUE due ipotesi interpretative, una principale e una subordinata.
In via principale l’Avvocato Generale propendeva per la non applicabilità del principio di diritto Lexitor alla MCD e sottoponeva alla CGUE una possibile interpretazione dell’art. 25, par. 1, MCD, nel senso che la riduzione proporzionale del costo totale del credito “si applica solo agli interessi dovuti e ai costi dipendenti dalla durata del contratto”.
Tale interpretazione – letteralmente intesa, almeno nella traduzione italiana, tenendo anche conto che essa venne redatta in lingua spagnola – non sembrava francamente apportare alcun contributo a chiarire il tenore – si ripete, nella traduzione italiana – dell’art. 25, par. 1, della MCD.
Si vuole con ciò evidenziare che – fermo il tenore letterale dell’art. 25, par. 1, MCD, secondo il quale la riduzione del costo totale del credito al consumatore riguarda “gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” – fornirne una interpretazione autentica secondo la quale la riduzione stessa “si applica solo agli interessi dovuti e ai costi dipendenti dalla durata del contratto”, non sembra che avrebbe offerto un particolare contributo chiarificatore, almeno sul piano strettamente letterale, laddove la linea interpretativa adottata fosse stata quella di escludere, puramente e semplicemente, la rimborsabilità dei costi up front, negando così l’applicabilità del principio di diritto Lexitor alla MCD.
In via subordinata l’Avvocato Generale proponeva un’interpretazione alternativa dell’art. 25, par. 1, MCD, di non facile lettura, di cui si riporta la traduzione italiana:
“L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale, […] la riduzione degli interessi e del costo totale del credito riguarda solo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Esso non osterebbe, tuttavia, a una normativa nazionale che limitasse tale riduzione ai costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, remunerano il creditore, ad esclusione di quelli dovuti a terzi”.
Sembra di poter “interpretare” tale ipotesi “interpretativa” nel modo che segue: assumendo come dato di partenza la validità del principio di diritto Lexitor (rimborsabilità pro quota di tutti gli oneri, sia di tipo recurring, sia di tipo up-front), l’art. 25, par. 1, MCD, non consentirebbe una normativa nazionale volta a circoscrivere la riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring (e quindi escludendo in radice la rimborsabilità dei costi up-front; del resto, così ragionando, si tradirebbe il principio di diritto Lexitor); corollario di tale affermazione è quindi che la riduzione del costo totale del credito dovrebbe riguardare tutti i costi sostenuti dal consumatore; sarebbe però ammissibile una normativa nazionale che – in relazione ai costi up-front – consentisse la “non rimborsabilità” di quelli pagati a soggetti terzi, perché comunque i costi up-front che remunerano il creditore dovrebbero essere rimborsabili.
Secondo tale ipotesi interpretativa, nell’ambito MCD vi sarebbe stata quindi – melius re perpensa – una sorta di “precisazione” o “deroga” al principio di diritto Lexitor in relazione ai (soli) costi up-front pagati a soggetti diversi dal creditore, perché – in questo specifico ambito – una normativa nazionale potrebbe escluderne la rimborsabilità. Ulteriore corollario di tale conclusione sarebbe stato poi quello che – laddove la normativa nazionale nulla disponga – il principio di diritto Lexitor risulterebbe pienamente applicabile anche alla MCD.
Tale conclusione, forse non particolarmente brillante per chiarezza, almeno nella traduzione italiana, sembrava proporre una interpretazione analoga al principio di diritto Lexitor, ma che avrebbe lasciato ai singoli Stati la possibilità di prevedere – con “normativa nazionale” – che la riduzione del costo totale del credito fosse limitata a quei costi che: “[…] indipendentemente dalla durata del contratto, remunerano il creditore, ad esclusione di quelli dovuti a terzi”; in pratica, secondo tale interpretazione, nei contratti di credito MCD, si sarebbe lasciata ai singoli Stati la possibilità di escludere – con legge nazionale – la rimborsabilità delle spese di perizia e delle imposte (che non remunerano il creditore e sono dovute a terzi), ferma restando la rimborsabilità pro quota alle spese di istruttoria (che remunerano il creditore).
Nella Sentenza UCBA (C-555/21) del 9 febbraio 2023, la CGUE ha sviluppato delle considerazioni che si ritiene utile riportare, a testimonianza (“autentica”, in quanto proveniente dalla CGUE), di quanto – alla prova dei fatti – risulti inadeguato e opinabile il tenore letterale delle due discipline CCD e MCD.
“21 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. […].
26 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell’11 settembre 2019 (Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702), in relazione all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un’analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest’ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione [sottolineatura aggiunta, ndr]. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
27 L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione [sottolineatura aggiunta, ndr]. Si deve quindi interpretare quest’ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”.
Ma oltre alle carenze evidenziate dalla CGUE sul dato normativo di partenza, a chi scrive sembra che la medesima CGUE, nello svolgimento delle sue argomentazioni, lungi dal chiarire i dubbi, ne faccia sorgere anche altri.
Dalla lettura della sentenza UCBA sembra emergere infatti che le Conclusioni dell’Avvocato Generale sarebbero state in parte recepite e in parte disattese:
“30 Orbene, occorre constatare, come sottolineato dall’avvocato generale, […], che il diritto alla riduzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato” [sottolineatura aggiunta ndr].
Posto che nella Sentenza Lexitor non erano state effettuate riflessioni in ordine al fatto che alcuni costi, sostenuti dal consumatore, potessero essere, o fossero, relativi a prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato, (ossia, indipendentemente dalla durata del contratto), al fine di escluderne la rimborsabilità[66], si deve anche osservare che il par. 31 della Sentenza UCBA (oltre ad essere difficilmente compatibile con il principio di diritto Lexitor), sembra essere stato enunciato quasi a mo’ di obiter dictum.
La CGUE evidenzia però – e questo sembra ben condivisibile – come la differenza tra le due discipline CCD e MCD, risieda nell’informativa precontrattuale fornita tramite il PIES[67], che – evidenziando: “34 […] una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. 35 […] riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto”.
In sostanza, sembra sia possibile riassumere il ragionamento della CGUE nel seguente modo: siccome nelle operazioni soggette alla MCD il PIES contiene una ripartizione tra “Spese una tantum” e “Spese periodiche”, il rischio di comportamenti abusivi del creditore nelle operazioni della specie sarebbe ridotto rispetto al medesimo rischio nelle operazioni CCD[68]; conseguentemente non vi sarebbe ragione di includere i “costi indipendenti dalla durata del contratto” (che nel PIES sarebbero “Spese una tantum”), nel diritto alla riduzione del costo totale del credito enunciato dall’art. 25, par. 1, MCD.
In effetti, però, con la sentenza UCBA è stato enunciato il seguente principio di diritto:
“L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE […], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito” (di seguito: il principio di diritto UCBA).
Il principio di diritto UCBA sembra pertanto consentire che la legislazione nazionale di un singolo Stato membro stabilisca regole volte a circoscrivere – nel senso suddetto – il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito ossia, limitando tale diritto ai soli “interessi e costi dipendenti dalla durata del credito”, che dovrebbero essere i costi recurring, con esclusione della rimborsabilità dei costi up-front[69].
Sembra quindi di poter evidenziare che la diversità di conclusioni tra la sentenza Lexitor in materia CCD e la sentenza UCBA in materia MCD, non risieda tanto nelle diverse esigenze di tutela del consumatore nell’una o nell’altra operatività, o nelle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, quanto piuttosto nella diversa modalità di esposizione dei costi nell’informazione precontrattuale, costituita – in ambito CCD – dal documento denominato “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” (IEBCC, o SECCI[70] che dir si voglia) e – in ambito MCD – (dalle Informazioni Generali e) dal PIES[71].
Argomentando a contrario si potrebbe allora ipotizzare che – laddove l’informazione precontrattuale nell’operatività CCD fosse stata concepita dalla CCD stessa – in particolare il riferimento è all’Allegato II alla CCD stessa, ossia al modulo relativo alle “Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori” – allo stesso modo di come è stata concepita dalla MCD (il riferimento è all’Allegato II alla MCD stessa, ossia al modulo PIES) – quindi con una più “chiara” evidenza delle “Spese una tantum” e delle “Spese Periodiche” – allora non vi sarebbe ragione di prevedere trattamenti differenziati nel caso di rimborso anticipato dei rispettivi contratti di credito.
Da notare ancora che, nel principio di diritto UCBA non viene fatto alcun cenno in relazione a quanto – da una parte – era stato proposto dall’Avvocato Generale e – dall’altra – a quanto indicato al par. 31, della medesima sentenza UCBA, a proposito di una differenziazione di trattamento tra i costi indipendenti dalla durata del contratto (che, si ripete, dovrebbero essere riconducibili ai costi up-front o una tantum), comunque sostenuti dal consumatore, a beneficio del creditore (ad es.: le spese di istruttoria), e quelli a beneficio di soggetti terzi (ad es.: le spese di perizia e le imposte)[72].
Anche la sentenza UCBA suscita comunque perplessità, che sono state prontamente evidenziate dai Commentatori, con riferimento alla farraginosità delle argomentazioni spese per addivenire a conclusioni differenti da quelle enunciate dalla precedente sentenza Lexitor, muovendo da un dato normativo di partenza sostanzialmente sovrapponibile[73].
La sentenza UCBA del 9 febbraio 2023 implica tuttavia la necessità di esaminare il disposto del nostro art. 120-quaterdecies.1, TUB, (introdotto dal 25 luglio 2021), alla luce del principio di diritto da essa sancito, avente efficacia retroattiva alla stessa stregua del principio di diritto Lexitor, per comprendere se la nostra disposizione nazionale consenta di circoscrivere il diritto del consumatore al solo rimborso pro quota dei costi recurring, oppure imponga una riduzione del costo totale del credito riguardante anche i costi up-front.
A parere di chi scrive, la risposta al quesito non è scontata: se si muove dall’assunto – che è proprio del ragionamento seguito dalla CGUE – che né il tenore letterale dell’art. 16, par. 1, della CCD, né quello dell’art. 25, par. 1, della MCD, sono sufficientemente chiari nell’affermare in cosa esattamente consista il diritto alla riduzione del costo totale del credito, allora neppure potrebbe ritenersi chiaro il tenore letterale del nostro art. 120-quaterdecies.1, TUB.
Per comodità di rappresentazione si riporta la seguente tabella:
| Art. 16, par. 1, della CCD | Art. 25, par. 1, della MCD |
| 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto | 1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto |
| Principio di diritto Lexitor | Principio di diritto UCBA |
| L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE […], deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore | L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE […], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito |
| Nuovo art. 125-sexies, TUB
(vigente dal 25-7-2021) Attuativo dell’art. 16 della CCD e del principio di diritto Lexitor |
Art. 120-quaterdecies.1, TUB
(vigente dal 25-7-2021) Attuativo dell’art. 25, par. 1, della MCD |
| 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. | 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto |
Sempre a parere di chi scrive, per essere ragionevolmente certi che la nostra norma nazionale in materia di rimborso anticipato dei contratti di credito MCD, affermi che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, ma senza tralasciare l’ulteriore dictum della sentenza UCBA, secondo il quale: “[…] siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, avrebbe dovuto (dovrebbe) essere (ri)formulata come segue, o di un analogo tenore letterale:
“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito; la riduzione del costo totale del credito non riguarda i costi indipendenti dalla durata del contratto pagati dal consumatore al creditore o a terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
8. Gli ulteriori interventi del legislatore italiano
In data 10 agosto 2023 furono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale due distinti provvedimenti di legge (la Legge n. 103 e il Decreto legge n. 104), contenenti – per quello che potrebbe essere stato, almeno all’apparenza, un malfunzionamento/disguido degli uffici legislativi – due distinte previsioni normative di diverso tenore[74], entrambe portanti modificazioni al secondo comma dell’art. 11-octies, del DL n. 73/2021.
Più in particolare:
- L’articolo 1, comma 1, della legge 10 agosto 2023, n. 103, di conversione in legge del Decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, ha introdotto all’articolo 1, del detto DL, un comma 1-bis, del seguente tenore: “1-bis. All’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ‘Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato” [sottolineatura aggiunta, ndr].
- L’articolo 27, del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104, poi convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136, ha stabilito che: “1. All’articolo 11-octies , comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: ‘Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte” [sottolineatura aggiunta, ndr].
Non ci si sofferma in questa sede a commentare il riferimento normativo alle “disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa” per le quali si rimanda all’acuta disamina di Bargelli[75] e di altri Commentatori, citando soltanto che: “Allo stato, non resta che attendere il “consolidamento” del confuso dettato normativo (nella speranza di una sua più felice formulazione che sia in grado di sciogliere i dubbi che si sono sopra prospettati) e l’applicazione che ne sarà data dagli interpreti”[76].
Neppure ci si sofferma a commentare le differenze tra i due testi normativi, per le quali si rimanda alla lettura di altri contributi[77].
Comunque sia, ad oggi, a seguito della intervenuta conversione in Legge del Decreto legge n. 104/2023, ad opera della legge 9 ottobre 2023, n. 136 (con abrogazione implicita della modificazione apportata dalla Legge n. 103[78] [79]), si deve ritenere vigente il quadro normativo che di seguito si cerca di descrivere.
Come si è già evidenziato, in ambito CCD, il vecchio art. 125-sexies, TUB, “Rimborso anticipato”, comma 1, vigente fino al 24 luglio 2021, stabiliva che:
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto […]”.
Il nuovo art. 125-sexies, TUB, commi 1 e 2, vigente dal 25 luglio 2021, stabilisce che:
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato […]”.
Al di là delle differenze lessicali – che come già evidenziato non aiutano a chiarire l’esatta portata precettiva delle due norme che si sono succedute nel tempo – è ora opportuno ricordare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, (come già evidenziato al precedente par. 5), ha precisato che:
“14.1 […] la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies [così nella sentenza, ma è da intendersi 11-octies, ndr], comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte […] – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor […] 14.2 sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021 […] può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor […] Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale” [sottolineatura aggiunta, ndr].
Detto in altre parole, la Corte Costituzionale – nel sancire la parziale illegittimità del vecchio comma 2, dell’art. 11-octies, nella parte in cui intendeva circoscrivere gli effetti del principio di diritto Lexitor ai soli rimborsi anticipati dei contratti di credito sottoscritti dopo il 25 luglio 2021 – ha preso comunque atto dei due differenti testi dell’art. 125-sexies, TUB, che si sono succeduti nel tempo, ma ha stabilito che sono sostanzialmente (anche se non formalmente), identici e si devono interpretare nello stesso modo, ossia secondo il principio di diritto Lexitor.
Ad oggi quindi, il nuovo comma 2, dell’art. 11-octies, del DL n. 73/2021, come emendato dalla Corte Costituzionale (prima) e come modificato (da ultimo), dall’articolo 27, del DL 104/2023, ha recepito i dicta della Corte Costituzionale precisando che il nuovo art. 125-sexies, TUB, si applica ai contratti sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021 ed inoltre stabilendo che: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea [con implicito riferimento non soltanto alla sentenza Lexitor, ma anche alla sentenza UCBA, ndr], in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima [del 25 luglio 2021, ndr], continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
Il Legislatore sembra quindi aver voluto dipanare il dubbio di cui si è fatto cenno al precedente par. 6), in relazione alla disciplina applicabile alle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD, sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ossia se a dette estinzioni si dovesse applicare il vecchio art. 125-sexies (in forza del rinvio operato dal vecchio art. 120-noviesdecies), oppure il nuovo art. 120-quaterdecies.1, TUB.
Il Legislatore ha così stabilito che per i contratti di credito (tutti, sia quelli CCD che quelli MCD), sottoscritti prima del 25 luglio 2021, l’unica norma di riferimento era – e resta – il vecchio art. 125-sexies, TUB, oggi da interpretare però alla luce del principio di diritto Lexitor. A partire dal 25 luglio 2021 (da intendersi quale data di sottoscrizione del contratto di credito), i “destini si separano”: il rimborso anticipato dei contratti di credito CCD sottoscritti a partire da quella data sarà regolato dal nuovo art. 125-sexies, TUB, mentre il rimborso anticipato dei contratti di credito MCD sottoscritti a partire da quella data sarà regolato dal nuovo art. 120-quaterdecies.1, TUB.
E’ da notare che la precisazione “non sono comunque soggette a riduzione le imposte” trova la sua spiegazione nel fatto che la precisazione stessa è presente nel nuovo art. 125-sexies, TUB, ma non era presente nel vecchio art. 125-sexies, TUB; ora – dovendosi prendere atto che i rimborsi anticipati dei contratti di credito sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (sia in ambito CCD che MCD), saranno regolati dal vecchio art. 125-sexies, TUB, che non la prevedeva, ma tenendo conto del principio di diritto Lexitor, che impone la riduzione del costo totale del credito in relazione a tutti i costi posti a carico del consumatore – con la nuova formulazione del comma 2, dell’art. 11-octies, del DL 73/2021, il Legislatore ha ritenuto opportuno stabilire espressamente che – anche in queste fattispecie – le imposte non siano rimborsabili.
Il suddetto principio di esclusione delle imposte dalla riduzione del costo totale del credito appare tuttavia – a chi scrive – di dubbia legittimità, come già evidenziato in precedenza.
Come detto, in ambito MCD, l’art. 120-quaterdecies.1, TUB, introdotto – e applicabile ai rimborsi anticipati dei contratti di credito sottoscritti – a partire dal 25 luglio 2021, stabilisce che:
“1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto“; senza disporre alcunché in ordine alla “non rimborsabilità” delle imposte.
Il suddetto quadro normativo è quindi molto farraginoso e il solo tenore letterale dello stesso non consente di addivenire ad una interpretazione chiara e certa; è comunque possibile osservare quanto segue.
In primo luogo, l’obiettivo delle ultime modifiche apportate all’art. 11-octies, comma 2, ad opera del DL 104/2023, è sembrato essere (più che quello di “chiarire” la materia), quello di evitare che la Commissione Europea aprisse una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano, per una difformità tra la legislazione statale e la Giurisprudenza comunitaria (sentenze Lexitor e UCBA), da una parte e la Giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 263/2022), dall’altra.
Fino al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore dell’art. 11-octies), la materia delle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD era disciplinata dalla stessa norma applicabile al rimborso anticipato in ambito CCD (ossia, il vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB).
In ragione di quanto sopra, la riformulazione dell’art. 11-octies, comma 2, secondo periodo), avrebbe il senso di precisare che anche in relazione alle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD, oltreché ovviamente ai rimborsi anticipati di quelli CCD, stipulati prima del 25 luglio 2021 (comunque tutti soggetti al vecchio art. 125-sexies, TUB), avrebbe dovuto e dovrà trovare applicazione il principio di diritto Lexitor.
Ciò si riferisce in quanto la norma: “[…] è finalizzata ad allineare […] la disciplina dei rimborsi anticipati nei contratti di credito al consumo o di mutuo immobiliare [sottolineatura aggiunta, ndr] antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021, applicando anche a tali ipotesi la riduzione, proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, ivi inclusi quelli sostenuti per la conclusione del contratto stesso”[80], sopperendo (in realtà e a ben vedere), al fatto che, il Legislatore, con la versione originaria dell’art. 11-octies, del luglio 2021, aveva introdotto il nuovo art. 125-sexies, TUB, che escludeva – in ambito CCD – il rimborso delle imposte, e l’art. 120-quaterdecies.1, TUB, che invece – in ambito MCD – non conteneva (e non contiene) una espressa esclusione del rimborso delle imposte; in questo senso (e si sarebbe tentati di dire: solo in questo senso), si può dire che la norma è stata riformulata al fine di “allineare” la disciplina dei rimborsi anticipati nei due ambiti di operatività.
La Decisione dell’ABF Collegio di Bologna del 22 novembre 2023, n. 11.463, relativa a un contratto di credito MCD stipulato nel luglio 2017 e oggetto di rimborso anticipato il 30 maggio 2023 (ossia, dopo l’introduzione dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB), ha precisato, con argomentazione però non del tutto condivisibile, che: “In merito alla richiesta di rimborso pro-quota delle spese up front stante l’estinzione anticipata del mutuo va preliminarmente ricordato che, per i contratti di mutuo come quello in esame rientranti nel c.d. “credito immobiliare ai consumatori”, le conseguenze del rimborso anticipato sono disciplinate dall’art. 120-quaterdecies 1 TUB […]. Detto articolo 120-quaterdecies 1 è stato inserito nel Capo I bis del Titolo VI del TUB, […] a sua volta introdotto nel TUB dal D.Lgs. n. 72/2016 […]. Le disposizioni transitorie del citato D.Lgs. n. 72/2016 (art. 3) disciplinano l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni introdotte dal provvedimento nei termini che seguono: ‘1. […] le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo. …..’. La specifica disciplina contenuta nell’art. 120-quaterdecies 1 TUB si applica, dunque, ai contratti di credito immobiliare sottoscritti successivamente alla data del 1° luglio 2016 e tale è il contratto in esame sottoscritto il 26/7/2017: la fattispecie in esame è dunque disciplinata dall’art. 120-quaterdecies 1 TUB il quale (a differenza dell’art. 125 sexies oggi non più richiamato dall’art. 120-noviesdecies), prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto in tal modo consentendo la non rimborsabilità dei costi c.d. up front che non riguardano la vita residua del contratto. E’ da ritenersi pertanto esclusa la rimborsabilità dei ratei relativi a commissioni di natura up-front applicati ai contratti di credito immobiliare. Detta normativa nazionale risulta invero pienamente conforme alla normativa di fonte europea come confermato anche dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 – causa C-555/21 la quale ha statuito che la normativa nazionale può legittimamente prevedere il rimborso pro-quota dei soli costi recurring, senza alcun diritto restitutorio in ordine ai costi cosiddetti up front, cioè non correlati alla durata del contratto (es. spese per la perizia, spese di istruttoria), […]”.
Quanto esposto non sembra pacificamente condivisibile per due ordini di motivi: il primo è che il D.Lgs. 72/2016, introdusse nel TUB la disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori, e l’art. 120-quaterdecies.1, è stato a sua volta introdotto nel TUB, ma non è stato introdotto nel D.Lgs. 72/2016; quindi, laddove il D.Lgs. 72/2016 stabiliva che: “le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data”, certamente non faceva riferimento all’art. 120-quaterdecies.1, TUB; non sembra quindi possibile affermare puramente e semplicemente che l’art. 120-quaterdecies.1, TUB, sia applicabile ai contratti di credito MCD sottoscritti a partire dal 1° luglio 2016, come se esso fosse stato introdotto nel TUB dal D.Lgs. n. 72/2016; il secondo motivo è che questa Decisione ABF è del 22 novembre 2023 e a tale data era già entrato in vigore il nuovo comma 2, dell’art. 11-octies, del DL 73/2021, come modificato dall’articolo 27, del DL 104/2023, quindi, trattandosi di una controversia relativa all’estinzione anticipata di un contratto di credito MCD stipulato prima del 25 luglio 2021, per espressa previsione normativa allo stesso non sarebbe stato applicabile l’art. 120-quaterdecies.1, TUB.
A margine di ciò si vuole porre in evidenza l’uso “distorto” fatto da parte dell’ABF della norma di cui all’art. 3, del D.Lgs. 72/2016: in alcuni casi la detta norma è stata completamente ignorata, allo scopo e con il risultato concreto di dichiarare applicabili norme (art. 120-noviesdecies, TUB), introdotte dalla disciplina sul Credito Immobiliare ai Consumatori, ad operazioni che in realtà non erano soggette alla disciplina stessa, perché stipulate prima della sua entrata in vigore; in altri casi detta norma è stata viceversa utilizzata nel senso opposto, ossia per dichiarare applicabili ad operazioni stipulate nella vigenza della disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori, norme introdotte in questa disciplina (art. 120-quaterdecies.1), ma non dal D.Lgs. 72/2016, anzi successive ad esso ed anche alla stipulazione delle operazioni stesse.
E’ anche possibile evidenziare che con questa Decisione l’Arbitro ha avvertito la necessità di fornire una motivazione, forse emblematica della difficoltà di “tirare le fila” della materia e di una qual certa eterogeneità degli orientamenti:
“Per inciso, e a completamento di quanto sopra esposto, si ricorda che, anche nel vigore della precedente normativa o comunque con riguardo ai contratti non disciplinati ratione temporis dal nuovo art. 120 quaterdecies 1 del TUB, i Collegi ABF sembravano comunque orientati nel senso di escludere l’applicabilità dell’art. 125sexies (come interpretato nella sentenza Lexitor) alla materia del credito immobiliare ai consumatori e ciò per varie ragioni. Taluni Collegi in considerazione dei maggiori margini di discrezionalità lasciati ai legislatori nazionali in quest’ultima materia (cfr. Coll. Napoli, n. 1753/21), nonché in ragione del diverso assetto di interessi alla base di due ambiti di credito ai consumatori (cfr. Coll. Napoli, dec. n. 1887/21; Coll. Roma, n. 6901/21); in altre decisioni si è utilizzato quale argomento il dato testuale rinveniente dall’art. 122 TUB, secondo cui le disposizioni del Capo II (in cui l’art. 125sexies è inserito) non si applicano ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili (così Coll. Torino, n. 14418/22; Coll. Bologna, n. 3047/22; Coll. Bari, n. 5008/23)”.
Comunque sia, se la Decisione del Collegio di Bologna del 22 novembre 2023, n. 11.463, era forse cronologicamente troppo vicina al DL 104/2023 e alla relativa legge di conversione n. 136/2023, dello stesso tenore è anche la Decisione del medesimo Collegio, n. 3.170 del 12 marzo 2024, cronologicamente più lontana, nella quale tuttavia ugualmente non viene fatto riferimento alle modificazioni apportate dal DL 104/2023 all’art. 11-octies, del DL 73/2021.
In relazione a tale ultima Decisione, sembra però opportuno rilevare che il contratto di credito era stato stipulato nel 2020 (ossia, prima dell’introduzione dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB), e il rimborso anticipato era stato effettuato il 26 luglio 2022 (ossia dopo l’introduzione dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB); in questa controversia il ricorrente – verosimilmente in considerazione di tale cronologia degli eventi – invocava la disciplina del vecchio art. 125-sexies, TUB, per ottenere il rimborso dei costi up-front, ma anche in questa circostanza l’Arbitro ha affermato che: “[…] come rilevato dalla resistente, al contratto oggetto di controversia non è applicabile l’art. 125 sexies del TUB, relativo ai contratti di credito ai consumatori, bensì l’art. 120-quaterdecies 1 TUB, inserito al Capo I bis del Titolo VI del TUB, rubricato “Credito immobiliare ai consumatori”, a sua volta introdotto nel TUB dal D. Lgs. n. 72/2016 […]. La norma richiamata risulta applicabile ai contratti di credito immobiliare sottoscritti successivamente alla data del 1° luglio 2016 […]”.
In entrambe le Decisioni, l’applicabilità dell’art. 120-quaterdecies.1, TUB, ai rimborsi anticipati di contratti di credito MCD stipulati precedentemente alla sua introduzione, è stata motivata dall’Arbitro sulla base delle “disposizioni transitorie del citato D.Lgs. n. 72/2016 (art. 3)”, per giungere ad affermare che: “La specifica disciplina contenuta nell’art. 120-quaterdecies 1 TUB si applica, dunque, ai contratti di credito immobiliare sottoscritti successivamente alla data del 1° luglio 2016 […]”; come già si è detto, tale argomentazione non sembra conforme al vigente quadro normativo.
9. La Sentenza Santander della CGUE
In data 17 ottobre 2024 la CGUE è nuovamente intervenuta con una ulteriore pronuncia pregiudiziale (nella causa C-76/22, QI – Santander Bank Polska S.A. – di seguito la sentenza Santander), sempre in materia di interpretazione dell’art. 25, par. 1, della MCD.
La domanda pregiudiziale formulata alla CGUE nasceva da una controversia sottoposta all’attenzione di un Tribunale della Repubblica di Polonia (Varsavia), innanzi al quale un consumatore – che aveva concluso un contratto di credito immobiliare di durata trentennale per poi estinguerlo anticipatamente dopo soli 19 mesi – chiedeva il rimborso proporzionale di: “13. […] una commissione connessa alla concessione di detto credito, pagabile al momento della conclusione del contratto e corrispondente al 2,50% dell’importo del credito medesimo, […] (circa EUR 600), che era indicata come elemento del costo totale del credito immobiliare”; sembra quindi di poter desumere che il consumatore chiedesse il rimborso pro quota di un costo up-front, verosimilmente assimilabile alle “spese di istruttoria”[81].
Più in particolare, secondo il consumatore, poiché il finanziamento nasceva per essere rimborsato in 360 mesi, essendo stato rimborsato dopo 19, la commissione pagata avrebbe dovuto essere rimborsata per (360-19=) 341/360esimi della commissione pagata, ossia per circa 570 Euro dei 600 inizialmente pagati.
Incardinata la lite, il Giudice polacco in data 5 febbraio 2022 sottoponeva quindi alla CGUE due distinti quesiti: il primo, se – anche in considerazione di quanto stabilito dal principio di diritto Lexitor – si debba ritenere che, in caso di rimborso anticipato di un credito ipotecario, il consumatore abbia diritto ad una riduzione del costo totale del credito che includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la “commissione per la concessione del mutuo”, ossia un costo up-front; il secondo, su quale (eventualmente) sia il metodo di calcolo da utilizzare per determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito[82].
In relazione a tale secondo quesito sorge spontaneo osservare che già nelle Conclusioni dell’Avvocato Generale Gerard Hogan, presentate il 23 maggio 2019, per la Causa C-383/18, decisa con la Sentenza Lexitor, era stato evidenziato che:
“36. Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 si può osservare che, poiché tale disposizione non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, ritengo che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia di lasciare gli Stati membri un certo margine di manovra in materia. 37. […] ciò non significa che gli Stati membri possano adottare qualsiasi metodo preferiscano. Essi devono rispettare i principi stabiliti dall’articolo 16, paragrafo 1, relativo all’obbligo di comprendere sia gli interessi sia i costi […] Sebbene l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva specifichi che tale parte corrisponde agli interessi e ai costi ‘[dovuti] per la restante durata del contratto’, tale disposizione è relativamente vaga in quanto potrebbe voler dire che gli interessi e i costi interessati sarebbero quelli che sorgono successivamente alla data di rimborso. 38 […] mi sembra chiaro che la direttiva 2008/48 non armonizza il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la riduzione applicabile nel caso di un rimborso anticipato del credito, ma enuncia i principi che gli Stati membri devono rispettare nella determinazione di tale metodo”.
Alla luce di quanto sopra, posta la sostanziale – anche se non letterale – coincidenza tra la previsione normativa di cui all’art. 16, par. 1, CCD, e quella di cui all’art. 25, par. 1, MCD, il quesito formulato dal Giudice polacco alla CGUE appare poco comprensibile e persino animato da un intento dilatorio.
Ciò posto, non sembra comunque possibile comprendere per quale ragione, in questa nuova causa, le Conclusioni dell’Avvocato Generale (il medesimo della Sentenza UCBA, Manuel Campos Sanchez-Bordona), erano state circoscritte “Su indicazione della Corte di giustizia” alla sola seconda questione pregiudiziale, ossia proprio quella sul (l’inesistente) metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, come se la CGUE avesse già un’opinione consolidata sulla prima questione pregiudiziale, tale da non necessitare del parere dell’Avvocato Generale.
E’ da notare che la CGUE, subito dopo l’avvio del procedimento, con decisione del 24 marzo 2022, aveva sospeso il procedimento in discorso (Santander), in attesa della sentenza UCBA, che venne poi pubblicata il 9 febbraio 2023; non appena pubblicata, quest’ultima venne notificata al Tribunale di Varsavia, il quale veniva invitato a comunicare alla CGUE se – tenuto conto di tale sentenza UCBA – intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale sulla questione Santander; il Tribunale di Varsavia comunicò quindi di insistere nella domanda pregiudiziale.
La CGUE, dopo ampi riferimenti ai precedenti (sentenza Lexitor e sentenza UCBA), ha enunciato i seguenti due principi di diritto:
“1) L’articolo 25, paragrafo 1 […] dev’essere interpretato nel senso che: in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione.
2) L’articolo 25, paragrafo 1 […] dev’essere interpretato nel senso che: da tale disposizione non deriva alcun metodo di calcolo specifico che consenta di determinare l’importo della riduzione del costo totale del credito di cui a detta disposizione”.
Circoscrivendo il commento al primo dei due principi (in quanto il secondo appare una mera constatazione – sia pure qualificata, in quanto proveniente dalla CGUE – di un evidente “vuoto normativo” nella stessa MCD (conseguente all’analogo “vuoto normativo” della CCD)[83], anche la sentenza Santander sembra presentare – a parere di chi scrive – profili di opinabilità.
In primo luogo essa, rifacendosi – come detto – ai due importanti precedenti specifici costituiti dalle sentenze Lexitor e UCBA, di quest’ultima sembra valorizzare – più che il formale principio di diritto in essa enunciato – il solo par. 31 (dove era stato detto che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito: “[…] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”).
Si riporta il seguente passaggio della sentenza Santander, dove risalta la differenza tra la sentenza Lexitor (della quale viene menzionato il principio di diritto) e la sentenza UCBA, della quale viene invece menzionato il par. 31:
“23 Per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che tale disposizione dev’essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di un credito al consumo rientrante in tale direttiva include tutti i costi posti a carico del consumatore (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 36).
24 Per contro, nella sentenza del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria (C-555/21, EU:C:2023:78, punti 27, 28 e 31), la Corte ha constatato che, tenuto conto in particolare delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e nonostante la formulazione quasi identica dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, il diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da quest’ultima disposizione non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”.
A chi scrive sembra che nella sentenza Santander sia stata posta una particolare enfasi nel valorizzare quello che, nella sentenza UCBA, sembrava essere un obiter dictum – enunciato al par. 31 – quasi a voler “travisare” il principio di diritto effettivamente enunciato dalla sentenza UCBA[84].
Inoltre la sentenza Santander prosegue affermando che siccome la MCD è volta ad assicurare ai Consumatori “un elevato livello di protezione”, saranno i Giudici nazionali a dover: “33. […] assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore”; giungendo poi ad affermare che: “34. […] un giudice nazionale non può presumere, sulla base del solo fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto di credito ipotecario, che tale costo rientri tra le spese indipendenti dalla durata del contratto, le quali non possono pertanto comportare la riduzione del costo totale del credito […]”.
Anche la sentenza Santander appare pertanto opinabile, perché da una parte demanda al Giudice nazionale l’indagine di cui al punto n. 33, sostanzialmente sulla “natura”, ossia sulla “giustificazione causale” degli oneri posti a carico del consumatore, con la precisazione di cui al successivo n. 34, che il solo dato di fatto del pagamento di un determinato costo una tantum al momento della conclusione del contratto di credito, non significa necessariamente che esso rappresenti un costo “indipendente dalla durata del contratto” (nel senso che potrebbe costituire il pagamento anticipato di oneri recurring), per poi affermare, si direbbe: con disinvoltura, che le spese indipendenti dalla durata del contratto non comportano la riduzione del costo totale del credito, ossia che non sono rimborsabili.
Quanto sopra sembra opinabile perché se da una parte un tale pronunciamento potrebbe avere l’effetto di incoraggiare il contenzioso Banca-Clienti, desiderosi questi ultimi di provocare il sindacato giurisdizionale sulla “natura” degli oneri posti a carico del consumatore, con conseguenze inflazionistiche del contenzioso, dall’altra l’affermazione relativa alla “non rimborsabilità” degli oneri “indipendenti dalla durata del contratto”, dovrebbe essere “testata”, alla luce del principio di diritto UCBA, sulla base delle normative nazionali.
Sembra tuttavia di poter affermare che il dictum della sentenza Santander secondo il quale: “in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione” possa essere circoscritto e “ridimensionato” tenendo conto del fatto che, come in essa evidenziato: “35. […] il creditore […] è tenuto […] a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione delle spese pagabili da quest’ultimo in funzione del loro carattere ricorrente o meno mediante il PIES. Incombe quindi al creditore stabilire se i costi in questione siano ricorrenti o meno”.
Ma anche questo passaggio sembra porsi – in qualche modo – in contrasto con la sentenza Lexitor, nella quale era scritto: “31. […] l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto”; quindi in ambito CCD il rischio che il creditore presenti i costi a suo piacimento doveva essere presidiato imponendo che la riduzione del costo totale del credito includesse tutti i costi posti a carico del consumatore, mentre in ambito MCD sembra normale e accettabile che il creditore stabilisca autonomamente se i costi “siano ricorrenti o meno”.
Come già detto, il modello di Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) – allegato alla MCD e poi trasfuso, nel nostro Paese, nell’Allegato 4E, alle Disposizioni in materia di Trasparenza, prevede – alla sezione “4. Tasso d’interesse e altri costi” – l’indicazione separata delle “Spese una tantum” (costi up-front) e delle “Spese periodiche” (costi recurring).
Ugualmente è a dirsi per quanto riguarda il documento denominato Informazioni Generali[85], dove – nel riquadro Spese, è presente una ripartizione tra le “Spese per la stipula del contratto” (Istruttoria; Perizia tecnica; altro) e le “Spese per la gestione del rapporto” (Gestione pratica; Incasso rata; Invio comunicazioni; Altro); sembra possibile desumere che si verta sempre in tema di “Spese una tantum” o costi up-front da una parte e “Spese periodiche” o costi recurring dall’altra.
In ragione di quanto sopra, dalla lettura della sentenza Santander – nella parte in cui è specificato che: “26. […] il creditore è tenuto a dimostrare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione. Nel procedimento principale, la Santander Bank Polska non ha tuttavia presentato una ripartizione dei costi del credito ipotecario indicando se i costi di cui trattasi nel procedimento principale siano oggettivamente connessi alla durata del contratto di credito” – sembra di poter desumere che in relazione allo specifico contratto di credito MCD oggetto di controversia di fronte al Giudice polacco – o meglio, nella relativa informazione precontrattuale – non fosse stato specificato che la commissione di cui si chiedeva il rimborso pro quota era da intendersi quale “Spesa una tantum”.
In tal senso, l’inciso secondo il quale: “in assenza di informazioni fornite dal creditore […]” il Giudice nazionale non potrebbe presumere che una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, dovrebbe – per converso – indurre a ritenere che laddove il creditore abbia fornito le dette informazioni al consumatore – mediante le Informazioni Generali, il PIES ed anche mediante il contratto di credito – la detta “commissione per la concessione del mutuo” (in ipotesi, assimilabile alle spese di istruttoria), non dovrebbe essere rimborsabile pro quota nel caso di rimborso anticipato.
Tralasciando il caso specifico sottoposto dal Giudice polacco alla CGUE, chi scrive non riesce a rintracciare una continuità logica tra quanto enunciato nelle due sentenze UCBA e Santander in materia di interpretazione dell’art. 25, par. 1, MCD.
Come si è detto, con la prima delle due, la CGUE dopo aver constatato che: “ […] il diritto alla riduzione del costo totale del credito previsto da quest’ultima disposizione non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, sembra aver poi smussato i toni stabilendo che: “L’articolo 25, paragrafo 1, […] non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”, quasi a voler dire: posto che i costi up-front non dovrebbero essere rimborsabili, tuttavia dovrebbe essere la normativa nazionale a stabilirlo espressamente.
Con la sentenza Santander, la CGUE ha affermato che: “33 […] spetta agli organi giurisdizionali nazionali assicurare che i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto di credito, sono posti a carico del consumatore non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l’uso temporaneo del capitale oggetto di tale contratto o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore […]. 34 Pertanto, un giudice nazionale non può presumere, sulla base del solo fatto che un costo sia stato pagato dal consumatore una tantum al momento della conclusione del contratto di credito ipotecario, che tale costo rientri tra le spese indipendenti dalla durata del contratto, le quali non possono pertanto comportare la riduzione del costo totale del credito di cui all’articolo 25, paragrafo 1, […]”, per poi concludere statuendo che: “L’articolo 25, paragrafo 1 […] dev’essere interpretato nel senso che: in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione”.
Nella sentenza Santander non c’è più un riferimento ad una (eventuale) normativa nazionale, ma si ha riguardo (si direbbe: soltanto) all’attività giurisdizionale.
Cercando quindi di ricapitolare, sembra di poter ritenere che in ambito MCD: 1) la legge nazionale potrebbe limitare il diritto alla riduzione del costo totale del credito ai soli costi recurring; 2) con il corollario che ove tale legge nazionale ciò non faccia, saranno rimborsabili anche i costi up-front; 3) tuttavia il compito dell’informazione precontrattuale è anche quello di esporre chiaramente gli uni e gli altri; 4) sarà il Giudice a dover verificare che i costi up-front siano effettivamente tali, ossia che non siano costi recurring presentati come costi up-front; 5) per verificare ciò il Giudice non potrà basarsi soltanto sul fatto che questi costi siano stati pretesi una tantum al momento della conclusione del contratto di credito; 6) in assenza di informazioni precontrattuali che depongano per la natura up-front di determinate voci di spesa, il Giudice dovrà ritenerle di tipo recurring e quindi rimborsabili pro quota.
Il tutto somiglia molto alle conclusioni raggiunte molti anni fa dall’Arbitro Bancario Finanziario in ambito CCD.
A margine di quest’ultima Sentenza Santander si ritiene opportuno anche segnalare che nel procedimento erano intervenuti i Governi polacco, ceco, italiano e portoghese; il nostro Governo in particolare era intervenuto anche per chiedere alla CGUE di limitare gli effetti nel tempo della sentenza, in modo che avesse efficacia ex nunc [86].
Nelle conclusioni dell’Avvocato Generale si trova specificato che: “70. […] In ogni caso, ritengo che la limitazione nel tempo invocata da tale governo non si appropriata, in quanto, come nella causa C-555/21 UniCredit Bank Austria, non è stato dimostrato che sussistano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a tale riguardo”.
Anche questo aspetto suscita perplessità: da una parte sembra che gli Stati membri non riescano a rappresentare in modo “convincente” alla CGUE l’impatto che – anche in relazione al singolo Stato e quindi con riferimento specifico alla sua Legge nazionale (ed eventualmente alle sue disposizioni attuative di rango secondario, prassi, orientamenti giurisprudenziali, livello di litigiosità) – una pronuncia pregiudiziale di un certo tipo possa produrre nel singolo Paese[87].
Dall’altra sembra di poter rintracciare un qual certo “autocompiacimento” ed “autoreferenzialità” della CGUE, quando afferma – e ripetutamente in molte sentenze, con la tecnica del copia-incolla – che: “52. […] non è ravvisabile alcun elemento che possa giustificare una deroga al principio secondo cui gli effetti di una sentenza interpretativa risalgono alla data di entrata in vigore della norma interpretata. 53. Pertanto, non vanno limitati nel tempo gli effetti della presente sentenza”[88].
10. Lo stato dell’arte
Ad oggi sembra di poter riassumere lo “stato dell’arte” come segue:
10.1 Adempimento anticipato di contratti di Credito al Consumo
L’adempimento anticipato dei contratti di Credito al Consumo – con ciò intendendosi in questa sede i finanziamenti di importo compreso tra lire 300.000 (Euro 154,94) e lire 60.000.000 (Euro 30.987,41), sottoscritti nel vigore della Sezione I – Credito al Consumo (artt. 18-24), della Legge 19 febbraio 1992, n. 142 e successivamente nel vigore dell’originario Capo II – Credito al Consumo – del Titolo VI, del TUB, vigente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 maggio 2011 – doveva ritenersi disciplinato dalle norme all’epoca vigenti[89].
Si è tuttavia visto che già prima della sentenza Lexitor, l’orientamento assunto dall’Arbitro Bancario Finanziario era stato quello di ritenere che le previsioni dell’articolo 125-sexies, TUB – introdotto in recepimento della CCD – fossero applicabili anche agli adempimenti anticipati dei contratti di Credito al Consumo già effettuati alla data di entrata in vigore della disciplina sul Credito ai Consumatori, o effettuati successivamente ad essa[90].
A ciò è anche possibile aggiungere che la Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25.997, ha avuto occasione di occuparsi del caso di un contratto di credito sottoscritto in data 13 aprile 2007 ed oggetto di adempimento anticipato in data 8 aprile 2010; detto rapporto era quindi soggetto alla previgente disciplina del Credito al Consumo.
In tale fattispecie, la Corte di Cassazione, ha riformato le decisioni dei precedenti gradi del giudizio, argomentando che – sebbene la previgente formulazione dell’articolo 125, comma 2, TUB, nella parte in cui stabiliva che: “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR” non abbia mai avuto seguito da parte del CICR – tuttavia il Consumatore non poteva essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, per la sola mancanza di una norma attuativa del CICR, essendo detto diritto al rimborso già sancito dalla norma di rango primario (art. 125, comma 2, TUB, nella versione vigente fino al 31 maggio 2011), e dalle Direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE[91].
Infine, la medesima Corte di Cassazione ha anche osservato che: “[…] una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33”, aggiungendo “sul piatto della bilancia” anche la censura di vessatorietà ai sensi dell’articolo 33, del Codice del Consumo[92].
Tale approccio è stato poi pedissequamente ribadito dalla Corte di Cassazione nelle successive Ordinanze del 28 maggio 2024, n. 14.836; del 13 giugno 2024, n. 16.550, del 16 ottobre 2024, n. 26.917 e del 30 maggio 2025, n. 14.528.
In ragione di ciò, agli adempimenti anticipati dei contratti di Credito al Consumo, si è ritenuto applicabile – a posteriori – il principio di diritto Lexitor anche se i detti contratti erano stati sottoscritti e/o addirittura estinti precedentemente all’introduzione della CCD.
Non può non rammentarsi tuttavia che l’articolo 30, della CCD, stabiliva che: “1. La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. 2. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1, seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
10.2 Rimborso anticipato di contratti di Credito ai Consumatori
Al rimborso anticipato dei contratti di credito soggetti alla disciplina del Credito ai Consumatori – con ciò intendendosi i finanziamenti di importo compreso tra Euro 200 e Euro 75.000, sottoscritti nel vigore del Capo II “Credito ai Consumatori”, del Titolo VI, del TUB, come sostituito dall’articolo 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della CCD – si dovrà sempre applicare il principio di diritto Lexitor.
Tuttavia, a rigore, la regola di cui al nuovo art. 125-sexies, comma 2, TUB, secondo la quale – per addivenire alla riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte – in mancanza di precise pattuizioni contrattuali si applicherà il criterio del “costo ammortizzato” – sarebbe applicabile soltanto nel caso del rimborso anticipato di contratti di credito sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021[93].
Da ciò consegue che, nel caso di rimborso anticipato di contratti di credito sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ferma la fisiologica mancanza di pattuizioni contrattuali a tale scopo, non vi sarebbero neppure regole di legge riguardanti i criteri da utilizzare per la riduzione medesima.
A tale proposito sembra quindi necessario continuare a fare riferimento alla Decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF, del 17 dicembre 2019, n. 26.525, ampiamente seguita dai Collegi territoriali, secondo la quale – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – si dovrà applicare ai costi recurring il criterio “pro rata temporis” e ai costi up-front il criterio della “curva degli interessi”.
Per quanto riguarda il criterio del “costo ammortizzato” – rinviando naturalmente a quanto evidenziato dalla Dottrina che se ne è occupata[94], e quanto evidenziato in alcune Decisioni ABF – si ritiene significativo riportare che, nella documentazione parlamentare reperibile[95], è segnalato quanto segue:
“[…] il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria corrisponde al valore iniziale al quale sono sottratti gli interessi pagati e i rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una perdita di valore”.
Il dubbio che ulteriormente si pone è quello se l’esclusione della rimborsabilità delle imposte – che pure entrano nel computo del costo totale del credito – stabilita dal Legislatore nazionale sia compatibile: (i) con il disposto dell’art. 16, par. 1, della CCD; (ii) con la definizione di costo totale del credito per il Consumatore; e (iii) con il principio di diritto Lexitor; detto in altre parole, il fatto che il Legislatore italiano abbia espressamente dichiarato non rimborsabili le imposte non sembra del tutto coerente con la normativa europea e anche tale aspetto potrebbe essere oggetto di censura/disapplicazione in sede giurisprudenziale.
10.3 Estinzioni anticipate di “mutui immobiliari” stipulati prima del 1° luglio 2016
L’articolo 3, del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, che ha introdotto nel TUB la disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori in recepimento della MCD, ha stabilito che: “[…] le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Per effetto di ciò si dovrebbe ritenere che alle estinzioni anticipate dei contratti di “mutuo immobiliare” stipulati precedentemente alla data del 1° luglio 2016, (quindi non soggetti alla disciplina MCD), non si debba applicare né l’art. 25, par. 1, della MCD, né l’art. 125-sexies (vecchio o nuovo), del TUB, né l’art. 120-quaterdecies.1, del TUB, né i principi di diritto enunciati dalla CGUE in relazione a tale Direttiva, anche se la specifica questione, sottoposta al vaglio dell’ABF e del Giudice ordinario, ha avuto – come si è detto – approcci ondivaghi.
10.4 Estinzioni anticipate di contratti MCD stipulati prima del 24 luglio 2021
Per quanto riguarda l’estinzione anticipata dei contratti di credito soggetti alla MCD (ossia, di quelli stipulati successivamente al 1° luglio 2016, ma fino al 24 luglio 2021), la stessa (per effetto del rinvio di cui al vecchio art. 120-noviesdecies, TUB), dovrebbe intendersi regolata dal vecchio art. 125-sexies, TUB, vigente sino a tale data, ma comunque da interpretarsi in conformità al principio di diritto Lexitor, secondo quanto precisato dall’attuale art. 11-octies, quindi con rimborso pro quota anche dei costi up-front, verosimilmente da effettuarsi secondo il criterio della “curva degli interessi”, eccezion fatta per le imposte.
Ad oggi però, in considerazione della specificità della sentenza Santander che è relativa all’interpretazione dell’art. 25, par. 1, della MCD ed ha efficacia retroattiva alla stessa stregua della sentenza Lexitor, si può ritenere che, anche all’estinzione anticipata dei contratti di credito MCD stipulati tra il 1° luglio 2016 e il 24 luglio 2021, valga il principio enunciato da quest’ultima sentenza, secondo il quale se le Informazioni Generali, il PIES e il contratto di credito consentono di presumere che le spese di istruttoria, le spese di perizia e le imposte rientrano nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, il Consumatore non avrebbe diritto al rimborso pro quota di tali voci.
10.5 Rimborso anticipato di contratti di credito MCD stipulati dopo il 24 luglio 2021
Il rimborso anticipato dei contratti di credito soggetti alla MCD stipulati a partire dal 25 luglio 2021 è ad oggi regolato dall’art. 120-quaterdecies.1, TUB, il cui intento, a prescindere dalla sua formulazione letterale – che riproducendo sostanzialmente quella del vecchio art. 125-sexies, TUB, non è di per sé univocamente significativa in un senso o nell’altro – sarebbe stato quello di escludere la rimborsabilità dei costi up-front.
Si vuole tuttavia evidenziare che la formulazione letterale dell’art. 120-quaterdecies.1 – letta alla luce del principio di diritto UCBA – non sembra consentire di affermare con certezza (almeno da parte di chi scrive), che la stessa possa essere univocamente interpretata nel senso di escludere la rimborsabilità pro quota dei costi up-front, e non è chiaro se il Legislatore italiano (peraltro in epoca precedente alla sentenza UCBA), abbia effettivamente voluto sancire ciò.
Per quanto invece riguarda la sicura rimborsabilità dei costi recurring, gli stessi dovrebbero essere rimborsati con il criterio del pro rata temporis[96].
La rimborsabilità pro quota delle imposte (che è espressamente esclusa dal nuovo art. 125-sexies, TUB, vigente dal 25 luglio 2021, per le operazioni CCD, ma non è menzionata dal nuovo art. 120-quaterdecies.1, per le operazioni MCD), a parere di chi scrive non potrebbe ritenersi serenamente esclusa, anche per le operazioni MCD, dalla nuova formulazione del comma 2, dell’art. 11-octies, introdotta dal DL n. 104/2023, il cui inciso finale stabilisce sì che: “non sono comunque soggette a riduzione le imposte”, ma che sembra riguardare soltanto il vecchio art. 125-sexies, e non l’art. 120-quaterdecies.1, TUB.
Detto in altre parole, la rimborsabilità delle imposte sarebbe chiaramente ed espressamente esclusa dal Legislatore per i rimborsi anticipati CCD, ma forse non altrettanto chiaramente per i rimborsi anticipati MCD.
Oltre a tale considerazione – che è riferibile al mero tenore letterale del comma 2, dell’art. 11-octies – si ritiene di dover esprimere, anche nell’ambito della disciplina MCD, gli stessi dubbi già espressi, in ordine alla “non rimborsabilità” delle imposte espressamente sancita in ambito CCD.
Come già detto, è infatti vero che la loro rimborsabilità sarebbe stata esclusa nelle argomentazioni sviluppate nelle Conclusioni (parr. 72 e ss.), dell’Avvocato Generale Manuel Campos Sanchez-Bordona, presentate , alla CGUE il 29 settembre 2022 per la causa C-555/21 UCBA – VKI, ma è anche vero che le argomentazioni medesime sono state riportate nella sentenza UCBA (soltanto) nel modo che segue: “31 Stanti tali condizioni, siffatto diritto [alla riduzione del costo totale del credito, ndr] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”, mentre il principio di diritto UCBA è invece il seguente:
“l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”; con il che la questione sembra francamente tutt’ora aperta.
Alla luce della sentenza Santander, la quale – da una parte – ha valorizzato un apparente obiter dictum della sentenza UCBA (secondo il quale il diritto del Consumatore alla riduzione del costo totale del credito: “[…] non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”), e – dall’altra – ha enunciato il principio di diritto secondo il quale: “in assenza di informazioni fornite dal creditore che consentano a un giudice nazionale di verificare se una commissione prelevata al momento della conclusione di un contratto di credito ipotecario rientri nella categoria dei costi che sono indipendenti dalla durata di tale contratto, detto giudice deve ritenere che tale commissione sia coperta dal diritto alla riduzione del costo totale del credito di cui a tale disposizione”, si dovrebbe auspicare che sia il modello delle Informazioni Generali (di cui all’Allegato 3, alle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia), sia il modello di PIES (costituente l’allegato II alla MCD, nonché, l’Allegato 4E alle medesime Disposizioni di Trasparenza), e i contratti di credito di volta in volta utilizzati, vengano ritenuti sufficientemente esplicativi in tal senso; ma ovviamente, anche in questo frangente, l’ultima parola spetterebbe al Giudice, nazionale e/o comunitario.
11. Conclusioni e prospettive
Al termine di questo lungo excursus – in cui però si è cercato di descrivere[97] una situazione che, a partire dall’11 settembre 2019, sembra essere divenuta decisamente cervellotica[98] – rimane una sensazione di disappunto e sconcerto per la complessità, che però sembra potersi definire del tutto artificiosa, di una questione semplice, acutamente evidenziata da certa Dottrina secondo la quale: “A conclusione delle riflessioni condotte nelle pagine precedenti sarebbe vano soffermarsi sull’altalena degli interventi legislativi nazionali e sulla tecnica imperfetta di cui questi sono dotati, per criticarli o deplorarli”[99], altalena sulla quale le presenti considerazioni si sono invece lungamente soffermate[100].
Il principio di diritto Lexitor, enunciato in ambito CCD, pur nella sua dirompenza, è apparso fin da subito molto chiaro. Meno chiari sono sembrati – a chi scrive – i portati delle successive sentenze UCBA e Santander, enunciate in ambito MCD.
Viene spontaneo pensare che la minor assertività, per non dire: la farraginosità delle argomentazioni di queste ultime, sia la conseguenza di un tentativo – da parte della CGUE – di mitigare, edulcorare, smussare gli impatti del principio di diritto Lexitor, ossia di introdurre dei “distinguo” allo scopo di evitarne l’applicazione “pura e semplice” anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito MCD.
Altra Dottrina ha sottolineato l’importanza delle difficoltà linguistiche e lessicali all’interno dell’Unione Europea[101].
Tanti anni fa il Cliente della Banca, fosse un consumatore o una società di capitali, sapeva – con sufficiente approssimazione – che se avesse estinto anticipatamente un finanziamento a medio o lungo termine, avrebbe dovuto pagare una penale, per compensare la Banca del mancato introito degli interessi che quello stesso Cliente avrebbe dovuto pagare negli anni a venire, se non avesse estinto anticipatamente il suo debito.
Con il passare degli anni alcune di queste penali sono state vietate dalla legge[102].
Ad oggi la situazione ha subito un radicale cambiamento per cui in molti casi sarà la Banca a dover rimborsare costi anticipatamente sostenuti dal consumatore, ma non “goduti” da quest’ultimo in conseguenza del rimborso anticipato.
Ciò deve senz’altro ritenersi corretto in relazione a determinati costi (ossia, quelli dipendenti dalla durata del rapporto, ma pretesi anticipatamente dal finanziatore); non sembra altrettanto condivisibile in relazione a costi che sono indipendenti dalla durata del rapporto; non sembra che sia rispondente ad un criterio di giustizia prevedere – a titolo puramente esemplificativo – la rimborsabilità di oneri di mediazione, di spese di istruttoria, spese di perizia e imposte[103].
Bargelli, op. cit., ha evidenziato che: “La decisione “Lexitor”, infatti, ha deliberatamente sancito l’eventualità che il consumatore possa arricchirsi chiedendo la restituzione della quota di corrispettivo versato per un’attività già interamente svolta in sede di perfezionamento del finanziamento. L’asimmetria degli obblighi restitutori, del resto, non è un fenomeno eccentrico nel diritto privato europeo, dove, al contrario, si scorge la tendenza a sancire l’unilateralità del diritto alla ripetizione — a favore dei consumatori — quando la bilateralità metterebbe in scacco gli obiettivi generali cui la legislazione dell’Unione è strumentalmente rivolta”.
La normativa, sia a livello eurounitario, sia a livello nazionale, dovrebbe puramente e semplicemente essere in grado di enunciare un quadro chiaro di norme giuridiche certe, nel quale finanziatori e finanziati siano posti nella condizione di conoscere con certezza diritti e obblighi.
Enunciare altisonanti norme programmatiche e principi di diritto, nonché fornire “interpretazioni autentiche” che sembrano suscitare ancor più dubbi che certezze, non sembra sia di utilità al “sistema”, al contrario appare foriero soltanto di una crescente litigiosità, dove gli operatori economici sono percepiti sempre di più come “nemici” e i Clienti presentati sempre di più come vittime di insopportabili prepotenze e soprusi, in una contrapposizione di opposte fazioni.
Appare di tutta evidenza che se una determinata norma europea – forse scritta in modo imperfetto e magari suscettibile di traduzioni non del tutto univoche nelle varie lingue dell’Unione – è stata interpretata per anni in certo modo – ma non da una singola Banca o intermediario finanziario, bensì da un intero Stato, quindi dal Legislatore, dai Regolatori di rango secondario e dai Giudici di quello Stato – e improvvisamente la CGUE afferma che quella norma doveva essere interpretata fin dall’origine in un altro modo, emergeranno prepotentemente nuovi filoni di litigiosità tra Banche, Clienti, Associazioni dei Consumatori, con conseguenze che – almeno a chi scrive – non sembrano propriamente auspicabili; ma certamente si tratta di un terreno insidioso e divisivo, dove entrano in gioco – da una parte – la certezza del diritto, la gestione dei rischi operativo, legale e reputazionale delle Banche e – dall’altra – il vantaggio del singolo Consumatore e di tutti coloro i quali hanno interesse a che un contenzioso purchessia venga ad esistenza.
Né francamente sembra possibile – nell’esercizio dell’attività bancaria – disattendere le interpretazioni della Banca d’Italia[104], così come non sembra possibile non tener conto di “un consolidato orientamento dell’autorità giudiziaria ordinaria”, affidandosi a: “la prudente previsione del futuro”[105], ove si consideri che – ad esempio – in materia di Credito ai Consumatori, le Disposizioni in materia di Trasparenza impongono (Sez. VII, Par. 5.2.1, lett. u), di indicare nei contratti di credito che: “[…] il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma”, e le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, impongono che: “ […] le procedure interne adottate dall’intermediario devono assicurare che l’ufficio o il responsabile della gestione dei reclami:
– si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall’organo decidente, attraverso la consultazione dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su internet […];
– valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi”.
Sarebbe allora auspicabile un intervento normativo – con disposizioni di tipo più precettivo e meno programmatico – volto a stabilire regole – anche tariffarie – certe.
Ad esempio, l’esperienza italiana della disciplina in materia di “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, di cui all’articolo 117-bis, TUB e conseguenti disposizioni applicative del MEF, a molti anni di distanza dalla sua entrata in vigore sembra aver portato un contributo significativo all’enunciazione di regole chiare e conseguentemente al miglioramento della relazione Banche-Clienti.
Dovrebbe quindi essere il Legislatore europeo a stabilire quali siano gli oneri applicabili, in quale misura ed eventualmente quali di essi – e con quali regole – siano destinati ad essere rimborsati in caso di scioglimento anticipato del rapporto[106] [107].
In tal senso non appare rassicurante[108] il quadro delineato dalla cd. CCD II, ossia dalla Direttiva (UE) 2023/2225 del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE, destinata ad essere recepita a decorrere dal 20 novembre 2026[109].
Al Considerando n. 70 è precisato che: “In linea con l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza Lexitor, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per il consumatore in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione. In caso di rimborso anticipato il creditore dovrebbe aver diritto a un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da parte delle autorità competenti dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al consumo, data la sua durata e il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di finanziamento a lungo termine, il limite massimo dell’indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specifica natura dei crediti ai consumatori e non dovrebbe pregiudicare l’approccio verso altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento a lungo termine, quali i prestiti ipotecari a tasso fisso”.
Per comodità di confronto si riporta poi il testo dell’art. 29, par. 1, “Rimborso Anticipato” della CCD II, a fianco di quello dell’art. 16, par. 1, della CCD:
| Art. 16, par. 1, della CCD | Art. 29, par. 1, della CCD II |
| 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto | 1. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore |
Non è confortante rilevare che – per la comprensione della norma – sembra ben più utile la lettura del Considerando n. 70, che non il tenore letterale dell’art. 29, par. 1, della CCD II.
In attesa di ciò è opportuno rammentare quanto indicato dalla Banca d’Italia nella già menzionata Comunicazione del 4 dicembre 2019, nella parte in cui veniva segnalata l’opportunità: “[…] di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l’applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento”[110] [111] [112].
[1] Per pronta evidenza: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
[2] Così il Considerando n. 9, della CCD.
[3] “Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.
[4] Rabitti M., “ABF e Lexitor: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa”, in questa Rivista, 31 gennaio 2020: “[…] il Collegio di Coordinamento risolve il problema dell’individuazione del metodo di calcolo utilizzabile per procedere alla riduzione dei costi up front, richiamando il medesimo criterio di calcolo utilizzato per gli interessi corrispettivi, che determina una riduzione progressiva del costo totale del credito in funzione del tempo trascorso. Questo criterio, che è inferibile dal piano di ammortamento, può dare risultati sostanzialmente analoghi a quelli ottenuti con uno schema tariffario che incorpori nel tasso annuo nominale (TAN) gli oneri connessi al finanziamento”.
[5] Secondo Rabitti, M., op. cit., la ragione secondo la quale “[…] la Banca d’Italia, nella Comunicazione del 4 dicembre scorso, ha scelto di escludere dall’obbligo di rimborso cui è tenuto l’intermediario il costo sopportato dal consumatore per le imposte”, potrebbe essere ascrivibile al fatto che l’intermediario non dovrebbe “[…] sopportare definitivamente il costo di una somma mai incassata, salvo che la stessa legge non lo disponga espressamente. Alla stessa conclusione si giunge anche ragionando in termini di corretta gestione imprenditoriale, considerando che, senza la possibilità di rivalersi su chi ha effettivamente ricevuto il vantaggio patrimoniale, l’intermediario si vedrebbe accollato un rischio di impresa non preventivamente valutabile e legato alla contingenza delle scelte dei consumatori. La restituzione di somme non percepite potrebbe anche essere considerata una scelta azzardata, imputabile a una non corretta gestione ad opera degli amministratori, esponendoli al rischio di dovere rispondere del loro operato nei confronti dei soci”.
[6] Fiorio P., “Oneri up-front e regolamentazione del mercato dopo la sentenza Lexitor”, su questa Rivista, 20 febbraio 2020: “Le indicazioni della Banca d’Italia e la decisione del Collegio di Coordinamento suscitano non poche perplessità con riferimento all’individuazione del criterio di calcolo per procedere alla riduzione di tutti i costi […] pilatescamente, Banca d’Italia rimette al ‘prudente apprezzamento degli intermediari’ la determinazione dei criteri di rimborso dei costi chiaramente indicati come up-front nei contratti, salvo precisare che ‘dovrà trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio lineare oppure costo ammortizzato)’”.
[7] Marasco C., “L’estinzione anticipata del credito: spunti di riflessione alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza”, in Rivista di Diritto Bancario, Fasc. II, Sez. II, 2023, pag. 365, ha evidenziato che: “Com’è stato evidenziato in letteratura, in sede europea sembrava fosse stato riconosciuto ai legislatori nazionali un certo margine di discrezionalità in ordine alla determinazione delle voci di costo e degli importi da restituire in concreto al consumatore. Conferma tale assunto la circostanza che gli Stati membri hanno recepito l’art. 16 della direttiva secondo modalità eterogenee tra loro, di fatto dettando in materia norme parzialmente dissimili l’una dall’altra. In particolare, il legislatore italiano, nel recepire la direttiva in parola mediante il D.lgs. 141/2010, ha introdotto nel Testo Unico in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) l’art. 125-sexies, il quale, nella propria originaria formulazione, prevedeva che il consumatore avesse diritto ‘a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto’. Chiaro appare il differente tenore letterale esistente tra la disposizione europea e quella interna, tenuto conto che quest’ultima limita la ripetizione delle spese alle due voci (interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto) che sono espressamente contemplate dalla stessa”.
[8] L’articolo 120-noviedecies, comma 1, TUB, nella sua formulazione originaria, vigente dal 1° luglio 2016 al 24 luglio 2021 stabiliva che: “1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater, 125-sexies, comma 1” [sottolineatura aggiunta, ndr].
[9] Di seguito, per brevità, si utilizzeranno le sigle CCD e MCD – in realtà, come detto, riferibili alle sole Direttive europee – anche per indicare, rispettivamente, la disciplina nazionale del Credito ai Consumatori e del Credito Immobiliare ai Consumatori.
[10] La locuzione “vecchio art. 125-sexies” è ampiamente utilizzata dall’Arbitro Bancario Finanziario a partire dalla Decisione del 22 febbraio 2022, n. 3.169 del Collegio di Palermo.
[11] Natale M., “Estinzione anticipata del credito ai consumatori, retrocedibilità dei costi e logica in apnea”, in Giustizia Civile, Vol. 8, fasc. 3, 2021, pag. 669, ha evidenziato che: “Tant’è che la corrispondenza testuale, a livello comunitario, del diritto al rimborso anticipato e alla riduzione del costo totale del credito ai consumatori aveva reso il recepimento dell’art. 25 dir. 2014/17/UE più semplice per il nostro legislatore. Si era deciso, cioè, attraverso la tecnica del rinvio, di legare il contenuto del rimborso anticipato nei rapporti di credito immobiliare a quello della disposizione già redatta, sulla medesima materia, nell’àmbito delle regole sul credito al consumo. Da qui l’introduzione, all’art. 120-noviesdecies TUB, di una disposizione di chiusura che rendeva tra l’altro applicabile ai contratti di credito immobiliare la previgente versione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB”.
[12] Secondo Natale M., op. cit., “[…] a destare perplessità è che, a livello comunitario, la formulazione testuale della seconda proposizione del § 1 dell’art. 25 dir. 2014/17/UE, che disciplina l’estinzione anticipata del credito immobiliare ai consumatori, sia di fatto identica a quella della seconda proposizione del § 1 dell’art. 16 dir. n. 48/2008/CE”.
[13] Gigliotti, F., “Rimborso anticipato del finanziamento e riduzione dei costi del credito. Variazioni ermeneutiche sull’art. 125-sexies T.U.B. (tra sentenza “Lexitor” e decreto sostegni bis)”, in Banca Borsa Titoli di Credito, Fasc. 2, 2022, pag. 198 e ss., ha evidenziato che: “ […] la Dir. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, la quale, confermando il diritto del consumatore «di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito» (art. 16, par. 1), ha però precisato che, in tal caso, gli va riconosciuta (più che una generica equa riduzione del credito) «una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»: in tal modo, fermo il diritto alla riduzione dei costi – conseguente al rimborso anticipato da parte del consumatore – la disciplina comunitaria ha superato il vago riferimento alla ‘equità’ (non altrimenti specificata) della riduzione, prescrivendo, più specificamente, che la stessa sia da praticare sul costo totale del credito e debba comprendere interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto […]”.
[14] Marasco C., op.cit., in relazione: “[…] al difficile raccordo tra le disposizioni di cui agli artt. 16 CDD e 25 MCD, così come tradotte in italiano, e il corrispondente testo ufficiale in lingua inglese”, ha segnalato che: “Nella versione italiana, infatti, la formulazione letterale delle norme risulta apparentemente coincidente, distinguendosi soltanto per i diversi predicati verbali utilizzati al fine di individuare i criteri di calcolo del rimborso spettante al debitore in caso di estinzione ante diem del rapporto. Come si è già ricordato, nell’ambito del credito al consumo, l’art. 16 CDD prevede che la riduzione ‘… comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’ laddove, nell’ambito del finanziamento a scopo immobiliare, l’art. 25 MCD stabilisce che il rimborso ‘… riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’. Volendo condividere l’orientamento della Corte, con il termine ‘comprende’ il legislatore europeo avrebbe riconosciuto ai singoli legislatori nazionali la facoltà di considerare ulteriori voci di spesa oltre a quelle espressamente contemplate; di contro, con il vocabolo ‘riguarda’ questa possibilità sarebbe stata preclusa”.
[15] Nella Decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 26.525/2019, era già stato segnalato che l’art.125 sexies TUB: “ […] dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Direttiva. Infatti l’art. 125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, ‘pari’ all’importo degli interessi e ‘dei costi dovuti per la vita residua del contratto’, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che ‘comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è ‘pari’ a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che ‘comprende’ esattamente le medesime voci”.
[16] Natale M., op. cit., ha evidenziato che il vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB: “[…] costituiva trasposizione pressoché letterale dell’art. 16, § 1, dir. 48/2008/CE. Qui l’unica variante lessicale percepibile stava nel fatto che la norma europea si riferisce ad una riduzione «che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto», mentre l’art. 125-sexies TUB prev. puntava a una riduzione «pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Una ipotetica estensione di significato poteva darsi soltanto assumendo che il riferimento alla «restante durata» del contratto servisse a selezionare i costi ammissibili a riduzione, in funzione del tempo di maturazione. La tesi era che la norma di diritto interno previgente («pari a») limitasse la portata della riduzione ai costi recurring, mentre la direttiva lasciava agli Stati membri la possibilità («comprende») di allargare l’oggetto della riduzione a costi diversi – evidentemente gli oneri up-front – da quelli maturandi nella restante durata del contratto”.
[17] Gigliotti, F., op. cit., mettendo a confronto l’art. 16, par. 1, della CCD e il vecchio art. 125-sexies, comma 1, TUB, ha evidenziato che: “Limitandosi, per il momento, alla mera considerazione esteriore, o formale, dei due testi normativi richiamati, indubbiamente può rilevarsi che se si mettono a confronto la lettera dell’art. 16, par. 1, Dir. 2008/48/CE – in forza della quale la riduzione (del costo totale del credito) da praticare comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto – e quella dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. – che quantifica la riduzione (sempre del costo totale del credito) in una misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto – una diversità testuale emerge innegabilmente, dal momento che la prima disposizione (almeno stando alla versione in lingua italiana della Direttiva) contempla una riduzione comprendente interessi e costi dovuti per la rimanente durata del contratto, mentre il secondo dato normativo equipara la riduzione all’importo di costi e interessi dovuti per la restante durata contrattuale; sì che, almeno prima facie, potrebbe sembrare finanche scontato che secondo la normativa comunitaria l’ammontare della riduzione possa (anche) superare (dovendolo soltanto “comprendere”) l’importo degli interessi e costi dovuti residuali; mentre in base alla norma di diritto nazionale la quantificazione della riduzione dovrebbe arrestarsi (“pari a”) al limite indicato”. Sempre nello stesso contributo l’Autore ha evidenziato che: “[…] non si avrà fatica a riconoscere che l’enunciazione linguistica recata dall’art. 125-sexies t.u.b. appare tutt’altro che suscettibile di un significato univoco e certo: e ciò non soltanto nella parte in cui essa stabilisce che la riduzione spettante al consumatore che ha rimborsato anticipatamente il prestito ricevuto va praticata sul costo totale del credito (parte che, come illustrato nel § che precede, risulta certamente compatibile con almeno tre significati diversi); ma anche nella parte in cui enuncia le modalità operative della riduzione, da effettuare elidendo (gli interessi e) i costi ‘dovuti’ per la vita residua del contratto. Tale ultimo riferimento, infatti, può certamente significare – se associato a una particolare “lettura” della prima parte della regola – che la riduzione consisterà nella eliminazione dei costi (e solo di essi) di tipo ricorrente (legando particolarmente la parola ‘dovuti’ alla espressione ‘vita residua del contratto’), i quali sarebbero maturati nel corso del rapporto anticipatamente estinto; ma può anche significare, per vero (prediligendo, in questo caso, una diversa ‘lettura’ della prima parte della regola) che la riduzione dovrà riguardare tutti i costi (dunque, anche quelli istantanei, cc.dd. up front) che concorrono a comporre il ‘costo totale’ del credito (costi anch’essi contrattualmente ‘dovuti’ dal consumatore ), la cui riduzione dovrà avere luogo in ragione della durata residua del contratto (laddove, in questa diversa prospettiva, il riferimento alla ‘vita residua del contratto’ – vita che viene tolta di mezzo dalla estinzione anticipata – assume il valore del rinvio a una ‘modalità’ di computo della riduzione , da effettuare in misura proporzionale alla restante (e venuta meno) durata del rapporto. Per quanto sin qui esposto, dunque, deve ragionevolmente concludersi per l’impossibilità di una interpretazione univoca […] dell’art. 125-sexies t.u.b., essendo invece da ammettere che esso risulta suscettibile di plurime e diverse interpretazioni ”.
[18] Nell’art. 3, “Definizioni”, della CCD (versione in lingua italiana) è infatti riportato che:
“g) “costo totale del credito per il consumatore”: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
h) “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare”: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito al consumatore; […];
l) “importo totale del credito”: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito”.
[19] Nell’art. 4 della MCD sono presenti le seguenti Definizioni:
“12) “importo totale del credito”: l’importo totale del credito definito all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2008/48/CE;
13) “costo totale del credito per il consumatore”: il costo totale del credito per il consumatore quale definito all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, inclusi i costi della valutazione dei beni se tale valutazione è necessaria per ottenere il credito ma esclusi i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile. Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
14) “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare”: l’importo totale che il consumatore è tenuto a pagare come definito all’articolo 3, lettera h), della direttiva 2008/48/CE”.
[20] Nel TUB non è invece stata inserita una definizione analoga a quella di “importo totale che il consumatore è tenuto a pagare” enunciata dall’articolo 3, lett. h), della CCD.
[21] Natale M., op. cit., ha segnalato che: “Sebbene l’arresto dei giudici europei si riferisca espressamente alla dir. 2008/48/CE, il solco segnato dalla sentenza Lexitor non sembra essere così distante dall’estensione di una disciplina di favore anche a chi ha contratto un mutuo immobiliare. Anzi, nella dir. 2014/17/UE campeggiano indicazioni che collocano la disciplina del credito immobiliare in continuità logica con la direttiva sul credito ai consumatori […] l’elemento che unisce le due direttive è l’aver posto al centro l’interesse del consumatore, per definizione soggetto debole della contrattazione. Indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili […]”.
[22] Ricciardi A., “Il principio sancito dalla Corte di Giustizia nell’ambito del caso Lexitor e Decreto Sostegni bis: problematiche applicative passate, presenti e future”, in Banca Borsa e Titoli di Credito, Fasc. 2, 2022, pag. 289: “5. Problematica che si è sin da subito posta nell’ambito della prassi applicativa concerne la possibilità di traslare le coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Giustizia Lexitor (successivamente recepite dal nuovo art. 125 sexies) con riguardo al credito al consumo nell’ambito del limitrofo settore del credito immobiliare ai consumatori”.
[23] La locuzione “mutui immobiliari”, oggi consacrata in vari testi normativi (ad es.: nella rubrica dell’articolo 120-ter, TUB), venne utilizzata ripetutamente dal Legislatore nel DL 31 gennaio 2007, n. 7 (cd. Decreto Bersani-bis), senza tuttavia darne una definizione tale da elevarla al rango di nomen juris; la stessa sembra pertanto riferibile ad un mutuo che abbia una qualche “connessione” ad un bene immobile, anche se non necessariamente garantito da ipoteca su bene immobile.
[24] Ancor più emblematicamente, in tale Decisione si legge: “Occorre preliminarmente soffermarsi sul rilievo dell’intermediario di inapplicabilità al finanziamento in esame dell’art. 125 sexies: in argomento, questo Arbitro osserva che, in base alla disciplina vigente al momento di stipula del contratto, effettivamente l’art. 122 del TUB esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione del Capo II relativo al Credito ai consumatori i finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili. Non sfugge tuttavia che un orientamento di questo Arbitro (Collegio di Napoli, decisione n. 21049/2018) milita nel senso che “in base a quanto letteralmente statuito dall’art. 122 lett. f) TUB la disciplina di cui al Capo II Titolo VI TUB (credito ai consumatori) non è applicabile alla fattispecie in questione. Purtuttavia, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, l’orientamento di questo Arbitro (e v. Collegio di Bologna, decisione n. 11702/17) milita nel senso dell’applicazione di quanto statuito dall’art. 125-sexies TUB anche a fattispecie analoghe a quella in esame”.
[25] “[…] il Collegio deve precisare che: se è vero che l’art. 122, 1° comma, lettera f, Tub, espressamente esclude dall’ambito di applicazione della disciplina […] relativa al credito ai consumatori i ‘finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili’; altrettanto innegabile è, tuttavia, che lo specifico rapporto in esame, palesando l’esplicita qualifica dei mutuatari come “consumatori” nell’atto di mutuo, […], rientra comunque nell’ambito di applicazione del […] credito immobiliare ai consumatori […]; e l’art. 120-noviesdecies Tub, segnatamente dispone che ai contratti di credito immobiliare ai consumatori si applica, fra gli altri, anche l’art. 125-sexies, 1° comma, Tub, […]. Va anche precisato sul punto che l’art. 120-noviesdecies Tub, per quanto inserito nel Testo unico bancario posteriormente […] alla stipula del contratto di mutuo fondiario in esame (20.9.2010), è comunque applicabile alla data di estinzione del contratto (14.5.2020) […]. Tanto premesso, malgrado sia ben noto il diffuso orientamento tra i Collegi di questo Arbitro incline ad applicare l’art. 125-sexies anche a fattispecie diverse dal credito ai consumatori [sottolineatura aggiunta, ndr] (cfr., in particolare, ABF Bari, n. 20119/2020; ABF Napoli, n. 17588/2020; ABF Napoli, nn. 5509 e 8382/2019; ABF Napoli, n. 21049/2018), la questione che qui viene in considerazione concerne, più esattamente, la riferibilità dei princìpi espressi dalla nota sentenza c.d. “Lexitor” […] anche alla fattispecie del credito immobiliare ai consumatori, trattandosi nella specie di verificare il fondamento di una specifica domanda di rimborso di costi c.d. up front. Il Collegio è dunque chiamato a stabilire se il principio di diritto statuito dalla sentenza testé citata […] debba valere anche per la diversa fattispecie del credito immobiliare ai consumatori […]”.
[26] “ […] Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene vada stabilito se, nel caso di specie, possa trovare applicazione la disciplina prevista all’art. 125-sexies, comma 1, TUB (introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010), che prevede il diritto al rimborso degli oneri anticipati e non goduti. Su tale aspetto osserva il Collegio che a norma dell’art. 122, comma 1 lett. f del TUB, le disposizioni sul “credito ai consumatori” (di cui al Tit. VI, capo II del TUB) non trovano applicazione per i “finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”. Peraltro, nell’art. 120 noviesdecies, comma 1, del TUB (introdotto dal d.lgs. n. 72 del 21 aprile 2016, […]), è stata espressamente estesa al “credito immobiliare ai consumatori” l’applicabilità dell’art. 125 sexies, comma 1 […]. Tuttavia, l’art. 3, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 72/2016 dispone che “1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Tale disciplina, dunque, non è applicabile al caso di specie in quanto il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato in data 7/05/2009 (nello stesso senso, Collegio di Bari, n. 20119/20)”.
[27] Natale M., op. cit., ha commentato: “Una decisione, si ricorderà, passata alla storia poiché i giudici di Lussemburgo avevano offerto una discussa interpretazione dell’art. 16, § 1, dir. 2008/48/CE, riconoscendo al consumatore il diritto alla riduzione di «tutti i costi» del credito, senza alcuna distinzione. Il dictum aveva prodotto effetti devastanti per l’ordinamento italiano, alzando l’asticella del contenzioso contro quei numerosi istituti di credito che, in nome della trasparenza, avevano per anni interpretato l’art. 125-sexies TUB prev. in modo selettivo, distinguendo tra costi rimborsabili, perché legati alla durata residua del contratto (recurring), e costi non rimborsabili, in quanto maturati anticipatamente alla concessione del finanziamento (up-front)”.
[28] Mocci F. – Bettoni A., “Decreto sostegni bis: il TUB si adegua alla Lexitor, ma solo per il futuro”, in questa Rivista, 29 luglio 2021, segnalarono che: “Una modifica inattesa, introdotta a fari spenti […] In un provvedimento consacrato alla risoluzione di problematiche legate alla crisi economica post-pandemica, è stato introdotto in sede di conversione, un poco a sorpresa, un emendamento extravagante al decreto ‘sostegni bis’, che avrà impatti significativi sul mercato del credito ai consumatori”.
[29] E’ da notare la terminologia utilizzata dal Legislatore: l’art. 16, della CCD, così come l’art. 125-sexies, TUB, (sia il vecchio che il nuovo), sono rubricati “Rimborso anticipato”; l’art. 25, della MCD, è rubricato “Estinzione anticipata”, mentre il nuovo art. 120-quaterdecies.1, TUB, è rubricato invece “Rimborso anticipato”.
[30] Così – in parte – anche nel comma 1, dell’art. 11-octies, del DL 73/2021. La mancanza di notizie sulla genesi e sulla ratio dell’art. 11-octies, del DL 73/2021, è stata rimarcata anche dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la Decisione n. 21.676, del 15 ottobre 2021, nella quale si legge: “[…] non può il legislatore avere ignorato le ricadute della sentenza Lexitor per l’ordinamento italiano e le correlative questioni interpretative emerse con esiti difformi in giurisprudenza, questioni in relazione alle quali questo Collegio aveva a suo tempo preso posizione nella più volte ricordata decisione n. 26525/2019. Pur in mancanza di relazioni o lavori preparatori all’intervento normativo di cui si disquisisce, tale ultima affermazione pare trovare una indiretta conferma in quanto si legge nella ‘Interrogazione a risposta immediata nella VI Commissione (Finanze)’, […] In tale documento si legge, infatti, che, con riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l’11 settembre 2019 (‘sentenza Lexitor’) si ‘auspica l’adozione immediata di «iniziative normative che chiariscano pro futuro l’applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa»’ ”.
[31] Secondo Marasco, C., op. cit.: “È stato chiaro l’intento del legislatore italiano di applicare il principio di onnicomprensività del rimborso dei costi stabilito dalla CGUE nel 2019 e, dunque, di assicurare il puntuale adeguamento dell’ordinamento nazionale alle indicazioni provenienti dai giudici di Lussemburgo, con l’obiettivo ultimo di arginare il rischio di una procedura d’infrazione cui l’Italia si sarebbe, probabilmente, altrimenti esposta”.
[32] Mocci F. – Bettoni A., op. cit., in relazione alla distinzione tra costi up-front e costi recurring riassumono che: “I primi sono quelli sostenuti all’atto della concessione del finanziamento: per esempio, le spese di istruttoria e di intermediazione; i secondi sono quelli che maturano nel tempo: per esempio, le spese di incasso rata”.
[33] Malvagna U., “La nuova disciplina dell’estinzione anticipata e i contratti di credito ai consumatori: tra legge, ABF e Corte Costituzionale”, in Banca Borsa Titoli di Credito, fasc.1, 2022, pag. 49 e ss., evidenzia che per up-front, in sostanza, si intendono quelle voci di spesa: “[…] riferite ad attività, costi o prestazioni già svolte, sostenuti o rese, e la cui utilità non si commisura alla durata effettiva del finanziamento, quanto invece al fatto del finanziamento, in quanto tale considerato”.
[34] Rabitti M., op. cit., all’indomani della pubblicazione della sentenza Lexitor, evidenziava tempestivamente: “Il rischio è che gli intermediari, che si sono progressivamente adoperati per adeguarsi alle buone prassi fondando su queste un legittimo affidamento, si trovino oggi a sopportare costi non preventivati per rimborsare le voci up front, oltre a costi di compliance necessari per adeguare i propri assetti organizzativi e i propri contratti così onerosi da indurli a disattendere le pronunce dell’arbitro preferendo assumere il rischio di lite innanzi all’autorità giudiziaria”.
[35] Caturano, W. G., “Caso ‘Lexitor’ – La legge di conversione del Decreto ‘Sostegni bis’ riforma il testo dell’art. 125 sexies TUB, recependo l’orientamento dei Giudici di Lussemburgo senza effetti retroattivi”, in Ex Parte Creditoris, 22 luglio 2021: “Privilegiando un approccio in linea con la ‘certezza del diritto’, il Legislatore si pone l’obiettivo di disciplinare gli effetti intertemporali della nuova disciplina, ‘ratificando’ di fatto l’operato degli Enti regolatori del settore bancario, che avevano sempre orientato gli istituti finanziatori ad interpretare la pre-vigente normativa nel senso di distinguere – nel rispetto della trasparenza contrattuale – tra oneri ‘up-front’ e ‘recurring’ ai fini del rimborso anticipato”.
[36] Mocci F. – Bettoni A., op. cit.: “Merita però apprezzamento il tentativo di premiare la buona fede di quegli intermediari che si erano adeguati alle prescrizioni e alle indicazioni dell’Autorità di vigilanza nella predisposizione della documentazione di trasparenza e dei contratti, trovandosi poi nell’incomoda situazione di subire perdite patrimoniali per un comportamento virtuoso”.
[37] Mucciarone G., “Estinzione anticipata del credito al consumo e riduzione del costo del credito”, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, novembre 2021: “L’articolo 11-octies del Decreto Sostegni-bis, […], nel dar nuova veste normativa de futuro all’interpretazione della Corte Europea, ha tentato di ripristinare, per il passato, la distinzione tra oneri recurring e up-front. […] Non dovrebbe dubitarsi che, riferendosi a tali provvedimenti, la mens legis del Decreto Sostegni-bis fosse di far rivivere, per i contratti stipulati prima, l’applicazione della distinzione recurring/up-front. E non ne hanno dubitato i primi, pronti commenti: che hanno salutato la morte della sentenza Lexitor”.
[38] Natale M., op. cit.: “[…] al fine di scongiurare l’applicazione estensiva dei princìpi sanciti dalla sentenza Lexitor, il legislatore della novella ha modificato il quadro normativo dell’estinzione anticipata anche nel settore del credito immobiliare ai consumatori […] Nella sua complessità, l’operazione di drafting legislativo è qui tesa a specificare che nel settore dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di immobili residenziali e/o assistiti da garanzia ipotecaria, la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato continuerà a riguardare i soli costi recurring. Analogamente, nell’escludere l’applicabilità al settore del credito immobiliare ai consumatori della nuova versione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB, il legislatore intende implicitamente affermare che i princìpi sanciti dalla corte di giustizia nel caso Lexitor non si applicano estensivamente alla direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive)”.
[39] E’ sembrato di diverso avviso Santagata R., “Prime note sulla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori (e del credito immobiliare)”, in Banca Borsa e Titoli di credito, Fasc. 2, 2022, pag. 179 e ss.: “Con specifico riguardo al credito ai consumatori, si è trattato di un intervento legislativo sicuramente doveroso, come dimostrano le coeve esperienze tedesca ed austriaca, in cui l’adattamento ai precetti della sentenza Lexitor è stato parimenti imposto […]. Non può dirsi altrettanto, per converso, rispetto alla nuova regola del rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori di cui all’art. 120-quaterdecies.1 t.u.b., non essendo stata affatto investita dalla pronuncia Lexitor la diversa direttiva 2014/17/CE (c.d. MCD), fonte della disciplina eurounitaria di tale tipologia di finanziamento […]”.
[40] Di diverso avviso, Natale M., op cit., il quale ha evidenziato che: “La disposizione si distingue dalla sua precedente formulazione per la chiarezza di significato, allontanandosi dalla stessa lettera dell’art. 16, § 1, dir. 2008/48/CE di cui costituisce attuazione. Tuttavia, a parte l’esplicita previsione della proporzionalità del rimborso e l’esclusione degli oneri erariali, che suscita perplessità con riferimento alla nozione di costo totale del credito, [sottolineatura aggiunta, ndr] la scelta del legislatore è qui, tutto sommato, ricognitiva. La novella non fa altro che recepire le istruzioni del giudice europeo, andando all’ingrosso con la regola della rimborsabilità di ‘tutti’ i costi, anche se a maturazione istantanea (up-front)”. Dello stesso avviso, Mocci F. – Bettoni A., op. cit.: “[…] la nuova previsione appare molto più chiara, sotto questo profilo, della stessa norma comunitaria da cui trae origine, di cui non rappresenta più una traduzione pressoché letterale. Il che se si vuole conferma, a posteriori, che la norma della CCD tanto chiara non sia e che le interpretazioni affermatesi in tutta l’Unione non fossero frutto di un cartello tra gli intermediari, ma il risultato di una formulazione imprecisa e aperta a diversi punti di vista”.
[41] Così Cass. 16 aprile 2008, n. 9972, che richiama numerosi precedenti della medesima Corte, tra cui Cass. 5 aprile 2000 n. 4221; ma v., anche dopo di essa, Cass. 20 marzo 2009, n. 6831; Cass. 3 luglio 2013, n. 16.620; Cass 9 aprile 2015, n. 7076.
[42] Rabitti, M. op. cit., all’indomani della pubblicazione della sentenza Lexitor, evidenziava tempestivamente che: “Vi è inoltre l’incertezza che in futuro l’intermediario riduca la catena della distribuzione, scegliendo di non avvalersi di agenti e mediatori per non sopportarne il costo in caso di estinzione anticipata, con evidente risparmio di costi ma con un aggravio della posizione del cliente che non potrà più avvalersi della capillarità dell’offerta”.
[43] Natale M., op. cit., secondo il quale: “La novità di rilievo sostanziale è però contenuta nel comma 2, che colma una delle lacune più evidenti lasciate dalla sentenza Lexitor, ossia il criterio di calcolo da adottare per la riduzione dei costi legati al finanziamento. La soluzione del legislatore è qui di compromesso. Nel bilanciare autonomia contrattuale e istanze del settore bancario, s’impone che «i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi». Segnatamente, le clausole generali di contratto dovranno d’ora in poi evidenziare in modo analitico l’applicabilità del criterio della proporzionalità lineare (c.d. pro rata temporis) o il criterio del costo ammortizzato (c.d. curva degli interessi) . In difetto di tale indicazione, sarà quest’ultimo ad applicarsi ex lege ai contratti di credito estinti anticipatamente La disposizione solleva, però, alcuni problemi […] Il criterio della curva degli interessi implica infatti una modalità di calcolo sfavorevole al cliente, in quanto, in genere, i finanziamenti prevedono un ammortamento alla francese che comporta il pagamento della quota interessi principalmente nelle rate iniziali”; lo stesso Autore, ibidem, alla nota 11, osserva che: “Nel calcolo pro rata temporis l’importo oggetto di restituzione viene calcolato mediante suddivisione dell’importo complessivo degli oneri per il numero totale delle rate e moltiplicazione del risultato calcolato per il numero di rate residue. Nel criterio del costo ammortizzato, invece, si calcola il peso percentuale degli interessi non ancora maturati alla data del rimborso anticipato rispetto all’ammontare complessivo degli interessi e si applica la percentuale così ottenuta all’ammontare delle spese collegate al finanziamento”.
[44] Per una critica della scelta legislativa del criterio del “costo ammortizzato” quale criterio di default, v. anche Malvagna U., op. cit., secondo il quale: “In particolare, la coerenza ai principi dell’individuazione del costo ammortizzato quale criterio residuale è assai dubbia, una volta che ci si faccia edotti del fatto che tale modalità di calcolo – la quale assume come propria base di riferimento il rapporto fra gli interessi maturati (e pagati) sino al momento del rimborso anticipato, e quelli maturandi sino al termine originario del rapporto […] – conduce generalmente, a motivo del comune impiego da parte degli operatori di piani di ammortamento cc.dd. « alla francese », a risultati di minore vantaggio per il consumatore. O, quanto meno, a risultati che non possono ritenersi sicuramente più favorevoli per il consumatore. Posto questo dato, sarebbe senz’altro stato più coerente con le logiche proprie della normativa di trasparenza e con i relativi obiettivi di policy – che richiedono l’enucleazione di strutture rimediali negoziali idonee a produrre un adeguato effetto di deterrenza rispetto alla violazione dei precetti posti dalla medesima normativa – prevedere che la mancata indicazione del criterio avrebbe comportato il ricorso a quella modalità di calcolo (“costo ammortizzato” ovvero “proporzionalità lineare”) tale da condurre, nel concreto, alla maggiore riduzione del costo del credito in favore del consumatore […]”.
[45] Santagata R., op. cit., ha evidenziato che: “4. Dal novellato testo dell’art. 125-sexies pare emergere per il credito ai consumatori, in buona sostanza, una nuova concezione delle commissioni alla stregua di componenti del compenso per il differimento della restituzione del capitale rispetto alla sua dazione, con il corollario di un loro trattamento giuridico tendenzialmente equivalente a quello degli interessi corrispettivi . Siffatta impostazione traspare anche dalla nuova regola sul criterio di calcolo del rimborso, […] la quale, nel silenzio del contratto, non lascia più alcun margine alla praticabilità del trattamento differenziato delle voci di costo up-front e recurring […]. In particolare, depone nei sensi testé indicati la scelta italiana, non imposta né dalla direttiva 2008/48/CE né dalla sentenza Lexitor, del metodo di calcolo residuale da utilizzare […] : il costo ammortizzato, usualmente adoperato proprio per il calcolo degli interessi corrispettivi. Ed invero, tale opzione è tanto più significativa se si considera che gli effetti economici dell’adozione di questo metodo risultano penalizzanti per il consumatore rispetto agli esiti dell’applicazione dell’alternativo criterio proporzionale puro, sinora prediletto dalla giurisprudenza togata ed arbitrale nel silenzio del contratto […]”, evidenziando altresì che si tratterebbe di una: “[…] singolare fattispecie di interpretatio contra proferentem ‘alla rovescia’ – in deroga, cioè, al principio declinato dagli artt. 35, comma 2°, cod. cons. e 1370, cod. civ. […]”.
[46] Malvagna U., op. cit., ha segnalato che: “2.2. Venendo alla considerazione della locuzione « criterio del costo ammortizzato », chi guarda a questa disposizione con il bagaglio conoscitivo derivante dalla lettura della produzione dell’Abf è portato a considerarla come una variante lessicale enunciativa del criterio della c.d. « curva degli interessi ». Come detto […], esso identifica il parametro sulla base del quale definire la misura della riduzione del costo del credito nel rapporto fra gli interessi maturati (e pagati) sino al momento del rimborso anticipato, e quelli maturandi sino al termine originario del rapporto. Così, ad esempio, Abf, Collegio di Roma, 2 luglio 2021, n. 15987, discorre di « criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi ». In altre decisioni, il medesimo metodo è definito come criterio dell’« interesse effettivo », a sua volta definito come « metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo », che « attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lunga la vita attesa dello strumento finanziario o, comunque, lungo un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziario » (così, ex plurimis, Abf, Collegio di Napoli, 11 agosto 2014, n. 5165). In realtà, dal punto di vista normativo (art. 2426 c.c. come integrato dai principi contabili nazionali o internazionali) il criterio del costo ammortizzato esprime una serie di regole tecniche, di natura contabile, che appare più articolata e complessa. Quando affronta il tema, lo IAS 39/IFRS 9 [richiamato, per quanto attiene ai principi nazionali, dal principio 15 dell’Organismo Italiano di Contabilità (11)] statuisce che « il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di insolvenza »; mentre il “tasso di interesse effettivo” è « il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria »”.
[47] Mocci F. – Bettoni A., op. cit., secondo i quali: “L’ipotesi è quella in cui il finanziatore abbia riconosciuto all’intermediario del credito (mediatore creditizio o agente in attività finanziaria) la provvigione per la sua attività, ribaltata poi sul cliente e inserita nel corrispettivo totale da questi corrisposto. In caso di estinzione anticipata, la banca o la società finanziaria si troverebbe a restituire anche una frazione di tale compenso al cliente, subendo così un (ingiusto) pregiudizio economico. Per ovviare a questo inconveniente, il legislatore ha quindi previsto che il soggetto finanziatore abbia la possibilità di agire in regresso nei confronti dell’intermediario del credito, limitatamente alla quota parte del compenso oggetto di restituzione. È fatta salva la possibilità per le parti di disporre diversamente. La previsione è stata vivacemente contestata, durante l’iter di approvazione della legge, dagli intermediari del credito, che hanno lamentato che la gran parte dell’attività di mediatori creditizi ed agenti in attività finanziaria si esaurisca al momento dell’instaurazione dei rapporti; con la conseguenza che la restituzione parziale delle spese di intermediazione ai clienti finali e il regresso pro quota dei finanziatori rende di fatto non remunerata una parte del lavoro degli intermediari del credito. L’osservazione è corretta, ma non sembra centrare esattamente il bersaglio. Infatti, oggetto di critica non dovrebbe essere, a ben vedere, il regresso, che rappresenta una naturale conseguenza dei ragionamenti della Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor. Se non lo si consentisse, sarebbero i soggetti finanziatori a subire un pregiudizio, dovendo pagare per intero gli intermediari e dovendo poi restituire una parte del compenso ai clienti: si sposterebbe soltanto il destinatario dell’ingiustizia. In verità, le ricadute sulle reti distributive (le associazioni di categoria parlano esplicitamente di rischio di disintermediazione, con prospettive fosche per il comparto, o di selezione dei distributori sulla base di criteri non più meritocratici ma legati alla possibilità di assorbire le conseguenze negative delle richieste di rimborso della clientela) evidenziano il semplicismo del ragionamento della Corte europea. La CGUE, per ragioni di praticità (e di facile appagamento delle ragioni consumeristiche) ha invero posto nel nulla una distinzione, quella tra costi upfront e recurring, che era corretta e che rispondeva alla realtà dei fatti, al di là degli abusi che qualche banca o società finanziaria aveva commesso (e che si poteva reprimere senza stravolgere dalle fondamenta il mercato, con danni anche per i player più virtuosi). Per cui la critica degli intermediari del credito è in definitiva una critica alla sentenza Lexitor: la quale è però ormai da considerarsi un fatto storico”.
[48] A chi scrive, non sembra condivisibile la critica di Natale M., op. cit., secondo il quale: “In pratica, vista la regola della rimborsabilità dei costi up-front, nei quali rientrano anche i compensi dei mediatori o degli agenti in attività finanziaria, e considerato che in caso di estinzione anticipata l’istituto di credito si troverebbe a restituire anche una frazione di tale compenso al cliente, il legislatore stabilisce ora che, salva diversa pattuizione, «il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito» La scelta del legislatore appare qui eccessiva e di dubbia costituzionalità. Gli intermediari sono infatti soggetti ai quali sfugge ogni potere di intromissione nel meccanismo contrattuale ed estintivo. Questi sono solitamente obbligati a soggiacere alle vicende del finanziamento impresse dai rapporti fra il cliente e il finanziatore. Chiamarli a divinare il futuro, ossia a valutare se il consumatore stia barando, nel senso di contrarre a lungo termine per poi anticipare l’estinzione, così da prendere un free ride, significa di fatto pretendere che gli stessi intermediari si facciano carico del rischio del cliente. Anche per questo, allora, la chiamata in responsabilità pro quota, ma non in solido con il finanziatore, appare una scelta davvero punitiva, oltre che irragionevole”. Non condivisibile, a parere di chi scrive, perché se l’intermediario del credito ha percepito una commissione, ma sia poi il finanziatore a doverla rimborsare al consumatore (che, in ipotesi, non sta “barando” nel senso ipotizzato, ma semplicemente ha deciso di rimborsare anticipatamente il suo debito con il finanziatore), non si vede per quale ragione questo onere (incassato dall’intermediario del credito), debba costituire poi un costo per il finanziatore, il quale pure non dispone di capacità divinatorie (forse anche meno dell’intermediario del credito), e soggiace alla scelta del consumatore di rimborsare anticipatamente alla stessa stregua dell’intermediario del credito.
[49] Malvagna U., op. cit., secondo il quale: “Al riguardo, colpisce anzitutto l’incongruità della disposizione rispetto alla sedes materiae […] di là dell’oggettiva non necessità in sé di una simile norma — giacché si tratta di un aspetto attinente a rapporti «interni» tra imprese, che hanno tutte le capacità organizzative per regolare, pro futuro, questi profili […]”.
[50] Santagata R., op. cit., evidenzia tra l’altro che: “ […] avvalendosi dell’opportuna ‘salvezza’ di una «diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito» posta in apertura del 3º comma dell’art. 125-sexies t.u.b., pare possibile convenire l’esclusione del diritto di regresso del finanziatore nei riguardi, ad esempio, di un mediatore creditizio […]. Una simile convenzione sortisce l’effetto di rendere irripetibile per l’intermediario del credito il compenso percepito […]. Tale accordo lascia comunque impregiudicato l’obbligo del finanziatore di ridurre il costo del credito anche per la quota parte di quel compenso proporzionale alla restante durata del finanziamento, sicché si traduce nel sostanziale accollo del finanziatore della porzione dei costi di intermediazione eccedente (e sproporzionata) rispetto all’effettivo periodo di godimento del finanziamento da parte del cliente. Il che impone allora di ricercare, sul piano teorico, un’adeguata giustificazione causale di tale attribuzione patrimoniale, gravante su un soggetto (il finanziatore) che non ha effettivamente incassato il compenso fatturato dal mediatore. È questo un tema “di vertice” destinato ad incidere sullo stesso inquadramento giuridico dell’istituto regolato dall’art. 125-sexies t.u.b., perciò bisognoso di un approfondimento inconciliabile con la prima lettura della nuova norma che in questa sede si è inteso proporre”.
[51] Mocci F. – Bettoni A., op. cit.: “È allo stato difficile ipotizzare quali saranno le reazioni delle associazioni dei consumatori, e quali argomentazioni verranno spese per cercare di neutralizzare l’intervento legislativo (dubbi di costituzionalità della norma; violazione del principio del primato del diritto comunitario; lesione delle prerogative della Corte di Giustizia; etc.)”.
[52] Gigliotti, F., op. cit., ha evidenziato che: “Non ci si può nascondere, tuttavia, che la prospettiva di un legislatore che, sia pure per varie ragioni di “politica del diritto”, ritenga di dovere consapevolmente e deliberatamente dissentire (sebbene, soltanto, con riguardo a una serie – circoscritta temporalmente, ma invero assai estesa quantitativamente – di relazioni negoziali determinate e non più incrementabili) da una disciplina eurounitaria vincolante, per un certo tratto temporale della sua vigenza, lascia emergere profili problematici che – probabilmente – finiranno per non resistere alla prova del tempo”.
[53] Tale Decisione, assai articolata, è emblematica della complessità della questione: “L’impostazione prospettata dal Tribunale di Savona nella citata decisione 15 settembre 2021, n. 680, non può, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, essere seguita e condivisa. Questa interpretazione, infatti, appare integrare una lettura contraria alla lettera della legge, introducendo una limitazione alla portata del secondo periodo dell’art. 11 octies, comma 2°, che il testo di tale disposizione non prevede. Il tentativo compiuto, seppur apprezzabile, pare superare i limiti di un’operazione meramente interpretativa (pur intesa in senso ampio), giungendo sostanzialmente a configurare una parziale disapplicazione dell’art. 11 octies comma 2°, esito, quest’ultimo, che deve ritenersi precluso per le ragioni più sopra evidenziate. Sulla scorta di tali rilievi deve quindi ribadirsi che i possibili profili di contrasto con il diritto europeo non appaiono risolubili semplicemente sul piano ermeneutico.
D’altra parte l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti (per la riaffermazione di tale consolidato principio cfr., per tutte, di recente, Corte di Giustizia, 7 agosto 2018, Smith, C-122/17, e ultt. decisioni ivi citate). In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt.11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale (così come chiaramente enunciato dalla Corte Cost., ord. 21 luglio 2011, n. 218). Dal che discende anche che non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea. In estrema sintesi: a) il quadro normativo esistente alla data in cui il Collegio di Coordinamento emise la decisione n. 26525/2019 è mutato e di ciò non può non tenersi conto; b) questo Collegio non può esimersi dal dovere di decidere la controversia sulla base della introduzione della disposizione di cui all’art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato; c) non è praticabile, nel caso concreto, né la suggerita interpretazione adeguatrice né la disapplicazione della norma nazionale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio: ‘in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014’”. Per un ampio commento della Decisione, v. Malvagna U., op. cit..
[54] Malvagna U., op. cit., nel commentare la Decisione del Collegio di Coordinamento dell’ABF n. 21.676/2021, nella parte in cui sembrava auspicare la possibilità che un Giudice sollevasse questione di legittimità costituzionale ha segnalato: “Il testimone è stato subito raccolto dal Tribunale di Torino. Con ordinanza del 2 novembre 2021, il giudice piemontese ha preso atto dei contenuti della decisione dell’Arbitro, per sollevare la questione di costituzionalità in via incidentale relativamente all’art. 11-octies, d.l. 73/2021, in ragione della sua ritenuta contrarietà agli artt. 3,11 e 117, primo comma, della Costituzione […] Come si nota, i contenuti dell’ordinanza di rimessione vengono ad allinearsi a quelli della decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario”.
[55] Marasco, C., op. cit., ha riassunto come segue: “[…] la Consulta ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 dell’art. 11-octies D.L. 73/2021 in quanto le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, espressamente richiamate nel nuovo testo della disposizione, contrastano con i principi delineati dalla CGUE nella sentenza Lexitor. In particolare, la Corte costituzionale ha rilevato che siffatto rinvio integrerebbe un’ipotesi di completamento prescrittivo della norma primaria, con la peculiarità che, nel caso in discorso, la norma oggetto di censura è una disposizione primaria successiva, volta ad integrare il contenuto normativo di una precedente, mediante il rinvio a norme di rango secondario. Alla luce di tale considerazione, la Corte ha affermato che applicare le disposizioni secondarie sopra menzionate ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. 106/2021 impedirebbe di interpretare l’intera norma in discorso in maniera conforme ai principi fissati nella sentenza Lexitor. Di qui, la condivisibile conclusione cui sono pervenuti i giudici nel provvedimento in parola, secondo cui dalla disposizione censurata andrebbe eliminato il riferimento alle ‘norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia’. Dunque, la Corte ha chiarito che i principi dettati dalla CGUE nella sentenza Lexitor vanno applicati a tutti i contratti, antecedenti e successivi alla pubblicazione della medesima, tenuto conto che, in assenza di una deroga espressa da parte della Corte, la pronuncia dispiega effetti retroattivi non modulabili dagli Stati membri”.
[56] V. anche quanto espresso da Natale M., op. cit., riportato alla precedente nota n. 40.
[57] Bargelli, E., “Anticipata estinzione dei contratti di credito al consumo e restituzione dei costi accessori: il ruolo dell’indebito e dell’ingiustificato arricchimento”, in Banca Borsa Titoli di Credito, Fasc. 2, 2024, pag. 204, evidenzia che: “[…] l’esclusione delle imposte dal principio della ripetibilità integrale è facilmente spiegabile proprio in ragione della fonte legale e della strutturale impossibilità di dar luogo al rischio di abusi […]”.
[58] Questa definizione è reperibile a pag. 174, del dossier “Schede di lettura” del D.L. 73/2021 – A.S. 2320, n. 393/2 del Servizio Studi del Senato della Repubblica, Volume I – Articoli 1-35-ter, datato 19 luglio 2021, reperibile sul sito internet del Senato.
[59] In tal senso, v. ABF Bari n. 1311/2021.
[60] Natale M., op. cit., ha segnalato che: “Di fatto, il perimetro applicativo del nuovo art. 120-quaterdecies.1. TUB dipenderà dalla prossima interpretazione del suo contenuto, che riproduce, però, quasi letteralmente, il previgente art. 125-sexies TUB”, precisando altresì che: “Allo stesso modo del nuovo art. 120-quaterdecies.1 TUB, anche l’art. 125-sexies TUB prev. disponeva nel senso del diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito in misura «pari all’importo degli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto». Non è escluso, pertanto, che, in relazione al nuovo art. 120-quaterdecies.1 TUB, la giurisprudenza riprenda le medesime argomentazioni utilizzate dalla corte di giustizia sull’irrilevanza dell’argomento testuale rispetto all’art. 16, § 1 dir. 48/2008/CE, applicandole all’art. 25 della dir. 2014/17/UE”.
[61] In questo senso, v. la già richiamata Decisione ABF Bologna 11.463/2023, dove si legge anche che: “[…] la fattispecie in esame è dunque disciplinata dall’art. 120-quaterdecies 1 TUB il quale (a differenza dell’art. 125 sexies oggi non più richiamato dall’art. 120-noviesdecies), prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto in tal modo consentendo la non rimborsabilità dei costi c.d. up front che non riguardano la vita residua del contratto. E’ da ritenersi pertanto esclusa la rimborsabilità dei ratei relativi a commissioni di natura up-front applicati ai contratti di credito immobiliare […]”.
[62] Secondo Santagata R., op. cit.: “L’intento del legislatore italiano di regolare diversamente l’istituto in questione nelle due tipologie di finanziamento traspare chiaramente dall’elisione del richiamo dell’art. 125-sexies, comma 1º, dall’elenco di disposizioni applicabili al credito immobiliare ai consumatori, di cui all’art. 120-noviesdecies t.u.b., come novellato dallo stesso art. 11-octies, comma 1º, lett. b, l. 106/2021. Eliminato il rinvio al credito al consumo, il rimborso anticipato del credito immobiliare è contemplato ora in una specifica norma (art. 120-quaterdecies.1 t.u.b.), che riproduce il 1º comma del previgente art. 125-sexies t.u.b.: disposizione, quest’ultima, fino alla sentenza Lexitor interpretata nel senso della spettanza, al consumatore, di un diritto al rimborso consistente nella sola quota parte degli oneri destinati a remunerare prestazioni ricorrenti dell’intermediario non ancora (in tutto o in parte) eseguite (c.d. recurring). Se ne deduce, a contrario, la conferma dell’irripetibilità del rimborso degli oneri relativi ad attività preliminari alla stipulazione (cc.dd. up front) di un contratto di credito immobiliare ai consumatori, troncando così in radice i tentativi di trasposizione a quest’àmbito, in via interpretativa, degli esiti della sentenza Lexitor ”. Lo stesso Autore, ibidem, dopo l’avvio della domanda di pronuncia pregiudiziale del 9 settembre 2021 nella Causa C-555/21, UniCredit Bank Austria AG – VKI, evidenziava altresì che: “Sul piano sostanziale, l’irripetibilità degli oneri cc.dd. up front trova solida ragione nelle indubbie peculiarità del credito immobiliare, ove i costi indipendenti dalla durata del contratto sono ben più ingenti poiché ineludibile è l’espletamento di una serie di attività a salvaguardia del mercato e del debitore medesimo — peraltro espressamente contemplate dalla direttiva c.d. MCD (cfr. art. 4, n. 13) -, come riconosciuto dallo stesso Oberster Gerichtshof remittente; esemplari gli oneri connessi all’iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari e di onorario notarile (anche) per l’autenticazione della firma, nonché i costi della perizia volta a stabilire il valore dell’immobile posto a garanzia del credito. Del resto, questi oneri una tantum non sono influenzati dal finanziatore e risultano normalmente assenti in un semplice credito ai consumatori stipulato ai sensi della direttiva c.d. CCD, il che pare di per sé giustificarne il diverso trattamento nelle due tipologie di finanziamento di cui si auspica la futura conferma da parte della Corte di Giustizia UE investita della specifica questione”.
[63] Così l’articolo 20, della legge federale austriaca in materia di contratti di credito ipotecario e immobiliare e altri crediti al consumo, del 26 novembre 2015.
[64] Marasco, C., op. cit.: “È solo il caso di precisare che, ai sensi dell’art. 25 MCD, in ipotesi di rimborso ante diem del credito, il consumatore ha diritto ‘ad una riduzione del costo totale […], che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto’. Evidenti sono, da una parte, la similarità testuale della disposizione in discorso con quella di cui all’art. 16 CDD, della quale si è dato conto in precedenza, dall’altra parte, l’ambiguità del dato letterale della norma dettata in materia di credito immobiliare, la quale ha favorito la formazione di orientamenti esegetici difformi tra loro con riferimento al criterio di rimborso da adottare in presenza di un consumatore che richieda di estinguere ante diem il rapporto”.
[65] Nascimbene, B. “La causa Unicredit Bank Austria. Le conclusioni dell’avvocato generale: Lexitor o non Lexitor”, in Dialoghi di diritto dell’economia, novembre 2022, spiega che: “Le conclusioni sono un atto tipico di quel membro della Corte di giustizia, che non ha funzione giudicante: l’avvocato generale, il quale ex art. 252 TFUE ‘assiste’ la Corte avendo il compito, ‘l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità ed in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento’. Le ‘conclusioni’ sono scritte, non sono vincolanti per la Corte anche se in un’alta percentuale di casi essa ne segue, in tutto o in parte, il contenuto. Si può dunque ritenere, in linea di massima, che le conclusioni abbiano una funzione anticipatoria del contenuto della sentenza e che, pertanto, nella vicenda in esame, che nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte suprema austriaca, (Oberster Gerichtshof), la risposta al quesito posto possa far ritenere che quello, molto probabilmente, sarà l’orientamento della sentenza”.
[66] “31 […] l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, […] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto. 32 […] limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. 33 […] il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. 34 […] il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito […]”.
[67] Il PIES (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato) è il documento – di cui la Direttiva 17/2014/UE riporta, quale Allegato II, il modello standard – che deve essere utilizzato dal finanziatore per fornire tempestivamente al Consumatore interessato l’informativa precontrattuale necessaria: “a confrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull’opportunità di concludere un contratto di credito”; in tal senso, v.: (i) i Considerando 7, 20, 40-45, 47, 53, 78 e gli articoli 2, 15-17, 23 e 44, della MCD; (ii) l’articolo 120-novies e 120-decies, TUB; (iii) la Banca d’Italia, con il Provvedimento del 30 settembre 2016, ha apportato integrazioni e modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, per dare attuazione alla nuova disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori, introducendo nuovi Allegati alle disposizioni medesime, tra i quali l’Allegato 4E contenente il modello del PIES, di cui all’Allegato II della MCD.
[68] Nascimbene, B., op. cit.: “ […] la riduzione dei costi è facilitata, nella direttiva 2014/17, dall’esistenza del PIES, il cui utilizzo è obbligatorio (sono individuati, fra l’altro, nell’informazione fornita in fase precontrattuale, i costi ricorrenti e non ricorrenti), mentre nella direttiva 2008/48, mancando tale documento, la determinazione dei costi (come afferma la sentenza Lexitor) che sono “oggettivamente correlati alla durata del contratto” è “molto difficile”, da parte sia di un consumatore, sia di un giudice”.
[69] Marasco, C., op. cit.: “[…] la CGUE ha escluso che l’art. 25 Dir. 2014/17/CE sia ostativo all’applicazione di una normativa nazionale la quale riconosca al consumatore il rimborso proporzionale del costo totale del credito immobiliare con esclusivo riferimento ai cd. costi recurring. Non si ravviserebbero, in tale contesto, le peculiari esigenze di salvaguardia degli interessi del consumatore avvertite nell’ambito del credito al consumo […]”.
[70] SECCI è l’acronimo di “Standard European Consumer Credit Information”; questa sigla è molto più utilizzata rispetto alla denominazione italiana di “Informazioni Europee di Base relative al Credito ai Consumatori”, la cui sigla potrebbe essere IEBCC.
[71] Marasco, C., op. cit.: “Sembra, dunque, che a parere della Corte, non sia necessario predisporre, in materia di credito immobiliare, appositi strumenti di tutela analoghi a quelli previsti per il caso di credito al consumo in quanto, in siffatto ambito, questi ultimi sarebbero di per sé idonei a garantire adeguata protezione del contraente debole; ci si riferisce agli obblighi informativi precontrattuali di cui all’art. 14 MCD, i quali sono previsti al fine di consentire al consumatore di assumere decisioni il più consapevole possibile”.
[72] Nascimbene, B., op. cit.: “Parimenti diversa è la disciplina dei ‘costi da pagare a terzi’. Il problema di tali costi non veniva in rilievo nella Lexitor, che quindi non si pronuncia sul punto”.
[73] Marasco, C., op. cit.: “[…] l’approccio adottato in materia dalla giurisprudenza della Corte non appare del tutto condivisibile. É vero, infatti, che i contesti disciplinari qui in discorso sono evidentemente differenti, ma le fattispecie considerate in sede normativa presentano significativi elementi di similarità. In primo luogo, occorre rilevare che la formulazione letterale delle disposizioni appare pressoché identica, donde le difficoltà di giungere a conclusioni differenti sulla base di una mera interpretazione letterale delle stesse. In secondo luogo, le richiamate diverse esigenze di tutela del consumatore non appaiono determinanti al fine di valutare la ripetibilità o meno di taluni costi non dipendenti dalla durata del contratto, sostenuti dal prenditore. A ben considerare, infatti, non sembra dirimente, al fine di stabilire l’ampiezza del diritto alla riduzione dei costi spettante al contraente debole, la circostanza che quest’ultimo, nell’ambito del credito immobiliare, possa beneficiare di rafforzate forme di protezione, predeterminate dalla normativa europea e di settore”.
[74] Ferretti, R. – Mantegazza, R., “La nuova disciplina delle estinzioni anticipate dei contratti di credito con i consumatori”, in questa Rivista, 27 settembre 2023, hanno segnalato che: “Con tali provvedimenti il legislatore ha introdotto due diverse e nuove versioni, tra di loro – almeno ad una prima lettura – confliggenti, dell’art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73”.
[75] Bargelli, E., op. cit., ha evidenziato che: “[…] la reviviscenza degli istituti dell’indebito e dell’ingiustificato arricchimento sancita dalla novella del 2023 potrebbe, in astratto, assumere cinque possibili significati: a) l’esclusione della ripetibilità dei costi upfront per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto; b) l’irripetibilità dei soli costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; c) l’esclusione della legittimazione passiva del finanziatore rispetto ai costi di intermediazione per tutti i contratti, siano essi stati stipulati prima o dopo la legge di conversione del decreto; d) la giustificazione dell’azione del finanziatore verso l’intermediario del credito per il recupero della quota dei costi di intermediazione restituiti al cliente, per tutti i contratti; e) la predilezione per il criterio di calcolo ispirato alla proporzionalità lineare”, per poi concludere che: “Per le ragioni già esposte, la disciplina indebito e il principio del divieto di ingiustificato arricchimento sono attualmente non solo inidonei a regolare la sorte dei costi anticipati dal consumatore nel credito al consumo, ma anche a correggere la direzione a essi impressa dalla sentenza della Corte di Giustizia attraverso la sottrazione di costi diversi dalle spese notarili e dalle imposte”.
[76] Così le conclusioni di Ferretti, R. – Mantegazza, R., op. cit., i quali hanno evidenziato che: “Non pare, infatti, chiaro se tale inciso possa in qualche modo influire sul diritto del cliente al rimborso dei costi in sede di estinzione anticipata del finanziamento per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 e, se sì, come. Si potrebbe, infatti, ritenere che esso miri a circoscrivere l’esperibilità dell’azione di restituzione del consumatore nei confronti di chi abbia effettivamente percepito i costi del credito, escludendo così la legittimazione passiva del finanziatore per la ripetizione delle somme dallo stesso incassate per conto di altri soggetti (ad es., intermediari del credito e assicuratori), nonché quella del cessionario del credito derivante dal finanziamento e del mandatario all’incasso. Una simile interpretazione, però, oltre a costringere il consumatore ad agire nei confronti di una pluralità di soggetti per recuperare la porzione non maturata dei costi, pare contrastare che [sic, ndr] la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ha da tempo e in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (cfr., tra le molte, Coll. coord. n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all’incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato e incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento […] Per altro verso, il richiamo alla disciplina civilistica dell’indebito e dell’ingiustificato arricchimento potrebbe avere lo scopo di fornire la base giuridica per l’azione del finanziatore che abbia dovuto restituire al cliente la quota non dovuta dei costi di intermediazione e dei premi assicurativi nei confronti degli intermediari del credito e delle assicurazioni che tali oneri hanno in precedenza percepito, anche in assenza di una specifica pattuizione tra le parti e anche nel caso di contratti di credito stipulati prima del 25 luglio 2021 […]”.
[77] V., per una disamina delle divergenze tra i due provvedimenti, Ferretti, R. – Mantegazza, R., op. cit.
[78] Che si tratti di una fattispecie di abrogazione implicita è peraltro precisato nell’Analisi tecnico-normativa (ATN) del Disegno di Legge di conversione del DL n. 104/2023, pag. 59.
[79] Ferretti, R. – Mantegazza, R., op. cit., avevano segnalato che: “Non vi è dubbio che è quantomeno singolare che vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta ufficiale due provvedimenti normativi (uno dei quali, peraltro, qualificato come urgente) che modificano entrambi una norma previgente e che il loro coordinamento non sia affatto agevole, anche per la mancanza di un’esplicita previsione in tali provvedimenti normativi che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell’art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore. La risposta a questa domanda non pare scontata, dato che i due provvedimenti in commento sono coevi e contemporanea è stata la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Occorre, inoltre, considerare che la modifica dell’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 non era contenuta nel d.l. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l’11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 1, comma 2, della legge stessa), cioè esattamente lo stesso giorno in cui è entrata in vigore l’analoga (ma diversa) modifica dell’art. 11-octies prevista dal d.l. n. 104/2023. Insomma, non è semplice comprendere se vi sia uno ius superveniens e, se sì, quale sia, trovandosi l’unico (labile) indizio di una successione temporale tra le norme in discorso nella numerazione dei due provvedimenti. Facendo applicazione di tale (labile) criterio cronologico, sembra a chi scrive che la prevalenza debba essere riconosciuta all’art. 27 del d.l. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 69/2023, il quale dovrebbe quindi intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell’art. 15 prel.”.
[80] Così in “Analisi di impatto della Regolamentazione della conversione in legge del DL n. 104/2023”, p. 136.
[81] Nella traduzione italiana della sentenza viene definita anche quale “commissione per la concessione del mutuo”.
[82] Nella traduzione italiana i quesiti formulati dal Giudice del rinvio sono i seguenti:
“1) Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva [2014/17] debba essere interpretato alla stregua dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], ossia, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato del mutuo includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la commissione per la concessione del mutuo.
2) Se l’obbligo previsto all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva [2014/17] di ridurre il costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato debba essere interpretato nel senso che il costo totale del mutuo ipotecario deve essere ridotto in proporzione al rapporto tra la durata del periodo compreso tra la data del rimborso anticipato e la data originariamente concordata come data di rimborso del mutuo, e la durata del periodo originariamente concordato compreso tra la data dell’erogazione del mutuo e la data del rimborso totale del mutuo, oppure nel senso che la riduzione del costo totale del mutuo ipotecario deve essere proporzionale al mancato guadagno da parte del mutuante, ossia al rapporto tra l’importo degli interessi da rimborsare dopo il rimborso anticipato del mutuo (dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo al rimborso totale effettivo e la data originariamente concordata per il rimborso totale) e l’importo degli interessi dovuti per l’intera durata del contratto di mutuo originariamente concordata (dalla data di erogazione del mutuo alla data del rimborso del mutuo concordata)”.
[83] Non è possibile sottacere che il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la nota Decisione del 17 dicembre 2019, n. 26.525, si era già lungamente confrontato con la mancata indicazione, nell’art. 16, par. 1, della CCD “[…] (e, a valle, nell’art.125 sexies TUB), del criterio di rimborsabilità dei costi up front, la cui diversità ontologica rispetto ai costi recurring osterebbe in modo radicale alla comune applicazione del criterio proporzionale puro (pro rata temporis) generalmente applicato rispetto alle attività di carattere continuativo”.
[84] Si rammenta infatti che il principio di diritto UCBA è quello secondo il quale: “L’articolo 25, […] non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito […] includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
[85] Le Informazioni Generali sono il documento menzionato al Considerando n. 38, e all’articolo 13, della MCD, nonché all’articolo 120-novies, TUB, che deve essere utilizzato dal finanziatore per fornire tempestivamente al consumatore interessato un’informativa precontrattuale chiara e comprensibile relativamente ai contratti di credito; l’articolo 13, della MCD, elenca una serie di elementi che devono essere indicati nelle Informazioni Generali, senza tuttavia fornirne un modello; la Banca d’Italia, con Provvedimento del 30 settembre 2016, ha apportato integrazioni e modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, per dare attuazione alla nuova disciplina del Credito Immobiliare ai Consumatori, introducendo nuovi Allegati alle disposizioni medesime, tra i quali l’Allegato 3, contenente il modello delle Informazioni Generali.
[86] Si riporta in tal senso che la CGUE, ha avuto occasione di precisare in molte sue sentenze che: “[…] secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, fornita dalla corte nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma […] Solo in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto intrinseco all’ordinamento giuridico dell’Unione, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare una disposizione da essa interpretata al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Affinché una tale limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti […] Più specificamente, la corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in circostanze ben precise, in particolare quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, segnatamente, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad adottare un comportamento non conforme al diritto dell’Unione in ragione di una oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni di diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione […]”; si legge così nella Sentenza del 10 luglio 2019 (Causa C-210/18), ma anche nella Sentenza del 14 marzo 2019 (Causa C-724717) e nella Sentenza del 22 settembre 2016 (Causa C-110/15); più recentemente, v. Sentenza del 16 settembre 2020 (Causa C-339/19).
[87] Fiorio, P., op. cit.: “Solo eccezionalmente la Corte di Giustizia, a tutela della buona fede dei soggetti interessati e al fine di evitare gravi inconvenienti, può limitare gli effetti temporali delle proprie sentenze. Tale potere non è stato esercitato con la sentenza Lexitor e non può essere invocato avanti il giudice nazionale per limitarne gli effetti”.
[88] Così nella sentenza CGUE del 16 settembre 2020, causa C-339/19, Romenergo – Aris Capital.
[89] L’articolo 21, comma 9, lett. d) e 10, della Legge n. 142/1992, stabiliva che: “9. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: […] d) le facoltà di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del contratto spettano unicamente al consumatore, che le può esercitare in qualsiasi momento, senza oneri e penalità.10. Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del comma 9; se il consumatore esercita tale facoltà, ha altresì diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all’articolo 19, comma 2”.
L’articolo 125, comma 2, TUB, nella formulazione vigente fino al 19 settembre 2010, stabiliva che: “2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
[90] In tal senso è possibile ricordare ABF Roma n. 1.215/2017; n. 10.772/2018; n. 9.884/2021.
[91] Gigliotti, F., op. cit., ha evidenziato che: “ […] la Dir. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, la quale, confermando il diritto del consumatore «di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito» (art. 16, par. 1), ha però precisato che, in tal caso, gli va riconosciuta (più che una generica equa riduzione del credito) «una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»: in tal modo, fermo il diritto alla riduzione dei costi – conseguente al rimborso anticipato da parte del consumatore – la disciplina comunitaria ha superato il vago riferimento alla ‘equità’ (non altrimenti specificata) della riduzione, prescrivendo, più specificamente, che la stessa sia da praticare sul costo totale del credito e debba comprendere interessi e costi dovuti per la restante durata del contratto […]”.
[92] Per una lettura critica dell’Ordinanza in discorso, v. l’ampia disamina di Tuccari, E., “La Cassazione abusa di ‘Lexitor’ e… apre una crisi di sistema?”, in Responsabilità civile e Previdenza, Fasc. 2, 2024, pag. 459, secondo il quale: “L’odierna pronuncia non spicca certamente per linearità nell’argomentazione, ma soprattutto lascia trasparire una tensione (forse perfino esagerata) verso una sorta di ‘giustizia sostanziale’ […] Se, per un verso, la pronuncia della Corte di cassazione sembra viziata, come si è visto, prevalentemente da un abuso della portata della pronuncia Lexitor — che si finisce per estendere del tutto arbitrariamente a Direttive precedenti alla 2008/48/CE (come la 87/102/CEE e la 90/88/CEE), tralasciando l’articolato dato normativo (primario e secondario) vigente all’epoca dei fatti — la decisione dei giudici di merito, per un altro, non aveva dato prova migliore, negando ogni rimborso dei costi sostenuti dal consumatore soltanto alla luce della presunta mancanza (poi, come si è cercato di dimostrare, neanche pienamente accertata) di disposizioni integrative della normativa primaria di cui all’art. 125 TUB […]”.
[93] Ciò si rammenta in quanto l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), del Dl 73/2021, ha introdotto il nuovo art. 125-sexies, TUB, che indica appunto il criterio del “costo ammortizzato”, ma il successivo comma 2, del medesimo art. 11-octies, stabilisce che: “2. L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, […], come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, ossia dal 25 luglio 2021.
[94] Oltre a quella già in precedenza richiamata, si rammenta altresì che Santagata R., op. cit., ha anche evidenziato che: “Vi è però almeno un’altra ragione che induce a dubitare che la previsione del criterio del costo ammortizzato possa effettivamente conciliarsi con l’«agevole comprensibilità e quantificabilità» del rimborso funzionale ad assicurare quell’«elevata protezione» al consumatore evocata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza Lexitor […] Tale criterio – già adoperato nei princìpi contabili internazionali (cfr. IAS 39 e IFRS 9) – costituisce ormai l’ordinaria tecnica di valutazione dei crediti prevista dal codice civile in tema di bilancio di esercizio della s.p.a. […] Sennonché: è senz’altro vero che il costo ammortizzato consente una migliore rappresentazione della vicenda economica, prevedendo la rilevazione degli interessi sulla base (non già del tasso di interesse nominale convenuto tra le parti, bensì) del tasso di rendimento effettivo dell’operazione di finanziamento, calcolato includendo tutti gli oneri corrisposti dal debitore, nonché eventuali costi di transazione, premi o sconti (cfr. IAS 39, § 9); altrettanto inconfutabile pare, tuttavia, che la trasposizione di questo metodo al peculiare àmbito del credito ai consumatori sortirà esiti opposti alla semplificazione, come del resto attesta il vivace dibattito che ne ha preceduto l’introduzione nel ben diverso contesto dei bilanci societari. E, se così stanno realmente le cose, la nuova norma potrebbe sì realizzare l’auspicato effetto di semplificare le voci di costo del credito al consumo, ma al prezzo di complicare poi il calcolo del rimborso anticipato là dove si renda necessario applicare un criterio i cui riflessi economici sono, per giunta, sicuramente negativi per il consumatore. Il che rischierebbe allora di vanificare le virtuose finalità di agevolazione della ristrutturazione del debito e di prevenzione del sovraindebitamento sottese alla sentenza Lexitor ed alla nuova disciplina del rimborso anticipato del credito ai consumatori”.
[95] V. i Dossier “Schede di lettura” del D.L. 73/2021 – A.S. 2320, n. 393/2 del Servizio Studi del Senato della Repubblica, Volume I – Articoli 1-35-ter, datato 19 luglio 2021, reperibile sul sito internet del Senato così come quelli del 5 settembre 2023, A.S. 854, pag. 98, e 28 settembre 2023 A.S. 854-A, pag. 180, sul DL 104/2023.
[96] Santagata R., op. cit., in un momento cronologicamente precedente alle sentenze UCBA e Santander, affermava che: “Va altresì rilevato che l’elisione del rinvio alla disciplina del credito al consumo dovrebbe incidere anche sul criterio di calcolo del rimborso delle commissioni c.d. recurring in caso di silenzio del contratto di credito immobiliare sul punto. In particolare, trattandosi di oneri destinati a maturare nel corso del tempo e che restano costanti nello svolgimento del rapporto, sembra più corretto e «conforme al diritto ed all’equità sostanziale» applicare qui – almeno allo stato attuale – il principio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e non già il criterio del costo ammortizzato, che invece costituisce oggi la regola residuale scelta dal legislatore in tema di credito ai consumatori […]”.
[97] Efficacissima la sintesi di Benincasa M., “Il rimborso anticipato del credito: entropia giurisprudenziale e incalcolabilità giuridica”, in Lateran Law Review, 24/II/1 e in Quaderni di Aggiornamento a cura del Conciliatore Bancario Finanziario 5/2024.
[98] Bargelli, E., op. cit.: “Nell’ultimo lustro il regime delle restituzioni delle spese accessorie ai contratti di credito al consumo nell’eventualità dell’estinzione anticipata (art. 125-sexies t.u.b.) ha subito oscillazioni e vicende altalenanti dovute alla difficoltà di tracciare con certezza la linea di confine e l’interazione fra la legislazione secondaria dell’Unione Europea – che costituisce la fonte dello specifico diritto dei consumatori di risolvere ante tempus il contratto – e la disciplina nazionale, che svolge un ruolo residuale e integrativo”.
[99] Bargelli, E., op. cit.
[100] Gigliotti, F., op. cit., ha evidenziato che: “ […] già a partire dalla stessa disciplina comunitaria ispiratrice della regolamentazione interna recata dal t.u.b., è stata positivamente disposta una riduzione dei costi del finanziamento (che tenga conto dell’anticipata definizione del rapporto di credito): nondimeno, l’esatta determinazione della riduzione (recte: delle modalità della riduzione) da praticare ha dato luogo – oltre che ad interventi “regolatori” di non uniforme portata – ad un significativo contenzioso, non ancora compiutamente definitosi […]”.
[101] Marasco, C., op. cit., ha segnalato che: “Ciò che, invece, si intende rilevare in detta sede è la circostanza che la formulazione in lingua inglese del disposto di cui agli artt. 16 CDD e 25 MCD è identica e assume il seguente tenore letterale: ‘the consumer shall be entitled to a reduction in the total cost of the credit to the consumer, such reduction consisting of the interest and the costs for the remaining duration of the contract’. Come è facilmente desumibile dalla lettura del testo riportato, ai differenti predicati verbali (‘comprende’ e ‘riguarda’) con cui vengono individuate le voci del rimborso in parola nella versione italiana, corrisponde l’uso di un unico termine (‘such’) in quella inglese. Di qui, la conclusione cui è possibile pervenire, secondo la quale è probabile che il legislatore europeo non avesse voluto effettuare alcun distinguo tra le fattispecie di estinzione del contratto di credito al consumatore, il quale sembra pertanto frutto di un equivoco interpretativo verificatosi in sede legislativa e giurisprudenziale. Alla luce delle considerazioni su esposte, deve evidenziarsi che il testo degli artt. 16 CDD e 25 MCD nella versione ufficiale in lingua inglese si presta ad essere tradotto in molteplici modalità, dando luogo ad interpretazioni talvolta confliggenti tra loro. Tale evenienza giustifica la considerazione espressa in sede tecnica in ordine al parziale fallimento degli obiettivi perseguiti in materia di tutela del consumatore, cui consegue la necessità di uniformare la disciplina in discorso in sede UE. Significativa al riguardo è la bozza di direttiva che la Commissione europea ha recentemente pubblicato, al fine di sostituire la disciplina vigente (nel contesto della Dir. 2008/48/CE)”.
[102] Con l’articolo 7, del Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, poi convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40 (cd. Decreto Bersani-bis), venne introdotto il divieto di clausole penali nel caso di estinzione anticipata dei “mutui immobiliari” stipulati o accollati a seguito di frazionamento, “per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche”. Successivamente, ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, la norma venne “trasferita” nel nuovo articolo 120-ter, TUB.
[103] Mucciarone G., op. cit., ha evidenziato che: “[…] dal punto di vista del consumatore, è indifferente che l’onere sia recurring ovvero up-front: in entrambi i casi, per il consumatore, quell’onere si giustifica in funzione del finanziamento e dunque in proporzione alla durata per cui beneficia del capitale prestato. Ed è il punto di vista del consumatore che conta: la ratio legis essendo la protezione dell’interesse del cliente a svincolarsi da un finanziamento non più conveniente: a ciò è preposto il diritto all’estinzione anticipata e la riduzione del carico economico; che questo sia costituito da oneri recurring ovvero up-front, per il consumatore è indifferente: non avendo più interesse al finanziamento, tutto il carico economico risulta per lui giustificato solo per il tempo per cui ha goduto del finanziamento. La riprova pare agevole: il finanziatore potrebbe assorbire tutto il carico economico negli interessi: dando valore alla distinzione tra costi recurring e up-front, accadrebbe che i costi d’istruttoria, per esempio, dove previsti come spese a carico del cliente sarebbero sopportati per intero da questi, dove invece assorbiti negli interessi sarebbero a carico del finanziatore: ma per il cliente, in entrambi i casi, quei costi si giustificano in tanto in quanto il finanziamento è durato”.
Tale approccio non sembra condivisibile; ciò che dovrebbe venire in rilievo – almeno nella ratio legis – non è il punto di vista del consumatore, ma ciò che è (ciò che dovrebbe essere) ritenuto conforme a regole di ragionevolezza. Il punto di vista del consumatore (e chi scrive è anche un consumatore), è con ogni evidenza quello di ottenere un rimborso che sia il maggiore possibile. Se il consumatore non ha più interesse al finanziamento, non sembra sia condivisibile l’assunto che: “tutto il carico economico risulta per lui giustificato solo per il tempo per cui ha goduto del finanziamento”; questo potrebbe certamente essere il punto di vista del consumatore, ma non per ciò soltanto si può ritenere il punto di vista più corretto; è un atteggiamento opportunista del consumatore, comprensibile da ogni consumatore (anche da chi scrive), ma non per questo automaticamente ragionevole o “giusto”. La riprova potrebbe essere data proprio dalle spese di istruttoria: si veda – ex post – alla controversia che ha dato luogo alla sentenza Santander, dove il consumatore aveva pagato tali spese in misura di circa 600 Euro, a fronte di un mutuo di 30 anni e avendolo estinto dopo soli 19 mesi chiedeva il rimborso di circa 570 Euro (pari a 341/360esimi delle spese). Poiché sembra plausibile ritenere che sia stato il consumatore stesso a chiedere alla Banca un mutuo di 30 anni e che la Banca abbia svolto un’istruttoria finalizzata proprio alla concessione di un mutuo di 30 anni, non sembra corretto che se il consumatore lo estingue dopo 19 mesi, ritenga di avere il diritto (o peggio ancora: abbia il diritto), di pagare soltanto quello che (secondo lui) sarebbe stato (o avrebbe dovuto essere, secondo lui), il costo di un’istruttoria di un mutuo di 19 mesi (nel caso di specie: 30 Euro), perché la Banca comunque aveva svolto un’istruttoria per un mutuo di 30 anni e – a chi scrive – sembrerebbe più corretto se non fosse dovuta retrocessione alcuna delle spese di istruttoria. Discorso analogo per le spese di perizia, dove peraltro l’attività peritale è svolta da un soggetto terzo.
[104] Nella richiamata Comunicazione al sistema sul rimborso anticipato nel credito ai consumatori, del 4 dicembre 2019, si trovava rammentato che: “La Banca d’Italia, nel suo ruolo di autorità di controllo in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti intermediari-clienti disciplinata dal TUB, si aspetta che tali linee – delle quali terrà conto nello svolgimento dell’azione di controllo – costituiscano un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”.
[105] Secondo Mucciarone G., op. cit.: “La diligenza nella gestione dell’impresa, cui è tenuta la banca (articolo 5 T.U.B.) come ogni altro imprenditore (p.es., artt. 2086, co. 2, c.c.; 217 l.f.), non consente di fare affidamento su di una interpretazione della norma solo perché autorevole. Diligenza significa prudenza nella previsione e gestione del rischio e Banca d’Italia è sì un autorevolissimo interprete, ma non ha un potere interpretativo maggiore di un soggetto privato. Le sue interpretazioni non sono vincolanti. Sì che non è stata la prudenza ad aver fatto aderire all’interpretazione di Banca d’Italia. Nella prospettiva dell’agire diligente anche un consolidato orientamento dell’autorità giudiziaria ordinaria potrebbe non costituire fonte di legittimo affidamento: il diritto è interpretazione, per questo è mutevole, e le sentenze devono essere motivate: la prudente previsione del futuro richiede un ponderato esame della correttezza delle motivazioni, delle ragioni di un’interpretazione, e non in sé ma nel contesto storico (culturale, economico etc.) dato”.
[106] Rabitti, M., op. cit., all’indomani della pubblicazione della Sentenza Lexitor, aveva tempestivamente evidenziato che: “[…] da più parti si è ritenuto che l’applicazione nel nostro sistema del principio enunciato dalla Corte di Giustizia possa comportare una overprotection dei consumatori, che altera l’equilibrio esistente nel sistema del credito e che rischia di tradursi, in una prospettiva di medio termine, in un pregiudizio per gli stessi consumatori determinando un’eterogenesi dei fini”.
[107] Molto interessante il contributo di Baffi E. – Parisi F., Early repayment of loans under EU Law: The Lexitor Judgment, in The Italian Law Journal, vol. 7, I, 2021, pag. 227 e ss., menzionato da Ricciardi, A., op. cit.: “[…] we can say that the introduction of a rule under which up-front costs must be partially reimbursed in the event of early repayment of loans will produce inefficiencies compared to the ideal world where only recurring costs must be returned. But the existence of this ideal world necessitates the impossibility of evasive behavior on the part of lenders. […] So, it is a matter of choosing the second-best solution. The Lexitor judgment opted for the rule that even up-front costs must be reimbursed. The inefficiencies produced by this rule could be limited by making the up-front costs items that cannot be artificially increased by lenders non-reimbursable. In other words, non-mandatory ancillary services, those voluntarily purchased by the consumer, should not be eligible for partial reimbursement in the event of early repayment […]”.
[108] Marasco, C., op. cit., in relazione alla bozza di detta Direttiva, evidenziava che: “A ben considerare, siffatta proposta di riforma si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo di superare la frammentazione normativa ancora sussistente nei Paesi dell’UE in materia di credito al consumo; tuttavia, essa non appare fornire una risposta alle problematiche di cui si è dato conto nel corso della presente trattazione e si auspica pertanto che, in sede di discussione, possa essere delineata una disciplina in materia che non dia adito ad interpretazioni fuorvianti”.
[109] Articolo 48, della CCD II: “1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026 […]”.
[110] Mucciarone G., op. cit., ha evidenziato: “Del resto, una delle direttrici che oggettivamente è stato possibile cogliere nella evoluzione dell’intera disciplina di trasparenza è quella della semplificazione e riduzione degli oneri economici a carico del cliente. E tale linea è venuta infine ad essere assecondata anche dall’Autorità di Vigilanza, raccomandando, nel provvedimento n. 145/2018 (§ 16), crediti al consumo “tutto TAN”. Giustamente, ché la concentrazione degli oneri risponde non solo ad un principio di trasparenza, ma di efficienza dell’impresa”.
[111] Natale M., op cit., ha evidenziato che il criterio del “costo ammortizzato” preso a riferimento dal Legislatore del nuovo art. 125-sexies, comma 2, TUB, quale criterio da utilizzare per la riduzione del costo totale del credito in difetto di una diversa pattuizione contrattuale: “[…] è in linea con il principio del “tutto-TAN” dettato nelle linee guida n. 1463869 del 4 dicembre 2019 da Banca d’Italia, che prevede l’inclusione degli oneri iniziali all’interno del tasso di interesse. Si tratta di uno schema tariffario che prevede l’inserimento nel tasso annuo nominale (Tan) della gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluse le spese istruttorie e il compenso per l’attività di intermediazione del credito. In questo modo, a dire di Banca d’Italia, si assicura che in caso di rimborso anticipato la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento. Tuttavia, l’inganno sta qui nel fatto che gli intermediari caricano la maggior parte dei costi nella fase iniziale dell’ammortamento, con la conseguenza che il rimborso dei costi up-front risulterebbe in ogni caso maggiore nel caso venisse applicato il criterio pro rata temporis”.
[112] Mocci F. – Bettoni A., op. cit.: “Gli intermediari dovranno quindi modificare, se non lo hanno già fatto, la modulistica contrattuale (adottando di fatto il criterio del c.d. “tutto TAN”, ossia l’incorporazione nel tasso annuo nominale degli oneri connessi con il finanziamento) e le procedure di calcolo dei conteggi estintivi, abbandonando le logiche pre-Lexitor”.