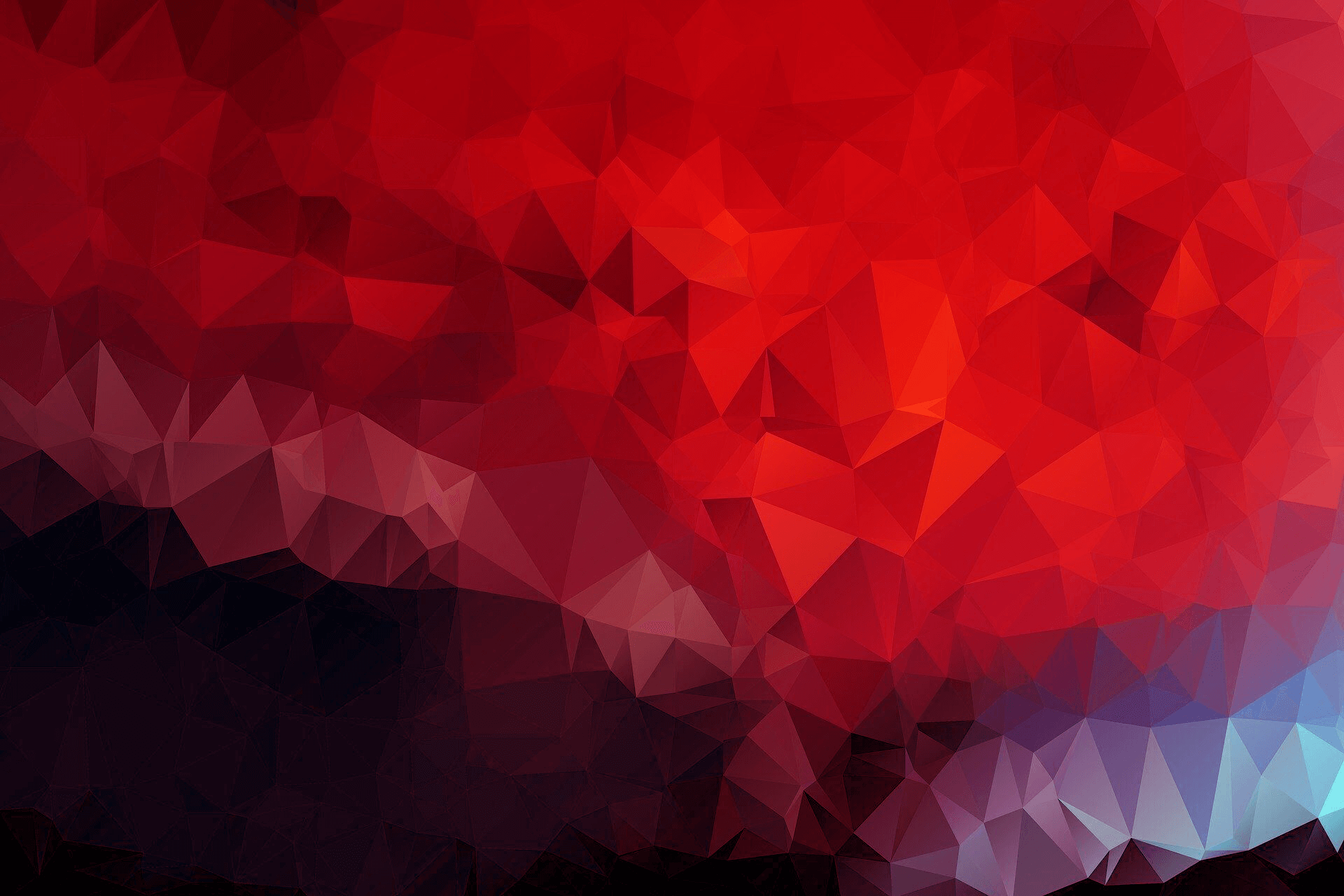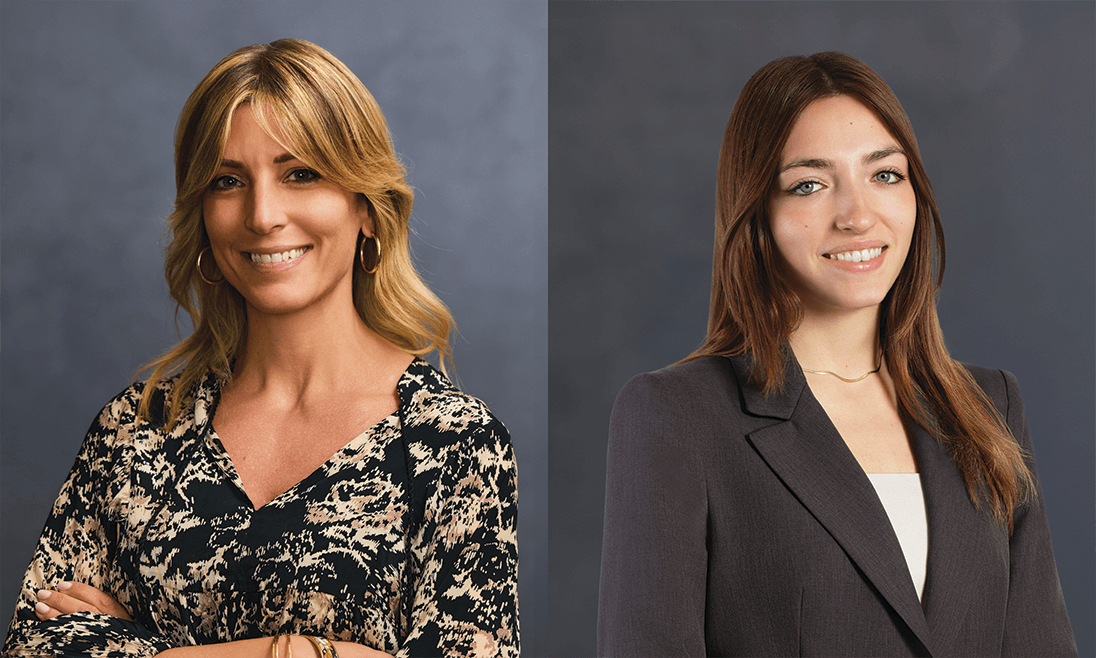Il presente contributo affronta il tema della clausola di fallback ex art. 118-bis TUB nei contratti di finanziamento, sia retail che corporate, fornendo alcuni spunti sui criteri di redazione ed analizzandone le criticità anche rispetto ai finanziamenti in pool.
1. Premesse
La disciplina delle clausole di fallback nei contratti di finanziamento rappresenta oggi uno dei temi più rilevanti e tecnici nel diritto bancario, in ragione delle profonde trasformazioni intervenute nel panorama degli indici di riferimento (c.d. benchmark[1]) e delle recenti innovazioni normative introdotte dal legislatore europeo e nazionale. L’adozione del nuovo art. 118-bis TUB, in vigore dall’11 gennaio 2024, segna un passaggio fondamentale nella gestione del rischio di variazione o cessazione degli indici di riferimento per la determinazione del tasso di interesse, imponendo agli intermediari finanziari obblighi stringenti in materia di trasparenza, informazione e revisione contrattuale.
Storicamente, la dipendenza dai tassi Interbank Offered Rates (“IBOR“), in particolare LIBOR ed EURIBOR, ha garantito la determinazione del prezzo di una vasta gamma di strumenti finanziari e contratti di credito. Tuttavia, gli episodi di manipolazione e la progressiva contrazione delle transazioni sottostanti hanno evidenziato la necessità di una riforma strutturale, culminata nel processo di transizione verso tassi risk-free e nell’adozione di strumenti di fallback contrattuale[2].
2. Il quadro normativo: l’art. 118-bis TUB
L’articolo 3 del decreto legislativo del 7 dicembre 2023, n. 207 ha attuato l’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. Regolamento Benchmark) introducendo il nuovo articolo 118-bis al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB“).
Le previsioni compendiate nell’articolo 118-bis TUB devono essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale con il cliente e le regole ivi incluse si applicano a tutti i contratti aventi ad oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (i.e. operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark.
La norma, in vigore dall’11 gennaio 2024, configura principalmente due nuovi oneri a carico delle banche e degli intermediari finanziari:
- predisporre, pubblicare e mantenere aggiornati piani che descrivano le misure da adottare in caso di modifica sostanziale o cessazione dell’indice di riferimento utilizzato (i “Piani di Sostituzione“); e
- garantire che i contratti stipulati con la clientela contengano previsioni idonee ad individuare, anche mediante rinvio ai Piani di Sostituzione, l’indice sostitutivo o le modalità di adeguamento dell’indice originario, nelle ipotesi di variazione significativa o di cessazione dello stesso. Tali previsioni, comunemente denominate clausole di fallback, costituiscono oggi un elemento essenziale della disciplina contrattuale degli indici di riferimento, in quanto assicurano la continuità e la certezza del rapporto obbligatorio anche in caso di discontinuità del benchmark di mercato[3].
3. I Piani di Sostituzione
L’articolo 118-bis, comma 1, del TUB riprende e specifica la disciplina dei Piani di Sostituzione introdotta dall’articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento Benchmark. Ai sensi di tale disposizione europea, gli intermediari finanziari sono tenuti ad adottare solidi piani scritti (contingency plans) nei quali siano descritte le azioni da intraprendere nell’eventualità di una variazione sostanziale o della cessazione dell’indice di riferimento utilizzato, indicando, ove possibile, uno o più indici alternativi e le ragioni per cui questi ultimi debbano ritenersi adeguati[4].
Il legislatore italiano, nel recepire tali previsioni, ha inteso rafforzare la trasparenza e la certezza dei rapporti contrattuali, precisando le modalità di definizione e di attuazione dei Piani di Sostituzione. Le banche e gli intermediari finanziari sono pertanto tenuti a predisporre tali piani e renderli pubblici, anche in forma sintetica, attraverso il proprio sito internet, assicurandone il costante aggiornamento. Gli eventuali aggiornamenti devono essere comunicati alla clientela con cadenza almeno annuale, o comunque alla prima occasione utile, mediante comunicazioni scritte o attraverso altri mezzi durevoli previamente accettati dal cliente.
La finalità della norma è duplice: da un lato garantire che il mercato disponga di informazioni chiare e verificabili sulle misure che gli intermediari intendono adottare in caso di discontinuità del benchmark; dall’altro, assicurare che i rapporti contrattuali non subiscano interruzioni o incertezze nell’ipotesi di cessazione o modifica dell’indice di riferimento. In questa prospettiva, il Piano di Sostituzione si configura come uno strumento di pianificazione preventiva e di trasparenza, strettamente connesso alle clausole di fallback che ne traducono operativamente i contenuti.
4. Le clausole di fallback
La disciplina dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 118-bis TUB impone agli intermediari l’obbligo di inserire nei contratti di finanziamento clausole che regolino espressamente le ipotesi di cessazione o variazione sostanziale del benchmark di riferimento, al fine di preservare la validità e l’efficacia del rapporto obbligatorio. Tali previsioni, denominate clausole di fallback, costituiscono lo strumento operativo attraverso il quale i Piani di Sostituzione trovano concreta applicazione nei singoli contratti, realizzando quella “traslazione” dalla dimensione organizzativa dell’intermediario a quella negoziale del rapporto con il cliente.
4.1 Funzione e contenuto della clausola
La clausola di fallback ha lo scopo di assicurare la continuità contrattuale in presenza di un evento di discontinuità dell’indice (c.d. trigger event) che può consistere nella cessazione definitiva nel benchmark o nella sua modifica sostanziale tale da comprometterne la rappresentatività. Essa prevede il meccanismo di sostituzione del tasso di riferimento, definendo in via preventiva l’indice alternativo o i criteri per la sua individuazione, e può strutturarsi secondo modelli diversi, anche mediante rinvio al Piano di Sostituzione.
In tal modo, il legislatore ha riconosciuto agli intermediari un certo margine di flessibilità nella redazione delle clausole, consentendo che l’indice sostitutivo sia determinato non rigidamente nel testo contrattuale ma attraverso un rinvio dinamico alle policy aziendali predisposte ai sensi del Regolamento Benchmark. Tale scelta riflette un approccio funzionale, in grado di adattarsi all’evoluzione del mercato e delle determinazioni delle autorità competenti (quali BCE, ESMA, FSMA, EMMI), ma impone, al contempo, un elevato livello di chiarezza e trasparenza nella formulazione della clausola, al fine di garantirne la determinatezza ai sensi degli artt. 117 e 125-bis TUB.
L’obbligo di comunicazione al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi del trigger event, e la possibilità di recesso senza oneri entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, costituiscono il principale presidio di tutela previsto dal legislatore. Tale meccanismo, pur evocando quello dello ius variandi di cui all’art. 118 TUB, se ne discosta sotto molteplici profili: non è richiesto un “giustificato motivo” soggettivo, il potere di modifica è ammesso anche nei contratti a tempo determinato, e la tutela si estende al momento dell’attivazione effettiva della clausola, non solo alla sua introduzione.
Ove, a seguito della suddetta comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.
In assenza di una clausola di fallback valida ed efficace, la sostituzione dell’indice di riferimento operata unilateralmente dall’intermediario è priva di effetto. In tal caso, trova applicazione l’indice sostitutivo determinato in via normativa (statutory replacement rate), secondo la gerarchia prevista dal comma 4 dell’art. 118-bis TUB: in primo luogo, il benchmark designato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Benchmark; ove tale indice non sia definito, il tasso minimo ex. art. 117, comma 7, lett. a) TUB; oppure, nei contratti di credito al consumo, il tasso previsto dall’art. 125-bis, comma 7, lett. a) TUB[5].
4.2 Redazione della clausola di fallback: criteri
La redazione di una clausola di fallback conforme alla normativa pone questioni di rilievo operativo e giuridico. Il legislatore non ha dettato uno schema tipico, ma ha fornito un quadro di riferimento sufficientemente ampio da consentire agli intermediari di adeguarsi alla natura del rapporto e alle caratteristiche del benchmark utilizzato.
Sulla base delle best practices internazionali, individuate anche dal Working Group on Euro Risk-Free Rates (“Working Group“)[6], la clausola dovrebbe prevedere con chiarezza:
- l’evento di attivazione (trigger), ossia le circostanze che determinano l’inapplicabilità del benchmark originario, come, a fini esemplificativi e non esaustivi, la cessazione della pubblicazione da parte del soggetto che lo amministra o la dichiarazione dell’autorità competente circa la perdita di rappresentatività del tasso;
- l’indice alternativo o la procedura di individuazione, che può comprendere una “waterfall structure“, ovvero una sequenza di indici sostitutivi da applicare progressivamente, o un rinvio al Piano di Sostituzione;
- l’eventuale spread di aggiustamento (c.d. spread adjustment), necessario per neutralizzare le differenze economiche tra l’indice sostitutivo (spesso un tasso risk-free come lo €STR[7]) e quello originario (ad esempio l’EURIBOR), evitando trasferimenti di valore tra le parti; e
- le modalità di comunicazione e decorrenza, stabilendo il momento esatto in cui il nuovo indice entra in vigore, in modo da garantire certezza nella determinazione del tasso applicabile alle singole rate o periodi di interesse[8].
Tali elementi rispondono all’esigenza di evitare vuoti contrattuali e contenziosi interpretativi, promuovendo la coerenza e stabilità nel passaggio ai nuovi benchmark. Inoltre, l’armonizzazione delle clausole tra i diversi strumenti finanziari è raccomandata, al fine di ridurre il rischio operativo e il cosiddetto basis risk.
4.3 Il rinvio ai Piani di Sostituzione
L’art. 118-bis TUB ammette espressamente che il meccanismo di fallback possa operare mediante rinvio ai Piani di Sostituzione predisposti dall’intermediario. Tale rinvio, di natura “dinamica”, comporta che la clausola si adegui automaticamente agli aggiornamenti del Piano di Sostituzione, che deve essere pubblicato e periodicamente rivisto in conformità alle indicazioni della Banca d’Italia e delle autorità europee.
Questa soluzione presenta evidenti vantaggi in termini di flessibilità e di allineamento con l’evoluzione del quadro regolamentare, ma solleva interrogativi circa la compatibilità con il principio di determinatezza del tasso d’interesse e la tutela del contraente debole. Qualora, infatti, il Piano di Sostituzione contenga esclusivamente previsioni di carattere organizzativo e procedurale, senza indicare criteri oggettivi per la scelta del nuovo benchmark, il rinvio potrebbe risultare eccessivamente generico e dunque inidoneo a soddisfare le esigenze di certezza richieste dalla normativa bancaria.
In tal senso, le linee guida dettate dalla Working Group sottolineano l’importanza che i meccanismi di fallback siano definiti secondo principi di trasparenza, coerenza e prevedibilità, includendo indicazioni chiare sulle modalità di determinazione del tasso sostitutivo e dello spread adjustment. Tali accorgimenti consentono di assicurare che il Piano di Sostituzione operi come uno strumento effettivo di stabilità contrattuale, coerente con le finalità del Regolamento Benchmark e con i principi di tutela del cliente sanciti dal TUB.
4.4 Tassi risk-free e ruolo dello €STR
Nell’ambito della riforma globale dei tassi di riferimento, promossa dal Financial Stability Board a seguito della crisi finanziaria del 2008 e delle vicende di manipolazione degli indici interbancari, le principali giurisdizioni hanno individuato nuovi tassi di interesse “risk-free“ (c.d. Risk-Free Rates), ossia parametri basati su transazioni effettive di mercato e privi del rischio di credito tipico dei tassi IBOR. Tali tassi, generalmente riferiti a operazioni overnight, mirano a garantire maggiore trasparenza e rappresentatività, costituendo oggi il riferimento centrale per la sostituzione dei precedenti benchmark nei contratti finanziari. Nell’area dell’euro, il Working Group ha individuato nello Euro Short-Term Rate (“€STR“) il principale indice alternativo ai tassi interbancari tradizionali, con particolare riferimento all’EURIBOR[9].
Lo €STR, elaborato e pubblicato quotidianamente dalla BCE dal 2 ottobre 2019, misura il costo della raccolta all’ingrosso non garantita di un campione di banche dell’area dell’euro con scadenza overnight.
A differenza dell’EURIBOR, che riflette un tasso di interesse forward-looking, determinato all’inizio del periodo di riferimento e incorporante una componente di rischio di credito interbancario, lo €STR è un tasso backword-looking, fondato su transazioni effettive e privo di rischio di credito. Questa caratteristica ne fa un parametro più solido, trasparente e difficilmente manipolabile, coerente con gli obiettivi di stabilità e affidabilità perseguiti dal legislatore europeo.
L’adozione dello €STR come indice di riferimento sostitutivo presenta tuttavia alcuni profili di complessità operativa. Nei contratti ancorati a tassi IBOR, gli interessi vengono solitamente calcolati sulla base di un tasso noto all’inizio del periodo di maturazione, mentre lo €STR, pubblicato giornalmente, richiede un meccanismo di calcolo differente. In tal senso, il Working Group ha raccomandato l’utilizzo della metodologia del compounded €STR in arrears, basata sulla capitalizzazione giornaliera dei tassi effettivi e sulla determinazione del tasso complessivo alla fine del periodo di riferimento.
Poiché lo €STR, in quanto tasso overnight, non incorpora il premio per il rischio di credito e di liquidità tipico dell’EURIBOR, la sua sostituzione richiede uno spread adjustment volto a preservare la neutralità economica del contratto. Il Working Group ha suggerito di calcolare questo spread adjustment come la mediana dello spread storico rilevato tra l’EURIBOR e l’€STR lungo i cinque anni precedenti[10].
5. Finanziamenti in pool: criticità operative
I finanziamenti in pool presentano profili di particolare complessità nell’applicazione della disciplina delle clausole di fallback, in ragione della pluralità di soggetti coinvolti, della struttura multilaterale del rapporto e della necessità di assicurare un coordinamento uniforme tra i partecipanti, che non necessariamente adottano le medesime policy interne o operano nel medesimo quadro regolamentare. Si tratta, infatti, di operazioni connotate da una forte componente negoziale, modellata sulle specifiche esigenze delle parti e sul contesto operativo dell’operazione.
Come evidenziato anche da diversi operatori del settore, la normativa europea e l’articolo 118-bis TUB non sembrano tener pienamente conto delle peculiarità di tali operazioni, con la conseguenza che la predisposizione di clausole di fallback uniformi risulta di difficile realizzazione. La presenza di finanziatori non appartenenti all’area europea, dunque non soggetti alla medesima disciplina di riferimento, accresce ulteriormente la complessità, imponendo soluzioni ad hoc e accordi individualizzati.
Nella prassi più recente, si è progressivamente affermato un modello operativo volto a garantire una gestione coordinata delle previsioni di fallback. Di consueto, una delle banche partecipanti al pool, spesso la banca con funzione di coordinamento (la banca agente), elabora una proposta di clausola standard, predisposta sulla base delle migliori prassi di mercato, delle proprie policy interne e dei più recenti schemi contrattuali diffusi tra gli operatori. In particolare, si osserva un diffuso ricorso a modelli contrattuali ispirati agli standard della Loan Market Association, opportunamente adattati al contesto normativo nazionale. Le altre banche, di conseguenza, possono optare per aderire alla suddetta formulazione o riservarsi la possibilità di introdurre integrazioni in modo tale da assicurare coerenza con le proprie policy interne e con i contenuti dei rispettivi Piani di Sostituzione. Tale meccanismo cooperativo, fondato su un principio di allineamento progressivo, consente di ridurre il rischio operativo e di garantire maggiore coerenza ed omogeneità nell’applicazione della disciplina. Tuttavia non è privo di complicazioni, non da ultime quelle legate alla tempistica delle operazioni. Il necessario coordinamento tra i diversi standard adottati da ciascuna banca partecipante finisce inevitabilmente per rallentare il processo di negoziazione e rischia di compromettere talvolta il buon esito delle operazioni.
Le clausole maggiormente diffuse sul mercato, anche alla luce dei modelli elaborati dagli operatori bancari, prevedono una struttura graduata (waterfall structure), che individua in primo luogo l’applicazione automatica dell’indice sostitutivo ufficiale designato dall’autorità competente ed in mancanza, la sostituzione con il tasso €STR capitalizzato, maggiorato di uno spread adjustment calcolato sulla base della mediana storica della differenza tra EURIBOR ed €STR nei cinque anni precedenti l’evento di sostituzione.
Tali clausole disciplinano inoltre in modo puntuale gli eventi di attivazione (trigger events), le modalità di calcolo del nuovo parametro e la decorrenza della sua applicazione, individuata nel primo periodo di rilevazione successivo all’evento di sostituzione, in modo da preservare la continuità contrattuale e la neutralità economica del rapporto.
In questo contesto, la possibilità di rinvio ai Piani di Sostituzione previsto dall’art. 118-bis TUB non appare particolarmente funzionale, poiché la pluralità dei finanziatori comporta la possibile (nonché probabile) coesistenza di diverse policy interne e differenti modalità di attuazione dei rispettivi piani. Tale asimmetria rischia di tradursi in disallineamenti applicativi e in una frammentazione delle soluzioni contrattuali.
Alla luce di ciò, si auspica l’individuazione di un raccordo sistematico tra la disciplina normativa e la prassi di mercato, volto a favorire l’adozione di modelli standardizzati di clausole di fallback, idonei a coniugare esigenze di certezza giuridica e flessibilità operativa. Un tale coordinamento consentirebbe, tra le altre cose, di rafforzare la coerenza applicativa tra i diversi intermediari, in linea con le finalità di trasparenza e di tutela della clientela perseguite dal legislatore europeo e nazionale.
[1] Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011, per indice di riferimento (benchmark) si intende ” un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”.
[2] Per maggiori informazioni si veda anche Daniela Della Gatta (2022), “Quale futuro per i benchmark del mercato monetario in euro?“, n. 17 della collana “Mercati, infrastrutture, sistemi di pagamento” pubblicata da Banca d’Italia e disponibile al seguente link https://www.bancaditalia.it/media/notizia/quale-futuro-per-i-benchmark-del-mercato-monetario-in-euro/.
[3] Art. 118-bis TUB; D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207
[4] Art. 28 Regolamento (UE) 2016/1011.
[5] Art. 118-bis TUB; D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 207
[6] Working group costituito nel 2018 dalla Commissione europea e dalla BCE insieme con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con la Belgian Financial Services and Markets Authority (FSMA) allo scopo di identificare e raccomandare tassi privi di rischio che potrebbero servire come alternativa ai benchmark dei tassi di interesse prevalenti.
[7] Per maggiori informazioni in merito si veda il paragrafo 4.4. del presente contributo
[8] Si veda il seguente documento pubblicato dal Working Group: “Guiding principles for fallback provisions in new contracts for euro-denominated cash products“, gennaio 2019
[9] Daniela Della Gatta, “Quale futuro per i benchmark del mercato monetario in euro?”, Banca d’Italia, 2022.
[10] Si vedano i seguenti documenti pubblicati dal Working Group: “Recommendations by the working group on euro risk-free rates on EURIBOR fallback trigger events and €STR-based EURIBOR fallback rates“, dell’11 maggio 2021; “Guidance for Corporate Lending Products for Implementing the Recommendations on EURIBOR Fallback Trigger Events and €STR-based EURIBOR Fallback Rates”, del 4 maggio 2023.