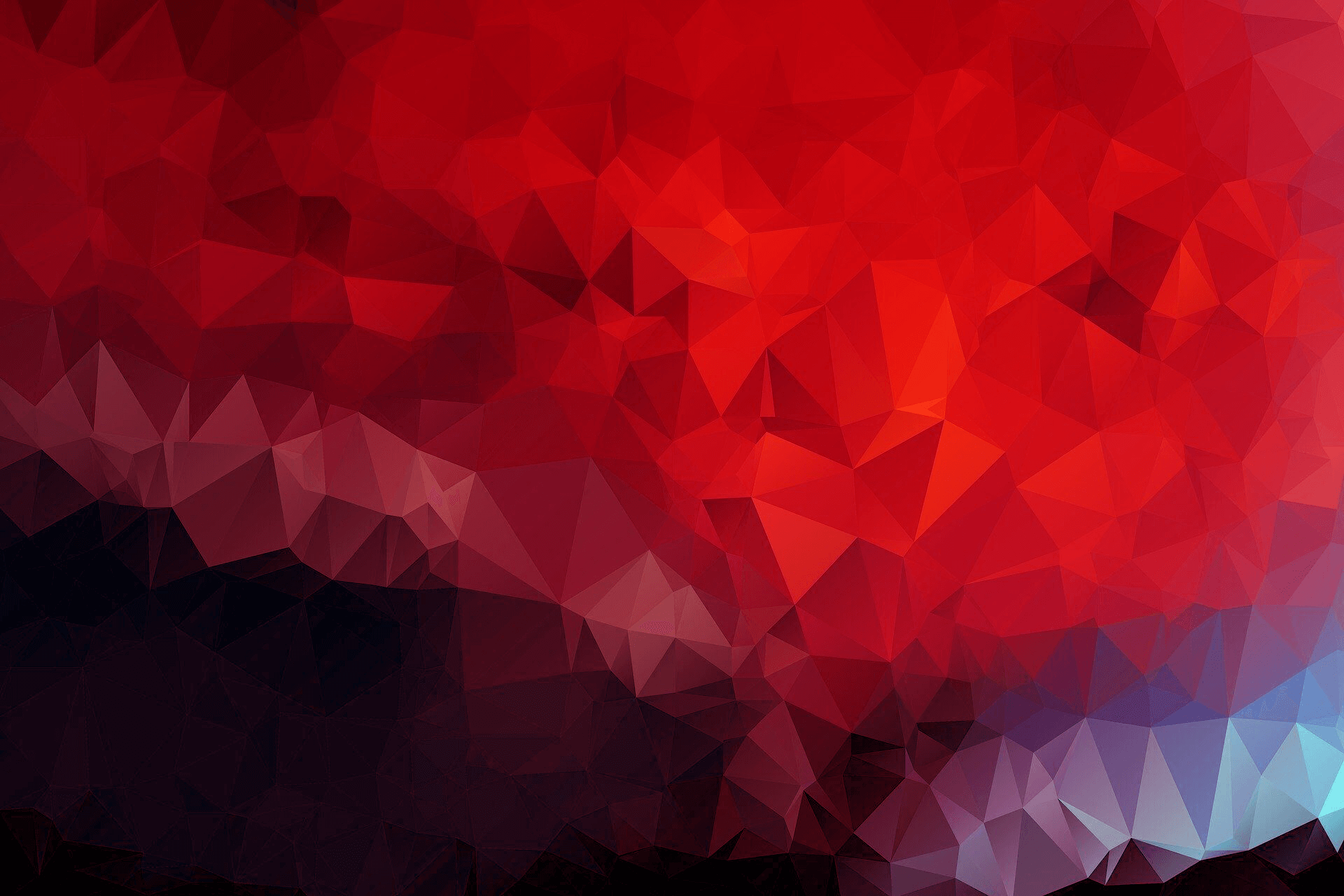Il presente contributo affronta il tema della gestione delle esposizioni deteriorate (NPE) da parte delle banche less significant, alla luce della recente consultazione BCE in materia e delle migliori prassi, profili di vigilanza prudenziale e delle prospettive di riforma.
Come è noto, lo scorso 15 settembre la Banca Centrale Europea ha avviato una consultazione pubblica [1], che si concluderà nel mese corrente, in vista dell’adozione di nuove linee guida sull’approccio di vigilanza delle Autorità nazionali competenti in merito alla copertura delle esposizioni deteriorate (non-performing exposure) detenute da enti meno significativi (less significant institution).
L’iniziativa merita di essere meglio contestualizzata sotto diversi punti di vista.
Anzitutto, vale la pena di dedicare poche righe ad un inquadramento di natura regolamentare. Le esposizioni deteriorate detenute dalle banche europee, siano esse banche significative ovvero meno significative, sono già da tempo oggetto di specifica attenzione e regolamentazione a livello europeo. Occorre ricordare, infatti, che la c.d. Capital Requirements Regulation [2] prevede regole di vigilanza prudenziale specificamente applicabili alle esposizioni classificate come “deteriorate”, secondo requisiti di copertura e regole di deduzione dell’esposizione dal capitale di vigilanza di classe 1 (Tier 1) da ultimo rafforzati con la riforma intervenuta nel 2019 (pacchetto c.d. CRR II [3]).
Tali disposizioni costituiscono oggi il principale incentivo per gli enti creditizi europei ad attivarsi per una gestione efficiente delle esposizioni non-performing, avendo queste ultime un peso rilevante in termini di assorbimento di capitale e conseguenti oneri di patrimonializzazione. Si tratta tuttavia di disposizioni che non hanno portata retroattiva e – per espressa previsione regolamentare (art. 469-bis CRR) – trovano applicazione soltanto per le esposizioni deteriorate sorte a partire dal 26 aprile 2019. Ed è proprio da tale circostanza che prende le mosse la recente iniziativa di BCE: la proposta di indirizzo riguarda infatti le sole esposizioni che, in virtù della cut-off temporale appena ricordata, ad oggi non vengono in considerazione quali elementi di assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche europee, e in particolare – vedremo tra poco per quale ragione – delle banche meno significative.
L’obbiettivo è, dichiaratamente, quello di ridurre lo stock di crediti deteriorati più “vintage” degli istituti less significant e la modalità è quella di un’estensione “ragionata” – e quindi con talune eccezioni e comunque in via graduata nel tempo – dei vincoli di copertura (i.e., obblighi di accantonamento) applicabili alle banche più grandi. Va ricordato, a tale ultimo proposito, che nell’ultimo decennio – e dunque ben prima dell’entrata in vigore delle nuove regole patrimoniali previste dal Regolamento CRR / CRR II – gli enti significativi (e soltanto questi ultimi) sono stati costantemente destinatari di plurime e convergenti raccomandazioni [4], azioni di indirizzo ed altre misure di c.d. soft law a livello unionale che hanno dato luogo negli anni ad aspettative di copertura ed obbiettivi minimi di calendar provisioning nell’ambito del MVU (Meccanismo di Vigilanza Unico europeo), per certi versi anche più stringenti rispetto ai requisiti poi introdotti a livello regolamentare. Tali misure, per contro, non hanno mai interessato gli istituti less significant, ragion per cui questi ultimi presentano oggi un maggiore accumulo di stock di crediti deteriorati di lunga data e ad essi è ora rivolta l’attenzione della BCE.
Volgendo lo sguardo sul mercato italiano, è indubbio che le nuove raccomandazioni coinvolgeranno – per definizione – gran parte degli enti creditizi operanti sul territorio: le più recenti aggregazioni bancarie non bastano infatti a ridisegnare la geografia del settore bancario nazionale, che resta a tutt’oggi prevalentemente popolato da istituti less significant, i quali mediamente presentano NPL ratio più elevati [5] rispetto alle banche operanti in altri Paesi UE.
Ciò nondimeno, l’iniziativa della BCE – oltre ad essere graduale e a prevedere una significativa area di flessibilità e discrezionalità da parte delle Autorità di Vigilanza nazionali, che valuteranno caso per caso l’opportunità di esentare i singoli enti vigilati, anche per evitare effetti distorsivi – si pone in linea di continuità con la maggiore attenzione che, a più livelli, la regolamentazione dell’Unione sta ponendo negli ultimi anni sul tema delle non-performing exposure, ma soprattutto con il maggior numero di strumenti oggi disponibili alle banche per meglio gestire le proprie esposizioni, vuoi mediante dismissione delle stesse, vuoi mediante esternalizzazione della relativa gestione a soggetti specializzati.
Nel primo trimestre di quest’anno si è concluso in Italia il processo legislativo e regolamentare di recepimento della c.d. Secondary Market Directive [6], con l’introduzione del nuovo Capo II nel Titolo V del Testo Unico Bancario dedicato all’acquisto ed alla gestione di crediti in sofferenza.
Si tratta di misure che, su spinta del legislatore europeo, ampliano gli strumenti e le modalità di dismissione e di gestione delle esposizioni deteriorate (e, segnatamente, delle sofferenze) da parte delle banche.
Uno degli aspetti principali della nuova regolamentazione appena ricordata consiste infatti nella “liberalizzazione”, seppur controllata, dell’attività di acquisto di crediti in sofferenza. Si tratta di un cambiamento significativo nel nostro ordinamento, posto che – storicamente – lo svolgimento in via professionale dell’attività di acquisto di crediti pecuniari, rientrando tra le forme di esercizio del credito, costituisce in Italia (diversamente da quanto accade in molti Paesi europei) attività riservata ad una cerchia ristretta di soggetti autorizzati e regolamentati (tra cui banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 TUB, società per la cartolarizzazione di crediti costituite ai sensi della legge n. 130/99, nonché – ma solo entro certi limiti – fondi di investimento, imprese assicurative e società di recupero crediti).
A seguito della recente riforma, le banche possono ora trasferire le proprie esposizioni classificate in sofferenza a “qualsiasi persona fisica o giuridica” che “nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale” acquisti crediti di tale natura. Tale attività infatti non configura più attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 106 TUB. Si è così notevolmente ampliato il novero dei soggetti che possono fungere da interlocutori delle banche italiane che abbiano l’esigenza di dismettere le proprie esposizioni non-performing, e tale ampliamento – almeno nelle intenzioni del legislatore europeo – dovrebbe avvenire anche oltre i confini nazionali con la creazione di un mercato unico di crediti non-performing a livello unionale. A quest’obbiettivo sono infatti volte le ulteriori disposizioni della Secondary Market Directive, come attuate con Regolamento di Esecuzione (UE) 2083/2023, che introducono un set uniforme e standardizzato di informazioni e dati che gli istituti bancari degli Stati membri devono mettere a disposizione dei potenziali acquirenti nel contesto delle procedure competitive indette per la dismissione di portafogli di crediti deteriorati.
Accanto all’ampliamento della platea di soggetti che può ora direttamente investire nelle esposizioni deteriorate, meritano poi di essere ricordati gli interventi di riforma effettuati, a più riprese, dal legislatore italiano [7] volti ad agevolare il ricorso alla cartolarizzazione dei crediti da parte delle banche quale tecnica di dismissione, anche massiva, di portafogli di crediti deteriorati. Lo schema della cartolarizzazione consente infatti di trasferire, anche solo in via sintetica (i.e., mediante trasferimento del rischio di credito, pur in assenza del trasferimento della titolarità giuridica del credito stesso), crediti o portafogli di crediti pecuniari ad una piattaforma societaria (special purpose vehicle), che consente ai propri stakeholder (i portatori dei titoli di cartolarizzazione) di investire, indirettamente, in asset cui gli stessi non avrebbero potuto accedere in via diretta.
Nell’arco dell’ultimo decennio, il ricorso alla cartolarizzazione nel settore dei crediti deteriorati è stato, sensibilmente, agevolato con l’introduzione di forme speciali ed agevolate non solo di trasferimento dei crediti così classificati, ma anche di segregazione a favore degli investitori degli asset di varia natura, posti a garanzia dei crediti medesimi (mediante apposite società veicolo cc.dd. “di appoggio” – nel gergo, leaseco o assetco – cui trasferire i beni a servizio della cartolarizzazione di crediti). Della possibilità di ricorso alla cartolarizzazione tiene debitamente conto anche la stessa BCE, che nella bozza di indirizzo in consultazione prevede infatti un’esenzione dai prospettati requisiti di copertura minima per le esposizioni deteriorate che siano state oggetto di cartolarizzazione, purché ricorrano i requisiti regolamentari per il c.d. “significative risk transfer”, ossia per il riconoscimento sul piano regolamentare del trasferimento significativo del rischio di credito dalla banca originator a soggetti terzi, ai sensi dell’art. 244 e ss. del Regolamento CRR, pur in presenza di un (limitato) reinvestimento della banca originator nella cartolarizzazione medesima.
In questo contesto, per quanto sia prematuro valutare l’effettiva portata e gli effetti dei nuovi indirizzi (ancora in consultazione, e dunque soggetti a modifiche) sul comportamento delle banche less significant, non può che essere accolto con favore il cambio di passo, almeno sul piano metodologico, delle Autorità di settore. E ciò non solo perché, come evidenziato anche dalla stessa BCE, l’iniziativa questa volta avviene in un momento storico di tendenziale aumento degli utili realizzati dal settore bancario e di riduzione – a livello aggregato – degli NPL ratio a livello europeo [8] (e non già in presenza di situazioni patologiche, come in passato), ma anche e soprattutto perché oggi è ben più maturo il framework regolamentare di riferimento e senz’altro più articolate sono le modalità alternative con cui le banche possono gestire gli stock di esposizioni deteriorate (tramite dismissione o esternalizzazione dei relativi processi di recovery) al fine di rafforzare la propria solidità patrimoniale.
[1] La documentazione oggetto di consultazione pubblica è consultabile al seguente link: https://www.bankingsupervision.europa.eu/framework/legal-framework/public-consultations/html/npe_lsis.it.html
[2] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
[3] Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013.
[4] Si segnalano, in particolare: BCE (2017), Linee Guida per le banche sui crediti deteriorati; BCE (2018), Addendum alle Linee Guida della BCE per le banche sui crediti deteriorati: aspettative di vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate; Orientamenti ABE in materia di gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni (EBA/GL/2018/06).
[5] Cfr. F. Ninfole, «NPL, stretta sulle piccole banche. Ecco le aspettative delle nuove linee guida della Vigilanza BCE», in Milano Finanza News, 15 settembre 2025 (URL: https://www.milanofinanza.it/news/npl-stretta-sulle-piccole-banche-ecco-aspettative-nuove-linee-guida-della-vigilanza-bce-202509151854163697).
[6] Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE, recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo 30 luglio 2024, n. 116.
[7] In particolare: art. 60-sexies, comma 1, lettera (b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato la Legge 130/1999 introducendo l’art. 7.1 in tema di cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari; art. 1, commi 1088-1090, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); art. 23 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (Decreto Crescita); art. 1, comma 215, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).
[8] Cfr. il documento intitolato “Risposte alle domande più frequenti sul progetto di indirizzo della BCE riguardante l’approccio di vigilanza delle ANC alla copertura delle NPE detenute da soggetti vigilati meno significativi”, disponibile tra i materiali scaricabili al link nella precedente nt. 1.