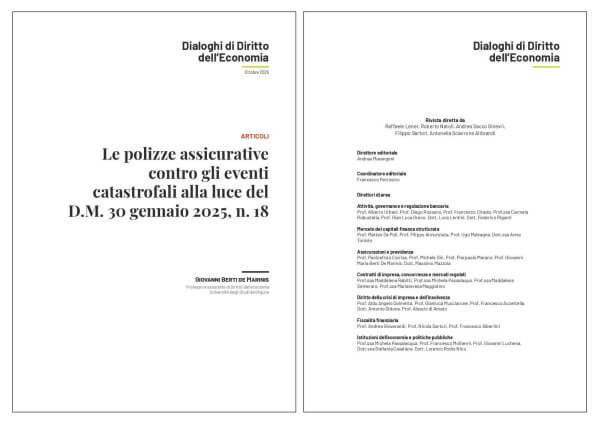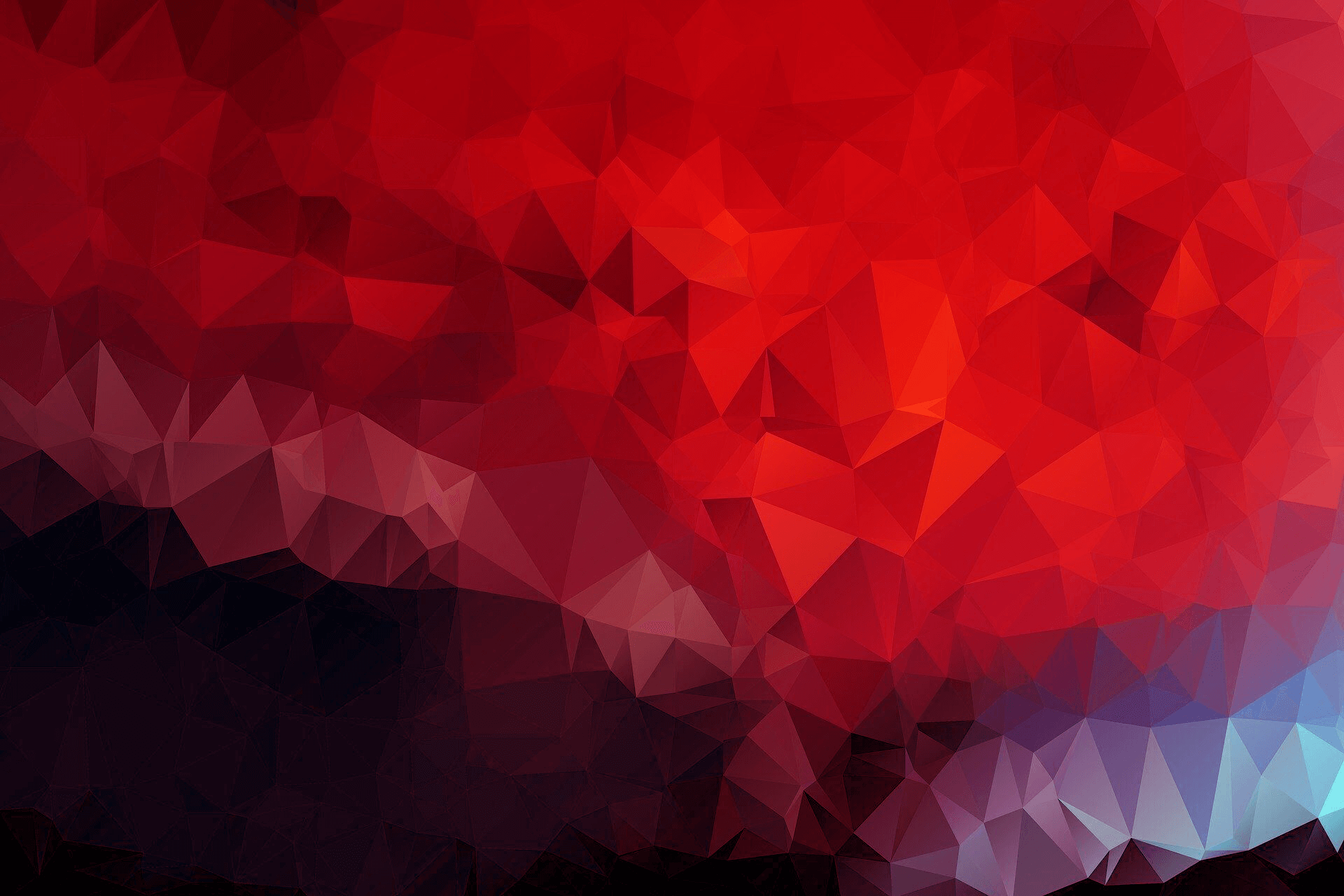SOMMARIO: Il lavoro analizza le principali problematiche poste dal D.M. n. 18 del 2025 in relazione alle polizze aventi ad oggetto eventi catastrofali. Oltre ai profili collegati all’esatta individuazione oggettivi e soggettivi collegati all’obbligo assicurativo, viene riposta particolare attenzione sui limiti all’autonomia negoziale imposti dal suddetto Decreto ministeriale.
ABSTRACT: The paper analyses the main issues raised by Ministerial Decree No. 18 of 2025 in relation to policies covering catastrophic events. In addition to the issues related to the precise identification of the objective and subjective profiles linked to the insurance obligation, particular attention is paid to the limits on contractual freedom imposed by the aforementioned Ministerial Decree.
1. Catastrofi naturali e mercato assicurativo
La gestione assicurativa dei rischi catastrofali ha da sempre messo a dura prova la scienza statistico-attuariale sulla quale le imprese di assicurazione fondano la loro capacità di neutralizzare i rischi che assumono. Trattandosi infatti di rischi caratterizzati da una tendenziale scarsa frequenza, dalla produzione di effetti nefasti su aree geografiche localizzate e dall’estrema significatività economica dei danni dagli stessi derivanti, tali eventi hanno sempre reso difficile la creazione di una mutualità che, per dimensioni, fosse idonea a permettere una gestione ordinaria di tale segmento di mercato[1].
Non è un caso che, già nel codice civile, l’art. 1912 c.c. escludesse dalla copertura assicurativa i danni derivanti da eventi quali terremoti, insurrezioni, guerre, tumulti salvo espresso patto contrario[2]. La disposizione menzionata, lungi dall’avere rilievo solo sotto il profilo del rapporto contrattuale che lega l’impresa all’assicurato, svolgeva invece anche un importante ruolo per il corretto svolgimento dell’attività assicurativa. Va infatti segnalato che, in assenza di più stringenti regole che disciplinassero il mercato assicurativo – norme oggi ovviamente presenti -, le peculiari norme che regolavano – e tutt’ora regolano – il contratto di assicurazione nel codice civile svolgevano anche il compito di rendere più agevole la gestione e neutralizzazione dei rischi da parte dell’impresa di assicurazione che, nel caso di specie, imponeva l’assunzione di particolari cautele nel trasferimento di rischi tanto significativi[3]. Proprio tale rapporto osmotico fra contratto di assicurazione e mercato nel quale lo stesso opera[4], ha infatti supportato una lettura estensiva della disposizione volta a non considerare tassativa l’elencazione degli eventi catastrofali ivi indicati[5], per estendere invece il principio sancito dall’art. 1912 c.c. a tutti i rischi che presentassero le stesse caratteristiche oggettive di quelli espressamente elencati[6].
Tuttavia, la crescente esposizione delle moderne società ad eventi di tale natura, sovente direttamente collegati al cambiamento climatico in corso[7], hanno incentivato l’adozione di disposizioni che rendessero più agevole – e, come si vedrà, in alcuni casi obbligatorio – assumere coperture assicurative in relazione ai suddetti sinistri[8]. Tale rinnovata attenzione è stata senza dubbio sollecitata sia dalla necessità dello Stato di non dover sopportare gli ingenti costi derivanti dagli aiuti economici ai soggetti colpiti da eventi calamitosi, ma anche dall’opportunità di garantire agli stessi dei ristori adeguati ed immediati i quali, soprattutto se diretti a supportare attività economiche, avevano il non secondario effetto di garantire una pronta ripartenza delle attività produttive nelle zone colpite da eventi catastrofali[9].
Non è un caso che un primo intervento di tal genere si sia registrato a favore delle imprese della filiera agricola le quali, particolarmente esposte ad eventi naturali avversi[10], potevano beneficiare di un contributo statale sui premi delle polizze a copertura dei suddetti rischi a tutto vantaggio della stabilità dell’attività di impresa[11]. Sempre nell’ambito delle attività agricole, l’esigenza di coprire i danni derivanti da eventi catastrofali è stata ancora perseguita tramite l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità che testimonia, ancora una volta, l’esigenza di mutualizzare determinati eventi nefasti al fine di creare mercati maggiormente stabili e performanti[12].
Fermo restando lo specifico regime che riguarda le imprese agricole – escluse infatti dall’ambito di applicazione delle disposizioni che di seguito si menzioneranno -, l’importanza della tematica è però riemersa con forza grazie alla l. 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) che, all’art. 1, commi 101 ss.[13], ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa in capo alle imprese aventi sede legale in Italia o aventi una stabile organizzazione in Italia a fronte di rischi quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni[14], delegando ad un Decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.
Se non vi sono dubbi sulla possibilità per chiunque sia portatore di un rischio di assicurarlo su base volontaria, l’emanazione del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18, completando il quadro regolatorio di dettaglio relativo all’obbligo assicurativo per i rischi catastrofali, ha reso effettivo e cogente tale obbligo che, alla luce delle ulteriori modifiche introdotte per effetto del d.l. 31 marzo 2025, n. 29 convertito con modifiche con l. 27 maggio 2025, n. 79, impone quindi alle imprese di dotarsi di idonee coperture verso tali eventi calamitosi[15] e, così facendo, si pone sotto l’ombrello assiologico dell’art. 41 cost.[16]. Va subito segnalato come la decisione di introdurre un obbligo assicurativo nei termini che a breve si vedranno, rappresenta una scelta imposta all’interno di un segmento di mercato poco mutualizzato il quale, se lasciato in balia delle regole che disciplinano le assicurazioni volontarie, potrebbe generare fenomeni di “antiselezione” che aggraverebbero ulteriormente la già difficile assicurabilità degli eventi catastrofali[17].
2. La particolare declinazione dell’obbligo assicurativo nelle disposizioni sui rischi catastrofali
Volendo dunque soffermarsi sulle principali problematiche poste dalle disposizioni sopra menzionate, va in primo luogo sottolineata la coraggiosa scelta del legislatore di prevedere un obbligo assicurativo supportato da un obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione. Analogamente a quanto accaduto per l’rc auto – segmento, però, assolutamente non paragonabile a quello oggetto di indagine per caratteristiche dei rischi e per ampiezza della mutualità -, infatti, le imprese di assicurazione operanti nel ramo 8 danni non potranno, salvo le considerazioni che a breve si faranno, rifiutare la copertura di tali rischi[18] la cui assunzione, proprio per le caratteristiche brevemente enumerate al principio, potrebbe però compromettere significativamente la solvibilità delle stesse e, per l’effetto la loro sana e prudente gestione. Di tale eventualità è consapevole il legislatore sia nel richiamare – cosa di per sé ovvia – la possibilità per le imprese di assicurazione di assumere tali rischi in coassicurazione o in forma consortile al fine di condividere tali rischi con altri soggetti vigilati, sia nel mettere a servizio di tale “progetto” normativo la garanzia prestata da SACE Spa al fine di permettere una più efficace gestione di tale portafoglio rischi soprattutto in fase di avvio ed in attesa che si formi una mutualità più solida[19].
Oltre a tale necessario sostegno pubblico, che rappresenta un valido esempio di cooperazione pubblico-privato nella corretta gestione di rischi che possono impattare significativamente anche sui delicati equilibri di bilancio nazionali[20], la legge finanziaria per il 2024 ha tentato di mitigare la rigidità dell’obbligo a contrarre delegando al Decreto ministeriale la possibilità di modulare tale disponibilità delle imprese a contrarre anche sulla scorta della loro effettiva capacità di assumere nuovi rischi di tale natura[21]. Sotto tale profilo, il D.M n. 18 del 2025 incrocia le peculiarità dei rischi oggetto di trasferimento con le disposizioni che regolano il governo societario delle imprese di assicurazione e gli obblighi di reportistica sulle stesse gravanti[22]. Nel richiamare gli obblighi che incombono sul c.d.a. descritti dall’art. 29 bis cod. ass. e meglio specificati dall’art. 5 del Reg. IVASS 3 luglio 2018, n. 38, viene richiesto alle imprese di assicurazione operanti nel ramo 8 di individuare, i relazione a tale peculiare tipologia di rischi, la propria propensione al rischio in diretta relazione al fabbisogno di solvibilità e, tramite ciò, fissare i propri limiti di tolleranza al rischio[23], segnalando all’Autorità di vigilanza la propria eventuale impossibilità di assumere ulteriori rischi catastrofali nel caso di raggiungimento di quei limiti di tolleranza[24].
A ben vedere, non si tratta di una novità quanto, piuttosto, di una particolare modulazione dell’approccio risk based richiesto alle imprese di assicurazione[25] e che trova nella Valutazione interna dei rischi e della solvibilità di cui all’art. 30 ter cod. ass.[26] la manifestazione esterna dell’attenzione che l’industria assicurativa deve riporre non solo nella misurazione dei rischi ai quali l’impresa è esposta anche su base prospettica, ma anche nell’individuazione del contestuale fabbisogno di solvibilità che risulta necessario assicurare[27]. Sulla scorta di queste analisi, poi, l’impresa dovrà individuare la propensione al rischio (risk appetite) ed i limiti di tolleranza al rischio che la stessa può sopportare (risk tolerance limits)[28]. Tramite tale Valutazione l’impresa, dopo aver individuato le tecniche di gestione e di mitigazione dei rischi che intende adottare, sarà chiamata poi a quantificazione il proprio fabbisogno di solvibilità ponendosi in una prospettiva di medio e lungo termine[29]. Appare opportuno segnalare che già in tale fase viene richiesto all’impresa di assicurazione di adottare un approccio particolarmente prudente in relazione ai rischi significativi che andranno sottoposti a stress test in modo da verificarne il concreto impatto sulla solvibilità soprattutto in situazioni avverse[30]. Sulla scorta di tali analisi, quindi, l’impresa sarà chiamata a verificare l’adeguatezza del proprio livello di solvibilità alla luce della quantità e qualità delle proprie risorse finanziarie[31].
Come pare evidente, l’assolvimento di tali obblighi si risolve non già in una valutazione statica[32] ma, al contrario, in un vero e proprio processo continuo di autovalutazione da parte dell’impresa[33] supportato ulteriormente dall’obbligo di comunicare periodicamente all’Autorità competente i risultati emergenti da tale Valutazione con il precipuo fine di rendere più agevole e penetrante la vigilanza[34]. Attraverso tale processo di autovalutazione, quindi, l’Autorità di vigilanza viene resa edotta non solo di come l’impresa di assicurazione e/o il gruppo assicurativo si collochi in relazione al rapporto rischio/solvibilità in chiave prospettica, ma anche delle misure che l’impresa e/o il gruppo intendono adottare per migliorare tale rapporto[35] risultando uno strumento di particolare rilievo nel flusso informativo da alimentare nei confronti dell’Autorità[36].
Tramite il D.M. n. 18 del 2025, quindi, si chiede espressamente alle imprese del Ramo 8 di fare particolare attenzione ai rischi catastrofali al fine di individuare la propria capacità assuntiva degli stessi e, nel mantenere il loro obbligo a contrarre, salvaguardare comunque la solvibilità necessaria a garantire a tutti i clienti – non solo a quelli che si assicurano avverso rischi catastrofali – le prestazioni assicurative concordate in caso di sinistro.
3. Eventi catastrofali ed individuazione dei beni oggetto di copertura obbligatoria
Se sotto il profilo soggettivo non sembrano residuare dubbi circa la portata dell’obbligo assicurativo[37], qualche difficoltà interpretativa potrebbe sorgere in relazione all’individuazione dei rischi oggetto di copertura obbligatoria e dei beni che devono essere necessariamente protetti dalla polizza. Il D.M. n. 18 del 2025, infatti, va a dettagliare gli eventi catastrofali già indicati all’art.1, comma 101 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 che li individuava in sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Nelle definizioni riprese e specificate dal D.M. n. 18 del 2025, se non emergono particolari incertezza per quanto concerne la definizione di «sisma»[38], qualche spunto di riflessione sorge invece in relazione agli altri rischi.
In primo luogo, infatti, l’art. 3, lett. a) del D.M. n. 18 del 2025 unifica dal punto divista semantico i concetti di «alluvione», «inondazione» ed «esondazione» definendoli come «fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali». Tale definizione individua quindi negli «eventi atmosferici naturali» i fattori che causano l’evento catastrofale qualificato quale «fuoriuscita d’acqua» da un bacino (anche artificiale). Ciò che conta, quindi, non è l’intensità dell’evento naturale né i danni derivanti direttamente dallo stesso[39] quanto, piuttosto, quelli che sono diretta conseguenza della «fuoriuscita d’acqua» dagli argini (naturali o artificiali) di un bacino o di una rete di drenaggio. Non risulteranno quindi coperti i danni direttamente derivanti da forti piogge, grandinate intense, trombe d’aria o forti raffiche di vento, ma solo ed esclusivamente quelli causalmente ricollegati alla «fuoriuscita d’acqua» generata dall’evento atmosferico.
In secondo luogo, qualche precisazione merita anche la definizione dell’evento «frana» il quale viene descritto dall’art. 3, lett. c) del D.M. n. 18 del 2025 quale «movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto il profilo della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d’acqua». Il fatto che si richiami la “rapidità” dell’evento, esclude alla radice che possano rientrare nella descrizione di tale avvenimento catastrofale le ipotesi, molto frequenti in realtà, nelle quali la «frana» si concretizzi in uno scivolamento lento ed inesorabile del terreno e, pertanto, graduale. In tali ipotesi, non ci troveremmo di fronte ad un evento catastrofale che rientrerà nella copertura obbligatoria[40].
Con portata più generale, va inoltre sottolineato che sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, per come definite nel dettaglio dal D.M. n. 18 del 2025, sono per legge qualificati come eventi catastrofali[41] e, tutto ciò, consente all’interprete di prescindere dal dover indagare caso per caso se, dal punto di vista della dimensione geografica o dell’estensione dei danni, gli stessi abbiano avuto effettivamente una portata non circoscritta ad un esiguo numero di soggetti coinvolti. Si ritiene, cioè, che si debba in questo caso accantonare la definizione comune di “catastrofe” o di “calamità” naturale quale evento di portata collettiva che genera danni ingenti su vasta scala, per accogliere, invece, la definizione normativa di tali lemmi per come descritti dall’apparato regolatorio sopra richiamato[42].
Per quanto concerne poi l’identificazione dei beni oggetto di copertura, questi vengono individuati nelle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, comma 1, Sezione attivo, voce B-II, nn. 1, 2, e 3 c.c. a qualsiasi titolo impiegate per l’esercizio dell’impresa. Rientrano quindi fra tali beni i terreni, i fabbricati, gli impianti ed i macchinari nonché le attrezzature industriali e commerciali (attrezzi, utensili, macchinari e mezzi non iscritti al PRA)[43]. Non rientrano invece nei beni oggetto di copertura obbligatoria né quelli che compongono il magazzino[44], né i macchinari iscritti al PRA cosa che impone di modulare la portata dell’obbligo assicurativo in funzione della tipologia di impresa che richiede la copertura. Per le attività di impresa che richiedono il mantenimento di un magazzino particolarmente consistente in termini di valore[45] o che utilizzino mezzi per i quali è richiesta l’iscrizione al PRA[46], l’obbligo assicurativo avrà un impatto poco significativo in termini di benefici attesi in caso di evento catastrofale.
4. La declinazione dell’obbligo assicurativo nel caso di immobilizzazioni di proprietà di terzi ma impiegate stabilmente nell’attività di impresa
I beni sopra descritti, poi, devono essere assicurati da parte dell’imprenditore in tutti i casi in cui siano impiegati «a qualsiasi titolo» per l’esercizio dell’impresa rendendo evidente come tale obbligo di copertura graverà anche sui beni che non sono di proprietà dell’imprenditore ma di cui lo stesso ha la disponibilità purché rientranti, ovviamente, nella categoria delle immobilizzazioni di cui sopra. Tale scelta, che parrebbe del tutto in linea con le finalità perseguite dalle disposizioni che, ad una valutazione epidermica, sembrerebbero introdurre un obbligo assicurativo fortemente orientate a dare all’imprenditore la possibilità di riattivare prontamente la propria impresa a seguito di eventi catastrofali ripristinando le immobilizzazioni utili all’attività produttiva, pone però non secondari problemi interpretativi circa le modalità con cui articolare il rapporto assicurativo ove le immobilizzazioni siano di proprietà di terzi[47].
Partendo dai dati normativi, va in primo luogo sottolineato come l’obbligo assicurativo graverà sempre sull’imprenditore anche se i beni oggetto di copertura sono di proprietà di terzi ma solo ove le suddette immobilizzazioni non siano già oggetto di adeguata copertura assicurativa contratta dal proprietario[48]. Ove dovesse provvedere l’imprenditore, però, si pone il problema della corretta individuazione del destinatario della prestazione assicurativa che è sì ontologicamente collegata ai danni subiti dal bene danneggiato o distrutto dall’evento catastrofale, ma che dovrebbe anche essere funzionalmente collegata alla rapida ripartenza dell’attività imprenditoriale. Appare particolarmente importante sottolineare il nesso sussistente fra il bene di proprietà del terzo e l’esercizio dell’attività di impresa tanto da far emergere come il “valore” compromesso dall’evento catastrofale non sia tanto collegato alle prerogative del proprietario ma, piuttosto, all’uso che di quel bene fa l’imprenditore. Dall’altro lato, però, deve anche tenersi in considerazione l’esigenza di evitare che valutazioni di opportunità da parte dell’imprenditore possano compromettere il ripristino/riparazione dei beni colpiti dal sinistro. Ciò accadrebbe, ad esempio, nelle ipotesi in cui l’imprenditore dovesse beneficiare della prestazione assicurativa per i danni sofferti alle immobilizzazioni di proprietà di terzi ma ritenesse non conveniente continuare la propria attività di impresa, almeno nell’immediatezza, nel luogo interessato dall’evento calamitoso perdendo, così, interesse alla ricostruzione, rimpiazzo o ripristino dell’immobilizzazione[49].
Tali distinti interessi hanno spinto il legislatore ad intervenire sul punto con il d.l. 31 marzo 2025, n. 39 che, come convertito con modifiche dalla l. 27 maggio 2025, n. 78, stabilisce all’art. 1, comma 3 sexies che, in tali casi, «l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene. Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al terzo periodo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario»[50]. Si tratta di una disposizione che dimostra di dare prioritaria protezione all’integrità del diritto di proprietà salvaguardandolo anche a scapito della prosecuzione dell’attività di impresa. Tale scelta fa quindi assumere alla vicenda assicurativa le sembianze dell’assicurazione per conto altrui nella quale, ai sensi dell’art. 1891, comma 2 c.c., i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato[51]. Ed infatti, il proprietario del bene funzionale allo svolgimento dell’impresa esercitata da terzi soggetti è, in tale prospettiva, il soggetto portatore del rischio ed assume, quindi, le vesti dell’assicurato. Vero è che su tale soggetto graverà l’obbligo di destinare l’indennizzo al ripristino del bene ma, ove decidesse di non farlo, dovrà soltanto riconoscere un indennizzo all’imprenditore contraente per lucro cessante pari al 40% della prestazione assicurativa ricevuta[52].
La norma introduce, però, una serie di ambiguità interpretative. La prima, riguarda la liceità o meno della scelta del proprietario di non destinare l’indennizzo alla ricostruzione, al rimpiazzo o al ripristino dell’immobilizzazione oggetto di copertura una volta ricevuto l’indennizzo da parte dell’assicurazione. La norma, infatti, da un lato sembra introdurre l’obbligo di destinare la prestazione assicurativa a favore dell’impresa del contraente ma, subito dopo, sembra anche garantire copertura normativa alla scelta del proprietario di non farlo introducendo, in tal caso, l’obbligo per l’assicurato/proprietario di retrocedere al contraente il 40% dell’indennizzo a titolo di lucro cessante. Non è dunque chiaro né se tale somma sia dovuta a titolo di indennizzo (da fatto lecito) o di risarcimento (da fatto illecito), né se si tratti di una somma forfetaria o la stessa identifichi solo il limite massimo in relazione ad un danno da lucro cessante che dovrà comunque essere dimostrato da parte dell’imprenditore contraente sia nell’an che nel quantum.
Andando per esclusione, se la scelta del proprietario del bene assicurato di non destinare l’indennizzo al ripristino/riparazione del bene concretizzasse un fatto illecito foriero di un danno da lucro cessante per l’imprenditore contraente, non si vede per quale motivo limitare il risarcimento al 40% dell’indennizzo percepito e non garantire, invece, l’integrale risarcimento del danno. Tale considerazione farebbe dunque propendere per qualificare la scelta dell’assicurato di non ricostruire/rimpiazzare il bene quale un fatto lecito portatore, però, un danno forfetariamente indennizzato nella misura del 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario[53]. L’obbligo di retrocedere all’imprenditore tale somma, oltre ad essere un elemento di ristoro per la maggiore difficoltà che incontrerà nel riattivare l’attività di impresa, rappresenterebbe anche uno “stimolo” indiretto per il proprietario assicurato a destinare l’indennizzo al ripristino/rimpiazzo del bene in modo da ristabilirne il valore economico e, tornando a destinare lo stesso all’attività di impresa, garantire la possibilità all’imprenditore contraente di riprendere rapidamente la propria attività economica.
Pure qualche dubbio genera la sorte dell’indennizzo nel caso di assicurazione stipulata dal proprietario su un bene proprio ma destinato all’attività di impresa altrui. In tal caso, come detto, non sussiste l’obbligo per l’imprenditore di assicurare l’immobilizzazione verso gli eventi catastrofali essendo quel bene già coperto da una polizza che si allinea alle caratteristiche sopra evidenziate. In tale circostanza, tuttavia, si tratterebbe di una polizza che il proprietario, quale contraente, stipula nel proprio interesse risultando portatore del rischio assicurato. In tali casi, quindi, contraente ed assicurato coincidono nel medesimo soggetto cosa che, logicamente, non rende estensibile in via interpretativa la disposizione di cui all’art. 1, comma 3 sexies del d.l. 39 del 2025 anche alla fattispecie in parola. Il contraente/assicurato, dunque, potrà destinare l’indennizzo alle finalità che riterrà più opportune e profittevoli disancorando completamente la vicenda assicurativa dall’attività di impresa. Tutto ciò, però, non rende comprensibile il perché si sia scelto di limitare l’obbligo assicurativo alle immobilizzazioni di cui all’art. 2424, comma 1, Sezione attivo, voce B-II, nn. 1, 2, e 3 c.c. Appare infatti evidente che se il legislatore ha inteso selezionare quei beni non è tanto per la natura oggettiva degli stessi quanto, piuttosto, per la funzione che gli stessi assolvono nell’attività di impresa. Disancorare completamente l’indennizzo dal ripristino delle condizioni ante sinistro nelle quali si trovava l’imprenditore colpito dall’evento catastrofale, rischia di vanificare in parte l’obiettivo perseguito dal legislatore.
Ciò lascia trasparire come ancora rimanga centrale nelle riflessioni del regolatore il peso che assume la protezione del diritto di proprietà, le prerogative che lo stesso riconosce al proprietario e l’integrità del patrimonio di tale soggetto da proteggere anche a prescindere dalle funzioni che quei determinati beni assumono all’interno delle attività economiche.
Se così stanno le cose, però, non si vede il senso di limitare l’obbligo assicurativo relativo agli eventi catastrofali alle sole imprese e solo ai beni sopra descritti. Se l’interesse protetto è il diritto di proprietà sui beni, infatti, risulterebbe allora maggiormente coerente estendere tali obblighi a tutti i soggetti magari circoscrivendolo ai beni di maggior valore o maggiormente esposti agli eventi catastrofali sopra descritti. Non è da escludere, però, che le disposizioni in parola siano una sorta di normativa pilota che ponga le basi per una futura estensione di tali obblighi assicurativi anche ad altri soggetti[54].
5. L’etero-conformazione dei contratti di assicurazione sui rischi catastrofali ed i limiti di indennizzo
Qualche cenno merita, ancora, il profilo delle limitazioni contrattuali dell’indennizzo dovuto a seguito dell’evento catastrofale. Tale aspetto risulta centrale proprio per individuare i confini entro cui l’impresa di assicurazione risulta obbligata verso l’assicurato all’interno di un segmento di mercato che, come detto al principio, appare caratterizzato da una scarsa mutualità e dalla presenza di oggettive difficoltà tecniche nella gestione di tale tipologia di rischi. Appare infatti evidente che, a prescindere dalle complesse regole che disciplinano l’attività assicurativa di gestione e neutralizzazione dei rischi, il contratto di assicurazione sia sempre il primo strumento giuridico che le imprese di assicurazione utilizzano per limitare e delimitare il rischio che assumono[55].
Va segnalato come, sul punto, vi sia una particolare attenzione da parte del D.M. n. 18 del 2025 nell’individuazione di vincoli all’autonomia negoziale che dovrebbero essere strumentali ad evitare che l’obbligo assicurativo venga aggirato de facto stabilendo limiti alle coperture tanto ampi da vanificarne gli effetti attesi in termini di protezione dell’assicurato. L’idea che la traslazione di tali rischi avvenga seguendo le regole del mercato[56] e che questa, quindi, debba transitare anche tramite il fisiologico articolarsi dell’autonomia negoziale, non vuol dire infatti lasciare alle parti la totale libertà di determinare il contenuto del contratto. Non è più trascurabile il fatto che il contratto stia progressivamente perdendo la sua originaria essenza di strumento rilevante solo nei rapporti fra i contraenti e che stia invece assumendo, con sempre maggiore insistenza, la dimensione più ampia di istituto in grado di incidere sulla corretta conformazione del mercato[57]. Il contratto diventa uno dei mezzi che l’ordinamento utilizza al fine di realizzare interessi che non sono più solo privati ma che, al contrario, richiamano anche obiettivi di natura collettiva e diffusa. Il D.M. n. 18 del 2025, tramite l’etero-conformazione di tale tipologia di polizze, si colloca proprio in tale visione dell’autonomia negoziale[58].
L’impostazione adottata dal regolatore è, in questo caso, quella di modulare la pervasività dei limiti in funzione del peso economico del soggetto assicurato probabilmente nella convinzione che contraenti di dimensioni rilevanti siano in grado da un lato, di sostenere una contrattazione ad armi pari con una impresa di assicurazione e, dall’altro, che abbiano una organizzazione tale da permettergli di internalizzare in parte tali rischi e di gestirli con tecniche para-assicurative anche in assenza di coperture assicurative pienamente adeguate[59].
Per quanto riguarda la determinazione del massimale della polizza, infatti, questo deve ammontare all’intero valore dei beni assicurati per le imprese che assicurino immobilizzazioni per un valore pari o inferiore ad un milione di euro. Ove il valore dei beni assicurati risulti compreso fra un milione e trenta milioni di euro, invece, le parti potranno pattuire un massimale che non sia però inferiore al 70% della somma assicurata. Per le imprese che assicurino beni per un valore superiore a trenta milioni di euro, invece, permane l’obbligo di stipulare la polizza – e, con esso, quello di trasferire in parte il rischio derivante da eventi catastrofali -, ma il massimale sarà liberamente determinabile dalle parti non sussistendo nessuna limitazione di sorta[60]. Tale scelta, che sicuramente si giustifica da un punto di vista sistemico alla luce dell’esigenza di evitare che sinistri tanto significativi possano mettere in pericolo la solvibilità dell’impresa di assicurazione o, vista da altra prospettiva, di creare le condizioni affinché rischi tanto consistenti possano essere almeno in parte assicurati, lascia però in qualche perplessità. Va infatti segnalato, in primo luogo, che le grandi imprese risulterebbero in linea con l’obbligo assicurativo anche pattuendo in polizza massimali del tutto inadeguati e, dunque, generando un trasferimento pressoché irrilevante dei rischi catastrofali i quali verrebbero quasi integralmente internalizzati. Né può trascurarsi, in secondo luogo, come sia del tutto lecito dubitare della capacità di imprese anche di grandi dimensioni di valutare correttamente e gestire in autonomia rischi di tale portata. Basti sul punto ricordare che la gestione di tali eventi catastrofali genera non secondari problemi alle stesse imprese di assicurazione la cui attività è, per l’appunto, proprio quella di neutralizzare i rischi tramite tecniche di mutualità assicurativa. Sarebbe stato forse più opportuno, nel lasciare comunque un più ampio margine all’autonomia negoziale rispetto alle impresi dimensionalmente meno strutturate, stabilire comunque anche in tale ultimo caso un limite minimo al massimale in modo da determinare un adeguato trasferimento del rischio.
Le considerazioni critiche sopra riportate vengono confermate anche alla luce della disciplina degli scoperti[61] che, sposando la medesima filosofica normativa, lascia alle imprese che assicurino una somma pari o inferiore ai trenta milioni di euro la possibilità di pattuire uno scoperto che, però, non può superare il 15% del danno indennizzabile. Per quanto però riguarda le imprese che assicurino somme superiori ai trenta milioni di euro torna a riespandersi in tutta la sua portata il principio di autonomia negoziale garantendo la possibilità di pattuire qualunque percentuale di scoperto. Tale disposizione, unita alla possibilità per tale categoria di imprese di negoziare liberamente il massimale di polizza, conferma le perplessità circa la capacità di tali disposizioni di generare un sufficiente trasferimento del rischio e, dunque, una adeguata copertura per tale tipologia di sinistri se patiti da imprese di grandi dimensioni.
6. Considerazioni conclusive con riferimento ai profili sanzionatori
Come si è cercato di evidenziare, l’assicurabilità dei rischi catastrofali pone una molteplicità di problematiche tecniche e giuridiche che il legislatore e la dottrina[62] stanno cercando di affrontare nel meritorio tentativo di sensibilizzare il mercato verso la necessità di coprire, mediante uno sforzo che coinvolga congiuntamente il pubblico ed il privato, gli effetti nefasti di tali eventi.
Il ricorso al mercato assicurativo – ed alle dinamiche regole concorrenziali che lo caratterizzano – ha indubbiamente effetti positivi in tal senso essendo idoneo a generare una competizione fra le imprese di assicurazione al fine di acquisire un miglior piazzamento all’interno di un segmento di mercato che, proprio per effetto dell’introduzione dell’obbligo assicurativo, dovrebbe conseguentemente beneficiare di un significativo incremento della mutualità rendendo maggiormente gestibili tali rischi con tecnica assicurativa. Tutto ciò, unito al supporto pubblico che almeno in questa prima fase è stato assicurato, potrebbe rendere particolarmente appetibile l’assunzione di tali rischi soprattutto se l’intenzione del legislatore è quella di estendere l’obbligo assicurativo anche al di fuori degli ambienti imprenditoriali.
In quest’ottica, sicuramente merita apprezzamento il fatto di aver ribadito che la copertura di tali rischi debba avvenire applicando premi proporzionali al rischio e che, contestualmente, sia stato previsto un virtuoso meccanismo incentivante che dovrebbe determinare l’abbassamento del premio al ricorrere di condotte proattive da parte dell’assicurato nella prevenzione dei rischi catastrofali e nella protezione dei beni esposti agli stessi[63]. Tale atteggiamento appare fortemente orientato a stimolare la nascita di una cultura del rischio derivante da eventi catastrofali con effetti senza dubbio positivi in termini di mitigazione degli effetti avversi da quelli generati.
Rimane sullo sfondo il tema della sanzione che colpisce le imprese in caso di mancata stipula di adeguate polizze contro i rischi catastrofali dal momento che l’art. 1, comma 102 della l. 213 del 2024, prevede soltanto che di tale inadempimento «si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». Non è chiaro però cosa si intenda, in concreto, per «tener conto» della mancata stipula della polizza e, quindi, se la violazione dell’obbligo assicurativo comporti una totale esclusione dalle agevolazioni pubbliche ovvero una sorta di penalizzazione nell’attribuzione delle stesse. Va però segnalato che lo schema di decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2 lett. b) della l. 27 ottobre 2023, n. 160, recherà il Codice degli incentivi, stabilisce fra le cause di esclusione dal percepimento delle agevolazioni pubbliche anche la violazione dell’obbligo assicurativo stabilito dall’art. 1, comma 101 della l. n. 213 del 2024[64]. Pur trattandosi di uno schema di decreto legislativo che ancora non ha completato il suo iter, il dato appare rilevante quantomeno nel lasciar trapelare l’intenzione del legislatore di propendere, in caso di violazione dell’obbligo, per la totale privazione del beneficio pubblico. Tale rigoroso atteggiamento viene in parte confermato anche dai più recenti interventi ministeriali che tendono ad escludere la possibilità di percepire incentivi nel caso di violazione dell’obbligo assicurativo in parola[65].
Sulla stessa linea, da ultimo, vale la pena tornare brevemente sulle conseguenze che derivano dalla totale libertà lasciata alle grandi imprese di modulare massimali e scoperti in maniera totalmente autonoma negoziandoli direttamente con le imprese di assicurazione. Come sopra detto, ciò implica che tali assicurati saranno compliant rispetto all’obbligo assicurativo anche con la sottoscrizione di polizze che trasferiscano rischi minimi rispetto al valore delle immobilizzazioni assicurate cosa che, per ovvie ragioni, inciderà in termini di significativa diminuzione dei premi per tali soggetti. Questi, avendo de facto rispettato l’obbligo assicurativo anche se concludendo polizze del tutto inadeguate a garantire una sufficiente copertura assicurativa di tali rischi, potranno però beneficiare degli incentivi pubblici cosa che rende tale “sanzione”, ricorrendo le circostanze di cui sopra, sicuramente poco efficace e scarsamente persuasiva.
Appare allora evidente, come segnalato da attenta dottrina, che la cogenza dell’“obbligo” assicurativo descritto dalle disposizioni di settore si regga, di fatto, sull’effetto deterrente che può generare il rischio di perdere il diritto a percepire incentivi di natura economico/finanziaria. Tutto ciò, però, trasforma di fatto tale “obbligo” assicurativo in quello che, giuridicamente, può essere definito più propriamente come un “onere” che, se correttamente assolto nelle forme sopra descritte, garantisce l’accesso a determinati benefici i quali sarebbero, in caso contrario, del tutto preclusi alle imprese che decidessero di non assicurarsi[66]. Si tratterebbe, quindi, di un approccio rimediale attenuato forse dettato dall’esigenza di non appesantire eccessivamente le imprese chiamate ad assicurarsi le quali, probabilmente, già percepiscono tale nuovo vincolo come un ulteriore costo certo da sostenere nel presente in vista vantaggi economici futuri ma solo eventuali e, forse, non ancora del tutto correttamente considerati e valorizzati da parte delle imprese.
[1] Preliminarmente v. P. Corrias, Le coperture assicurative dei rischi catastrofali, in Sostenibilità Finanza Mercati e Ambiente, spunti di riflessione, A. Antonucci, S. Cavaliere, A. Davola e G. Luchena (a cura di), Bari, 2025, 228 ss. e, pur se con riferimento al rischio pandemico, Id., La gestione dei rischi pandemici nei contratti assicurativi, in Resp. civ. prev., 2020, 1398 ss. Va segnalato come sul punto la crescente attenzione della stessa Autorità di vigilanza assicurativa. V., in tal senso, la Lettera al mercato del 6 agosto 2025 con la quale l’IVASS avvia la «Rilevazione sull’andamento dei prezzi delle coperture catastrofali».
[2] Sul punto, in generale, E. Bottiglieri, Dell’assicurazione contro i danni, in Comm. cod. civ. Schlesinger, Milano, 2010, 200.
[3] Si pensi, in questo senso e senza pretesa di esaustività, alle disposizioni che regolano le dichiarazioni inesatte o le reticenze o a principi quali quello dell’indivisibilità del premio. Si tratta di regole contrattuali funzionali a supportare la particolare attività di impresa portata avanti dalle assicurazioni. Per qualche ulteriore considerazione, si rinvia a G. Berti de Marinis, Inadempimento dell’assicurato e principio di indivisibilità del premio, in Resp. civ. prev., 2020, 547 ss.
[4] Sul rapporto fra contratto ed impresa nel mercato assicurativo, v. P. Corrias, La causa del contratto di assicurazione: tipo assicurativo o tipi assicurativi?, in Riv. dir. civ., 2013, 55; O. Clarizia, Contratto di assicurazione, impresa e mercato: dialoghi tra passato (l’impresa requisito del contratto) e presente (nullità di protezione ed eteroregolamentazione), in Rass. dir. civ., 2017, 1211 ss.
[5] Sosteneva la tassatività dell’elencazione degli eventi contenuta all’art. 1912 c.c., A. Donati, Trattato del diritto delle assicurazioni private, Milano, 1956, 159.
[6] Per tale lettura estensiva, v. V. Salandra, Delle obbligazioni (artt. 1891 – 1932), Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, 333; P. Corrias, La risposta assicurativa ai danni catastrofali, in Resp. civ. prev., 2024, 1140 s.
[7] V. M. Frigessi di Rattalma, L’assicurazione contro i danni da catastrofi naturali nel contesto delle politiche sul cambiamento climatico, in Fundamental rights, 2024, 75 ss.
[8] Cfr., D. Cerini, Assicurazioni contro rischi di catastrofi naturali: profilature italiane dopo il Green Paper Ue, in Dir. fisc. ass., 2013, 464 ss.
[9] Ampiamente, sul punto, S. Cavaliere, Sostenibilità e assicurazione danni catastrofali, in Assicurazioni, 2025, 77 ss.
[10] Diffusamente, sul punto, S. Bolognini, La gestione del rischio nella Politica Agricola Comunitaria (PAC): in particolare, gli strumenti per far fronte agli eventi catastrofali, in Assicurazioni, 2023, 616 ss.
[11] Si veda, in tal senso, il d.lg. 29 maggio 2004, n. 102 su cui v. A. Grasso, Il sistema delle assicurazioni contro i rischi in agricoltura, in Dir. giur. agr. amb., 2005, 699 ss.; S. Landini, Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali, in Assicurazioni, 2013, 19 ss.; A. Candian, Rischi della filiera agro-alimentare e diritto comparato delle assicurazioni, in Riv. dir. agr., 2019, 401 ss.
[12] Si tratta della l. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 515 ss. Sulla gestione dei rischi in agricoltura, v. S. Landini, Assicurazione del rischio in agricoltura, in Assicurazioni, 2021, 539 ss.
[13] P. Corrias, La risposta assicurativa ai danni catastrofali, cit., 1445 s.
[14] S. Cavaliere, Calamità naturali e assicurazione obbligatoria, in giustiziacivile.com, 2024; L. Rodio Nico, Il nuovo obbligo assicurativo per le catastrofi naturali, in Dir. merc. ass. fin., 2024, 259 ss.; S. Landini, Assicurabilità e indennizzabilità dei rischi catastrofali ambientali, in Assicurazioni, 2024, 22 ss.
[15] Va sul punto segnalato che la decorrenza dell’obbligo assicurativo viene fissata al 31 marzo 2025 per le grandi imprese, al 1 ottobre 2025 per le medie imprese ed al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese.
[16] Va tuttavia segnalato, come si specificherà in seguito, che risulta ancora centrale nelle dinamiche regolatorie la protezione del diritto di proprietà e della connessa integrità del patrimonio del proprietario dei beni colpiti dall’evento catastrofale a prescindere dalla funzione produttiva impressa a quei beni. Tale considerazione, soprattutto nelle ipotesi in cui i beni danneggiati o distrutti dall’evento catastrofale siano di proprietà di un terzo soggetto ma impiegati stabilmente nell’attività di impresa, pone potenzialmente un singolare contrasto fra le ragioni costituzionali cristallizzate dall’art. 41 cost. con quelle descritte, invece, dall’art. 42 cost.
[17] Il fenomeno della selezione avversa si verifica quando solo i soggetti maggiormente esposti ad un determinato rischio ricorrono al sistema assicurativo. Ciò comporta il trasferimento di un numero inferiore di rischi e, soprattutto, il trasferimento solo di quei rischi che hanno maggiore probabilità di convertirsi in sinistri. Tale processo porta ad un significativo aumento dei premi che, a sua volta, allontana ulteriormente dal mercato assicurativo i soggetti meno esposti al rischio creando, di conseguenza, un circolo vizioso che rende ancor più difficile gestire tali rischi con tecnica assicurativa. Sul punto, v. M. Frigessi di Rattalma, Verso un regime di assicurazione obbligatoria contro i danni da catastrofi naturali, in Copertura dei danni catastrofali e trasparenza delle polizze: le attuali sfide del mercato assicurativo, P. Corrias, M. Frigessi di Rattalma e S. Landini (a cura di), Napoli, 2024, 23 s. Che questo sia uno dei rischi percepiti dallo stesso regolatore è testimoniato dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 18 del 2025.
[18] L’art. 1, comma 107 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 prevede che «Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000».
[19]Ai sensi dell’art. 1, comma 108 della l. 30 dicembre 2023, n. 213 «la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui al comma 105, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per l’anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore all’importo maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell’anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 110».
[20] M. Frigessi di Rattalma, Verso un regime di assicurazione obbligatoria contro i danni da catastrofi naturali, cit. 28.
[21] L’art. 1, comma 105 della l. 30 dicembre 2023, n. 213, prevede infatti che tramite Decreto ministeriale si individuino, fra le altre cose, «le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese».
[22] Va segnalato come una parte della dottrina abbia già sottolineato come le disposizioni che disciplinano l’impresa di assicurazione avessero già tenuto in considerazione le problematiche inerenti le calamità naturali imponendo alle imprese dei rami danni di costituire una riserva di perequazione per rischi di calamità naturali avente la funzione di compensare nel tempo l’incerto andamento della sinistralità collegata a tali eventi. V., in tal senso, P. Corrias, La risposta assicurativa ai danni catastrofali, cit., 1442.
[23] Sul ruolo del cda nella valutazione dei rischi e della solvibilità, v. S. Dell’Atti e S. Sylos Labini, Il governo societario nelle imprese di assicurazione. Regolamentazione, proporzionalità e gestione del cambiamento, Padova, 2019, 193.
[24] In questo senso, l’art. 5, comma 3 del D.M. n. 18 del 2025.
[25] C. Dittmeier, La governance dei rischi. Un riferimento per gli organi e le funzioni di governo e controllo, Milano, 2015, 71 ss. Su un approccio al rischio necessariamente dinamico, v. P. Manes, La nuova normativa Solvency II: corporate governance, approccio al rischio e mercato assicurativo europeo, in Contr. Impr., 2018, 261 ss.
[26] Su cui v. S. Landini, Art. 30 ter, in Codice delle assicurazioni private, Appendice, A. Candian e G. Carriero (a cura di), Napoli, 2018, 83 ss.
[27] P. Manes, La nuova normativa Solvency II: corporate governance, approccio al rischio e mercato assicurativo europeo, cit., 27, la quale pone in rilievo che «fattori esterni – quali, ad esempio, cambiamenti delle condizioni economiche, del contesto giuridico di riferimento, del mercato assicurativo, degli aspetti tecnici che incidono sul rischio di sottoscrizione –, potrebbero avere un effetto negativo sul fabbisogno di solvibilità globale o sui fondi propri dell’impresa; pertanto, tali fattori devono essere identificati e tenuti in considerazione dall’impresa, unitamente alle misure da adottare per far fronte a condizioni economiche sfavorevoli».
[28] S. Dell’Atti e S. Sylos Labini, Il governo societario nelle imprese di assicurazione. Regolamentazione, proporzionalità e gestione del cambiamento, cit., 195.
[29] Così il Regolamento IVASS n. 32 del 2016, art. 6, comma 1.
[30] Cfr., Regolamento IVASS n. 32 del 2016, art. 6, comma 2.
[31] V. Regolamento IVASS n. 32 del 2016, art. 6, comma 4.
[32] C. Bernardino, Solvency II implementation – beyond compliance, Conferenza IVASS 2016, The lounch of Solvency II, Roma, 3 marzo 2016, in www.ivass.it, secondo il quale, l’ORSA non è uno strumento statico di valutazione dei rischi ma uno strumento dinamico.
[33] Cfr., sul punto, le considerazioni di A.J. McNeil, R. Frey e P. Embrechts, Quantitative Risk Management: Concepts, Technique and Tools, Princeton, 2015, 25 s.
[34] M. Siri, La centralità del governo societario nel sistema di Solvibilità II, cit., 71 ss.
[35] Lo puntualizza P. Manes, La nuova normativa Solvency II: corporate governance, approccio al rischio e mercato assicurativo europeo, cit., 275, la quale evidenzia che «l’ORSA rappresenta anche un’importante fonte di informazioni per le autorità di vigilanza, poiché le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a descrivere i processi che hanno adottato per soddisfare i requisiti stabiliti da Solvency II attraverso reporting richiesti dalla normativa. Nell’intento del legislatore, tale adempimento non rappresenta un mero esercizio stilistico di produzione di report o di compilazione di formulari ma richiede la cooperazione di tutte le strutture aziendali per la raccolta di informazioni a tutti i livelli di impresa».
[36] In questo senso, U. Cunial, Solvency II: le novità del Regolamento IVASS n. 32/2016 (ORSA), in dirittobancario.it.
[37] V. supra.
[38] L’art. 3, lett. b) del D.M. n. 18 del 2025 lo definisce come «sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma».
[39] Non dovrebbero quindi rientrare nella copertura obbligatoria i danni derivanti da piogge di particolare intensità, grandine, o venti particolarmente forti che determinino danni ai beni oggetto di copertura.
[40] Sul punto, v. le considerazioni di S. De Polis, L’assicurazione obbligatoria delle imprese per danni da catastrofi naturali, Relazione al Convegno di studi «L’assicurazione dei rischi catastrofali», La Sapienza Università di Roma, 12 febbraio 2025, in www.ivass.it, 5 ove evidenzia, in relazione all’evento «frana», che «è incluso nella copertura assicurativa l’evento che si manifesta in maniera “rapida”, ma non il movimento, scivolamento o distacco “graduale” di roccia, detrito o terra. Si tratta di una scelta richiesta dalla tecnica assicurativa che, come noto, si basa sul principio dell’aleatorietà dell’evento, ossia, che per assicurare un rischio deve esservi incertezza in merito al suo verificarsi; nello scivolamento o distacco graduale di roccia l’evento avverso non è più incerto in quanto è già parzialmente avvenuto anche se i suoi effetti non si sono ancora del tutto manifestati».
[41] In questo senso si esprime la l. n. 213 del 2024, all’art. 1, comma 101.
[42] Riflette sulla definizione di calamità G. Luchena, Aiuti pubblici e vincoli comunitari, Bari, 2006, 77 ss.
[43] V. art. 1, comma 1, lett. b del D.M. n. 18 del 2025.
[44] Ancora S. De Polis, L’assicurazione obbligatoria delle imprese per danni da catastrofi naturali, cit., 3.
[45] Si pensi all’attività di natura commerciale o della distribuzione.
[46] Si pensi alle imprese che effettuano attività di trasporti e logistica.
[47] S. De Polis, L’assicurazione obbligatoria delle imprese per danni da catastrofi naturali, cit., 3 ove precisa che «in questo caso i contratti assicurativi dovranno opportunamente disciplinare obiettivi, forme, modalità e beneficiari dei risarcimenti».
[48] In questo senso depone l’art. 1 bis, comma 2 del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modifiche dalla l. 9 dicembre 2024, n. 182 e l’art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 18 del 2025.
[49] Si pensi all’ipotesi di una vasta area interessata da un evento sismico di significativa entità che, colpendo l’intero tessuto economico del cratere sismico, non renda più potenzialmente profittevole mantenere l’attività di impresa in quel luogo.
[50] L’art. 1, comma 3 sexies del d.l. 31 marzo 2025, n. 39 modifica l’articolo 1 bis, comma 2, del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155.
[51] Ampiamente, sul punto, M. Mazzola, L’interesse nel contratto di assicurazione. Teoria e problemi del tipo, Napoli, 2025, p. 181 ss.
[52] La disposizione, coerentemente con la ricostruzione di tali polizze secondo lo schema dell’assicurazione in favore di terzi, fa salvo il privilegio di cui all’art. 1891, comma 4 c.c. per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per la somma pari al 40% dell’indennizzo dovuta a titolo di lucro cessante nel caso in cui il proprietario assicurato non intenda destinare la prestazione assicurativa al ripristino, rimpiazzo o ricostruzione dell’immobilizzazione danneggiato o distrutta dall’evento catastrofale.
[53] Non va trascurato che, nella ricostruzione proposta da parte del legislatore, il soggetto portatore del rischio è proprio il proprietario il quale, quindi, sarà portatore di un interesse prevalente rispetto a quello del contraente che, per l’appunto, contratta in favore di un terzo (il proprietario).
[54] Cfr., M. Frigessi di Rattalma, Verso un regime di assicurazione obbligatoria contro i danni da catastrofi naturali, cit. 29.
[55] Sia concesso il rinvio a G. Berti de Marinis, Responsabilità delle strutture sanitare e mezzi di gestione del rischio, in Actualidad juridica iberoamericana, 2023, 299.
[56] Lo è sicuramente in relazione alla determinazione del premio che varierà al variare del rischio al quale i beni oggetto di assicurazione sono esposti.
[57] Si rinvia, sul punto, a G. Berti de Marinis, Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, Napoli, 2019, passim e diffusamente, da ultimo, A. Davola, Eteronomia e contratti nei mercati finanziari, Bari, 2025.
[58] Nell’ambito dei contratti di assicurazione sono ormai numerosi gli interventi di natura etero-conformativa che avvengono tramite Decreti ministeriali su “delega”, ovviamente, di una disposizione di rango primario. Si vedano, ad esempio, il D.M. 22 settembre 2016 sulle polizze per l’r.c. professionale degli avvocati ed il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 che detta i requisiti minimi relativi alle polizze per r.c. medica. In generale, sulla possibilità di incidere tramite Decreti ministeriali sull’autonomia provata, v. G. Berti de Marinis, Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione, cit., 139 ss. e, con specifico riferimento alle polizze catastrofali, A. Davola, Eteronomia e contratti nei mercati finanziari, cit., 303 ss.
[59] G. Berti de Marinis, L’impresa di assicurazione e la distribuzione di prodotti assicurativi, in Comm. cod. civ. Cicu e Messineo, Milano, 2023, 58 ss. Si veda, pure, L. Velliscig, Come garantire i danneggiati. Considerazioni sul ruolo dell’assicurazione e dell’autoassicurazione, in Annuario dir. comp. st. legisl., 2019, 539 ss.; L. Gasparini, La disciplina dell’obbligo assicurativo, in San. pubbl. priv., 2023, 27 ss.; F. Onnis Cugia, Riflessioni sulla tanto attesa efficacia dei profili assicurativi della legge Gelli-Bianco, in Assicurazioni, 2024, 282 ss.
[60] V. l’art. 7 del D.M. n. 18 del 2025.
[61] Art. 6 del D.M. n. 18 del 2025. La disposizione menzionata riprende il disposto dell’art. 1, comma 104 della l. 213 del 2023.
[62] Si pensi al tema delle polizze parametriche, estraneo alla presente trattazione ma che emerge proprio in relazione alle assicurazioni avverso eventi atmosferici estremi, che sta generando un significativo dibattito dottrinale volto a ricostruire tale fattispecie ed indagarne la coerenza con le regole ed i principi generali che riguardano il contratto di assicurazione danni. Sul punto, senza pretesa di esaustività, v. R. Santagata, Polizze assicurative parametriche (o index based) e principio indennitario, in Riv. dir. civ., 2022, 134 ss.; E. Locascio Aliberti, Funzione indennitaria e irrilevanza del danno nelle polizze parametriche, in Riv. dir. impr., 2024, 577 ss.; G.P. Travaglino, Le polizze index based: nuovi rischi, riassicurazione e danni catastrofali, in Danno resp., 2024, 161 ss.
[63] In questo senso, v. l’art. 4, commi 1 e 2 del D.M. n. 18 del 2025. In dottrina, v. S. Cavaliere, Sostenibilità e assicurazione danni catastrofali, cit., 82 ss.
[64] Così l’art. 9, comma 1, lett. f) dello schema di decreto legge contenente il Codice degli incentivi.
[65] Si veda, sul punto, il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025 che individua una serie di incentivi preclusi alle imprese che non siano in linea con l’obbligo assicurativo relativo ai rischi catastrofali. Tale decreto, ovviamente, non esaurisce il ventaglio di tutti gli incentivi gestiti dal MIMIT né, tantomeno, quello degli incentivi gestiti da altri Ministeri. Il quadro risulta, dunque, ancora in corso di costruzione.
[66] P. Corrias, La risposta assicurativa ai danni catastrofali, cit., 1446, ove sostiene la natura non sanzionatoria di tale prescrizione evidenziando che «a differenza di ciò che vale per l’assicuratore, al quale sono erogate sanzioni pecuniarie in caso di rifiuto alla stipulazione, per le imprese commerciali tenute alla stipulazione non è stato introdotto un obbligo in senso proprio ma, viceversa, un mero onere. L’inosservanza del comportamento richiesto, infatti, implica unicamente mancati vantaggi, quali perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario ma non sanzioni».