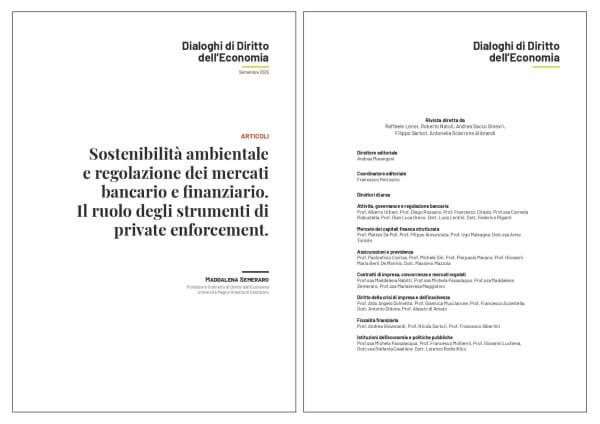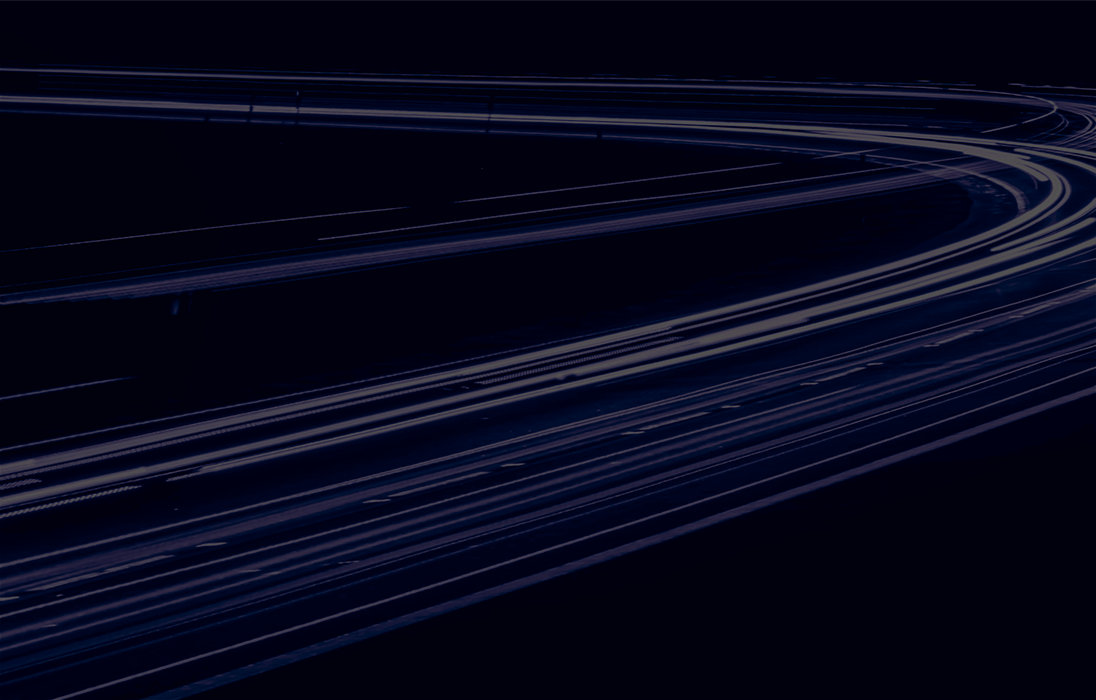[*] SOMMARIO: A fronte dell’attuale quadro normativo sulla sostenibilità ambientale nei mercati bancario e finanziario, interrogarsi sul ruolo del Diritto privato può rappresentare una prospettiva d’indagine utile per comprendere la portata sistematica dei nuovi provvedimenti e, in particolare, il loro impatto sulla classica relazione tra contratto e mercato. Da questo angolo visuale, vale soprattutto riflettere sul rapporto tra regolazione e rimedi; segnatamente, sull’impatto che la regolazione di tali mercati può avere sul rapporto contrattuale e, perciò, sul ruolo attribuibile agli strumenti di private enforcement rispetto a quelli di public enforcement.
ABSTRACT: Given the current regulatory framework on environmental sustainability in the banking and financial markets, questioning the role of private law can be a useful perspective for understanding the systematic scope of the new measures and, in particular, their impact on the classic relationship between contract and market. From this perspective, it is particularly worth reflecting on the relationship between regulation and remedies; specifically, on the impact that the regulation of these markets may have on contractual relationships and, therefore, on the role attributable to private enforcement instruments as opposed to public enforcement instruments.
1. Premesse.
Negli ultimi tempi il dibattito sulla sostenibilità ambientale dei modelli di produzione si è diffuso a tutti i livelli. In apice vi sono le questioni assai note della sorte dell’attuale forma di capitalismo, che è capitalismo finanziario, e della necessità di dirigersi verso un sistema economico “resiliente ai cambiamenti climatici e circolare” che, in una parola, assicuri la sostenibilità dell’attuale società del benessere. Se poi sia corretto stimare il benessere tenendo in considerazione non soltanto ordini di grandezza relativi alle attività economiche, ma anche inerenti alla qualità della vita, per definizione difficilmente monetizzabili, è altra faccenda[1]. Ed è peraltro faccenda non di oggi, ma fino a oggi relegata alle discussioni accademiche e a qualche iniziativa politica, che però non ha trovato decisa concretizzazione[2]. In particolare, vale menzionare il Rapporto Stiglitz del 2011, che auspicava un deciso cambio di prospettiva, spostando l’attenzione «da un sistema di misurazione “orientato alla produzione” ad uno focalizzato sul “benessere delle attuali e future generazioni”» [3].
Per ragioni ben note, che è inutile ricordare, l’approccio a questi temi è radicalmente cambiato nei tempi più recenti. I provvedimenti normativi di matrice europea affrontano in modo diretto la questione della sostenibilità ambientale, tentando di indirizzare le attività economiche verso modelli produttivi maggiormente virtuosi. L’obiettivo, declinato nel Piano di azione della Commissione Europea, è di «riorientare il processo di coordinamento macroeconomico del semestre europeo per integrarvi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile il fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’UE»[4]. La produzione regolamentare è alluvionale. Come pure moltissimi sono gli atti delle Autorità indipendenti volti a incidere direttamente sui sistema di governance degli operatori economici, almeno di quelli di maggiori dimensioni.
In premessa va subito detto che, declinati gli obiettivi di sostenibilità, l’attenzione del legislatore europeo si concentra sulla transizione, ossia sul percorso di mezzo tra il presente e un futuro reputato prossimo, caratterizzato dalla completa riconversione delle attività economiche talsì che concorrano alla costituzione di «una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse»[5].
È esattamente su questo piano che è assegnato un ruolo importante ai mercati bancari e finanziari, sul presupposto, da un lato, della centralità degli investimenti privati per procedere lungo la strada della conversione dei modelli di produzione e, dall’altro, del riconoscimento del forte impatto, sulle condotte degli operatori economici, di rigide politiche creditizie che mettano al centro i fattori di sostenibilità. In sintesi, le idee di fondo che muovono il legislatore europeo sembrano essere: stimolare il capitale privato verso investimenti finanziari ecosostenibili; al contempo, orientare le banche verso politiche creditizie che tengano sempre più conto dei fattori di sostenibilità e così incentivare le imprese a convertire i loro modelli di produzione.
L’approccio regolatorio si mostra parzialmente differente da quello cui il legislatore Europeo ci ha abituati[6]. Né avrebbe potuto essere diversamente considerato che la finalità prefissata non è assicurare il corretto funzionamento di un mercato concorrenziale. La finalità è invece incidere sull’organizzazione dell’attività di impresa: l’intervento regolatorio è destinato anzitutto a impattare su tale attività nel suo complesso, più che sulla singola transazione.
In tale quadro, interrogarsi sul ruolo del Diritto privato può rappresentare una prospettiva d’indagine utile per comprendere la portata sistematica dei nuovi provvedimenti normativi e, in particolare, il loro impatto sulla classica relazione tra contratto e mercato. Da questo angolo visuale, vale soprattutto riflettere sul rapporto tra regolazione e rimedi; segnatamente, sull’impatto che la regolazione di tali mercati può avere sul rapporto contrattuale e, perciò, sul ruolo attribuibile agli strumenti di private enforcement rispetto a quelli di public enforcement.
È bene anticipare che, su quest’ultimo piano, la maggiore rilevanza assunta – nella prospettiva del Regolatore – dalla dimensione dell’organizzazione dell’attività d’impresa rispetto a quella della contrattazione porta con sé alcune conseguenze di non poco momento in ordine alla scelta degli strumenti di enforcement, rendendo opportuna la combinazione tra la sanzione pubblicistica e il rimedio privatistico e, forse, la prevalenza della prima sul secondo. La realizzazione degli obiettivi di politica economia sembra cioè debba passare anzitutto per l’adozione di sanzioni irrogate dalle Autorità di Vigilanza. Affinché la transizione vada a buon fine e l’intervento sui mercati bancario e finanziario faccia da volano di questo cambiamento, pare necessaria insomma soprattutto una spinta non troppo gentile da parte del regolatore[7].
2. Il quadro normativo sulla sostenibilità ambientale nei mercati bancario e finanziario.
Considerata la copiosità degli interventi[8], è forse più utile tracciare le traiettorie di questa produzione normativa, tentando di distinguere tra mercato bancario e finanziario, per provare poi a stringere sugli specifici piani di intervento al fine di rendere più agevole il percorso che condurrà a fare qualche riflessione sulla incidenza di detta produzione sui contratti, dall’angolo visuale del private enforcement.
Brevemente, nel mercato bancario l’intervento più massiccio riguarda l’organizzazione interna dell’impresa: le banche sono tenute a formulare e attuare strategie aziendali e sistemi di governance e di gestione dei rischi climatici e ambientali. Devono dunque predisporre politiche di sostenibilità e devono monitorare le loro esposizioni, tenendo conto di quanto il rischio fisico e il rischio di transizione incidano sul rischio di credito, operativo, di mercato e di liquidità.
Ai rischi fisici e di transizione sono esposti tutti gli attori economici: dai partecipanti al mercato finanziario, alle imprese non finanziare, alle banche. Per queste ultime, il rischio fisico, non strettamente legato alla transizione ma agli effetti negativi del cambiamento climatico che l’attuale modello produttivo produce, è dato dall’impatto finanziario del deterioramento ambientale sulle imprese, conseguentemente esposte a danni materiali o a cali o a blocchi di produttività. Basti pensare, ad esempio, al caso di una garanzia immobiliare che gravi su immobili ubicati in luoghi a rischio alluvioni. Diverso è il rischio di transizione, che per gli istituti bancari si traduce nella perdita finanziaria cui può andare incontro l’impresa finanziata per il mutamento del ciclo produttivo e per il suo adeguamento ai criteri di sostenibilità, tale da incidere sulla capacità di restituire il prestito.
L’obiettivo è incentivare le banche a selezionare i propri clienti, inducendole a orientare il finanziamento verso imprese virtuose. Gli interventi hanno dunque una duplice direzione: da un lato, monitorare i crediti già in essere che espongono gli intermediari a un maggiore rischio (sia esso di credito, di mercato o reputazionale); dall’altro, implementare l’erogazione di finanziamenti o finalizzati alla realizzazione di progetti green o a imprese che hanno un rating di sostenibilità buono.
Ovviamente, l’adozione di date politiche creditizie è destinata a impattare sulla fase di accesso al credito e, in particolare, sulla valutazione del merito creditizio. I fattori ESG infatti entrano nella valutazione del merito di credito dei clienti, diventando determinanti su questo piano[9].
Quanto sinteticamente rappresentato conferma che per ciò che riguarda il mercato bancario, il piano di incidenza di questa copiosa normativa è l’organizzazione dell’attività di impresa.
Nel mercato finanziario l’approccio del legislatore europeo è in parte differente. L’intervento normativo e regolatorio infatti se, da un lato, continua a riguardare i profili di governance e di gestione dei rischi dell’impresa finanziaria e la product governance (ossia il governo del prodotto), dall’altro, impatta più direttamente anche sulle condotte che gli intermediari devono tenere nei confronti dei loro clienti.
Il provvedimento principe in questo mercato è il Regolamento Tassonomia. Con esso si definiscono gli obiettivi di sostenibilità e i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile al fine di stabilire il grado di sostenibilità di un investimento. La Commissione ha ripetuto che il regolamento, come gli atti delegati, sono provvedimenti in divenire che verranno arricchiti con l’inserimento di nuove attività non ancora prese in considerazione e che la mancata inclusione di alcune non implica una automatica valutazione delle stesse in termini di insostenibilità[10].
Gli obiettivi indicati dal Regolamento sono: a) la mitigazione dei cambiamenti climatici; b) l’adattamento ai cambiamenti climatici; c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; d) la transizione verso un’economia circolare; e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Tra i criteri sulla base dei quali valutare se una attività sia in linea con la tassonomia ci sono poi: a) il contributo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali individuati; b) il non arrecare un danno significativo ai medesimi obiettivi e c) lo svolgimento dell’attività in conformità ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione. Il Regolamento specifica sia cosa si debba intendere per contributo sostanziale in relazione a ciascun obiettivo di sostenibilità, sia la portata del riferimento al danno significativo prodotto da una attività economica in relazione a ciascun obiettivo. L’individuazione dei criteri di vaglio tecnico alla luce dei quali valutare il contributo sostanziale e l’assenza di danno significativo è rimessa ad atti delegati.
Con il Regolamento Tassonomia, l’intenzione è introdurre un concetto comune di investimento sostenibile, a partire dalla classificazione dell’attività economica sottostante, al fine di implementare la trasparenza dei mercati finanziari circa le informazioni fornite agli investitori finali sulla reale qualità in termini di sostenibilità del prodotto acquistato. Il provvedimento normativo va infatti letto unitamente al Regolamento del 2019 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
Quest’ultimo impone una serie di obblighi ai partecipanti al mercato, rendendo rilevanti i fattori di sostenibilità su più livelli. In primo luogo, obbliga gli intermediari a informare i loro clienti su come il «rischio di sostenibilità»[11] venga preso in considerazione nelle politiche di investimento. Che significa altresì rendere noto sia di avere tenuto conto degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sia di non averlo fatto. In seconda battuta, impone di includere nelle politiche di remunerazione informazioni sulla loro stessa coerenza con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. Prescrive di inserire nelle informazioni precontrattuali le caratteristiche di sostenibilità del prodotto di investimento, con particolare riguardo al relativo impatto, positivo o negativo, sui fattori di sostenibilità. Infine, nel contesto della profilazione, viene dato rilievo alla propensione del cliente a effettuare investimenti sostenibili, con conseguenze a cascata sotto il profilo della delimitazione dell’oggetto del giudizio di adeguatezza che gli intermediari devono effettuare nei servizi di consulenza e di gestione dei portafogli prima di dare corso all’investimento.
Rispetto al mercato finanziario si conferma la rilevanza della dimensione organizzativa dell’attività d’impresa, particolarmente incisa dalla regolazione. Accanto a essa, viene tuttavia considerazione anche la relazione orizzontale tra cliente e intermediario. Il piano di incidenza della disciplina sulla sostenibilità diventa perciò pure il rapporto contrattuale.
Con specifico riferimento a quest’ultimo, la tecnica di intervento è assai nota e si sostanzia nella moltiplicazione degli obblighi di comunicazione e di informazione che gli intermediari devono adempiere nei confronti dei loro clienti[12]. L’informazione dovrebbe rafforzare la trasparenza del mercato e aiutare gli investitori a orientarsi. Va nondimeno segnalato che, in un recente Parere di EBA, EIOPA ed ESMA di giugno 2024 – parere che fa il punto sui risultati applicativi proprio del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari[13] – si mette in guardia la Commissione dall’eccesso di informazioni date agli investitori, proponendo di optare o per una suddivisione dei prodotti finanziari in categorie o per l’adozione di un indicatore che sia in grado di misurare la sostenibilità (ambientale o anche sociale) dei diversi prodotti di investimento.
3. Relazione tra interesse generale regolatorio e tutela del cliente: le ragioni della utilità del rimedio privatistico sul piano del corretto funzionamento del mercato.
Questo è per sommi capi il disegno del legislatore europeo. Il ruolo svolto dal private enforcement al suo interno dipende da quanto le discipline sulla sostenibilità – che riguardano in prevalenza l’attività, salvo ciò che si è detto con riferimento agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari – possano assumere rilevanza nella prospettiva del rapporto tra intermediario e cliente. Rilevanza, che a sua volta dipende da una serie di fattori: primo fra tutti la natura degli interessi generali da esse veicolati.
Guardare alla natura di tali interessi significa anzitutto interrogarsi sulla loro possibile incidenza sul contratto. Il fenomeno dell’incidenza dell’interesse generale sul regolamento contrattuale è ben noto al codice civile e non è certo estraneo ai contratti dei mercati regolati. In questi mercati, anzi, l’iper-regolamentazione ha portato nel tempo a un fitto intreccio di norme pubblicistiche e privatistiche, al quale è seguito un aumento delle ipotesi in cui la disciplina della singola contrattazione è stata influenzata dall’esigenza di attuare obiettivi regolatori.
Su questo piano, la peculiarità dei mercati bancario e finanziario sta in ciò, che l’incidenza dell’interesse generale (regolatorio) sul contratto – la portata della quale consiste nell’alterare la classica dinamica del rapporto, di solito orientata alla sua giustizia, con importanti conseguenze sull’esito del bilanciamento degli interessi dei contraenti in caso di conflitto – si manifesta, oltre che con la classica previsione di requisiti specifici in relazione ai soggetti, all’oggetto o alla causa, anche con la imposizioni di obblighi di condotta in capo al contraente professionale o di obblighi di organizzazione che, pur inerendo alla dimensione della attività di impresa, si riverberano sul contenuto del regolamento.
Gli esempi a questo riguardo sono molti.
Basti pensare alla trasparenza bancaria. Ai diversi obiettivi regolatori che negli anni si sono succeduti sono corrisposti approcci differenti alla regolamentazione del rapporto. Quando l’obiettivo consisteva principalmente nella implementazione della concorrenza, la trasparenza veniva tutta centrata sull’obbligo di informazione[14]. Quando il regolatore ha avuto come finalità principale la responsabilizzazione sia delle banche, sia dei clienti dall’angolo visuale, rispettivamente, della concessione e della assunzione del prestito, in funzione dell’interesse alla stabilità del sistema, strategica è diventata l’attribuzione di rilevanza formale nella relazione orizzontale agli obblighi prima reputati afferenti alla sola dimensione organizzativa dell’attività dell’intermediario[15] (è il caso dell’obbligo di valutazione del merito di credito, per come disciplinato nella Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali).
Al medesimo collegamento tra regolazione e contratto si è assistito nel mercato dei servizi di pagamento[16]. Nel tentativo di rafforzare la fiducia degli utenti in questi servizi, al fine di implementare l’uso di strumenti di pagamento elettronici, la PSD2 ha introdotto l’obbligo di dotarsi di modalità di autenticazione forte del cliente. Tale obbligo inerisce senza dubbio al piano della organizzazione dell’attività d’impresa. Esso, però, entra anche nel contenuto del contratto, dovendo il prestatore di servizi di pagamento adempierlo nei confronti del cliente in ragione di quanto disposto dall’art. 10 bis del d.lgs., n. 11 del 2010. Le sue modalità di attuazione sono specificate in alcuni atti regolatori; queste stesse modalità diventano un metro per valutare la condotta dell’intermediario, in termini di diligenza, nell’ambito del rapporto con la controparte[17].
Ebbene, rispetto a queste discipline l’osservazione delle dinamiche dei rapporti tra banca e cliente conferma il ruolo decisivo svolto dagli strumenti di private enforcement. Anche il rimedio privatistico infatti ha concorso a orientare le condotte degli operatori economici nella direzione della adozione di buone prassi.
Sulle ragioni di questo successo, in primo piano sembra stare la particolare relazione che in passato si è venuta a instaurare tra interesse generale veicolato dalle norme impositive di obblighi – o più strettamente attinenti allo svolgimento dell’attività o rilevanti nella relazione orizzontale – e interesse del cliente. L’interesse generale di volta in volta veicolato da dette discipline (ora alla instaurazione di un mercato concorrenziale, ora alla tutela della stabilità del sistema finanziario) ha quasi sempre incrociato l’interesse del cliente, nel senso che la tutela del secondo ha spesso rappresentato un passaggio irrinunciabile per l’attuazione del primo.
Non meno importante, tuttavia, è stata anche la scelta della tipologia di rimedio da applicare. Su questo piano, in apice sta la stessa definizione di private enforcement.
Sugli strumenti che in concreto si possono definire di private enforcement si può discutere[18]. Possono essere considerati tali soltanto i rimedi che seguono alla violazione di obblighi organizzativi imposti all’impresa, ma rilevanti pure ai fini della valutazione dell’adempimento della prestazione contrattuale; oppure tutti i rimedi che costituiscono una reazione alle condotte in contrasto con norme che hanno come finalità, anche indiretta, di impattare sul mercato di riferimento. Le quali norme nei mercati regolati – va pure ricordato – sono la maggior parte.
La questione definitoria appassiona poco. Di più profondo v’è però che l’approccio volto soltanto a escludere o includere prova troppo o troppo poco, rischiando di non cogliere le specificità della disciplina sul contratto nei mercati bancario e finanziario, dal lato del trattamento rimediale. Per un verso, riconoscere soltanto nei rimedi che seguono alla violazione di atti regolatori la natura di strumenti di private enforcement può condurre a ipostatizzare soltanto parte di una realtà che è eterogenea e che in questa eterogeneità trova il suo punto di forza. Per altro verso, limitarsi a identificare tali strumenti con i rimedi collegati alla violazione di qualunque regola posta a presidio della contrattazione bancaria o finanziaria, comunque rischia di obnubilare i tratti qualificanti di questa eterogeneità, in particolare rendendo più complicato distinguere tra fattispecie in ragione degli interessi rilevanti in gioco.
Meglio sembra essere invece partire dalla consapevolezza che l’utilità dell’utilizzo del sintagma private enforcement nei mercati regolati è apprezzabile anzitutto sul piano interpretativo, poiché è soltanto su di esso che è possibile cogliere la specifica attitudine del rimedio privatistico a concorrere alla attuazione degli obiettivi regolatori. Oltretutto, nei mercati bancario e finanziario i maggiori problemi nella selezione della disciplina applicabile in punto di tipologia del rimedio si sono posti e continuano a porsi nelle ipotesi – che sono la maggioranza – in cui la disposizione nulla preveda per il caso della sua violazione. In dette ipotesi, il dibattito è stato interamente centrato sull’utilizzo del rimedio invalidante, tornando perciò in auge le note costruzioni sulla categoria della nullità virtuale.
Spostato dunque il piano della riflessione, ciò che in prima battuta vale a distinguere è l’attitudine del rimedio a costituire una reazione calibrata sulla migliore soluzione del conflitto di interessi sorto tra i contraenti nella prospettiva del corretto funzionamento del mercato. Non secondaria ai medesimi fini è poi la seguente considerazione: che, se è vero che l’obiettivo finale che il legislatore europeo intende raggiungere nei mercati regolati con la disciplina del contratto è sempre l’efficienza del mercato, vero è anche che questa efficienza, nella prospettiva dello stesso legislatore, passa per la tutela del cliente dell’impresa. Detto più chiaramente, passa per la necessità che il rischio di condotte opportunistiche assunte dagli operatori economici non ricada sul fruitore finale del bene o del servizio. È, in definitiva, una efficienza qualitativamente qualificata.
Il corollario più significativo sotto il profilo del trattamento rimediale è che nei mercati regolati non vale l’alternativa secca tra nullità assolute, riferibili all’ordine pubblico di direzione, e nullità relative, ascrivibili all’ordine pubblico di protezione per come ci è stata consegnata dalla tradizione, ma anche da alcune elaborazioni teoriche in tema di nullità di protezione[19]. Le ragioni che giustificano il ricorso al rimedio invalidante possono ben essere ascrivibili all’ordine pubblico di direzione e, nondimeno, richiedere che ai fini della attuazione dell’interesse generale (quasi sempre regolatorio) venga comunque tutelata la posizione del cliente. A fare la differenza tra l’una ipotesi e l’altra è la disponibilità della tutela, che resta in capo al cliente soltanto qualora alla ratio della previsione violata resti estranea ogni valutazione in ordine al complessivo funzionamento del mercato.
Pertanto, qualora l’interesse che giustifica l’assunzione dell’obbligo in capo all’impresa sia riconducibile all’ordine pubblico c.d. di protezione, il rimedio previsto per l’ipotesi di sua violazione tenderà a ripristinare l’equilibrio del rapporto violato. Ed è questo il classico caso delle nullità di protezione parziali e a legittimazione relativa. Qualora, invece, l’interesse generale veicolato afferisca all’ordine pubblico c.d. di direzione, il rimedio, anziché ripristinare un equilibrio violato, tenderà a impattare sugli interessi in gioco in modo da disincentivare condotte contrastanti con la regola, rendendole poco convenienti. Non è detto che in questo secondo caso, il regime applicabile debba essere quello proprio delle nullità assolute. Ben potrebbe essere che la legittimazione resti relativa e che la nullità resti parziale, al fine di assicurare l’efficienza (come detto, qualitativamente qualificata) del mercato, ma che la disponibilità dello stesso rimedio sia sottratta al cliente, considerata la natura dell’interesse generale sottostante[20]. Resterebbe perciò al giudice il potere di rilevare d’ufficio la nullità, nel silenzio della parte a vantaggio della quale la stessa deve operare.
L’art. 127 TUB pare confermare questo approccio ricostruttivo, nel disporre che «le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice». Si potrebbe reputare che l’introduzione del comma 2 del menzionato articolo abbia definitivamente chiarito che le nullità previste dal testo unico bancario siano tutte nullità di protezione. Sembra invece che la reale portata della norma sia un’altra: chiarire, in via definitiva certo, che la applicazione della nullità derivante dalla violazione di una regole di trasparenza non può mai risolversi in un danno per il cliente, nel senso che il rischio delle conseguenze negative proprie della condotta opportunistica dell’operatore economico deve restare confinato alla sua sfera giuridica[21].
Quanto appena detto con riguardo ai contratti del mercato bancario, vale, almeno in parte, anche con riferimento ai contratti del mercato finanziario[22]. In particolare, l’incrocio appena delineato tra disciplina del mercato e disciplina del contratto ha sicuramente cominciato a funzionare dopo la crisi degli anni duemila anche in questo mercato, quando cioè è mutato l’approccio regolatorio e agli obblighi di informazione sono stati affiancati anche obblighi direttamente incidenti sulla fase di organizzazione della attività, che pure hanno di riflesso inciso sul contenuto del rapporto contrattuale. Tipico è il caso della disciplina sulla product governance.
4. Sostenibilità ambientale e mercato bancario. Interessi generali veicolati dalle discipline sulla sostenibilità. Loro limitata rilevanza sul contratto. Residualità degli strumenti di private enforcement.
Interrogarsi sulla natura degli interessi generali veicolati dalle discipline sulla sostenibilità ambientale significa dunque soprattutto domandarsi se detti interessi siano in grado sia di rilevare in via autonoma rispetto ai classici interessi generali che muovono il legislatore europeo e le Autorità regolatorie sul piano della regolazione del mercato, sia di incrociare l’interesse del cliente, rendendo perciò necessario passare per la sua tutela ai fini della relativa attuazione.
Il sintagma sostenibilità ambientale rinvia a una serie di valori che si traducono in altrettanti interessi generali (al clima, all’ambiente, alla biodiversità, al paesaggio, etc.). Tutti valori, peraltro, oramai entrati, se dubbi ci fossero mai stati, in Costituzione. Non è importante ai fini del presente discorso qualificare la sostenibilità ambientale nell’alternativa tra il principio o la clausola generale. Di là da ogni tentativo di qualificazione infatti, guardando alla regolamentazione in materia bancaria e finanziaria, tale sintagma, in detto ristretto ambito, sembra avere la valenza di formula riassuntiva di una disciplina. D’altro canto, la stessa prospettazione della sostenibilità ambientale come valore in sé e, dunque, come principio, sembra spostare ben poco sul piano dell’impatto di questi nuovi provvedimenti sul contratto bancario e finanziario. Che poi a monte sia possibile rintracciare, a seguito della riforma della Costituzione, il diverso principio costituzionale di sviluppo sostenibile è altra questione. Rispetto alla quale, va nondimeno precisato che anche lo sviluppo sostenibile chiama in campo più valori spesso in concorso tra loro.
Ciò che invece rileva sul piano della specificazione degli interessi generali veicolati dalle discipline sulla sostenibilità in ambito bancario e finanziario è che essi sono tendenzialmente esogeni rispetto ai menzionati mercati. Preliminare è dunque comprendere se, e nel qual caso come, le discipline evocate riescano a introitarli al loro interno, rendendoli endogeni.
Sul mercato bancario si è detto che il principale impatto delle riforme è anzitutto apprezzabile sul piano dell’attività d’impresa. La tecnica regolatoria adottata consiste nel rendere rilevanti nella valutazione dei requisiti prudenziali delle banche i rischi fisico e di transizione, integrandoli nei tradizionali rischi di credito, di mercato, di liquidità e reputazionale. Dalla lettura dei molti documenti pubblicati negli ultimi anni (in primis le linee guida della BCE e le linee guida dell’EBA sul monitaroggio e la concessione del credito), il quadro che ne risulta è caratterizzato da forti limitazioni all’autonomia organizzativa delle banche, le quali, all’atto della scelta sul se concedere il credito, devono tenere conto anche di tali ulteriori rischi, con importanti riflessi sulle condizioni economiche imposte ai clienti, destinate a mutare in ragione della finalizzazione del credito e delle qualità dell’impresa che si finanzia.
Guardando al complesso della normativa, dunque, ciò che si può in prima battuta constatare è che gli interessi generali veicolati dalle discipline sulla sostenibilità non acquistano rilevanza autonoma rispetto al classico interesse alla stabilità bancaria, esaurendo il loro rilievo, almeno per ora, nella necessità di assicurare detta stabilità. Dagli atti delle Autorità regolatorie (BCE ed EBA) risulta evidente che i rischi di sostenibilità vengono in definitiva presi in considerazione ai fini della valutazione della sana e prudente gestione[23].
Pensando proprio alla massiccia incidenza di tale regolamentazione sul profilo organizzativo, è chiaro che affinché le linee di intervento delle Autorità si traducano in cambiamenti concretamente orientati alla adozione di un modello di governance ispirato dai fattori di sostenibilità è necessario che a seguito di questa prima fase di adeguamento delle strutture, sia introdotto anzitutto un efficace sistema di public enforcement. Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando le iniziative provenienti dal mondo bancario. Queste iniziative, tuttavia, non sembrano bastare ad assicurare il reale compimento della transizione. Ove la mole di documenti delle Autorità regolatorie non fosse accompagnata da un adeguato apparato di sanzioni pubbliche è attuale il rischio di depotenziarne l’impatto sull’economia reale nel lungo periodo.
Gli strumenti più adatti per stimolare una completa revisione delle politiche creditizie vanno pertanto costruiti seguendo la logica degli incentivi e disincentivi. In questa direzione si sta riflettendo se dare un peso ai rischi fisico e di transizione nell’ambito della valutazione dei requisiti patrimoniali.
Consequenziale è il ruolo ancillare che può essere assegnato agli strumenti di private enforcement. Di diverso rispetto al passato c’è infatti che l’obiettivo regolatorio, consistente nell’orientare le condotte delle banche a tenere conto dei rischi di sostenibilità nell’esercizio della loro attività di impresa, difficilmente passa per la tutela dell’interesse del cliente.
A tale proposito, possono bastare un paio di esempi.
Si è già detto che le più evidenti ricadute di questa impalcatura regolatoria si hanno sulla fase di valutazione del merito creditizio. La valutazione del merito di credito rileva sul piano della attività bancaria, ma può avere una sua rilevanza anche sul piano del rapporto tra banca e cliente. Sicuramente ce l’ha con riferimento ai rapporti di credito (immobiliare e non) concessi ai consumatori, al preciso scopo di dare attuazione al principio del credito responsabile, pure in un ottica di tutela del cliente.
Ebbene, sul merito di credito l’EBA afferma che nella valutazione preliminare alla concessione del finanziamento (chiaramente all’impresa, ma può essere anche al consumatore ove si tratti di un mutuo immobiliare), bisogna tenere conto del rischio fisico e del rischio di transizione ai quali la concessione può esporre. Dunque, pensando alla ipotesi di richiesta di finanziamento per ristrutturare un immobile che si trova in un territorio fragile, soggetto al pericolo di catastrofi alluvionali, la banca dovrebbe effettuare una valutazione complessa sulla concessione del credito, che prenda in considerazione anche i menzionati profili.
Ciò che viene spontaneo osservare con riferimento all’ipotetico ruolo degli strumenti di private enforcement è anzitutto che la logica sottostante alla vigente disciplina sul merito di credito nel finanziamento ai consumatori[24] è del tutto estranea alla fattispecie appena rappresentata. Rispetto a essa infatti, non si tratta di tutelare il cliente onde evitare che assuma un finanziamento in modo irresponsabile. L’interesse generale che muove a dare rilevanza al rischio fisico e al rischio di transizione trasporta gli interessi rilevanti nella fattispecie su un piano diverso. In un contesto nel quale si tratta di fare fronte a catastrofi naturali che si verificano sempre più spesso e in cui, per assicurare la stabilità finanziaria del sistema, diventano necessari strumenti come le polizze obbligatorie, gli indennizzi degli Stati o si diffondono strumenti finanziari come i cat bond, è evidente che si è su un terreno al quale la logica del private enforcement è del tutto estranea.
Il ragionamento è in parte diverso ove si pensi alla ipotesi di richiesta di un finanziamento da parte di una impresa c.d. brown. Ma la conclusione sul ruolo del private enforcement sembra la medesima.
Rispetto a questa ipotesi, de iure condendo, si potrebbe pensare a una norma che fa divieto alla banca di concedere il finanziamento ogni qual volta non sia destinato a investimenti sostenibili. Ove una tale norma fosse davvero inserita nel TUB, la sanzione non potrebbe che essere la nullità assoluta, poiché il divieto starebbe a esprimere l’interesse dell’ordinamento a che tale genere di finanziamenti non abbia a concludersi. All’attuazione dell’obiettivo regolatorio resterebbe in definitiva estranea ogni valutazione in ordine alla necessità di tutelare il cliente, ossia l’impresa brown. Un tale rimedio tuttavia è del tutto privo del carattere di deterrenza nei confronti dell’operatore bancario e rischia di rivelarsi inefficiente nella prospettiva del corretto funzionamento del mercato.
In alternativa, si potrebbe prospettare – di nuovo de iure condendo – la previsione mirata della nullità della clausola sui costi del finanziamento. Il risultato sarebbe di fare gravare i costi della violazione soltanto sull’intermediario, con un effetto premiante per l’impresa, senza però che le relative conseguenze vengano rimosse. Una soluzione, che in prospettiva di sistema, suscita non poche perplessità.
A quanto detto va pure aggiunto però che riconoscere la residualità degli strumenti di private enforcement nell’attuale disegno del legislatore europeo non significa che il contratto bancario sia del tutto insensibile alle disciplina sulla sostenibilità. Significa soltanto che la via di accesso degli interessi generali espressi dal sintagma sostenibilità ambientale difficilmente, almeno allo stato, sono gli atti di regolazione. Può esserlo, invece, la stessa autonomia negoziale, la quale può dare rilevanza a questi interessi attraverso la previsione o di clausole di sostenibilità che contemplino, ad esempio, variazioni di tassi di interesse in relazione al raggiungimento di obiettivi fissati a monte o della diretta destinazione delle somme prese a mutuo alla loro realizzazione.
Ma di nuovo, viene da interrogarsi sulla ragione per la quale gli intermediari dovrebbero utilizzare queste clausole o funzionalizzare il contratto. Forse, anche perché in molti casi a incentivarli c’è l’intervento dello Stato. Sono state già sperimentate, peraltro, le garanzie pubbliche per l’attuazione di programmi di transizione.
5. Segue. Il mercato finanziario. Rilevanza dell’interesse a effettuare un investimento sostenibile. Riflessi sul ruolo del private enforcement.
Il ragionamento va articolato diversamente per quanto riguarda il mercato finanziario.
In questo mercato l’obiettivo regolatorio – si è detto – è incanalare gli investimenti privati verso strumenti sostenibili. A tal fine, sia la disciplina primaria, sia gli atti regolatori agiscono su due piani. Accanto a quello dell’attività di impresa, oggetto di specifica attenzione è anche il contratto. Nella prospettiva del legislatore europeo, infatti, l’investitore ha un ruolo attivo. Il raggiungimento dell’obiettivo regolatorio passa anche per la sua tutela; nella specie, per il riconoscimento della rilevanza giuridica del suo interesse a effettuare un investimento sostenibile. Di questo interesse l’ordinamento si fa carico, predisponendo una serie di misure che ne garantiscano la migliore attuazione.
Si è già menzionato l’obbligo di tenere in considerazione i fattori di sostenibilità nella fase di produzione, gestione e distribuzione del prodotto finanziario. In questa direzione va la Direttiva 2021/1269, che impone agli Stati membri di adottare provvedimenti affinché le imprese di investimento identifichino «a un livello sufficientemente granulare il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario» e specifichino «il/i tipo/i di cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, sono compatibili con lo strumento finanziario».
Ci sono poi gli obblighi di informazione, attivi e passivi, sulle caratteristiche di sostenibilità del prodotto di investimento. Infine, uno spazio ai fattori di sostenibilità è riservato nell’ambito delle valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza. Le due valutazioni, seppure con portata differente, sono prodromiche alla esecuzione dell’ordine da parte dell’intermediario. Classicamente dirette ad accertare la corrispondenza tra il profilo di rischio dell’investitore e la tipologia di investimento, con le ultime modifiche si arricchiscono di un nuovo elemento di giudizio, dato dalle inclinazioni del cliente a effettuare un investimento sostenibile[25].
Evidente è dunque l’impatto di queste discipline sul rapporto di investimento. Esse, in particolare, consentono di reputare particolarmente qualificato, nella specie dal lato qualitativo, l’oggetto del contratto. Sebbene non si sia di fronte a una vera e propria ipotesi di incidenza di un interesse generale su uno degli elementi essenziali del contratto, sembra nondimeno che il carattere della sostenibilità, alla cui emersione l’interesse regolatorio tende, qualifichi, cioè penetri particolarmente l’oggetto. Con la conseguenza che dovrebbe discorrersi di inadempimento, qualora il cliente abbia interesse ad acquistare uno strumento finanziario sostenibile e l’intermediario non offra uno strumento in linea con le sue aspirazioni.
Pure a fronte di tale rinnovato quadro normativo, tuttavia, il ruolo degli strumenti di private enforcement pare destinato a rimanere recessivo rispetto a quello che potrebbero svolgere gli strumenti di pubblic enforcement. Le ragioni sono diverse. Le principali sono la non necessaria corrispondenza tra qualità (sostenibile) e redditività dello strumento finanziario; ancora, la difficoltà di rendere autonoma la valutazione sulla qualità rispetto a quella sulla redditività.
In via preliminare, va detto che il sistema di tutele è costruito diversamente nel TUB e nel TUF. Mentre nel primo, molte norme imperative, pure quando impositive di obblighi di condotta, esprimono interessi generali afferenti all’ordine pubblico di direzione direttamente collegabili alle ragioni del mercato, nel secondo, la maggioranza delle previsioni esprime interessi afferenti all’ordine pubblico di protezione. Di conseguenza, nel Testo unico bancario sono frequenti le ipotesi in cui è la stessa disposizione normativa a indicare il rimedio applicabile per il caso della sua violazione, costruendo altresì la reazione in una logica di deterrenza. Nel Testo unico finanziario, al contrario, quasi mai il corpo normativo prevede il rimedio. L’individuazione della reazione alla violazione delle regole, per lo più di condotta e ispirate – si ripete – all’ordine pubblico di protezione, è perciò rimessa all’interprete, finendo così con il dipendere dal modo nel quale è costruito il potere negoziale dell’intermediario.
In altre parole, nella parte del Testo unico finanziario dedicata alla relazione tra intermediario e cliente – e nel Regolamento Consob, che ne specifica i precetti – la disciplina del rapporto è in prevalenza orientata dall’interesse generale a che l’intermediario curi nel miglior modo l’interesse dell’investitore. Su questo piano, la disposizione cardine è contenuta nell’art. 21 Tuf, il quale dispone che «nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati». Vero è che la tutela del cliente resta strumentale al perseguimento dell’obiettivo regolatorio; vero è anche però che l’interesse generale che spinge verso di esso spesso si mantiene estraneo alla ratio delle previsioni impositive degli obblighi di condotta, non impattando sul bilanciamento degli interessi nel rapporto contrattuale.
Corollario di quanto osservato è che nei mercati finanziari, gli strumenti di private enforcement svolgono un ruolo importante di ausilio nel raggiungimento degli scopi di regolazione soprattutto quando sono utilizzati per sanzionare, nell’ambito della relazione tra intermediario e cliente, la violazione di obblighi di organizzazione inerenti all’attività di impresa. È il caso, ad esempio, degli obblighi imposti dalla disciplina sulla product governance la cui violazione, a date condizioni, è stata riconosciuta rilevante anche nel rapporto contrattuale, conducendo alla qualificazione della condotta dell’intermediario in termini di inadempimento.
Nelle altre ipotesi – ossia quando a essere violata è una disposizione direttamente riferibile al rapporto – il rimedio privatistico, quasi sempre nella logica della giustizia del rapporto, viene utilizzato o per sanzionare un comportamento abusivo dell’intermediario (come accaduto con la nullità per difetto di causa cui è ricorsa la giurisprudenza in tema di interest rate swap)[26] o per ristorare un danno subito dal cliente in ipotesi di violazione di obblighi di informazione (come è stato con il risarcimento del danno e la risoluzione del singolo contratto di investimento; rimedi ai quali ha fatto appello la stessa giurisprudenza quando ha reputato che la violazione si fosse tradotta in un adempimento contrattuale rilevante[27]).
Sulla costruzione di questi rimedi, il diverso peso attribuito al principio costituzionale di tutela del risparmio è stato condizionante. Ciò, laddove il riflesso delle differenti scelte interpretative fatte è apprezzabile anzitutto sul piano della ampiezza/estensione delle tutele più che su quello della relativa ispirazione. In particolare, soltanto chi ha letto l’art. 21 Tuf unitamente all’art. 47 Cost., abbandonando la classica costruzione del potere di autonomia che fa perno sulla dicotomia tra libertà e autorità nella logica dell’art. 41 Cost., ha qualificato la posizione dell’intermediario in termini di ufficio di diritto privato, giungendo ad attribuirgli, in quanto titolare di un potere/dovere, il dovere generale di cooperare con il cliente, a prescindere dalle qualità soggettive di quest’ultimo e dalla tipologia di servizio, ai fini della cura del suo stesso interesse[28].
L’emersione dell’interesse del cliente a effettuare un investimento sostenibile, la cui tutela nella prospettiva del regolatore è strumentale a orientare i capitali privati verso imprese c.dd. green, sembra spostare ben poco rispetto al quadro appena delineato, confermando il ruolo ancillare degli strumenti di private enforcement. Considerate la centralità nell’attuale architettura normativa della tutela del cliente, che sottende l’interesse generale alla tutela del risparmio, e la relativa posizione di strumentalità rispetto all’obiettivo regolatorio della stabilità del sistema finanziario, diventa arduo, con gli strumenti di private enforcement a disposizione, comporre gli interesse del singolo investitore a effettuare un investimento sostenibile e al contempo redditizio[29].
Supponiamo che l’intermediario offra al cliente un prodotto che non è in linea con le sue preferenze di sostenibilità. Fermato l’obbligo di cura gravante sul primo, isolare l’interesse dello stesso cliente a investire i propri danari in uno strumento finanziario qualitativamente connotato dovrebbe portare a qualificare la condotta dell’intermediario o in termini di abuso o di eccesso, così ricavando la nullità o l’inefficacia dell’atto di investimento[30], oppure alla stregua di un inadempimento che potrebbe giustificare la risoluzione del contratto di investimento[31]. Tutto questo, pure quando l’operazione sia stata redditizia.
Sia la nullità, sia la risoluzione rappresentano però soluzioni poco efficiente per il mercato, che potrebbero andare anche a detrimento dello stesso interesse del cliente, a meno che non si ipotizzi una nullità azionabile a suo esclusivo interesse, la quale tuttavia, a sua volta, potrebbe esporre al rischio di comportamenti opportunistici. L’unica opzione disponibile resta in definitiva l’obbligazione risarcitoria, quantificabile in ragione della funzione che le è propria, la quale, al netto di futuri interventi normativi, è funzione soltanto compensativa.
6. Conclusioni.
Sul piano della effettività delle discipline sulla sostenibilità nei mercati bancario e finanziario, gli strumenti di private enforcement svolgono, dunque, un ruolo residuale.
Un’ulteriore conferma si può forse trovare nella Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (c.d. Direttiva due diligence). È noto che la sua entrata in vigore è stata salutata con grande euforia nella convinzione della relativa capacità di impattare, funditus, sulla sistemazione del diritto societario. Questa Direttiva infatti impone obblighi specifici alle imprese, volti a evitare o ridurre gli eventuali impatti negativi derivanti dalla loro attività, da quella delle società controllate e dei partner commerciali (diretti o indiretti) sull’ambiente e sui diritti umani. Incide, nella sostanza, sulla c.d. catena di valore.
Senza considerare la proposta di modifica della Commissione europea attualmente pendente e contenuta nel c.d. pacchetto omnibus, che ne alleggerisce in modo assai significativo la portata, il ruolo secondario di questa Direttiva nell’ambito dei mercati bancario e finanziario è apparso chiaro già all’indomani della sua approvazione da parte del COREPER.
Nel considerando n. 51 si afferma in modo esplicito che le imprese finanziarie regolamentate sono soggette agli obblighi relativi al dovere di diligenza solo per la parte a monte delle loro catene di attività. Quindi: le imprese finanziarie sono obbligate all’adempimento degli obblighi di due diligence anzitutto con riferimento alla propria attività, alla attività delle loro filiazioni e dei loro partner commerciali. Restano esclusi pertanto i rapporti a valle; ossia i rapporti con i clienti, i quali non sembrano potere entrare nella nozione di catena di attività.
Alla chiara delimitazione del suo ambito applicativo si aggiunge anche una regolamentazione dello strumento risarcitorio che ne attenua di molto la forza deterrente.
Segnatamente, l’art. 29 della Direttiva (prima versione) stabilisce che «gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che: a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, quando il diritto, il divieto o l’obbligo elencato nell’allegato alla presente direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; e b) a seguito dell’inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale». Aggiunge poi che «una società non può essere ritenuta responsabile se il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali nella sua catena di attività».
Ebbene, l’illecito, alla rimozione degli effetti negativi del quale il rimedio risarcitorio dovrebbe essere rivolto, è costruito, nella più classica delle tradizioni, come illecito soggettivo. I criteri di imputazione del rischio derivante dallo svolgimento dell’attività continuano a essere rappresentati, cioè, dalla colpa e dal dolo.
Fermato questo profilo di disciplina, ciò che ancora di più sembra svilire la portata della Direttiva è l’esclusione della responsabilità delle società nelle ipotesi in cui non abbiano concorso con i partner commerciali alla causazione del danno. Che significa, in altre parole, avere rinunciato ad attribuire alle società (anche bancaria) una posizione di garanzia rispetto all’attività svolta dai relativi partner.
È oggi pendente una Proposta di modifica della Direttiva sulla due diligence, che ne limita ulteriormente l’ambito applicativo, alleggerendo tra l’altro gli obblighi imposti alle imprese e riducendo il novero delle società cui essa dovrebbe applicarsi. Questa Proposta incide profondamento anche sulla stessa disciplina della responsabilità civile, prevedendo l’eliminazione dell’attuale art. 29: si rinuncia a una disciplina uniforme per rinviare ai singoli diritti nazionali degli Stati membri, specificando altresì che, di là dalla scelta effettuata su questo piano da ciascun Paese dell’Unione, «victims are able to receive full compensation, which should be granted in accordance with the principles of effectiveness and equivalence, while balancing this through safeguards should prevent against overcompensation».
Guardando alla seconda ondata di provvedimenti dell’Unione Europea, sembra che la attuale tendenza del legislatore – e ciò vale ben oltre i mercati bancario e finanziario – sia ridurre l’impatto del processo di transizione, specie in termini di oneri economici, sulle imprese e, in particolare, su quelle piccole e medie. Il pacchetto omnibus di recente approvazione contiene anche una proposta di modifica della Direttive UE 2022/2464 sulle rendicontazioni di sostenibilità, che parimenti va nella direzione di limitarne il relativo ambito applicativo. Ed è recente la notizia di un possibile ritiro della Direttiva UE 2024/825 sul green washing.
Senza dubbio l’adeguamento dei modelli produttivi ai nuovi standard di sostenibilità rappresenta un costo. Un costo per le imprese, che rischia anche di ricadere sui consumatori. Diversi settori produttivi hanno difficoltà ad allinearsi, opponendo un quasi certo tracollo finanziario. A ciò si aggiunga che nell’attuale realtà economica globalizzata, l’assenza di consenso politico di una parte mondo, rischia di rendere inutili i sacrifici fatti dall’altra. E le scelte che la transizione presuppone sono anzitutto scelte politiche, di compromesso tra i diversi interessi in gioco.
Il Piano di azione della Commissione sul Green deal, assieme agli atti normativi e regolatori che si sono susseguiti, hanno convinto molti che nell’idea del legislatore europeo il processo di transizione dovesse passare per la funzionalizzazione dell’impresa e dell’autonomia negoziale. Idea che, oggi, sta rivelando tutta la sua fragilità[32]. Anche a fronte di ciò che appare una brusca frenata da parte delle Istituzioni europee, l’unica certezza è che ai fini del compimento di questo processo la prevalenza vada data agli strumenti di public enforcement rispetto a quelli di private enforcement. Il mutamento del sistema economico necessita infatti anzitutto di incentivi pubblici.
Stingendo sui mercati bancario e finanziario, è oramai chiaro che rispetto a essi la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è quanto mai sfumata[33]. Come sfumata appare in ultima analisi la stessa distinzione da private e public enforcement, la quale, come dimostra quanto detto, non può essere costruita in ragione della natura degli interessi tutelati: privati, nel primo caso; pubblici nel secondo. Anche gli strumenti di private enforcement possono rivelarsi funzionali al perseguimento di interessi generali; con riferimento ai contratti bancari e finanziari, di interessi regolatori. E, anzi, si rivelano più efficaci in ottica di deterrenza esattamente quando il rimedio è costruito sulla base dell’interesse generale di volta in volta perseguito, fuggendo dalla classica logica della riconduzione a equilibrio del rapporto.
Pure per questi mercati vale nondimeno quanto detto in linea più generale. Senza un adeguato piano di incentivi (pubblici) e sanzioni (parimenti pubbliche) il progetto di traghettare i capitali privati verso investimenti sostenibili rischia di arenarsi sul nascere[34].
* Il lavoro riproduce il testo della relazione tenuta al Convegno “Dottrine generali della sostenibilità”, organizzato dall’Università degli studi della Tuscia, Viterbo, nei giorni 24-26 ottobre 2024.
[1] Il tema è collegato alla più ampia questione della sostenibilità dell’attuale modello di sviluppo e della sua giustizia in termini di distribuzione della ricchezza. Capisaldi nella letteratura economiche sono in particolare i lavori di A.K. Sen, La diseguaglianza. Un riesame critico, Bologna, Mulino, 2010; J.E. Stiglitz, Invertire la rotta. Disuguaglianza e crescita economica, 2018, Bari, Laterza.
[2] Rapporto della Commissione Sarkozy sulla misura della performance dell’economia e del progresso sociale (Il Rapporto Stiglitz, I e II parte), 15 gennaio 2011.
[3] O.u.c., p. 27.
Che l’approccio a questi temi sia mutato è anche testimoniato dall’ultima riforma della Costituzione, che è intervenuta sull’art. 9 Cost., inserendo un riferimento esplicito all’interesse delle nuove generazioni.
[4] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il Green Deal europeo, 11 dicembre 2019.
[5] Comunicazione della Commissione sul Green Deal, cit, p. 2.
[6] Sull’approccio regolatorio del legislatore europeo e sull’ampio dibattito in ordine al ruolo della disciplina del contratto al fine di evitare i fallimenti di mercato e garantirne il corretto funzionamento v., almeno, F. Denozza, Mercato, razionalità degli agenti e disciplina dei contratti, in Osservatorio di diritto commerciale, 2012, p. 1 ss.; Id., La frammentazione del soggetto nel pensiero giuridico tardo liberale, in Riv. dir. comm., 2014, p. 13 ss.; Id, In viaggio verso un mondo re-incantato? Il crepuscolo della razionalità formale nel diritto neoliberale, ibidem, 2016, p. 419 ss.
[7] I segnali non sono tuttavia incoraggianti, considerata l’approvazione del recente pacchetto omnibus di modifica delle Direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760, rispettivamente sulla rendicontazione della sostenibilità e sulla due diligence delle imprese, che ne limita fortemente l’ambito di applicazione. Tra l’altro questo pacchetto incide sul Green Asset Ratio, il principale indicatore di performance delle banche basato sulla tassonomia, stabilendo che le banche potranno escludere dal denominatore del GAR le esposizioni relative a imprese non soggette all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità.
[8] Per citarne soltanto alcuni: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (c.d. Regolamento tassonomia), il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento; Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (anche detta Direttiva Green washing); Direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti; Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.
[9] V. gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti del 29.05.2020 dell’European Banking Authority (EBA).
[10] Comunicazione della Commissione “Tassonomia dell’UE, comunicazione societaria sulla sostenibilità, preferenze di sostenibilità e doveri fiduciari: dirigere i finanziamenti verso il Green Deal europeo”, 21 aprile 2021.
[11] Definito dal Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari come «un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell’investimento, come specificato nella legislazione settoriale, in particolare nelle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/ UE, (UE) 2016/97, (UE) 2016/2341, ovvero negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione adottati a norma alle suddette direttive».
[12] Per tutti F. Sartori, Informazione economica e responsabilità civile, Torino 2011.
[13] Joint ESAs Opinion, On the assessment of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), 18 giugno 2024.
[14] V., almeno, F. Sartori, Informazione economica e responsabilità civile, cit., passim; A.A. Dolmetta, Trasparenza dei prodotti bancari. Regole, Bologna 2013.
[15] Sulla trasparenza alla luce delle più recenti evoluzioni normative A.M. Pancallo, La Trasparenza bancaria nella transizione ad un mercato sostenibile, Cacucci, Bari, 2022. Nella prospettiva del testo v., in particolare, R. Di Raimo, La trasparenza trent’anni dopo, in M. Perassi, M. Rabitti, F. Sartori e V. Troiano (a cura di), A 30 anni dal testo unico bancario (1993-2023). The test of Time, in Quaderni Banca d’Italia, 2024, p. 203 ss.. Ma anche M. Semeraro, Informazioni adeguate e valutazione del merito creditizio: opzioni interpretative nel credito ai consumatori, in Riv. dir. civ., 2021, I, 704 ss.
[16] In prospettiva simile al testo v. F. Denozza, Il mercato, e la sua tutela, tra diritto privato “relazionale” e diritto privato “regolatorio”, in Accademia, 2024.
[17] Sulla particolare natura del rimedio risarcitorio introdotto dalla PSD2 M. Semeraro, Modelli di responsabilità e private enforcement: appunti su PSD2 e operazioni di pagamento non autorizzate, in Riv. dir. banc., 2022, p. 825 ss.
[18] Sul tema, in generale, v., almeno, M. Maugeri, A. Zoppini (a cura di), Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2010. Con attenzione specifica ai mercati regolati e al legame tra obiettivi regolatori e disciplina del contratto H. Micklitz, The Transformation of European Private Law through competition, in European Law Jornal, 22, no. 5 (Septembre 2016), 627 ss.
[19] Il dibattito sulla costruzione delle nullità di protezione è stato ampio. Per tutti, v. G. Passagnoli, Nullità speciali, Milano, 1995; M. Girolami, Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, Padova, 2008; S. Polidori, Discipline della nullità e interessi protetti, Napoli, 2001; Id., Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016; V. Scalisi, Contratto e regolamento nel piano d’azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, I, p. 459 ss.; M. Mantovani, Le nullità e il contratto nullo, in A. Gentili (a cura di), Trattato del contratto da V. Roppo, IV, Rimedi, Milano, 2006; A. Gentili, Le «nullità di protezione», in Eur. dir. priv., 2011, p. 77; S. Pagliantini, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da Parigi e dalla Corte di Giustizia, in Riv. dir. priv., 2009, 139 ss.; Id., L’azione di nullità tra legittimazione ed interesse, in Riv. trim. proc. civ., 2011, p. 407 ss.
[20] Questo sembra il caso della nullità prevista dall’art. 125 bis Tub qualora l’intermediario non abbia indicato in contratto il Taeg, ossia il costo complessivo del finanziamento. Va detto che in questa ipotesi a essere (pesantemente) sanzionata non è la mancata informazione. È invece soltanto il non avere inserito un costo, comunque riportato in contratto, nella voce che sintetizza il costo complessivo del finanziamento. Il che fa pensare che l’intervento manutentivo non segua la logica della riconduzione ad equilibrio del rapporto e che perciò l’obiettivo della norma non sia rendere giusto un contratto ingiusto; sia, invece, incidere, o quantomeno tentare di incidere, sulle condotte degli operatori di mercato attraverso l’irrogazione di una vera e propria sanzione di diritto privato.
[21] Al riguardo, v. U. Malvagna, Credito fondiario, nullità « a vantaggio del cliente » e legittimazione di altri, in Banca borsa tit. cred., 2014, p. 139 ss.
[22] V. infra, per le specificità di questi contratti in punto di disciplina dei rimedi.
[23] In particolare, nel Piano d’azione del 2019 dell’EBA si afferma che «il lavoro dell’EBA sui rischi ESG e sulla finanza sostenibile è strettamente legato all’obiettivo più ampio di contribuire alla stabilità, alla resilienza e al funzionamento ordinato del sistema finanziario a breve, medio e lungo termine». E che «l’EBA riconosce che, sebbene affrontare le sfide ESG richieda l’attuazione di una serie di politiche pubbliche, il ruolo principale del quadro prudenziale è quello di garantire un settore finanziario stabile e resiliente che sarà in grado di fornire i finanziamenti per la necessaria transizione economica e sociale».
[24] Come detto, dalla individuazione della ratio della norma violata (nella specie quella che impone l’obbligo di valutare il merito di credito del cliente) dipende la selezione del rimedio: in questa prospettiva v., seppure con diversità di approcci, R. Di Raimo, Ufficio di diritto privato e carattere delle parti professionali quali criteri ordinanti delle negoziazioni bancaria e finanziaria (e assicurativa), in Giust. civ., 2020, p. 322 ss.; G. Piepoli, Sovraindebitamento e credito responsabile, in Banca borsa tit. cred., 2013, I, 38 ss.; A.A. Dolmetta, Trasparenza bancaria, cit., 133 ss.; F. Falcone, “Prestito responsabile” e sovraindebitamento del consumatore, Dir. fall., 2010, 649; L. Modica, Concessione «abusiva» di credito ai consumatori, in Contr. Impr., 2012, 493 ss.
[25] Va ricordata, inoltre, la Direttiva 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE. Questa Direttiva riconduce alle pratiche commerciali ingannevoli anche «le pratiche che contengono informazioni false o ingannevoli sulle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto o comportino la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise come pure altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori».
[26] La prima in ordine di tempo è stata App. Milano, 8 settembre 2013, n. 3459, in Rass. dir. civ., 2014, 1, p. 295 s.
[27] Tra le altre Cass., 23 maggio 2017, n. 12937, in Banca borsa tit. cred., 2018, II, p. 293 ss.; Cass., 9 agosto 2016, n. 16820, in dejure; Cass., 27 aprile 2016, n. 8394, ivi; Cass., 26 ottobre 2015, n. 21711, in Guida dir., 2016, p. 59.
[28] Sulla costruzione della posizione dell’intermediario in termini di ufficio di diritto privato v. R. Di Raimo, Fisiologia e patologia della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema, in F. Cortese e F. Sartori (a cura di), Finanza derivata, mercati e investitori, Pisa, 2010, spec. 55 ss.; Id., Dopo la crisi, come prima e più di prima. (Il derivato finanziario come oggetto e come operazione economica), in D. Maffeis (a cura di), Swap tra banche e clienti. Le condotte e i contratti, Milano, Giuffrè, 2013, 37 ss.; Id., Finanza, finanza derivata e consenso contrattuale, a valle delle crisi d’inizio millennio, in Giust. civ., 2015, 1106 ss.; Id., Ufficio di diritto privato e carattere delle parti professionali quali criteri ordinanti delle negoziazioni bancaria e finanziaria (e assicurativa), cit., p. 322 ss. In altra prospettiva, qualifica parimenti in termini di ufficio l’agire dell’intermediario D. Maffeis, Intermediario contro investitore: i derivati over the counter, in Banca borsa tit. cred., 2010, p. 779 ss. Id., L’ufficio di diritto privato dell’intermediario e il contratto derivato over the counter come scommessa razionale, in Id. (a cura di), Swap tra banche e clienti, cit., 3 ss.
[29] Affronta la questione A. Carrisi, Il ruolo degli strumenti finanziari ESG nella transizione ecosostenibile dell’economia, in Contratto impr. eur., 2022, p. 363 ss.; Id., La finanza sostenibile e la ricerca di nuovi parametri di adeguatezza, in Riv. dir. banc., 2023, p. 1 ss.
[30] Così dovrebbe essere se si qualifica la posizione dell’intermediario in termini di ufficio di diritto privato: per tutti, R. Di Raimo, Fisiologia e patologia della finanza derivata. Qualificazione giuridica e profili di sistema, cit., p. 55 ss.
[31] Aderendo alla giurisprudenza che individua nella risoluzione del contratto di investimento e nel risarcimento del danno i rimedi principali per l’ipotesi di violazione degli obblighi di informazione o di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore: v. le pronunce citate alla nota 27.
[32] Superfluo ripercorrere il noto dibattito che occupò la dottrina commercialistica italiana sui pericolo del concetto di impresa funzione. Basti qui menzionare la pagine classiche di G. Minervini, Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata, in Riv. dir. civ., 1958, I, 618 ss. Va invece ricordato che gli interventi normativi di cui si scrive si inseriscono entro la cornice della economia sociale di mercato, espressione di costruzioni ideologiche molto distanti da quelle che hanno teorizzato l’impresa/funzione (sulle quali, seppure in prospettiva differente F. Denozza, Spettri del mitico “ordo”: diritto e mercato nel neoliberalismo, in Moneta e credito, 2019, p. 327 ss.; M. Libertini, Concorrenza, in Enc., dir., Ann., III, Milano, 2010, p. 191 ss.; Id., A “Highly Competitive Social Market Economy” as a Founding Element of the European Economic Constitution, in Concorrenza e mercato, 2011, p. 496).
[33] Sul rapporto tra diritto pubblico e diritto privato nei mercati regolati v. le ampie osservazioni di B. Sordi, Diritto pubblico e Diritto privato. Una genealogia storica, Bologna, p. 211 ss.
[34] R. Lener e P. Lucantoni, Sostenibilità ESG e attività bancaria, in Banca borsa tit. cred., 2023, p. 6 ss.