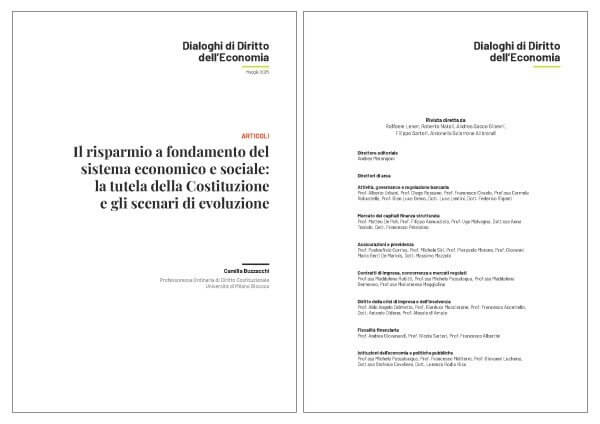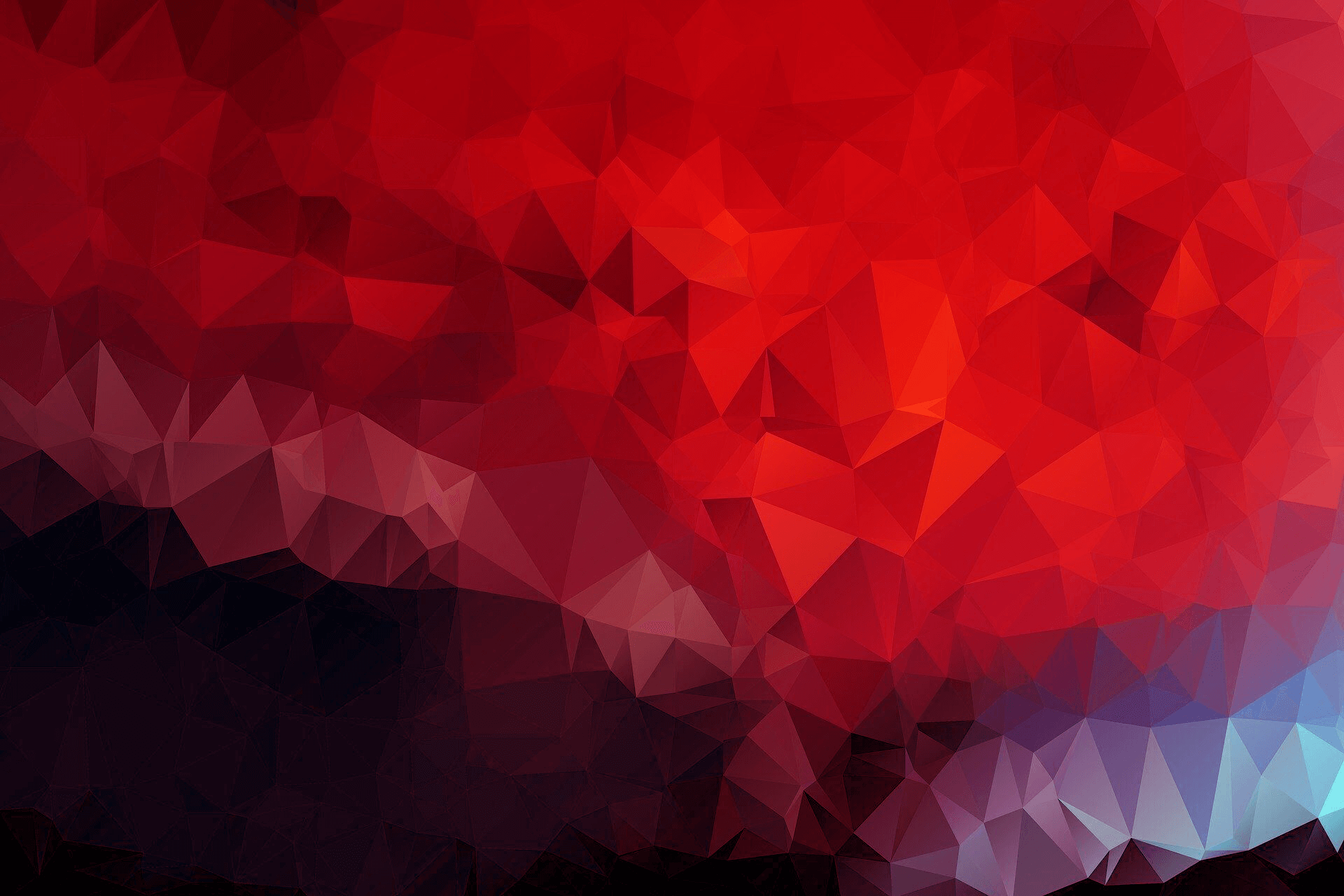SOMMARIO: Il risparmio è oggetto di un riconoscimento in Costituzione, che non è circoscritto all’art. 47: i suoi impieghi coinvolgono infatti una molteplicità di interessi costituzionali, cosicché esso appare attualmente un’entità che è condizione di realizzazione di vari obiettivi della Carta fondamentale. Il saggio approfondisce le funzionalità nella prospettiva dei privati e della collettività, con l’obiettivo di dimostrare le positive ricadute per scopi economici e sociali, nonché la fondamentale necessità di assicurare al risparmio adeguata tutela.
ABSTRACT: Savings are the subject of a constitutional recognition that is not limited to article 47: in fact, its uses involve a multiplicity of constitutional interests, so that it currently appears as an entity that is a condition for the realisation of various objectives of the Fundamental Charter. The essay examines its functioning from the point of view of individuals and the community, with the aim of demonstrating its positive effects for economic and social purposes, as well as the fundamental need to ensure adequate protection of savings.
1. Il risparmio nell’art. 47 Cost.: una disciplina non isolata, né datata
Con lungimiranza, nonché notevole originalità, la Costituzione italiana ha accolto, fin dalle origini, il riconoscimento e la tutela di un bene che si inserisce nell’ordinamento giuridico con un ruolo decisivo rispetto ad un ricco ventaglio di finalità: il risparmio costituisce un’entità che offre utilità di varia natura, e che deve essere oggetto di valorizzazione in vista del raggiungimento di molteplici interessi, che la Carta fondamentale promuove. Pertanto, mai può dirsi esaurita una riflessione volta a comprendere quali benefici esso offra e quali misure esso richieda, affinché il medesimo venga «incoraggiato» – secondo il dettato del patto costituzionale – e indirizzato verso le funzionalità più meritevoli, nel quadro dei valori che accompagnano la convivenza della comunità nazionale.
L’elevazione del risparmio a bene costituzionale sembra da localizzare solo nell’art. 47, che a lungo è stata una disposizione ritenuta isolata, perché dedicata ad un fenomeno economico parziale nel quadro del più ampio sistema della creazione di valore[1]. In più, di questa disposizione si è a lungo fornita una lettura storicizzata, ancorata alle scelte della Costituente e prevalentemente subordinata all’assetto economico e sociale di quel passaggio storico. Salvo poi, nel 2001, l’apparizione tra le competenze esclusive dello Stato dell’art. 117, co. 2, lett. e) che associa «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari». Il passaggio di revisione non ha di per sé aggiunto più di tanto alla disciplina che già l’art. 47 Cost. offre, posto che le tre categorie di moneta, risparmio e mercati finanziari rilevano in quella norma esclusivamente come ambiti di attribuzioni nel rapporto tra Stato e Regioni: indubbiamente il risparmio risulta collegato in maniera inscindibile ai mercati dove esso viene impiegato, cosicché la sua destinazione appare univocamente predeterminata. Tuttavia, la novella del Titolo V non presenta l’efficacia necessaria per rafforzare la portata dell’art. 47, né arricchire il suo contenuto.
L’intento delle riflessioni che seguono è duplice.
Da un lato l’«isolamento» e la «parzialità» della previsione collocata nel Titolo III vanno definitivamente superati, perché al contrario è agevole rappresentare e argomentare la forte connessione di questa disposizione con molteplici altre della Costituzione, che sotto diversi profili implicano il risparmio, o sono oggetto di implicazione del medesimo: il diritto al lavoro e la sua disciplina, la previdenza (obbligatoria e facoltativa), l’iniziativa economica, la proprietà, le imposte, la stabilità finanziaria, la spesa pubblica ed il debito, dello Stato e degli enti territoriali, costituiscono tasselli del disegno costituzionale che, in forme diversificate, rimandano alla capacità dei privati di non consumare il loro reddito o la loro ricchezza.
Il secondo obiettivo è la valorizzazione dell’attualità della previsione in esame: per la lettura che se ne fa oggi, essa sembra additare scelte individuali e collettive legate ad una società superata, ad un contesto di vita distante dal modello di convivenza del presente. Tuttavia, con l’esemplificazione che riporta, l’art. 47 è in grado di esprimere efficacemente le funzionalità fondamentali del risparmio, e come l’ordinamento giuridico debba – oggi come ieri – porsi rispetto ad esso.
Questa seconda prospettiva richiede però un breve excursus sulla genesi della disposizione, che – come si è già segnalato – è dotata di vera originalità[2]: esso può illuminare in merito alla realtà sociale ed economica del tempo, alla cultura che ha generato la previsione, nonché alle intuizioni che hanno accompagnato la sua elaborazione, dimostrando la lungimiranza di cui si è detto in apertura. Il sintetico percorso che pare necessario proporre vuole essere funzionale non a calare la norma nell’epoca per la quale è stata concepita, ma a scoprirne le potenzialità anche per l’avvenire.
Anticipando le considerazioni che ci si accinge a svolgere, il convincimento che emergerà è che il risparmio sia attualmente tanto la linfa del circuito dei rapporti tipici dell’economia di mercato, quanto che esso sia chiamato ad assicurare anche significative utilità di carattere sociale, dando soddisfacimento a bisogni individuali ma anche a obiettivi più diffusi, di cui spesso, nel momento presente, sempre più si fa carico l’economia sociale o civile: l’insieme delle finalità non strettamente economiche, ma prevalentemente ispirate alla solidarietà, è altrettanto bisognoso di essere alimentato dal risparmio, che può consentire il raggiungimento di traguardi importanti nella prospettiva del progresso sociale, primo tra tutti il traguardo della salvaguardia ambientale.
Proprio in collegamento a questi impieghi di economia civile, a cui il risparmio si presta, il passaggio conclusivo dovrà necessariamente focalizzare gli indirizzi più recenti di investimento, strettamente dipendenti da bisogni legati a demografia e ambiente: le traiettorie dell’uso del risparmio cambiano rapidamente, in ragione di necessità umane in costante evoluzione, è soprattutto in ragione di queste evoluzioni è sempre e incessantemente necessario che il risparmio goda di adeguata tutela.
Per finire, prima di avviare le diverse analisi ora prospettate, pare importante sottolineare come il fattore «tempo» accompagnerà costantemente la linea del ragionamento. Esso risulta ormai elemento che condiziona le scelte pubbliche e quelle private, e impone una sintonizzazione delle politiche pubbliche, che sempre meno devono darsi orizzonti temporali a breve, per sviluppare invece capacità predittive e di cura di interessi futuri.
2. Il risparmio come fonte di utilità private e pubbliche
Avviando la riflessione a partire dal primo piano di indagine, l’immediata osservazione che nasce dal dato testuale è che il riconoscimento parallelo di risparmio e credito conduce a correlare necessariamente il primo alle attività tipiche del settore bancario: quest’ultimo risulterebbe l’unico settore a cui i privati destinano quanto non consumano del loro reddito.
Tale collegamento ha infatti condotto ad un’enfasi totale a favore del settore bancario[3], che per lungo tempo è parso esaurire le modalità di valorizzazione del risparmio: la lettura attuale della disposizione non può evidentemente tralasciare, accanto al settore del credito, quello assicurativo e l’industria del risparmio gestito, a cui è affidata una grande parte del risparmio; ma al tempo stesso vi è da chiedersi se la liquidità preservata dai soggetti privati sia tutta necessariamente da affidare agli operatori della finanza, o se gli impieghi a cui si presta siano anche di altra natura.
Anzitutto possono essere indagate le molteplici funzioni che il risparmio può assicurare, e a questo fine è necessario riferirsi alle teorie economiche, che ben prima della scienza giuridica si sono interrogate sulle possibili utilità. Gli approcci che si sono sviluppati sono stati di natura microeconomica, con attenzione ai comportamenti dei singoli e delle famiglie; ma anche macroeconomica, per comprendere le utilità che il risparmio offre a livello di sistema.
Senza pretendere di offrire un’analisi esaustiva, un breve accenno alle alterne fortune della grandezza del risparmio nelle diverse teorie economiche[4] può fornire alcuni strumenti di comprensione per giungere ad una lettura più completa dell’art. 47 Cost.
I primi studi, quelli degli economisti classici, hanno collegato il risparmio unicamente agli investimenti e alla crescita della produzione, con una posizione di particolare apprezzamento per il protagonismo della borghesia imprenditoriale, contrapposta alla staticità dei grandi proprietari terrieri, fermi negli investimenti in un settore – quello primario – che rimaneva dominante ma in calo di redditività. A seguire, gli economisti neo-classici a inizio Novecento hanno cominciato a mostrare attenzione per le scelte del consumatore in una prospettiva intertemporale: la preoccupazione era che questo soggetto potesse mantenere un profilo di consumo costante a fronte di redditi che variavano nel corso della vita, e dunque il nesso tra decisioni di risparmio e decisioni di investimento non era più quello esclusivamente osservato, ma a questo si è affiancato l’interesse per decisioni di consumo dei privati.
Passando a una figura di particolare rilievo, si può sostenere che Keynes ha considerato sfavorevolmente il risparmio: non lo ha individuato come fattore di crescita, come invece è il consumo. L’economista britannico ha elaborato la legge «psicologica fondamentale del risparmio», secondo la quale la propensione a tale pratica cresce all’aumentare del reddito: tale posizione è stata poi contraddetta dalla scuola di Franco Modigliani, che negli anni ‘40 e ‘50 ha capovolto l’approccio. Secondo la teoria del «ciclo vitale»[5] del premio Nobel il livello dei risparmi dipende dall’età dei consumatori, e quindi dalla struttura demografica della società, piuttosto che dal livello del reddito familiare: anche Milton Friedman si è associato a questa visione, tale per cui è la crescita economica che unilateralmente favorisce il risparmio, e non viceversa.
Questo più che parziale sconfinamento nel perimetro della logica economica è qui funzionale solo a evidenziare come il risparmio possa essere visto quale fonte di utilità private e collettive; di attività di consumo e di investimento; di protezione e di speculazione/arricchimento. La teoria economica lo ha preso in considerazione in relazione a tutte queste diversificate collocazioni, e tale circostanza conduce la riflessione giuridica a interrogarsi, a sua volta, circa le utilità pubbliche e private che esso garantisce; circa i benefici a singoli o al sistema che da esso arrivano; circa le diverse provenienze che lo generano, e gli scopi che tramite esso sono raggiungibili.
La letteratura giuridica[6] ha definito il risparmio tanto come un’attività quanto come il risultato della stessa: l’attività è quella di destinare una parte delle risorse disponibili in un dato momento ad un uso che se ne farà in futuro; il risultato sono le risorse stesse che, non consumate, vengono preservate per quando potranno essere maggiormente necessarie. Tale attenzione per la dimensione temporale emerge anche nella posizione espressa dal Governatore di Banca Italia il 31 ottobre 2024, quando – in occasione della Giornata per il risparmio – ha affermato che «risparmiare significa trasferire risorse dal presente al futuro»[7]. Un futuro che può essere non troppo lontano, se si riflette su alcuni consumi; oppure collocato in una seconda fase dell’esistenza, se si pensa a scelte previdenziali. In ogni caso decisiva è la trasposizione nel tempo dell’uso di una liquidità, e ciò in ragione di esigenze del tutto eterogenee.
Calata nel duplice contesto di un sistema produttivo di carattere capitalistico e di uno Stato di ispirazione sociale, questa concezione conduce a qualificare il risparmio anzitutto come la fonte di vari impieghi che, da un punto di vista economico, appaiono vantaggiosi: impieghi, in primo luogo, in termini di capitale, che alimenta il processo produttivo, perché le risorse non consumate diventano un «ingranaggio fondamentale» su cui l’impresa fa affidamento «per potere avviare e realizzare il ciclo produttivo»[8]. Ma possibili impieghi di carattere economico sono anche il consumo di beni e di servizi, che è un comportamento idoneo a imprimere stimoli di crescita al complesso produttivo; o la creazione di un patrimonio finanziario, con prospettive di una remunerazione[9].
Dunque, il risparmio è stato da ampia dottrina interpretato in chiave prettamente economica, come quell’insieme di risorse finanziarie che sono destinate a entrare nel circuito economico, e come liquidità monetaria, volta ad assicurare la difesa del valore della moneta contro l’inflazione[10]. I commenti della norma da parte di Fabio Merusi, di Vincenzo Spagnuolo Vigorita[11] e di Sergio Ortino[12] hanno valorizzato il risparmio come garanzia degli investimenti e delle risorse finanziarie della struttura economica, evidenziando la sua funzione strumentale alla distribuzione della proprietà e della ricchezza. Ciò ben si coniuga con la simultanea tutela offerta al credito, e in ogni caso si è in presenza di una forma di proprietà, inquadrata per la sua idoneità ad entrare nel ciclo economico[13] nella forma di investimenti oppure nella forma di consumi.
Accanto a queste destinazioni del risparmio, altre possono trovare spazio, connotate dalla circostanza che le utilità che rendono possibili si inscrivono in prima istanza in una prospettiva di valore sociale, nella misura in cui forniscono forme di protezione alle persone: l’abitazione, i servizi per la salute, la copertura previdenziale sono usi del risparmio che vanno a dare soddisfacimento a situazioni di bisogno. Una gamma di bisogni di impronta personale e dai risvolti del tutto materiali, di sostegno alla situazione del singolo, ma non necessariamente da intendere in una dimensione economico-finanziaria.
Si può allora affermare che l’esemplificazione offerta dall’art. 47 Cost. sia idonea a restituire questa apertura a impieghi di varia utilità, non solamente economica e non solamente individuale. Dall’elencazione della disposizione si ricava la meritevolezza di interessi legati a vari obiettivi, che spaziano dal lavoro alla vita privata, fino allo sviluppo del Paese: e tale impostazione conserva intatta attualità, perché anche gli impieghi dell’epoca attuale sono chiamati a recare vantaggio a situazioni personali e a finalità collettive. E infine la lett. e) dell’art. 117 Cost., che si è già richiamata, dimostra quanto sono ora determinanti i mercati finanziari, che attestano anche la profonda torsione che ha caratterizzato il sistema economico: quest’ultimo crea valore prevalentemente con le attività finanziarie, molto di più di quanto facciano le attività dell’economia reale.
Il risparmio risulta allora qualificabile come bene tanto pubblico quanto privato, e più precisamente è un «interesse» per i singoli così come per la collettività, in una prospettiva che si potrebbe definire «comunitaria». Le funzionalità precedentemente richiamate sono evidentemente tutte legittime alla luce dell’art. 47 Cost., ma è chiaro che le ricadute delle diverse destinazioni possono essere molto distanti: anzitutto il risparmio presuppone una specifica libertà costituzionale – il diritto di proprietà – e dunque va a tutelare scelte libere del singolo rispetto all’utilizzo di una parte del suo reddito e della sua ricchezza. Molto diversi saranno gli effetti in ragione dei diversi impieghi che ogni privato può decidere in merito alla propria liquidità. La prospettiva del diritto costituzionale è evidentemente quella di accogliere nella maniera più ampia possibile le esigenze degli individui che «praticano» la virtuosa attività di accantonare risorse finanziarie, nella misura in cui – nell’orizzonte personalista dell’ordinamento giuridico – ciò contribuisce allo sviluppo della personalità; ma anche quella di garantire un’utilità sociale, e dunque il perseguimento – in via diretta o mediata – di interessi generali, che per effetto di scelte di destinazione dei singoli, trovano realizzazione. Utilità sociale, funzione sociale e utilità generale sono le clausole elastiche che gli artt. 41, 42 e 43 Cost. prevedono per correggere distorsioni nel contesto economico, ed è difficile immaginare che le altre disposizioni della Costituzione economica – pur nei limiti che risiedono in questa formula – non risentano a loro volta di questa impostazione. In tale direzione può essere allora utile disegnare il raggio degli effetti dell’art. 47 Cost., che certamente è idoneo a garantire l’equilibrio economico-finanziario del sistema, ma altrettanto assicura altri interessi di rango costituzionale. In alcuni casi il risparmio funge da premessa, in altri casi costituisce la condizione o l’effetto di molteplici previsioni e capisaldi costituzionali[14], di cui è possibile offrire una panoramica essenziale.
3. Un importante crocevia di interessi costituzionali
Anzitutto il principio lavorista ex art. 1 Cost. individua come obiettivo primario del complessivo modello economico la piena occupazione, che è condizione ideale perché una società sia capace di generare risparmio e riversarlo nelle attività creditizie[15]: il fondamento della Repubblica sul lavoro apre ad un quadro di generalizzata distribuzione di redditi, che sono irrinunciabile presupposto per l’accantonamento di liquidità.
Collegato al lavoro l’art. 36 Cost. esige una «retribuzione sufficiente per una esistenza libera e dignitosa» del lavoratore, e introduce così una capacità di acquisto della moneta, di cui si compone la retribuzione, che deve essere tendenzialmente costante: accanto a tale esigenza anti-inflazionistica, la disposizione lascia inoltre intendere che il carattere «sufficiente» della remunerazione possa consentire anche margini di risparmio. Sempre con riferimento alla sfera lavoristica, il diritto sociale dell’art. 38 Cost. necessita il risparmio tanto laddove prevede la previdenza obbligatoria, che si basa su un accantonamento che è equivalente al non completo consumo del proprio reddito[16], quanto a livello di previdenza complementare e facoltativa, che in maniera più diretta assorbe quote di risparmio. Il sistema di sicurezza sociale, soprattutto nella sua manifestazione previdenziale, esige un modello delle retribuzioni che si apra al risparmio, e dunque tanto la previdenza assicurata da istituzioni pubbliche quanto quei prodotti finanziari che, nel libero mercato, assicurano la medesima copertura, richiedono un reddito idoneo e un’attitudine a preservarne una parte.
L’attività di impresa riconosciuta dall’art. 41 Cost. è quella che trova nel risparmio vera e propria linfa, sia per la formazione del capitale di investimento che internamente essa stessa può generare, sia per il sostegno azionario, che lo stesso art. 47 Cost. raccomanda. Il nesso tra risparmio e attività di produzione e circolazione di beni e di servizi è quello che per primo è stato teorizzato e che ha costituito l’originaria chiave di interpretazione della norma: in un’economia capitalistica e di mercato, la destinazione della redditività alla crescita del sistema che genera valore[17] appare da sempre e a ragione l’utilizzo privilegiato.
Come già osservato, il risparmio ricade pure sotto la disciplina dell’art. 42 Cost. in quanto proprietà in forma di liquidità monetaria: il suo godimento – secondo le prescrizioni della disposizione – incontra i limiti della legge che sono volti ad assicurare alcuni interessi di carattere sociale.
Viene poi in rilievo la materia fiscale: il dovere di contribuire alle spese dello Stato incide evidentemente sulla capacità di risparmio delle persone, ma può essere anche agevolato da una struttura di tassazione che crei regimi di esenzione. Il prelievo tributario e la pratica del risparmio appaiono quasi in antitesi, ma un’equilibrata attuazione del quadro costituzionale dovrebbe piuttosto evitare che l’imposizione diventi impeditiva rispetto all’attività di accantonamento, ed usare la leva fiscale per produrre quel risultato di incoraggiamento che espressamente l’art. 47 Cost. affida alla Repubblica. Inoltre, il collegamento del prelievo della ricchezza alla capacità contributiva ed al criterio della progressività esige che venga combattuto il fenomeno dell’inflazione, che rappresenterebbe una forma di prelievo non rispettosa delle garanzie espresse dall’art. 53 Cost.
Il sistema della finanza pubblica impone poi un corretto rapporto con il risparmio privato.
Dall’art. 81 Cost., e dunque dal principio dell’equilibrio di bilancio, si evince l’obiettivo della stabilità finanziaria, che è da considerare come una delle più importanti forme di tutela del risparmio: l’equilibrio di bilancio diventa così condizione di praticabilità del risparmio, che può svilupparsi solamente in un contesto di solida tenuta dell’ambiente economico e finanziario. Come è stato osservato, a seguito della crisi del 2008 e ancora più della pandemia, il perseguimento della stabilità economica nelle sue diverse forme – monetaria, fiscale e finanziaria – risulta ormai costituire uno degli obiettivi fondamentali a cui si indirizza l’azione degli Stati e delle organizzazioni internazionali economiche. La stabilità economica è un vero e proprio obiettivo di sistema, essenziale per un ordinato svolgersi delle relazioni economiche e commerciali tanto a livello macro (tra Stati) quanto micro (tra imprese e individui)[18], e rappresenta contestualmente il requisito necessario per un diffuso risparmio così come l’esito di un assetto sociale, nel quale sia consolidata l’attitudine a risparmiare.
Ma ancor più concretamente il risparmio sta a fondamento dell’indebitamento dello Stato, coinvolgendo dunque anche da un’altra prospettiva la disciplina dell’art. 81 Cost[19]. L’emissione di titoli del debito pubblico è effettuata a partire dall’aspettativa che i privati decidano di riversare verso le casse pubbliche i loro investimenti, e così facendo essi diventano interlocutori diretti dello Stato, verso di loro esposto per la raccolta di risorse da destinare a impieghi pubblici. Per l’entità del debito pubblico nel momento presente, e ormai da vari anni, evidente risulta quanto nevralgico sia per il soggetto Stato la circostanza che il risparmio abbondi nella collettività nazionale, e che vi sia la disponibilità degli investitori a indirizzare lì i loro risparmi: a tal fine le condizioni di appetibilità devono essere attrattive, e deve essere garantito il grado di solvibilità del debitore.
Questa funzione cruciale del risparmio solleva una riflessione rilevante connessa alla «alternatività» del debito rispetto alla raccolta fiscale: il singolo privato è chiamato dall’ordinamento a contribuire in maniera doverosa alle spese della collettività[20] – e a ciò risponde l’art. 53 Cost. – ma può altresì offrire equivalente sostegno attraverso un risparmio che si traduce in detenzione di titoli del debito pubblico. Le due situazioni sono, evidentemente, profondamente diverse, posto che il sacrificio del dovere tributario è regolato – e produce effetti nei confronti dell’attore che si priva della sua ricchezza – in maniera del tutto differente rispetto all’investimento indirizzato ai titoli dello Stato[21]. Senza potere ora affrontare questa sorta di dualismo, che tanto incide anche sulle politiche pubbliche – se si considera che il debito pubblico è accompagnato da una consistente spesa per interessi, nota come «servizio del debito» – quanto ora qui rileva è evidenziare che nella misura in cui il debito pubblico è finanziato dai risparmiatori italiani, esso trova nell’art. 47 Cost. un’area di credito, e quindi a maggior ragione vi è un preponderante interesse generale a incrementare l’attitudine a preservare reddito e ricchezza. Vi è tuttavia da osservare che la disciplina del debito, in Costituzione, non è formulata nel segno del favore e di un’apertura ad un suo impiego in via ordinaria. Al contrario, la revisione costituzionale del 2012 ha introdotto tale categoria – prima assente e oggetto di utilizzo secondo le coordinate fissate dalla sent. n. 1/1966 del giudice delle leggi – prevedendo le condizioni in presenza delle quali il debito «è consentito»: cosicché si deduce che al di fuori di situazioni di eccezionalità e di ciclo economico avverso sarebbe non sarebbe opportuno rivolgersi ai mercati finanziari, per il costo che i prestiti ottenuti dai privati possono generare. Il già richiamato «servizio del debito» è infatti fonte di remunerazione per i risparmiatori, ma rappresenta un ulteriore costo a carico del bilancio pubblico, che va assunto con prudenza e consapevolezza, per i riflessi sul sistema di finanza pubblica che genera. Il rapporto tra risparmio e debito appare pertanto complesso perché capace di incidere su vari interessi e su capisaldi del diritto del bilancio, che rispondono a loro volta a indirizzi del diritto europeo[22]: conferma, tale rapporto, quanto cruciale possa essere il risparmio per finalità pubbliche, che tuttavia non sempre sono perseguibili in parallelo e in completa concordanza con le aspettative private.
A chiusura di questa breve panoramica appare riduttivo accogliere una visione della materia del risparmio come ambito circoscritto e a sé stante: la sfera di rapporti di natura finanziaria che esso genera spicca, al contrario, per la sua capacità di riflettersi su tanti e diversificati beni costituzionali, e per la sua idoneità a permeare molteplici fenomeni che sono protetti dalla Carta fondamentale. Secondo modalità diversificate, il risparmio fornisce alimento ad un insieme di realtà, che sono tutte di massimo interesse: da qui scaturisce la sempre attuale esigenza di salvaguardarlo.
4. L’attualità della disciplina
La previsione presenta un tratto di sicura originalità, in conformità con lo spirito sociale del quadro costituzionale del 1948: nel delineare i tratti di una struttura produttiva che si apriva alle regole del capitalismo e dell’economia di mercato, essa dà rilevanza – senza esempi analoghi in altre costituzioni – ad un esercizio virtuoso che fino allora non aveva meritato l’attenzione nei testi giuridici. Le destinazioni che vengono elencate rimandano ad un’organizzazione sociale e produttiva che sembrerebbe di un altro tempo: l’abitazione, la terra e i complessi produttivi nazionali sembrano riduttivi rispetto alla complessità degli impieghi che oggi si possono considerare. Ad una prima lettura la disposizione sembrerebbe ferma nel tempo, articolata in categorie che solo parzialmente colgono il contesto attuale.
È invece possibile calare l’art. 47 Cost. nella dimensione del presente, tenendo conto – tuttavia – che esso è il frutto di una complessa elaborazione che ha avuto luogo nella fase di genesi della Costituzione repubblicana.
La materia del credito, del risparmio e della moneta è stata anzitutto oggetto di studio da parte della Commissione economica presieduta da Giovanni Demaria, a beneficio del Ministero per la Costituente: i volumi III e IV del Rapporto presentato all’Assemblea Costituente[23] ne trattano. Il Rapporto riconosce la validità dell’impostazione già operante in materia di disciplina del credito, ed indica l’opportunità dell’inserimento nella Carta costituzionale di norme sul controllo del settore: emerge il suggerimento della Commissione economica che «l’attuale estensione dell’intervento diretto o indiretto dello Stato nel settore del credito non dovrebbe essere totalmente ignorato dalla Carta costituzionale, anche ai fini della precisazione degli scopi e dei limiti». Si auspica «un’esplicita enunciazione del carattere di pubblico interesse che riveste la funzione di intermediazione del credito» già propria della legislazione del 1936, al fine di stabilire la «necessità di ordine economico e sociale di tutelare il regolare esercizio di tale funzione mediante pubblico controllo».
La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito vengono espressamente indicati come funzioni di interesse pubblico e come tali «giustificano e richiedono una particolare disciplina da parte dello Stato»: i due interessi della difesa del risparmiatore e dell’esercizio del credito vengono considerati ugualmente meritevoli di tutela e di apposito intervento di natura pubblica. L’impresa bancaria viene riconosciuta come espressamente assoggettabile ad un «complesso e organico regime di vigilanza», che da un lato è destinato a limitare le sue attività, ma dall’altro si traduce in un complesso di garanzie, applicabili al di là della natura privatistica delle aziende, che si presentano come soggetti economici e giuridici «nettamente identificati ed assistiti da guarentigie»[24].
Complessivamente risulta avvertita, nel Rapporto Demaria, la preoccupazione di dare espressa tutela alla stabilità della moneta, dalla quale si ritiene indirettamente tutelato anche il risparmio: tuttavia tale preoccupazione non si è tradotta, nel testo costituzionale, secondo le aspettative della Commissione economica.
Nel corso dei lavori della Commissione dei Settantacinque, ed in particolare di due Sottocommissioni, la Prima e la Terza, la materia del risparmio e del credito è stato oggetto di dibattito. Nella Prima Sottocommissione[25] Palmiro Togliatti ha proposto la formula «La proprietà dei cittadini e il risparmio sono tutelati dalla legge»[26], mentre il deputato liberale Roberto Lucifero ha sostenuto il collegamento tra risparmio e lavoro, insistendo che la tutela del primo non potesse essere disgiunta dai diritti conseguenti al lavoro; ma soprattutto il risparmio è stato ricondotto strettamente alla proprietà, che del lavoro e del risparmio è il risultato.
Trattando del controllo sociale dell’attività economica, la Terza Sottocommissione ha elaborato la formula: «Lo Stato stimola, coordina e controlla il risparmio. L’esercizio del credito è parimenti sottoposto al controllo dello Stato al fine di disciplinarne la distribuzione con criteri funzionali e territoriali»[27]. Il successivo coordinamento del testo delle due Sottocommissioni ha condotto alla versione presentata all’Assemblea costituente il 31 gennaio 1947: il testo dell’art. 44, all’interno del Titolo III dedicato ai rapporti economici, suonava inizialmente «La Repubblica tutela il risparmio; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito»[28]. A Tommaso Zerbi si deve l’aggiunta del secondo comma – «favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice, al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese» – che il deputato cattolico ha così motivato: «l’elencazione da noi proposta non è limitativa, bensì esemplificativa, delle più consuete forme d’investimento del risparmio popolare oppure di quelle forme alle quali particolarmente si pensa. (…) l’emendamento da noi proposto contiene una affermazione finalistica, che non esige necessariamente applicazione immediata e radicale ma lascia alle leggi future il compito di trovare forme adatte a favore del risparmio popolare. In secondo luogo, con riferimento alla situazione contingente (…) non possiamo esimerci dal sottolineare che proprio le masse operaie e impiegatizie contribuiscono largamente specie in via indiretta al finanziamento dello Stato, anche nell’attuale momento (…). Se mai il nostro emendamento contiene implicita l’esigenza di una migliore giustizia distributiva fra tutte le classi dei cittadini dell’onere di concorrere al finanziamento dello Stato sia attraverso le forme dirette che attraverso le forme indirette del risparmio obbligatorio e del portafoglio degli istituti previdenziali»[29].
Vi è dunque stata consapevolezza, nel dibattito in Assemblea costituente, della complessità e dell’intreccio degli interessi collegati alla materia del risparmio; e della sua connessione con il credito, condizionato tuttavia da un quadro giuridico che non poteva essere altro che mantenuto e confermato. La formulazione del principio in maniera così essenziale ha probabilmente determinato il successivo impegno attuativo da parte del legislatore, di tenore decisamente modesto almeno per alcuni decenni. Tale essenzialità rappresenta al tempo stesso il pregio della norma, suscettibile di adattarsi alle evoluzioni che hanno riguardato risparmio e credito.
L’adattamento ha avuto luogo, di fatto, e dunque la perdurante attualità del riconoscimento costituzionale del risparmio non è tanto da ricercare negli impieghi che l’art. 47 Cost. richiama a titolo esemplificativo, quanto piuttosto rispetto alle esigenze di «incoraggiamento» e «tutela» che dichiara, e che sono apparse nel tempo irrinunciabili. Come precedentemente già sostenuto, l’elenco delle tre destinazioni enunciate nella disposizione può ben essere interpretato, con una lettura aggiornata, in termini di meritevolezza di interessi legati a obiettivi di lavoro, di vita privata e di progresso del Paese, cosicché si può sostenere che il criterio delle destinazioni «privilegiate» non risulta superato.
Ma ancor più il valore aggiunto della disposizione, che la qualifica al passo coi tempi, è la sua chiara enunciazione dell’azione di incoraggiamento e tutela che sempre impone alla Repubblica di adoperarsi, predisponendo nuove modalità di sostegno e di difesa del risparmio.
Nel tempo le forme di favore e di salvaguardia sono incessantemente mutate[30], perché in costante mutamento sono i fattori che possono costituire minaccia o frenare rispetto alla pratica del risparmio: la l. n. 262 del 2005 ha rappresentato un passaggio rilevante[31], ma le rapide evoluzioni dei mercati finanziari, delle tecnologie, delle varie normative europee su mercati digitali, privacy e Artificial Intelligence rendono indispensabile un assiduo lavoro di analisi e di regolamentazione degli strumenti più adeguati per valorizzare al meglio, e proteggere, il risparmio privato.
Al di là del fatto che la solidità del sistema economico è di per sé una forma di tutela, tuttavia modalità più specifiche – e assai sofisticate – di promozione e di tutela sono anzitutto l’alfabetizzazione finanziaria[32], alla quale il mondo dell’istruzione si sta via via dimostrando sensibile e attento, anche in considerazione del fatto che la tendenza via via più evidente è che i risparmiatori, potenziali investitori, cercano le informazioni economiche e finanziarie nella rete digitale, con gravi ricadute legate alla inappropriatezza delle indicazioni che possono essere lì rinvenute. Il Report Consob 2024 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane riporta il dato che 67% dei risparmiatori si affida a motori di ricerca internet e 36% ai social media, ben più che alla televisione o ai siti degli intermediari[33]. Il risparmiatore appare sempre più «fragile e vulnerabile» e risulta spaesato tra molteplici fonti di informazione piatte e orizzontali, quando invece dovrebbe avere un solo interlocutore che offrisse una visione di insieme[34].
La tutela deve poi poter consistere in strumenti semplici da attivare e a basso costo affinché i risparmiatori possano far valere i propri diritti, in casi di contenzioso; mentre la necessità di prevenire inquinamenti provenienti dal riciclaggio di denaro o dal finanziamento del terrorismo, nonché di contrastare i rischi cibernetici per le infrastrutture finanziarie e di mercato, garantendo la sicurezza del sistema dei pagamenti, si prospetta come una sfida veramente ardua, che richiede tecnologie e conoscenze avanzate rispetto a dinamiche di illegalità, che operano con mezzi quanto mai sofisticati. Pertanto, il provvidenziale inserimento dell’azione di «tutela» nella Costituzione risulta certamente attuale: tale tutela deve necessariamente declinarsi in maniera composita e articolata nel presente, e impone di non lasciare mai indifesa la sfera del risparmio.
5. Gli scenari futuri del risparmio: incognite e sviluppi
Alcune ultime considerazioni di chiusura intendono indirizzare l’analisi verso le tendenze e le evoluzioni dell’equilibrio economico e sociale, suscettibili di plasmare in maniera sempre diversa le modalità di esercizio della pratica del risparmio, nonché del suo utilizzo. Sviluppi nuovi nell’uso del risparmio non sono del tutto esenti da criticità, cosicché rimane più che mai attuale la preoccupazione di tutelare in maniera appropriata tale bene.
Pare pacifico quanto autorevolmente evidenziato da Paolo Grossi, che la preservazione delle risorse finanziarie che originano da reddito o patrimonio non sia «un semplice tesoreggiamento» e «non coincide né con l’inerte e cieca accumulazione o il mero accantonamento di ricchezza, senza alcuna previsione di destinazione, né con una rinuncia e neppure con una resa. Non è una sterile custodia o una sorta di malinconica imbalsamazione di ciò che si è prodotto»[35]. Il risparmio è, al contrario, entità con potenzialità significative, per il cambiamento che può produrre nell’esistenza del singolo, sul piano economico e sociale; e per le azioni che rende possibili nella dimensione pubblica[36], ad opera di una pluralità di attori – istituti di credito e altri protagonisti della finanza privata, istituzioni pubbliche, associazionismo di varia finalità – che utilizzando questa riserva possono determinare nuovi assetti nel sistema della produzione del valore e nella società.
Del resto nel secondo decennio dello scorso secolo Luigi Einaudi sollecitava dalle pagine del Corriere della Sera il sostegno dei risparmiatori italiani alle sorti del Paese, prima in guerra e poi in faticosa ripresa: avvertiva che «il dovere di risparmiare non è mai stato così urgente come oggi. Grande è la responsabilità di coloro i quali guadagnano, come salario, o stipendio o profitto, somme superiori a quanto occorre per mantenere un sobrio tenore di vita»[37], e così facendo già assegnava alla pratica della preservazione della ricchezza privata una funzionalità di carattere pubblico.
Vari fenomeni recenti attestano la vitalità del bene in questione, e la sua funzionalità a obiettivi economici oppure sociali, o con utilità su entrambi i versanti.
Si pensi agli investimenti aziendali che negli ultimi anni hanno voluto premiare le priorità legate alle tematiche Environmental, Social, Governance (ESG), che hanno sollevato una nuova sensibilità e consapevolezza degli operatori economici[38] verso un orizzonte di equità sociale. O si rifletta sul fenomeno del crowdfunding – letteralmente il «finanziamento della folla» – che è una manifestazione di diffusa raccolta di risparmio, contrassegnata da questo «neologismo nato dall’esigenza di identificare un fenomeno di recente diffusione: un meccanismo di finanziamento che, mediante il web, promana dal basso, dalla folla appunto, in luogo dei tradizionali canali istituzionali»[39]. La dinamica è in costante espansione e si presenta nella forma di processi collaborativi di piccoli investitori non professionali – i c.d. crowdfunders – che sostengono gli sforzi di persone o organizzazioni con capacità creative e imprenditoriali, ma prive dei fondi necessari. I possibili ambiti applicativi sono i più ampi che si possono immaginare, e in tal modo si raccoglie il sostegno a progettualità con svariate motivazioni, che oscillano dall’aiuto in frangenti di drammi umanitari al supporto a iniziative culturali, per tradursi anche in finanziamenti a beneficio di imprese innovative. Attraverso piattaforme generaliste o tematiche – queste ultime specializzate in singoli settori – viene mobilitato risparmio, che proviene da una platea di persone che non avranno diretti benefici dalle attività che sostengono, ma che in una prospettiva quasi di solidarietà – o comunque di cittadinanza attiva – aderiscono a tali forme di gestione collettiva delle risorse, per finalità economiche e sociali.
In conclusione, le destinazioni e le modalità di gestione del risparmio hanno indubbiamente attraversato evoluzioni costanti e ricche di portata innovativa, e attestano le potenzialità del bene in esame, suscettibile di finanziare iniziative economiche e progetti sociali: dunque è viva la coscienza della centralità di questo mezzo per raggiungere scopi diversificati, talvolta collocati nell’area dell’economia tradizionale, talaltra in quella dell’economia sociale. Del resto gli artt. 2, 3, 9 e 118 Cost. consegnano un quadro denso di beni e valori costituzionali, in vista dei quali proprio l’insieme dei soggetti dell’area non profit tradizionalmente si prodiga: la giustizia sociale, lo sviluppo dei singoli e dell’intera comunità, l’ambiente, gli interessi delle generazioni future sono alla radice del proficuo coinvolgimento dei privati nel perseguimento di finalità di portata generale, e tale coinvolgimento costituisce, nel lessico della nostra Carta fondamentale, quel paradigma che dà nutrimento alla c.d. economia sociale. L’apporto delle formazioni sociali, che sono impegnate su questo terreno – e che nel linguaggio nostrano sono in gran parte conosciute come Terzo settore[40] – dell’organizzazione della comunità e del perseguimento della «sostenibilità sociale», riceve autonomo riconoscimento nel testo costituzionale, e di conseguenza assume identità ben distinta rispetto all’apporto che dal mercato può derivare. Anche a questi soggetti dell’economia civile o sociale il risparmio dei privati può fornire oggi prezioso alimento, offrendo un sostegno finanziario che si traduce principalmente in valore sociale. Dunque, il ventaglio degli impieghi del risparmio si prospetta nel presente veramente ampio e fecondo.
Eppure, alcuni segnali lasciano presagire che in qualche misura si cominci a deflettere rispetto a questi orientamenti, e che avanzino scenari legati anche ad attività illecite, che sventuratamente risultano anch’esse attrattive.
Circa la tendenza a premiare investimenti ESG[41], dal rapporto Consob del 2022 emerge che l’integrazione di tali fattori nella strategia di investimento è ormai una prassi generalizzata dei gestori. Uno studio realizzato per Il Sole 24 Ore[42] riporta, tuttavia, un quadro di disaffezione e disimpegno dei gestori, che cominciano a essere molto meno attenti a tematiche ESG e registrano un cambio di priorità tra i risparmiatori e gli investitori: nell’ultimo trimestre del 2024 vi è stato un record di riscatti per cui, benché i fondi ESG a livello globale abbiano ancora 3.200 miliardi di dollari di attivi in gestione, e dunque cifre ingenti, la variazione nel sostegno all’imperativo della «sostenibilità» si comincia a percepire chiaramente.
Vi è poi da constatare che in misura significativa i risparmi delle famiglie italiane si stanno dirigendo verso l’estero, e i capitali stranieri non dimostrano propensione a investire nel tessuto produttivo nostrano: la «quota Italia» all’interno dei portafogli dei fondi comuni di investimento sottoscritti dai risparmiatori italiani è scesa a fine 2023 al 16%. L’impressione è che i fondi pensione, che amministrano la previdenza integrativa degli italiani, dimostrino poco interesse per gli investimenti in società italiane: dati recenti sono che «su 114 miliardi di masse gestite, “solo” il 46% sono investimenti esteri, mentre la quota investita in titoli di Stato e azioni italiane è rispettivamente il 72 e il 79% del totale»[43].
Tale criticità è stata evidenziata anche in occasione della 100a Giornata mondiale del risparmio a Roma: il 31 ottobre 2024 il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, nel richiamare alla consapevolezza che «il risparmio è innanzitutto una paziente e saggia virtù civile e sociale, fortemente connessa al rispetto delle regole e premessa di utilità private e collettive», ha in più sottolineato la necessità di prepararsi rispetto a scenari ormai prevedibili. L’ormai prossima scadenza dei finanziamenti collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il concomitante defilarsi della Banca centrale europea dall’acquisto di titoli di Stato dell’Italia «spingeranno famiglie e imprese a maggiori investimenti e a crescenti richieste di prestiti», e ciò richiede pertanto modalità sempre più efficienti della gestione del risparmio. Il Presidente ha lamentato la vigenza di «vetuste leggi fiscali, molto antecedenti alle nuovissime tecnologie e all’intelligenza artificiale» che «dispongono ancora uguale tassazione per il risparmio e per la speculazione» e ha raccomandato la correzione di tutto questo, perché «la tutela dei risparmiatori è una necessità etica e strategica per l’Italia»[44].
Forti interrogativi emergono poi dall’attrazione crescente che le c.d. cripto valute mostrano di esercitare nei confronti di risparmiatori, che ad esse indirizzano le loro riserve finanziarie. Negli ultimi mesi, anche a seguito del cambio di amministrazione negli Stati Uniti d’America, il loro mercato ha riacquistato vigore e «l’obiettivo della deregolamentazione, come spiega il Financial Times, è chiaro: facilitare l’acquisizione di criptoasset da parte degli intermediari tradizionali e i fondi pensione». È stato espresso l’auspicio «che l’apertura sia accompagnata da adeguate misure prudenziali, visto che gli investimenti in criptovalute hanno già giocato un ruolo nel fallimento di alcune banche»[45]: i recenti fallimenti nel mercato delle criptovalute hanno sollecitato «l’esigenza, peraltro già avvertita, di una normativa organica a livello UE sul fenomeno delle cripto-attività e, in particolare, di una maggior tutela nei confronti dei consumatori che decidono di investire in tale settore»[46]. La dimensione della speculazione e dell’azzardo è quanto mai evidente in questo anno 2025, che si è aperto all’insegna di un insieme di indirizzi – nei mercati globalizzati – in materia economica e finanziaria, che vanno in totale discontinuità con il passato: le sorti che attendono il risparmio non appaiono rassicuranti.
Anche le evidenze di decrescita del fenomeno demografico possono avere rilevanti riflessi sul risparmio e sul sistema finanziario italiano. Studi economici[47] evidenziano come «le tendenze demografiche, il progressivo aumento della speranza di vita e la necessità di mantenere in ordine la finanza pubblica imporranno un riequilibrio tra consumi correnti e risparmio per far fronte alla carenza della struttura di welfare attuale, fortemente sbilanciata sul versante della previdenza pubblica obbligatoria. Il complesso delle attività finanziarie dovrà accompagnare un crescente impiego di risorse destinate al differimento dei bisogni di consumo nella più estesa fase di vita successiva all’uscita dal mercato del lavoro». Se si considera che l’accumulo di risorse disponibili per il risparmio tende a partire con ritardo rispetto al passato, perché tardivo è l’ingresso nel mercato del lavoro dopo anni di attività di studio e di occupazione precaria, si può immaginare che occorrerà introdurre nuove componenti del sistema previdenziale e assicurativo per esigenze di consumo in prospettiva.
Quest’ultima considerazione porta ad una conclusiva constatazione di quanto sia stretto il legame tra Costituzione e tempo: è sempre opportuno tornare a riflettere sulla portata del programma di trasformazione, che già era insito nella lettura della Carta effettuata alle origini, e che oggi conserva e acquista nuova vitalità e significato con una forte attenzione al fattore tempo, che induce a non smarrire mai la proiezione verso un orizzonte futuro, più o meno lontano.
Al di là della novità di politica costituzionale di inserire tre anni fa, con la legge di revisione n. 1 del 2022, le generazioni future nella Carta fondamentale, il tempo sembra diventare ormai criterio fondamentale per le scelte di realizzazione delle finalità poste in Costituzione. È vero per un insieme di politiche che non è possibile pensare con una prospettiva a breve, ma che occorre proiettare nel lungo termine: ricerca scientifica, previdenza, cambiamento climatico e anche la stessa protezione del risparmio – che ben può considerarsi politica a sé – sono ambiti che la Costituzione vuole ben presidiati dalle istituzioni pubbliche, e non lasciati solo al mercato; e governati con scelte equilibrate ed efficaci, che rifuggono da soluzioni contingenti ma piuttosto prefigurano gli sviluppi che attendono la comunità nazionale, e offrono le appropriate misure di carattere regolativo e normativo. Per il risparmio tale è lo scenario da invocare, per la salvaguardia dei singoli e il progresso della comunità.
[1] Così inquadrano la disposizione gli illustri commenti che l’hanno riguardata: F. Merusi, Art. 47, in Comm. della Cost. Branca Bologna-Roma, 1980, e G. M. Salerno, Art. 47, in Commentario breve alla Costituzione, V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), Padova, 1990.
Sono poi intervenuti i commenti più recenti: S. Baroncelli, Art. 47, in Commentario alla Costituzione, R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), vol. I, Torino, 2006, e M. Giampieretti, Art. 47, in Commentario breve alla costituzione, S. Bartole, R. Bin (a cura di), Padova, 2008.
Sia consentito rinviare a C. Buzzacchi, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 cost. e funzioni della Banca Centrale Europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della Repubblica e ordinamento dell’Unione, in Costituzionalismo, 2016, 2.
[2] In un duplice lavoro G. Cerrina Feroni offre la lettura comparatistica: nella curatela Tutela del risparmio e vigilanza sull’esercizio del credito. Un’analisi comparata, Torino, 2011, e La tutela del risparmio. Un quadro comparato, in Dir. pubbl. comp. eur., 2009, 3.
Cfr. anche F. Scuto, La dimensione sociale della Costituzione economica nel nuovo contesto europeo, Torino, 2022.
[3] F. Riganti, La gestione “sostenibile” del “risparmio gestito” Divagazioni sull’articolo 47 della Costituzione (e non solo), in Contratto e impresa/Europa, 2023, 3, riflette sull’impostazione «bancocentrica» dell’art. 47.
[4] Si rinvia a T. Jappelli, L. Pistaferri, Risparmio e scelte intertemporali, Bologna, 2000; A. Martini, Tra Crescita e parsimonia. Il risparmio nel dibattito economico dai classici all’ipotesi del ciclo di vita, Milano, 2022.
[5] Cfr. M. Baranzini, La teoria del ciclo vitale del risparmio di Modigliani cinquanta anni dopo, in Moneta e credito, 2005, giugno-settembre.
[6] Oltre ai commentatori della nota 1, si rinvia a S. Dettori, A. Zito, Risparmio (tutela del), in Trattato di diritto amministrativo europeo, G. Greco, M. Chiti (a cura di), Milano, 2007.
[7] F. Panetta, Cento anni di cultura del risparmio, in Astrid Rassegna, 2024, 16.
[8] S. Dettori, A. Zito, op. cit., 1732.
[9] Anche qualche dato può poi essere interessante per comprendere l’incidenza del risparmio sul sistema.
Nel 1924 la consistenza dei depositi bancari e dei libretti postali ammontava al 27% del PIL.
I successivi eventi quali la grande depressione, la guerra e l’inflazione post-bellica hanno ridotto drasticamente la ricchezza finanziaria di un’intera generazione: nel 1948 il valore dei depositi bancari e postali era crollato al 10% del PIL.
Dal secondo dopoguerra ai primi anni Novanta le famiglie italiane hanno risparmiato in media un quarto del reddito ogni anno e il saggio di R. ha iniziato a ridursi negli anni Ottanta, accelerando dal 1992, per poi stabilizzarsi al 10% nel Duemila. Hanno contribuito la crisi valutaria del 1992 e il successivo consolidamento fiscale, che hanno compresso il reddito disponibile, inducendo le famiglie a diminuire il saggio di risparmio al fine di sostenere i consumi. Ma anche il calo dei tassi di interesse determinato dall’introduzione dell’euro e il migliore accesso al credito hanno favorito il consumo corrente rispetto a quello futuro.
Inoltre, va detto che non risparmiano solo le famiglie, e anzi il risparmio delle imprese è divenuto via via più rilevante, fino a rappresentare due terzi del risparmio privato nell’ultimo decennio. Attualmente il flusso annuo di risparmio privato supera i 400 miliardi, un quinto del reddito nazionale.
[10] F. Merusi, op. cit., 156.
[11] V. Spagnuolo Vigorita, Principi costituzionali sulla disciplina del credito, in Rass. dir. pubbl., 1962, 1.
[12] S. Ortino, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979.
[13] F. Guizzi, La tutela del risparmio nella Costituzione, in Il Filangieri, 2005, 2-3-4, 172, ricostruisce che il valore tutelato dalla norma in esame non sarebbe il risparmio in sé, che godrebbe della tutela dell’art. 42 Cost. in quanto forma di proprietà privata, ma risulterebbe solo quello che rifluisce nel circuito della liquidità monetaria assicurata dall’attività bancaria.
[14] F. Merusi, La posizione costituzionale della Banca centrale in Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1981, 31, 1084 ss.; Id., Art. 47, in Codice commentato della banca, F. Capriglione, V. Mezzacapo (a cura di), Milano, 1990, 22 ss.
[15] F. Scuto, op. cit., 103.
[16] Sia consentito rinviare alle riflessioni sviluppate nei fascicoli Una Repubblica fondata sul lavoro?, in Diritto costituzionale, F. Pizzolato, C. Buzzacchi (a cura di), 2023, 2, e Previdenza e generazioni future, in Diritto costituzionale, C. Buzzacchi (a cura di), 2024, 2.
Cfr. anche C. Buzzacchi, Reddito e Costituzione. La cifra smarrita, Milano, 2022, 70 ss.
[17] Si vedano le parole di I. Visco, Scelte consapevoli, educazione, responsabilità. La sfida del risparmio per le nuove generazioni, Intervento del governatore della Banca d’Italia alla 99ª Giornata Mondiale del Risparmio, 31 ottobre 2023: «il risparmio è anche, per non dire soprattutto, un bene pubblico, capace di generare benefici per la collettività nel suo complesso attraverso il trasferimento delle risorse nello spazio, dalle famiglie risparmiatrici verso imprenditori e aziende. Se ben impiegato, contribuisce in modo cruciale alla crescita economica di un paese attraverso il finanziamento di investimenti produttivi in capitale fisico, umano e tecnologico».
Da ultimo cfr. S. Caselli, Non c’è crescita senza la forza del risparmio, in LaVoce.Info, 17 settembre 2024.
[18] G. Peroni, Crisi e ricerca della stabilità economica, in Dir. economia, 2020, 3, 272.
[19] Cfr. I. Musu, Il debito pubblico, Bologna, 2012.
In vari lavori si è sviluppata l’analisi del debito pubblico. Sia consentito rinviare a C. Buzzacchi, Spesa ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97 Cost., in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 2; Ideologie economiche, vincoli giuridici, effettiva giustiziabilità: il tema del debito, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2016, 4; Risparmio e debito pubblico: una prospettiva costituzionale, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Le cose nuove del XX secolo, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore, https://www.dizionariodottrinasociale.it/, 2021.
[20] Sia consentito il richiamo di C. Buzzacchi, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Milano, 2011; «Capacità contributiva» e «progressività» alla prova dell’equilibrio di bilancio, in Osservatorio AIC, 2017, 3.
[21] Si veda la riflessione di A. Guazzarotti, Debito e democrazia. Per una critica del vincolo esterno, Milano, 2024, 43.
[22] Non si può approfondire oltre tale vasta tematica,e si rinvia a S. Baroncelli, The Independence of the ECB after the Economic Crisis, in About The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, M. Adams, F. Fabbrini, P. Larouche (eds.), Oxford, 2014.
[23] Per la parte che segue si veda M. Sarcinelli, La Costituzione italiana e la moneta: un incontro mancato, in Rivista di Politica Economica, 2006, 88 ss., e Id., La tutela del risparmio nel pensiero e nell’azione del Governatore Baffi, in Moneta e credito, 1999, 225 ss., per una più approfondita ricostruzione delle vicende del Ministero per la Costituente presieduto dal ministro Pietro Nenni e del Rapporto prodotto dalla Commissione economica.
Cfr. anche C. Buzzacchi, Risparmio, credito e moneta, cit., par. 2.
[24] Ministero per la Costituente, Rapporto – IV, 36 ss.
[25] M. Sarcinelli, op. cit., 97 ss.
[26] Prima Sottocommissione, 10 ottobre 1946, 221.
[27] Terza Sottocommissione, 26 ottobre 1946, 259.
[28] Si veda la trattazione offerta da F. Pedrini, Consumo, risparmio, finanza. Un’analisi costituzionale, Torino, 2019, 278 ss.
[29] Assemblea Costituente, 19 maggio 1947, 4044.
[30] Ai tempi della formulazione dell’art. 47 Cost. essa poteva declinarsi in termini di salvaguardia dei depositi di carattere monetario M. Sarcinelli, La legge per la tutela del risparmio. Un anno dopo, in La legge per la tutela del risparmio. Un confronto tra giuristi ed economisti, P. Abbadessa, F. Cesarini (a cura di), Bologna, 2007, 16 ss.
[31] F. Capriglione (a cura di), La nuova legge sul risparmio. Profili societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, Padova, 2006; Id., Crisi di sistema ed innovazione normativa: prime riflessioni sulla nuova legge sul risparmio, in Banca, borsa, titoli di credito, 2006, 1; G. Rossi, La legge sulla tutela del risparmio ed il degrado della tecnica legislativa, in Rivista delle società, 2007, 6; A. Nigro, V. Santoro (a cura di), La tutela del risparmio, Torino, 2007.
[32] Gli studi sulla financial literacy cominciano ad accumularsi: M. Caratelli, A. Naccarato, O. Ricci, Alfabetizzazione finanziaria. Il contributo dell’esperienza, in Bancaria, 2012, 6; E. Cavezzali, G. Gardenal, U. Rigoni, Alfabetizzazione finanziaria e «asset allocation» dei non espe rti: uno studio sperimentale, in Analisi giuridica dell’economia, 2012, 1; C. Cruciani, G. Gardenal, A. Moretti, Fiducia e competenze finanziarie: un’analisi sperimentale, Bologna, 2015; G. Guzzetti, Risparmio: quali prospettive?, in Astrid Rassegna, 15, 2017; A. Canepa, “Social media” e “fin-influencers” come nuove fonti di vulnerabilità digitale nell’assunzione delle decisioni di investimento, in Riv. trim. dir. econ., 2022, 1; C. Milli, Il ruolo della cultura finanziaria nell’evoluzione tecnologica, in Rass. dir. pubbl. eur., 2024, 1.
[33] Consob, Report on financial investments of Italian households, Roma, 2024, 81.
[34] M. Tofanelli, Come il risparmio privato può diventare un alleato per il welfare e la crescita, in La Repubblica, 16 dicembre 2024.
Circa la «debolezza» del risparmiatore v. anche le riflessioni di F. Pedrini, op. cit., 291 ss.
[35] P. Grossi, La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’art. 47 della Costituzione, Roma, 19 maggio 2017, 8.
[36] Si osserva ancora, 7, che «l’espresso favore, nel secondo comma dell’art. 47, per il “risparmio popolare” – diretto, genericamente, verso l’accesso alla “proprietà”, di beni materiali o, anche indirettamente, di beni immateriali –, lungi dal poter sembrare esclusivamente orientato verso prospettive di tipo “egoistico” o appropriativo, rivela, piuttosto, una destinazione eminentemente “sociale”: l’incentivo per un eventuale vantaggio individuale, infatti, di persone storicamente escluse dai circuiti della “ricchezza”, non può risultare disgiunto dall’intento di includerle nella costruzione di un benessere, in ogni caso, anche comune».
[37] L. Einaudi, Il dovere di risparmiare non è mai stato così urgente, in Corriere della Sera, 26 luglio 1919.
Corrado Sforza Fogliani ha curato la raccolta di Elogio del rigore. Aforismi per la patria e i risparmiatori», Soveria Mannelli, 2021, nella quale sono riportati questo e altri articoli: nel 1915 Alberto Albertini, in nome del direttore e fratello Luigi, invitò l’amico Einaudi a comporre per il Corriere della Sera una «piccola serie di aforismi, di massime, di consigli brevissimi per esortare il pubblico a sottoscrivere il prestito», volontario e non forzoso. Einaudi ha così dimostrato, ben prima che la disciplina costituzionale del risparmio venisse definita, il suo favore per un risparmio di pubblica utilità.
[38] La Direttiva sul reporting di sostenibilità (CSRD) 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) si inquadra nell’ambito del Green Deal Europeo e ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese, dopo la precedente direttiva NFRD 2014/95/UE.
[39] E. Fregonara, L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi, 4, con rinvio ad ampia letteratura in nota 7; e Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le start up innovative, in Orizzonti, 2014.
L’A. aggiunge che si è in presenza di una forma di «democratizzazione della finanza», che consente agli artefici di un progetto di sponsorizzarsi online, attraverso nuove risorse che implementano la capacità di generare ricchezza a sostegno delle iniziative più meritevoli.
[40] L. Gori, Terzo settore e Costituzione, Torino, 2022, nei capitoli 3 e 4 affronta le questioni di rilievo costituzionale, alla luce della sussidiarietà orizzontale che la Costituzione eleva a principio cardine, e delle azioni di sostegno e incoraggiamento che i pubblici poteri devono organizzare per i soggetti che ricadono nel c.d. Terzo settore.
La letteratura sul Terzo settore è ampia, qui i richiami principali: L. Gori, E. Rossi (a cura di), La riforma del Terzo settore, numero monografico Non profit paper, 2017, 3; A. Mazzullo, Il nuovo Codice del Terzo settore, Torino, 2017; A. Fici (a cura di), La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, Napoli, 2018; M. Gorgoni (a cura di), Il Codice del Terzo settore, Pisa, 2018; AA.VV., Dalla parte del Terzo settore. La riforma letta dai protagonisti, Bari, 2019; P. Consorti, L. Gori, E. Rossi, Diritto del Terzo settore, Bologna, 2018; E. Rossi, Costituzione, pluralismo solidaristico e terzo settore, Modena, 2019; F. Donati, F. Sanchini (a cura di), Il Codice del Terzo settore, Milano, 2019.
[41] Sul tema si veda lo studio recente di A. Blandini, F. Masa Felsani, G. Alfano, Sviluppo sostenibile e lotta alle diseguaglianze nella regolamentazione delle attività economiche, in Federalismi, 2024, 22.
[42] M. Longo, Boom di riscatti e svolta narrativa: ecco i dati della frenata dei fondi Esg, in Il Sole 24 Ore, 30 gennaio 2025.
Si veda l’analisi di M. Calderini, Economia, clima, sostenibilità. Ora ci dicono «tutte balle» ma i problemi veri rimangono, in Corriere della Sera, 4 febbraio 2025.
[43] Si vedano i dati di G. Ursino, Risparmio degli italiani, solo il 16% resta nel Paese, in Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2024. Gli investimenti delle Casse che gestiscono la previdenza obbligatoria dei liberi professionisti vengono invece considerati «più patriottici».
[44] ABI, Relazione del Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana Dott. Antonio Patuelli, 100a Giornata mondiale del risparmio a Roma: il 31 ottobre 2024.
[45] L. Fantacci, L. Gobbi, L’America di Trump, capitale delle criptovalute, in Lavoce.info, 4 febbraio 2025.
[46] F. Di Benedetto, I. Nunziata, Profili regolatori in tema di cripto-asset, in Astrid Rassegna, 2024, 16, 2; cfr. anche L. Donato, Cripto-asset e banche. Rischi per la stabilità finanziaria e regolamentazione, in Bancaria, 2023, 5, e F. Panetta, Caveat emptor does not apply to crypto, in Financial Times, 4 gennaio 2023.
[47] D. Curcio, G. Di Giorgio, G. Zito, Le implicazioni del cambiamento demografico sul sistema economico e finanziario italiano, in Economia italiana, 2022, 3, 216. Si osserva ancora, 246, che gli schemi pensionistici pubblici e privati sono in corso di cambiamento ed è destinata ad aumentare l’influenza che il risparmio accumulato e investito a fini pensionistici esercita sui mercati finanziari. Occorrono strumenti finanziari che siano in grado di rappresentare un’adeguata destinazione per l’investimento previdenziale, con un’offerta di prodotti e servizi in grado di assicurare la tutela del risparmio e soprattutto il suo trasferimento nel tempo.